Crepuscoli dello spettatore. Attività, inattività e lavoro dello
spettatore nell’economia performativa.
Marco Pustianaz
1. Crepuscoli
Da qualche anno l’archiviazione dell’evento performativo è alla base delle mie riflessioni. Tale questione ha
preso la forma non tanto della sua archiviazione in quanto azione artistica, ma dell’archiviazione della relazione
che lo costituisce e lo fa apparire1. Pur essendo questa una relazione a due vie, tra performer e spettatore e
viceversa, il mio sguardo è puntato non tanto sulla scena, vale a dire sulla parte luminosa e illuminata di una
parola e di un gesto che si danno a vedere, ma sullo spettatore. Chi sia lo spettatore, sia durante l’evento sia
dopo che ha visto, quando la sua condizione temporanea si è dissipata, mi pare una delle questioni più cruciali
del teatro, sebbene sia una domanda che appartiene ai suoi limiti estremi, ai suoi margini spazio-temporali.
L’enigma del teatro non è quanto accade sulla scena, ma quanto accade dall’altra parte e tra le due parti.
Porre domande intorno allo spettatore oggi significa interrogarlo sulla soglia della sua mutazione, se non
progressiva sparizione. In questa direzione il teatro si salda a buona parte dell’arte contemporanea, dove
dominano i paradigmi dell’interazione, della collaborazione e della partecipazione (Bishop 2006; Miessen
2010; Jackson 2011; Alston 2013). Lo spettatore così come l’abbiamo conosciuto rischia di diventare un residuo
mal tollerato. Del resto, la sparizione è sua abitudine e destino. La presenza spettatoriale è dichiarata
necessaria a ogni evento performativo, eppure anche differente, separata, lasciata nell’ombra. La presenza
l’uno all’altro di performer e spettatore, caratteristica ontologica della relazione teatrale secondo i più, è
attraversata da una linea di demarcazione, per quanto mobile e costantemente rielaborata, senza la quale la
scena del teatro non comparirebbe. Quindi, se di compresenza possiamo parlare essa è solo apparentemente
irenica: seppure fondata su un generale consenso vi è comunque una impari visibilità dei due ordini di corpi e
spazi. La linea che li demarca è anche il ricordo di una frattura e la relazione che ne risulta non può che essere
una relazione di potere. Possiamo ragionare politicamente su questa divisione soltanto se accettiamo di
considerarla non come accidente, ma come condizione costitutiva per l’apparizione stessa del teatro. Si tratta
di una “partizione del sensibile” che, come ha mostrato Rancière, separa e distribuisce spazi, tempi e capacità
rendendo conflittuale proprio ciò che viene definito terreno comune (Rancière 2011b). La politicità del teatro
è radicata in questa divisione, mai suturata dall’evento.
La marginalità dello spettatore che ne deriva ha una conseguenza profonda anche nella difficoltà di
teorizzare chi o che cosa sia stato lo spettatore una volta che egli2, insieme con l’evento, non appaia più. Se il
teatro è luogo delle ombre, non lo è per via degli attori – ombre ben attrezzate per il loro lavoro – ma per via
di un’umbratilità spettatoriale che attende, sottende e sparisce. O forse proprio questa è la questione
crepuscolare da interrogare, una questione al limite del visibile e invisibile: la sparibilità dello spettatore. È
1 Ho affrontato in modo più esteso la questione dello spettatore nell’ambito del teatro in Pustianaz (2011). La centralità della
relazione performer-spettatore nella creazione di senso dell’evento è anche sottolineata da Fischer-Lichte (2014), soprattutto nel
capitolo 3, “La co-presenza corporea di attori e spettatori”. Per un approccio socio-culturale alla spettatorialità teatrale si veda
Bennett (2013). La spettatorialità è stata indagata in modo più esteso nel cinema: per un’utile rassegna italiana cfr. Somaini
(2005).
2 Il genere maschile è naturalmente fuorviante: lo spettatore è anche spettatrice. Mentre il suo guardare gli assegnerebbe una
posizione maschile, il suo essere soggetta allo spettacolo gliene confermerebbe una femminilizzata. Infine, quale soggetto
transizionale possiamo pensarlo maschile e femminile, nonché transindividuale poiché generalmente non spettatore singolo ma
co-spettatore.
�una questione di archiviazione affettiva3. È la questione di come lavorare nel crepuscolo e intorno al crepuscolo
politico dello spettatore. Poiché, come sappiamo dalla lingua italiana, vi sono almeno due sensi ambivalenti
nella temporalità crepuscolare, a seconda che il crepuscolo preluda al tramonto o all’alba. Nel primo crepuscolo
lo spettatore si avvierebbe al tramonto insieme al dispositivo che l’ha storicamente forgiato; nel secondo lo
spettatore rappresenterebbe una diffusa e tenue emergenza, fragile e appena percepibile. Insistere sullo
spettatore significa affrontare il dubbio di una presenza che può ugualmente sparire nella luce o nel buio.
Il primo crepuscolo è più agevole da descrivere in quanto sembra presentarsi come una mutazione
inevitabile, con tutta la positività degli eventi riconosciuti come storici. In effetti, non possiamo dimenticare
che lo spettatore, in quanto elemento di un dispositivo, deve essere teorizzato come funzione variabile e
contingente, costituita in relazione a un particolare medium. La sua volatilità odierna non è un’eccezione e
dipende dal fatto che la configurazione dello spettatore così come lo conosciamo è formazione estetica, politica
ed economica prodotta da un dispositivo teatrale in continua trasformazione, soggetto alle pressioni di altri
dispositivi e discorsi. In particolare, la costituzione dello spettatore occidentale moderno attraverso il suo
collocamento spaziale – la sua messa in situ – e la sua modalità di incorporazione nell’evento rappresentano
una forma di biopolitica, definibile come la messa a questione del corpo vivente come risorsa disponibile,
trasformabile, aggregabile o separabile: in breve, mobilizzabile. Nel periodo moderno le arti performative sono
state un campo privilegiato di technè dei corpi, sino a diventare, come sappiamo, “laboratori” in cui il corpo
attorale è stato messo al lavoro per saggiare le sue capacità di riproduzione e rappresentazione. Il corpo messo
esplicitamente a lavorare è stato quello del performer ed è per questo motivo che sia l’attenzione teorico-pratica
sia la speculazione critica si sono concentrate sull’efficacia del corpo attorale performativo: è il suo agire – e
l’estensione del suo agire – ad aver trasformato l’attore nel corpo privilegiato della relazione performativa.
Tuttavia, se questo è il corpo esplicito oggetto di disciplina biopolitica, l’efficacia del suo lavoro non potrà che
misurarsi rispetto a un corpo implicito e virtuale, potenzialmente modificabile, che è quello dello spettatore,
corpo affettivo implicato nell’evento e introdotto nelle sue pieghe – un evento predisposto per modularne una
riconfigurazione.
Ogni pratica teatrale, così come ogni riflessione sull’attore, è – in modo neanche troppo dissimulato –
pratica e riflessione intorno al corpo spettatoriale in quanto corpo in transizione, disponibile al cambiamento.
Con il termine spettatorialità possiamo indicare la condizione affettiva in cui il soggetto rende disponibile il
proprio corpo a una soggettivazione temporanea, in eccesso rispetto alla quotidiana: un incorporamento
inedito, aperto al nuovo e alla discontinuità che, tenendone a mente la connessione con altri corpi spettatoriali,
possiamo interpretare come agencement4. La riconfigurazione di tale corpo temporaneo e in divenire è
l’obiettivo sempre sfuggente del teatro. La performance artistica, dunque, sembra innescare una connettività
tra due ordini di corpi – l’uno posizionato come attivo e agente, l’altro come reattivo e patente – il cui obiettivo
è la trasformazione consensuale del secondo. Tale consensualità, tuttavia, non è da intendersi in senso
contrattualistico, bensì come consenso a un assoggettamento che apre le porte a una discontinuità affettiva
non predeterminabile (Clough 2010). In quanto corpo per definizione manipolabile, e tuttavia secondo una
potenzialità aperta che lo rende corpo su cui nessuno – nemmeno ella stessa – può vantare un controllo
preventivo, il corpo spettatoriale è dunque il corpo che fa problema nella relazione teatrale. Intorno alla sua
mobilità e posizionamento rispetto agli assi di attività e passività, controllo e autocontrollo – oltre che sugli
assi già accennati di visibilità e invisibilità, di riconoscimento e disconoscimento – si gioca una parte
importante delle relazioni estetico-politiche tra performer e spettatore.
Non è un caso se nell’unico saggio esteso dedicato al teatro il filosofo francese Jacques Rancière abbia scelto
di concentrarsi sul destino politico dello spettatore contemporaneo, proponendone una genealogia esteticopolitica che affonda le sue radici in epoca precedente (Rancière 2008). Dal titolo del saggio, Le spectateur
émancipé, il primo impulso sarebbe quello di attendersi un manifesto a favore dell’emancipazione dello
spettatore, un’attesa smentita nelle prime pagine, quando appare chiara la tesi contro-intuitiva del saggio:
l’emancipazione promessa allo spettatore odierno equivale all’uscita dalla condizione di spettatore, alla
rinuncia dell’ombra, dell’inerzia e della passività – secondo una partizione del sensibile che vorrebbe attività e
3 Se l’archivio è il luogo in cui l’oggetto memoriale è costituito in documento da consegnare al futuro, l’affetto è il moto che
scompagina l’oggettualità e la chiusura dell’archivio. Lo spettatore è corpo-soggetto archiviante: il suo archivio affettivo non
conserverà l’evento performativo, ma la propria relazione in divenire con esso. All’archiviazione affettiva è stato dedicato il
convegno internazionale Archivi affettivi / Affective Archives (Vercelli-Torino, 11-13 novembre 2010): cfr. Palladini-PustianazSacchi 2013.
4 “Concatenamento” o “articolazione” (agencement) è il concetto introdotto da Deleuze e Guattari per riferirsi a costellazioni
eterogenee e temporanee di corpi, oggetti, qualità, espressioni e territori. Secondo questa prospettiva lo spettatore non è dunque
soggetto autonomo bensì corpo senza organi e macchina desiderante.
�passività ordinatamente attribuite ai due diversi ordini di corpi. Tuttavia, la promessa di emancipazione si
fonda su un presupposto inferiorizzante, nella misura in cui costituisce lo spettatore come assoggettato in
senso reatroattivo. Soltanto poiché sino ad ora lo spettatore è stato passivo ha senso la promessa che cambia il
segno del suo presente e del suo futuro: per poter emancipare presente e futuro sarà necessario aver asservito
formalmente il passato. Perciò la promessa è letteralmente ancipite; un crepuscolo si traduce nell’altro, un’alba
produce un tramonto, a ritroso. Lo spettatore “emancipato” si troverà a essere pienamente libero tranne nella
condizione in cui è stato interpellato dalla promessa: la promessa rende nulla ogni altra possibilità di
emancipazione che la preceda. Il paradosso politico per cui un’emancipazione si sdoppia anche in asservimento
fa di questa transizione una conversione che viaggia nei due sensi e produce sia il futuro che il suo relativo
passato.
Di contro a tale emancipazione in realtà anti-spettatoriale il tentativo di Rancière è quello di ristabilire una
attività pregressa, o meglio postulata, dello spettatore “qualunque”, in modo da rendere nulla un’offerta
emancipativa che serve piuttosto a sventare il pericolo di eguaglianza radicale incarnato dalla figura dello
spettatore. L’offerta di emancipazione che lo porta oggi a divenire partecipante e collaboratore non è per
Rancière elemento nuovo, ma al contrario l’effetto a lungo termine della posizione paradossale da lui occupata
tradizionalmente nel teatro occidentale. Egli riassume questo paradosso nel modo seguente: da una parte, 1)
non esiste teatro senza spettatore; dall’altra, 2) essere spettatore è una condizione di difetto, nella misura in
cui guardare significa non agire e non produrre sapere. In confronto alla programmata, ripetuta e intenzionale
attività dell’attore (definita come arte dell’agire)5, l’inattività dello spettatore lo condanna a un’inferiorità di
fatto. Rancière insinua persino il sospetto che la diffidenza del teatro nei confronti della spettatorialità sia
sintomo di una teatrofobia interiorizzata dislocata sulla figura dello spettatore. Questo varrebbe persino per le
avanguardie teatrali del Novecento, tutte vòlte, seppure in modi diversi se non opposti (si vedano Brecht e
Artaud), a convertire lo spettatore in qualcos’altro, come se la spettatorialità nominasse una mancanza
costitutiva da sanare per il tramite del teatro stesso. È la logica della connessione tra arte e vita che il filosofo
francese ha definito “regime estetico delle arti”, in cui la vita deve essere rinnovata dal surplus di vita dell’arte
(Rancière 2011b). Se il posizionamento dello spettatore come soggetto passivo è stato biopoliticamente utile a
immaginarne la capacità di conversione in altro, affermarne come postulato l’attività, come fa Rancière,
potrebbe rappresentare una sorta di emancipazione preventiva, quasi a protestare dicendo, “non siamo mai
stati passivi”. È importante distinguere l’affermazione dalla rivendicazione, poiché per il filosofo francese
l’eguaglianza è un principio che va verificato, un metro di misura da cui partire, non un ideale a cui aspirare.
In questo senso la temporalità dell’eguaglianza non è proiettata in un futuro, ma radicata come fondamento
per misurare qualsiasi gesto politico.
Oggi, tuttavia, siamo entrati in un’altra fase. Il problema che resta aperto dopo la lettura di Le spectateur
émancipé è il seguente: ammesso che la spettatorialità vada positivamente postulata come attività, come farlo
senza collassarla nell’attività definita dal paradigma emancipativo della partecipazione? Rancière identifica
l’attività dello spettatore con la generale capacità degli anonimi di associare e dissociare, di produrre senso
comparando e traducendo parole, immagini, storie – una capacità interpretativa che risiede innanzitutto nello
stabilire relazioni sensibili capaci di allacciare i tempi diversi dell’esperienza e attraversare le partizioni date
del sensibile. Ci si può chiedere se questa eguaglianza delle capacità sia sufficiente. Far emergere un’attività
dalla passività potrebbe costituire in sé e per sé un passo ambiguo e insufficiente nel contesto odierno, a meno
di non introdurre una differenza interna alla definizione stessa di attività nella nuova economia performativa.
Infatti, estrarre attività dalla passività spettatoriale nel momento in cui tale passività è già in processo di
conversione implica l’onere non solo di rovesciare quella passività in attività, ma di produrre un’attività altra
e divergente, non ricompresa nell’alveo di quella dominante. Una simile produzione è del tutto simile a
un’invenzione creativa, o meglio a un’autopoiesi: l’attività dello spettatore consiste oggi nella produzione di sé
come spettatore. Tale attività lo situa dentro la transizione e lavora in una doppia direzione, producendo non
solo un’attività divergente nel tempo presente, ma anche di una capace di essere vera per il passato. Il postulato
sull’attività dello spettatore resta inerte se non è prodotto dallo stesso spettatore come verità innanzi tutto
producibile e prodotta nel presente, per poi divenire postulato che torni a verificarla apriori, per la seconda
volta.
In questo senso, la produzione di spettatorialità divergente rispetto all’evento, inevitabilmente sottratta alla
partecipazione, entra a pieno diritto nel novero delle pratiche creative che costituiscono lo spazio possibile per
5 Un rovesciamento di questa figura attivista è proposto da Romeo Castellucci, secondo il quale l’attore è piuttosto un corpo
posseduto da altri corpi e passivizzato, persino inchiodato sulla scena dallo sguardo dello spettatore: cfr. la performance, esito del
laboratorio condotto nel 2010 e 2011 alla Biennale Teatro di Venezia, Attore, il tuo nome non è esatto.
�una politicità del teatro (Pustianaz 2012). Tale divergenza, per poter mostrarsi, ha necessità di un crepuscolo
in cui lo spettatore, lungi dallo sparire o dall’essere catturato in scena, persista, vale a dire si prenda il suo
tempo. Non basta più valorizzare il crepuscolo dello spettatore, bisogna innanzi tutto produrlo come intervallo.
Va letteralmente inventato di contro a un’economia che riconosce il lavoro spettatoriale soltanto nella forma
della collaborazione e nel tempo illusoriamente simultaneo della co-creazione di evento. Per questa ragione
diventa cruciale oggi interrogare criticamente il luogo comune sia di questa simultaneità che di questa cocreazione. Tale luogo comune non può più essere riconosciuto come comune, se serve a ottundere o cancellare
le differenze tra il lavoro del performer e quello dello spettatore per creare lo spazio liscio e transitivo della
collaborazione. Una simile configurazione dello spazio-tempo teatrale contribuisce a totalizzare lo spettatore,
trasformandolo in membro di un corpo collettivo assimilabile tout court come pubblico, laddove né il tempo
dello spettatore né il suo guardare comune potranno mai essere simultanei o identici a se stessi.
Mettere in evidenza le diffrazioni, le differenze e i differimenti all’interno dello spazio-tempo dell’evento
performativo può apparire controproducente rispetto alla valorizzazione del teatro come arte comunitaria e
socialmente utile. Questa è tuttavia una delle conseguenze del rovesciamento di sguardo portato sullo sguardo
marginale dello spettatore. Introdurre il margine nel teatro significa mettere al centro il dissenso spettatoriale,
quello che potremmo chiamare mésentente, riprendendo uno dei termini chiave del pensiero estetico-politico
di Rancière (2007), qui applicato all’attività dello spettatore. Tale concetto, generalmente tradotto in italiano
con “disaccordo” ma che preferisco in questo frangente tradurre con “dissenso”, è importante perché configura
l’attività emancipata dello spettatore come singolarità dissensuale. Per quanto l’evento appaia unico e si offra
come esperienza unificante, lo spettatore non vede, non sente e non percepisce la stessa cosa; l’evento è
attraversato da una molteplicità di atti spettatoriali che ricostituisce a sua volta l’evento come non identico a
se stesso. Il mantenimento di questa non identità è cruciale per la possibilità stessa di una virtualità politica. Il
dissenso spettatoriale è dunque una esperienza estetica – un sentire divergente, un dis-sensus – che opera di
traverso rispetto alla partizione del sensibile che si vorrebbe data. È una dissensualità che precostituisce un
atto di dissidenza rispetto alla partizione teatrale che vorrebbe, ad esempio, gli spettatori tutti dalla stessa
parte.
Propongo perciò di teorizzare la dissensualità spettatoriale in almeno tre direzioni. Nella prima direzione
lo spettatore postumo dissentirà dallo spettatore che fu durante l’evento: la questione qui è sino a che punto
dopo l’evento l’esperienza spettatoriale sarà o meno assorbita in una sfera eminentemente privata – in pratica
che cosa avverrà del surplus non consumato dall’evento. Il corpo affettivo e archiviante dello spettatore lascia
in sospeso il destino e il futuro di ciò che avrà visto. In questo senso si può parlare di un “teatro superstite” la
cui apparizione è archiviata da un testimone impossibile: lo spettatore, infatti, è testimone nella misura in cui
non è più lì dov’era ciò che dovrebbe ora testimoniare (Pustianaz 2009). Nella seconda direzione lo spettatore
dissentirà in quanto singolarità dalle altre singolarità con cui è temporaneamente incorporato durante
l’evento: la sua è infatti una condizione ibrida che potremmo definire con il paradosso di esposizione segreta.
In modo analogo Samuel Weber afferma la non identità a se stesso del cosiddetto “pubblico”: «The audience
is no more – nor less – identical with itself than the actors are identical with their roles» (Weber 2004: 271).
La sua non identità pone la questione dell’identità dello spettatore come necessità figurale, vale a dire la scelta
di quali figure poetiche e teoriche possano nominare la “parte” dello spettatore al fine di contrastarne la
generalizzata elisione impolitica. Nella citazione menzionata Weber suggerisce come la spettatorialità produca
nello spettatore una sorta di doppiezza, paragonabile al corpo doppio dell’attore. Nella terza direzione, infine,
lo spettatore dissente rispetto alla creazione dell’evento stesso. La sua attività di creazione, pur legata
all’evento, non lo garantisce affatto; in questo senso è problematico parlare di collaborazione e co-creazione,
se non innestando in questi termini il senso cruciale di una divergenza insita nell’evento stesso. La questione
dello spettatore è intrattabile dal sapere disciplinare perché lo spettatore non soltanto co-crea l’evento, ma lo
derealizza anche, vale a dire lo collassa in una evenienza incapace di essere totalizzata 6. Parlare dello spettatore
è l’inciampo che impedisce di parlare dell’evento come di una unicità. Del resto il teatro non ha a che fare con
la produzione di un’opera, ma con un “coming to pass”: lo spettatore è lì per ricordarcelo.
Radicalizzando questo punto di vista, persino il lavoro del performer diventa, da unica certezza del teatro,
dubitabile, essendo il suo un lavoro senza esito certificabile, un lavoro di ripetizione che si realizza in gran parte
provando senza la presenza dello spettatore. Non un lavoro, dunque, ma piuttosto una prova di lavoro, una
preparazione al teatro. L’incompiutezza del lavoro teatrale risuona nelle bellissime parole di Roberto Latini
che ritrovo sul programma di sala relativo alla prima parte dei suoi Giganti della montagna: «L’incompiutezza
6 Per un approccio che discute l’evento performativo come temporalità in divenire non totalizzabile si veda Massumi (2011).
Ho sinteticamente dato conto di alcuni snodi concettuali in Pustianaz (2011).
�è per la letteratura, per il teatro è qualcosa di ontologico». Se l’incompiutezza è ontologica rispetto al lavoro
attorale, che cosa diremo del lavoro, così incerto e a maggior ragione incompiuto, dello spettatore? La
mutazione della figura dello spettatore per effetto della trasformazione del dispositivo teatrale spinge la
questione del suo lavoro alla luce del giorno. È come se il teatro non potesse più permettersi né l’alterità dello
spettatore, né la sua sospensione in un limbo di apparente inoperosità – come se fosse finita la tolleranza verso
il margine oscuro e il limite poroso della spettatorialità. Entrando sulla scena lo spettatore annuncia da sé il
proprio crepuscolo aderendo a un nuovo orizzonte: la disponibilità immediata dell’affetto spettatoriale alla
produzione di valore. Nella nuova divisione del lavoro performativo tutti, anche chi fu spettatore, devono
visibilmente collaborare. È evidente, dunque, come il nuovo regime del lavoro teatrale dislochi la politica
performativa su un terreno nuovo e conflittuale: la questione della messa al lavoro dell’affetto. In questo
scenario è il postulato stesso dell’attività a mutare di segno. Parlare dello spettatore come lavoratore non è
dunque una semplice provocazione ma una prospettiva di analisi secondo la quale la frattura costitutiva tra
performer e spettatore può essere riformulata in termini espliciti di divisione del lavoro.
1.
Lo spettatore al lavoro
Far emergere la questione del lavoro spettatoriale significa tradurre il paradosso rancièriano dello spettatore
nei termini espliciti di divisione del lavoro, tornando a fare pressione sul luogo comune dello spettatore come
co-produttore. L’effetto di straniamento che ne risulterà sarà una prova ulteriore di quanto sia produttivo
insistere con lo sguardo sullo spettatore proprio mentre transita da un regime di relativa invisibilità a uno di
massima visibilità. Questo passaggio permette infatti di cogliere nell’istante storico in cui se ne percepisce la
discontinuità il ruolo per così dire infrastrutturale dello spettatore rispetto all’economia dell’evento
performativo. Inoltre, seguire la traiettoria dello spettatore in questo transito ha anche il vantaggio di destituire
i fondamenti disciplinari dei saperi che si sono costituiti intorno alla visibilità delle forme riconosciute di
partizione del sensibile; in altre parole, lo spettatore può fungere da operatore transdisciplinare a causa della
sua obliquità e del suo statuto nuovamente instabile.
Il paradosso dello spettatore in termini di divisione del lavoro è il seguente: da una parte, 1) lo spettatore è
parte integrante della produzione di evento; dall’altra, 2) la sua capacità di produzione è secondarizzata. In
breve, il performer lavora, lo spettatore emancipato coadiuva. Seppure ritradotta in attività, l’emancipazione
dello spettatore in collaboratore tende nuovamente a mascherare o a sfumare una dissimmetria. La relazione
collaborativa viene fraintesa come complementarietà caratterizzata dal mutuo riconoscimento. Ciò
sembrerebbe indicare che il prodotto principale del lavoro di collaborazione teatrale è la produzione di un
terreno comune, in cui la spettatorialità emancipata è sussunta interamente come collaborazione all’interno di
una più generale e valorizzata operatività consensuale. A restare immutata, tuttavia, è la priorità data al lavoro
visibile del performer. Più raffinati sono gli strumenti per descrivere, valutare e analizzare il lavoro di chi è
lavoratore, più scarsi rischiano di essere quelli che potrebbero analizzare il lavoro richiesto a chi lavoratore
primariamente non è. Sarà il lavoro collaborativo di quest’ultimo riconducibile alla medesima economia
performativa? Oppure la loro congiunzione biopolitica suggerisce piuttosto una sostanziale inassimilabilità,
tenuta insieme da un differenziale di potere? Questo spiegherebbe come mai il lavoro dello spettatore continui
a contare primariamente come tempo libero, semplicemente perché il valore del suo lavoro non può trovare
un esatto corrispettivo nell’economia della performance7. Da questo punto di vista, il suo lavoro sembra essere
paragonabile ad altri tipi di lavoro, formalmente assai diversi ma analogamente non teorizzati, secondarizzati
e, naturalmente, non pagati: il lavoro riproduttivo delle donne, il cosiddetto lavoro domestico, e, in termini
contemporanei, il lavoro di cura e più in generale il lavoro affettivo 8.
7 Ho ragionato pubblicamente sulla contraddizione tra lavoro spettatoriale e sua gratuità nell’economia performativa
intervenendo al progetto di Thomas Hirschhorn “Flamme éternelle” al Palais de Tokyo di Parigi (7-8 giugno 2014):
http://www.palaisdetokyo.com/en/exhibition/flamme-eternelle (ultimo accesso 02.07.2015).
Sul tempo libero dello spettatore e la sua convertibilità in performance si veda Palladini (2011) che analizza l’emergere di
performance amatoriali tra le due guerre mondiali, tra cui le maratone di ballo. Nel 2012-13 al festival di Santarcangelo il collettivo
Zapruder ha prodotto una performance amatoriale di ballo a coppie per girarne poi il bellissimo film «I topi lasciano la nave? Yes
Sir, I can boogie».
8 Uno dei contributi storici del femminismo italiano sul lavoro riproduttivo è Fortunati (1981). Una definizione di “lavoro
affettivo” è stata data da Hardt-Negri (2004: 132): «Il lavoro affettivo è un lavoro che produce e modifica degli affetti, come l’essere
a proprio agio, il benessere, la soddisfazione, l’eccitazione e, più in generale, la passione». Questo concetto è una riformulazione
�Quale politica si manifesta attraverso il disconoscimento o il riconoscimento del lavoro spettatoriale?
Queste due alternative sono opposte come sembrano? Delle due l’una: o disconosciamo l’attività produttiva
dello spettatore, come se lo spettatore fosse consumato dal suo assorbimento nell’evento, oppure dobbiamo
presumere che la sua presenza sia produttiva sì, ma in attesa di essere organizzata e convertita in lavoro
visibile: in collaborazione. La seconda opzione è se possibile ancor più sintomatica poiché testimonia anche
indirettamente come la spettatorialità sia comunque collegata al lavoro; la differenza è che ora viene
riconvertita da latente e implicita virtualità – il lavoro affettivo dello spettatore – a esplicita capacità di lavoro
formalizzata nei termini di una performance collaborativa. Per questo motivo le forme partecipative di teatro
e performance sono divenute un sito cruciale in cui il lavoro sommerso dello spettatore è contemporaneamente
affermato e negato: affermato in quanto estratto come risorsa, negato in quanto la sua forza è prestata alla
cornice performativa. L’affetto dello spettatore, in realtà, non è riducibile alla capacità di amplificare con il suo
feedback la relazione con il performer, ma produce una molteplicità di mutevoli e temporanee connessioni,
centrifughe rispetto all’evento, vere e proprie “linee di fuga” per utilizzare un concetto deleuziano. Infine,
l’affetto spettatoriale eccede la definizione positiva di attività; ugualmente attivo e passivo, è prodotto in un
circuito di relè consci e inconsci che si sottrae a ogni definizione di pura agentività. Tuttavia, la trasformazione
di affetto in lavoro affettivo si fonda in prima istanza sulla premessa della sua riducibilità ad attività
organizzabile e spendibile. Il lavoro affettivo dello spettatore è dunque prodotto due volte: in primo luogo
recuperato, e quindi trasferito (“alienato”) per essere integrato nella cornice della performance, se non
addirittura come suo fine.
Se questo è vero, l’attività postulata da Rancière come emancipazione radicale dello spettatore rischia di
non contestare la premessa di attività che apre la porta alla conversione in lavoro. Non è infatti soltanto
l’attività dello spettatore a essere oggetto di contesa, è anche la sua inattività – un doppio conflitto che rende
ambigua la questione dell’emancipazione e la partecipazione nelle arti performative cruciale nella sua
ambivalenza. Il fatto che lo spettatore diventi una risorsa impiegabile significa che il lavoro estratto (o
distratto) dalla sua spettatorialità era già calcolato come latente e operante nell’ombra. Per questo motivo la
partecipazione non cancella la spettatorialità: piuttosto la riscrive, ne cattura l’affetto rendendolo visibile in
una nuova economia della performance. Mentre nella precedente divisione del lavoro il lavoro spettatoriale
non contava affatto come tale, il campo ridisegnato dalla partecipazione implica che esso debba essere
formalmente elevato (emancipato) alla dignità di lavoro. Ma la partecipazione non cancella il conflitto; ne
innalza la posta in gioco spostando il terreno sul tipo di lavoro che viene condiviso, sulle condizioni di tale
lavoro e sul tipo di capacità e di ruoli che vengono distribuiti.
Possiamo forse concludere che nel regime partecipativo il termine “spettatore” è svuotato di senso, vale a
dire che attraverso il suo lavoro collaborativo lo spettatore si è definitivamente emancipato dalla
spettatorialità? Al contrario, la spettatorialità può ancora nominare il residuo della partecipazione, il surplus
sottratto al lavoro messo in comune nella performance. Fare questo significa riattivare altrimenti lo spazio
politico dello spettatore interpellandolo con un’altra figura rancièriana: la “parte che non ha parte”, quello che
egli chiama il demos (Rancière 2011a). Se partecipare implica la possibilità concessa a chi fu spettatore di
prendere parte a un’attività che gli era negata, il punto cruciale di una politica dissensuale sta nel lavorare
intorno al residuo negato di tale partecipazione, interrogando ciò che la partecipazione lascia fuori per
produrre la “parte che non ha parte”. È residuo negato perché la partecipazione si definisce come ciò che non
lascia alcun resto. Se di spettatore avrà senso parlare, invece, è chiaro che bisognerà verificare un resto escluso
dalla partecipazione, non attraverso una verifica empirica, ma attraverso una produzione di vero
(letteralmente, un verum facere): lo spettatore va prodotto come resto, quella parte che non ha parte una volta
sottratta la parte che partecipa – surplus improduttivo persino rispetto al lavoro senza prodotto finale che è
l’evento performativo. Volendo superare la divisione tra performer e spettatore l’agenda inclusiva della
partecipazione installa un’altra soglia: quella che divide ciò che lo spettatore può condividere nel lavoro
comune da ciò che invece non produce nulla di immediatamente socializzabile, nulla che possa essere
scambiato. Mentre nell’economia tradizionale lo spettatore rappresentava l’alterità crepuscolare ai margini del
teatro, ora lo spettatore nomina la parte che letteralmente non ha parte e che va attivamente prodotta.
Il passaggio rappresentato dalla svolta partecipativa non va né rifiutato né liquidato. Va interrogato rispetto
ai suoi resti attivabili. In effetti essa richiede un nuovo tipo di spettatorialità autoprodotta: guardare a sé e agli
altri come partecipanti situati e sottrarre con ciò alla partecipazione la spettatorialità per attivarla come resto
in termini post-marxisti delle teorie dell’affetto (cfr. Gregg-Seigworth 2010) ed è legato alla riflessione sulla categoria di “lavoro
immateriale”.
�non messo in comune9. In questo modo la partecipazione costringe la politica del teatro a tornare alle sue
origini: al terreno contestato di ciò che può dirsi comune tra performer e spettatore. Investendo esplicitamente
nella spettatorialità come risorsa preziosa integrabile nel processo collaborativo di produzione performativa –
un processo venduto agli stessi partecipanti come prodotto culturale immateriale – il teatro partecipativo si
colloca all’interno di un generalizzato investimento postfordista nell’affetto, nella vita stessa. Paolo Virno ha
descritto in modo analogo la trasformazione del lavoro in disponibilità al lavoro e la produzione di una forza
lavoro precaria, flessibile e capace di una generica adattabilità: «Poiché la cooperazione sociale precede ed
eccede il processo lavorativo, il lavoro postfordista è sempre, anche, lavoro sommerso. […] Lavoro sommerso
è in primo luogo la vita non retribuita, ossia la parte di attività umana che, omogenea in tutto all’attività
lavorativa, non è però computata come forza produttiva» (Virno 2001: 73). Questo tipo di forza lavoro è
impiegabile in virtù di capacità che attingono a risorse che non sono proprietà esclusive del lavoro stesso, ma
pertengono all’incalcolabile ‘mestiere di vivere’ e alla dimensione relazionale dell’affetto.
La tesi di Virno sul lavoro sommerso trasformato in risorsa esplicita anche quando non effettivamente
svolto (pensiamo in generale al precariato come esemplificazione di questo paradossale lavoro non-lavoro),
suggerisce che anche il teatro può diventare un’officina sperimentale biopolitica – un laboratorio – nel quale
l’accento sul dressage del corpo attorale lascia posto al dressage del corpo flessibile e temporaneo di chi fu
spettatore. Leggendo la trasformazione del lavoro spettatoriale attraverso la lente politica della moltitudine di
Virno, potremmo dire che la questione del teatro è cambiata: la domanda “Cosa fare dello spettatore?” si è
mutata in “Che cosa può fare lo spettatore?”. La sua partecipazione collaborativa è diventata parte di una più
ampia valorizzazione di capacità che, come fa osservare Virno, precedono ed eccedono il processo lavorativo.
Nel passo citato egli pone l’accento sulla natura politica dell’improduttività nascosta tra le pieghe delle
generiche capacità umane, le quali non solo precedono il lavoro – e quindi lo possono sempre adombrare come
virtualità in attesa di impiego – ma lo eccedono anche, costituendone anche il resto. Se questa capacità di
mobilizzazione – sintetizzabile con il concetto di affetto – è oggi al centro dell’investimento biopolitico, non è
tuttavia a motivo della sua implicita produttività, bensì per il fatto che «è difficilmente descrivibile in termini
economico-produttivi». Virno sottolinea che «appunto per ciò (non: malgrado ciò) è una componente
fondamentale dell’odierna accumulazione capitalista» (Virno 2001: 78).
Alle fondamentali componenti di tale accumulazione possiamo certamente aggiungere l’affetto
spettatoriale. Virno ci ricorda che le capacità virtuosistiche della creatività, della flessibilità,
dell’improvvisazione e della precarietà sono passate dall’essere qualità caratteristiche del settore culturale e
artistico a essere qualità desiderabili in tutta la forza lavoro postfordista, così come nei lavoratori del terziario
e dei servizi. Il teatro partecipativo mostra come la centralità virtuosistica del performer stia recedendo dal
centro della scena. L’accumulazione capitalista attrae nel suo regime di produzione non tanto i soggetti già
disponibili come lavoratori, quanto i soggetti il cui lavoro non è ancora tale. Ecco perché il soggetto
precedentemente noto come spettatore diventa più interessante del performer. Se Virno suggerisce come il
concetto di performance ha invaso il terreno della politica attraverso l’appropriazione economica della vita e
dei corpi, una simile invasione di campo ha investito anche il teatro post-spettatoriale, che elide i confini con
il management, le politiche sociali, il campo educativo e, in ultima analisi, l’ingegneria politica 10.
La svolta partecipativa nell’arte contemporanea ha attirato l’attenzione di numerosi studiosi che hanno
sottolineato come contesti diversi producano un diverso significato delle pratiche partecipative. Se negli anni
Sessanta e Settanta la partecipazione si alleava a una domanda di democrazia e di contestazione delle divisioni
sociali, sessuali e di genere, nell’ultima dozzina di anni il concetto di partecipazione è stato oggetto di critiche
proprio nei campi di utilizzo dove prima era considerato strumento di agentività politica: ad esempio, nel
campo della pianificazione dei processi di sviluppo, dei progetti sociali e di comunità, dell’attivismo e delle arti
performative chiamate a coadiuvare in tali processi. Molte critiche rilevano che la partecipazione è messa in
atto come strumento per smussare i conflitti, costruendo una finzione comunitaria che può contribuire
positivamente alla gestione e integrazione di gruppi sociali secondo processi primariamente eterodiretti.
Markus Miessen, ad esempio, sostiene che la svolta sociale nelle pratiche artistiche si presta spesso a una
politica depoliticizzata del consenso che ha abbandonato ogni nozione conflittualità, nel senso agonistico in
cui la intende Chantal Mouffe (Miessen 2010: 83-104). L’effetto principale della partecipazione sarebbe in
9 La questione della messa in comune, di che cosa e in comune con chi, non è limitata soltanto alla spettatorialità durante
l’evento, ma si trasferisce a quella post-evento, dove si dà per scontato che lo spettatore si ritragga sparendo nella propria
privatezza. Lavorare sugli spazi e tempi post-spettatoriali, su un’archiviazione affettiva capace di riattivare una spettatorialità che
si sottragga sia alla socialità puramente ricondotta ai social network sia alla semplice privatizzazione dell’esperienza significa
immaginare performance liminari che lavorino dentro e per il crepuscolo spettatoriale.
10 Sul nesso novecentesco tra performance e rendimento nei campi gestionali, industriali e tecnologici cfr. McKenzie 2002.
�questi casi di persuadere soggetti marginalizzati intesi come target passivi di politiche sociali a vedersi invece
inclusi quali attori di processi collaborativi volti a un bene comune la cui definizione è predeterminata. Così il
linguaggio progressista del coinvolgimento sociale, dell’empowerment e dell’inclusione si è mutato in risorsa
retorica e gestionale di una governamentalità che satura la socialità neo-liberista.
In quanto pratica emergente non spettatoriale, o post-spettatoriale, la partecipazione contribuisce alla
produzione specifica di un campo di relazioni in cui i differenziali di potere, lungi dall’essere sospesi,
continuano a dipendere da un insieme di divisioni mobili (spesso meno visibili rispetto alla violenta frontalità
del teatro tradizionale), dalla conseguente rimodulazione di agentività e da partizioni estetiche che
costituiscono le nuovi cornici dello spazio collaborativo della performance. In effetti, se con la sua strategica
benevolenza la partecipazione sembra mettere in ombra le divisioni, la conseguente perdita di potenziale
politico suggerisce al contrario che è forse in atto una divisione più violenta. La performance consensuale
sembra essere il segnale di quello che Rancière ha chiamato “polizia” (Rancière 2011, vale a dire una
distribuzione ordinata (partage) che ha già calcolato le risorse disponibili: il dicibile, il visibile e il distribuibile
– ciò che può essere messo in comune. Tale partage ha già allocato le rispettive capacità tra i soggetti
riconosciuti come aventi parte. Un effetto di questo ordinamento poliziesco (contrario alla politica, secondo
Rancière) è che non prevede né eccesso né surplus. Al livello della quotidiana distribuzione di possibilità nella
realtà sociale la partecipazione tende a funzionare come una forma amministrativa, allo scopo di distribuire
ciò che esiste (quella parte che è resa disponibile e comune) in modo che ciascuno possa essere incluso secondo
quanto gli compete. Scambiare la parte di spettatore con quella di partecipante parrebbe inserirsi in un’analoga
agenda di inclusione, beneficiando così del riconoscimento di una capacità attiva in precedenza negata. Anche
la moltitudine di cui parla Virno incarna il potenziale di vita continuamente attratto e convertito in forza
lavoro; ciò avviene perché le capacità convertite in lavoro hanno la loro fonte nel non-lavoro. In ogni caso, è
precisamente il confine tra lavoro e non lavoro, tra tempo del lavoro e tempo libero che viene eroso, anzi
capitalizzato.
Lo scenario, tuttavia, non deve essere normativizzato né stabilizzato come egemonico. Al contrario, esso va
messo in gioco come politicizzabile. Se il Capitale capitalizza la parte di vita non riducibile a esso, la politica
non può che politicizzare ciò che della vita non è politico (Esposito 1999). Mentre il concetto rancièriano di
“polizia” presuppone che non vi sia né resto né esteriorità – che il sociale comprenda tutte le parti che ne
prendono parte -, il suo concetto di “politica”, invece, verifica che un resto esiste, non calcolato e dunque
incalcolabile, non rappresentato nella distribuzione esistente. Come abbiamo visto, Rancière chiama questa
parte non calcolata e sotto certi aspetti inesistente demos, la parte che non ha parte. Anche la moltitudine, nei
termini in cui la teorizza Virno, sebbene catturata come forza lavoro persino quando non lavora – o forse
specialmente quando non lavora – esprime capacità o virtualità non riducibili al “puro” lavoro. La loro
irriducibilità fonda il diritto a un surplus negativo, vale a dire non quello in attesa di essere valorizzato, bensì
il surplus al quale verrà rifiutato ogni valore, che si tratti di valore di uso o di scambio. Mentre il valore di
scambio aumenta con la relativa scarsità e il valore di uso incrementa in relazione alla capacità di soddisfare i
bisogni sociali, il valore di ciò che eccede entrambi e manca la valorizzazione non può che essere incalcolabile,
nella duplice accezione di senza valore e di superiore ad ogni valore. Il fatto di non essere rappresentato non
significa che giaccia in un vuoto astorico; al contrario, una parte di esso sarà sempre convertita e soggetta a
investimento e mobilizzazione. In un certo senso, ciò che non ha valore è doppiamente risorsa, positiva e
negativa, grazie all’interna separabilità tra parte catturabile e parte che non ha parte.
L’analogia che ho suggerito tra lo spettatore, la moltitudine di Virno e il demos di Rancière non intende
proporre un’equivalenza di figure, semmai moltiplicarle per contribuire a verificare in che modo lo spettatore
sia stato – e continui a essere – il punto cieco più persistente del teatro, una presenza indispensabile eppure
disattesa persino quando emancipata, o forse proprio quando emancipata. Il fatto è che lo spettatore è
irriducibile a una piena integrazione o valorizzazione dal punto di vista della performance. All’interno
dell’evento eppure ai suoi margini e sempre eccedente, lo spettatore può rappresentarne il soggetto
paradossalmente politico; la sua soggettivazione affettiva e costituzione temporanea richiedono una risposta
che non può esaurirsi né nel suo riconoscimento, né nel suo recupero in termini partecipativi. Venire in
soccorso dello spettatore integrandolo come co-produttore può significare sprecarne il valore incalcolabile e
depotenziarne l’attività improduttiva. L’attività senza prodotto e senza esito dello spettatore rimette in gioco
la crepuscolarità non tanto di un agire positivo, ma di un segreto lavorìo. Verificare la crepuscolarità dello
spettatore – una verifica che non può che partire dallo spettatore stesso – significa sdoppiarlo, produrlo in
entrambe le direzioni della sua sparibilità. Emergendo come spettatore nel momento in cui viene incluso nella
scena egli/ella capitalizzerà il resto eccedente alla propria valorizzazione. Il suo tramonto sarà così anche la
sua alba, poiché avrà emancipato con la seconda il primo. Avrà emancipato l’inclusione con la forza
�dell’esclusione. Come l’Angelus Novus commentato da Walter Benjamin, lo spettatore annuncia il crepuscolo
con la forza di una promessa retroattiva che lo sospinge come una tempesta oltre l’evento; con «il viso rivolto
al passato» (Benjamin 1997: 80) fisserà lo spazio evacuato del teatro, in cui lampeggiano le rovine che egli/ella
non cessa di produrre. Chiamare lavoro questa tempesta spetta solo a noi.
Riferimenti bibliografici
Alston Adam, 2013, “Audience Participation and Neoliberal Value. Risk, Agency and Responsibility in
Immersive Theatre”, Performance Research 18:2, pp. 128-38.
Benjamin Walter, 1997, “Tesi di filosofia della storia”, in Angelus novus. Saggi e frammenti, Einaudi, Torino.
Bennett Susan, 2013, Theatre Audiences, London, Routledge.
Bishop Claire, ed., 2006, Participation, Cambridge (MA), MIT Press.
Clough Patricia T., “The Affective Turn: Political Economy, Biomedia, and Bodies”, in Gregg Melissa, Gregory
J. Seigworth, eds., 2010, The Affect Theory Reader, Durham NC, Duke University Press, pp. 206-225.
Esposito, Roberto, 1999, Categorie dell’impolitico, Bologna, Il Mulino.
Fischer-Lichte Erika, 2014, Estetica del performativo. Una teoria del teatro e dell’arte, Roma, Carocci.
Fortunati, Leopoldina, 1981, L’arcano della riproduzione: casalinghe, prostitute, operai e capitale, Venezia,
Marsilio Editori.
Gregg Melissa, Gregory J. Seigworth, eds., 2010, The Affect Theory Reader, Durham NC, Duke University
Press.
Hardt Michael, Toni Negri, 2004, Moltitudine: guerra e democrazia nel nuovo ordine imperiale, Milano,
Rizzoli.
Jackson Shannon, 2011, Social Works: Performing Art, Supporting Publics, London-New York, Routledge.
Latini Roberto, 2015, programma di sala per I giganti della montagna. Atto primo, Fonderie Limone
(Moncalieri, Torino), 11 gennaio 2015.
Massumi Brian, 2011, Semblance and Event: Activist Philosophy and the Occurrent Arts, Cambridge (MA),
MIT Press.
McKenzie Jon, 2002, Perform or Else: From Discipline to Performance, London-New York, Routledge.
Miessen Markus, 2010, The Nightmare of Participation, Berlin, Sternberg Press.
Palladini Giulia, 2011, “The Amateur Hour: On Value, Personality and the Form of Appearance in the Economy
of Attention”, South Atlantic Review 75: 3, pp. 59-77.
Palladini Giulia, Marco Pustianaz, Annalisa Sacchi, 2013, Archivi affettivi / Affective Archives. Un catalogo,
Vercelli, Edizioni Mercurio.
Pustianaz Marco, 2009, “Teatro superstite”, Art’O 27 (primavera-estate), pp. 13-21.
Pustianaz Marco, 2011, “La presenza dello spettatore”, in Culture teatrali 21, “On Presence”, ed. Enrico Pitozzi,
pp. 191-206.
Pustianaz Marco, 2012, “Il teatro (è) politico. Una promessa tra parentesi”, in Casi Stefano, Elena Di Gioia,
eds., Passione e ideologia. Il teatro (è) politico, Spoleto, Editoria e Spettacolo, pp. 45-63.
Rancière Jacques, 2007, Il disaccordo, Roma, Meltemi.
Rancière Jacques, 2008, Le spectateur émancipé, Paris, La Fabrique.
Rancière Jacques, 2011a, Ai bordi del politico, Napoli, Cronopio.
Rancière Jacques, 2011b, Estetica e politica. Dialogo sulla partizione del sensibile, Roma, Edizioni Alegre.
Somaini Antonio, ed., 2005, Il luogo dello spettatore. Forme dello sguardo nella cultura delle immagini,
Milano, Vita e Pensiero.
Virno Paolo, 2001, Grammatica della moltitudine: per una analisi delle forme di vita contemporanee, Soveria
Mannelli, Rubbettino.
Weber Samuel, 2004, Theatricality as Medium, New York, Fordham University Press.
�
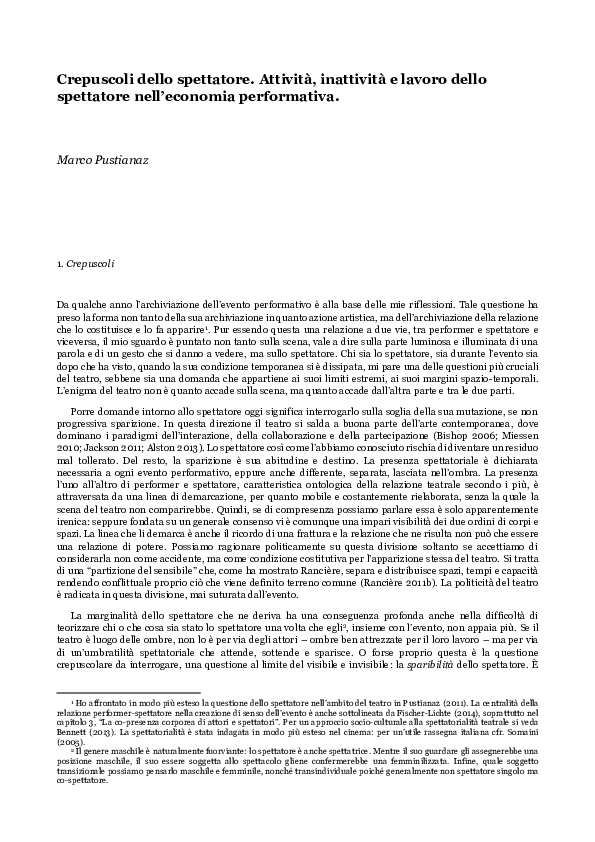
 Marco Pustianaz
Marco Pustianaz