Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
Claudio Vicentini
La teoria della recitazione.
Il distacco dell’attore dal personaggio
La regola del distacco
Nella considerazione ecologica delle nozioni usate nello studio della
recitazione si collocano, accanto all’identificazione, due concetti chiave, il
‘distacco’ (l’attore rappresenta il personaggio manifestandone i sentimenti
senza provarli), e la ‘dislocazione’ (l’attore mentre recita rende visibile la
propria presenza accanto alla figura del personaggio).1 Tuttavia anche la
dislocazione viene per lo più indicata come distacco, e l’impiego delle due
nozioni, sovente confuse, si è ampiamento diffuso in omaggio a una sorta di
vulgata della teoria brechtiana dove il distacco e la dislocazione appaiono
connessi nella produzione dell’effetto di straniamento (far apparite
straordinari e quindi oggetto di attenzione critica fatti e comportamenti
consueti), al punto da essere sovente intesi come sinonimi, o quanto meno
come tecniche inseparabili.
Le origini e lo sviluppo delle sue nozioni sono però indipendenti. Sono
nozioni elaborate tra la metà del settecento e gli inizi dell’ottocento nel
tentativo di rispondere a un problema assolutamente lontano dalla nozione
di straniamento (che è inesistente prima di Brecht), e apparentemente
insolubile: come rendere sulla scena un personaggio inadatto a manifestarsi
nella realtà umana dell’attore. Nelle risposte a due diverse forme di
«irrappresentabilità» del personaggio veniva messa a punto prima la
nozione di distacco, e poi quella di dislocamento.
Il distacco è teorizzato per la per la prima volta nell’Art du Théatre à Madame
*** di Antoine-François Riccoboni apparso nel 1750. Secondo una
convinzione indiscussa, posta a fondamento della teoria della recitazione fin
dalle prime formulazioni d’epoca greca e romana, l’adesione emotiva è un
aiuto prezioso o addirittura indispensabile alla resa delle espressioni che
l’attore manifesta interpretando il personaggio. All’adesione emotiva erano
attribuite due funzioni: imprimere spontaneamente sul volto e
nell’atteggiamento l’espressione richiesta dalla parte, e caricarla di
un’energia particolare che contagiava lo spettatore coinvolgendolo nello
stato emotivo rappresentato.
Contro questo postulato Antoine-François Riccoboni muoveva un’obiezione
destinata a diventare celebre. Se un attore prova davvero il sentimento che
Sulla considerazione ecologica delle nozioni impiegate nello studio del teatro vedi C.
Vicentini, Per un’ecologia delle nozioni di lavoro. L’identificazione dell’attore con il personaggio,
«Acting Archives Review«, n. 7, maggio 2014 (www.actingarchives.it).
1
© 2016 Acting Archives
www.actingarchives.it
1
�AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
manifesta perde la capacità di controllare le proprie espressioni, rendendole
false e confuse, o addirittura pericolose. Questo pericolo, ma solo
sporadicamente e in termini assai generici, era già stato considerato dalla
letteratura precedente. Si ricordava il tragico episodio di Montdory colpito
da paralisi sulla scena del Théâtre du Marais nell’agosto del 1637 mentre
pronunciava con eccessiva veemenza le imprecazioni del personaggio di
Hérode nella Mariamne di Tristan. Si ricordava anche la fine di Montfleury
morto trent’anni dopo in seguito ai furori declamatori con cui aveva
interpretato la follia di Oreste nell’Andromaque di Racine. Ma non era
necessario arrivare a tanto. Le insidie dell’emozione potevano avere effetti
meno tragici ma comunque devastanti. Nelle Réflexions sur l’eloquence de ce
temps del 1671 René Rapin citava il caso di un avvocato trascinato dal suo
discorso al punto da ingarbugliare la pronunzia e diventare incomprensibile.
In tempi più recenti Grimarest aveva osservato che un’eccessiva passione,
realmente provata da un avvocato, poteva alterarne la voce e impedire
un’efficacia scelta delle parole, e Jean Poisson aveva ribadito l’esigenza di
regolare l’adesione emotiva nel parlare in pubblico perché altrimenti la voce
si soffocava e la memoria si smarriva.2
Si trattava però dei danni provocati da un evidente eccesso emotivo. Con
Antoine-François Riccoboni la questione si poneva in termini diversi. Non
riguardava soltanto un’eventuale sovrabbondanza di adesione sentimentale.
Si stabiliva piuttosto una regola assoluta che escludeva sempre e comunque
la partecipazione interiore, più o meno intensa che fosse: «se si ha la sfortuna
di provare realmente quello che si deve esprimere», stabiliva l’Art du Théatre
à Madame ***, «non si è in grado di recitare». Veniva proposto un esempio
che doveva apparire inequivocabile:
Se in un punto di intenerimento vi lasciate trasportare dal sentimento della
vostra parte, il vostro cuore si troverà ad un tratto serrato, la vostra voce si
soffocherà quasi del tutto; se cade una sola lacrima dai vostri occhi, dei
singhiozzi involontari impacceranno il gosier, vi sarà impossibile proferire una
sola parola senza dei singulti ridicoli. Se dovete allora passare subitamente alla
più grande collera, ciò vi sarà forse possibile? No, senza dubbio. Cercherete di
rimettervi da uno stato che vi priva della facoltà di proseguire, un freddo
mortale si impadronirà dei vostri sensi e per qualche istante non reciterete più
che macchinalmente. Cosa ne sarà in quel momento dell’espressione di un
sentimento che richiede molto più calore e forza del primo? Quale orribile
scompiglio ciò non produrrà nell’ordine delle sfumature che l’attore deve
percorrere affinché i sentimenti appaiano legati e sembrino nascere gli uni dagli
altri?3
R. Rapin, Réflexions sur l’eloquene de ce temps, Paris, Barbin et Muger, 1671, pp. 69-70 ; J.-L. Le
Gallois de Grimarest, Traité du Récitatif, Paris, Jacques Lefèvre et Pierre Ribou, 1707, p. 118 ; J.
Poisson, Réflexions sur l’art de parler en public, s.l., 1717, p. 25.
3 A. F. Riccoboni, L’arte del teatro, tr. it., introduzione e note di E. De Luca, Napoli, Acting
Archives, , 2015, p. 182, www.actingarchives.it (Books).
2
2
�Claudio Vicentini, Il distacco dell’attore dal personaggio
Dunque anche gli stati d’animo moderati, come l’intenerimento – diversi
dagli impeti del furore tragico, dall’odio, dalla disperazione – trascinano
l’attore in una sorta di confusione espressiva. Poi Antoine-François
Riccoboni passava a un secondo esempio:
Un attore entra in scena, le prime parole che sente devono causargli una
sorpresa estrema, coglie la situazione e tutto a un tratto il suo viso, l’aspetto e
la sua vice marcano uno stupore da cui lo spettatore è colpito. Può egli
veramente essere sorpreso? Egli conosce a memoria ciò che gli verrà detto:
giunge a bella posta perché glielo si dica.4
La conclusione, di nuovo, era chiara. Esistono circostanze e scene in cui
l’adesione emotiva è impossibile.
Il distacco inteso come regola assoluta della recitazione veniva ribadito nel
Paradoxe sur le comédien di Diderot, composto tra il 1773 e il 1777 e pubblicato
parecchio tempo dopo, nel 1830.5 Qui le considerazioni e gli esempi si
moltiplicavano e riguardavano due generi di argomenti assai diversi. Gli
argomenti del primo genere sottolineavano l’inaffidabilità dell’adesione
emotiva. Nessuno può decidere di provare un sentimento quando vuole, e
dunque, osservava Diderot, nessun attore potrebbe produrre l’espressione
dettata dalla parte nel preciso momento in cui viene richiesta dallo sviluppo
del dramma.6 Inoltre, affidandosi alla propria sensibilità emotiva, l’attore
sarebbe soggetto alle interferenze dei sentimenti della sua vita privata che
turberebbero lo stato interiore necessario alla resa del personaggio: «avrà
anch’egli un padre, una madre, una moglie, dei figli, dei fratelli» e
«bersagliato al pari di noi e colpito da una serie infinita di disgrazie», non
potrebbe il più delle volte recitare.7 Infine la gamma di stati d’animo di cui
ognuno dispone è limitata e definita dalla sua personalità individuale, perciò
un interprete non riuscirebbe mai a provare passioni che gli sono estranee.
Incapace di recitare due personaggi differenti «potrebbe eccellere soltanto in
alcuni punti di una medesima parte».8 Da tutto questo Diderot traeva una
regola del distacco non dissimile da quella di Antoine-François Riccoboni: la
recitazione richiede sempre un atteggiamento «freddo e tranquillo», spoglio
da qualsiasi elemento emotivo prodotto dalla sensibilità dell’interprete.9
A Diderot non sfuggiva però che la stessa recitazione, per quanto fredda e
distaccata, poteva di per sé provocare nell’attore uno stato emotivo che
Ivi, p. 184.
Diverse argomentazioni contenute nel Paradoxe, erano già note, sia pure in un ambito
ristretto, prima del 1830. Diderot le aveva esposte in un articolo, Observations de M. Diderot sur
une brochure intitulée Garrick ou les acteurs anglais, pubblicato in due numeri, il 15 ottobre e il 1
novembre del 1770, sulla «Correspondance littéraire», periodico manoscritto.
6 D. Diderot, Paradosso sull’attore, tr. it. a cura di P. Alatri, Roma, Editori Riuniti, 1989, p. 73.
7 Ivi, pp. 116-117.
8 Ivi, p. 135.
9 Ivi, p. 75.
4
5
3
�AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
definiva «fittizio» (acquis ou factice)10. Di un «calore» prodotto dall’azione
recitata, che investe progressivamente lo stato emotivo dell’attore, si era del
resto già parlato. Vi aveva accennato d’Aubignac nella Pratique du théâtre
ricordando che talvolta Montdory, «per animarsi un po’» prima di recitare
le battute della parte, passeggiava «dondolando la testa, alzando e
abbassando gli occhi e assumendo diversi portamenti secondo il sentimento
da esprimere».11 Di un «fervore» prodotto dall’azione che anima la resa
emotiva dell’interprete accennava, diverso tempo dopo, Jean Dumas
d’Aigueberre in un saggio del 1730 riferendosi alla recitazione della Duclos.12
Nel 1734 Aaron Hill spiegava che la stessa postura fisica assunta dall’attore
nel recitare la parte, l’atteggiamento, le azioni compiute, lo emozionavano
facendogli provare «i veri sentimenti delle passioni recitate».13 Anche
Antoine-François Riccoboni aveva osservato che l’attore quando interpreta
«i pezzi di grande passione» sente per un effetto naturale della recitazione
«un’emozione vivissima».14 Tuttavia, mentre d’Aubignac, d’Aigueberre e
Aaron Hill individuavano in un fenomeno del genere un aiuto alla resa del
personaggio, e Riccoboni, paladino del distacco, non pareva né apprezzarlo
né condannarlo, Diderot compiva un passo ulteriore. La sensibilità fittizia gli
offriva l’occasione per denunziare l’effetto nefasto che l’emotività - in
qualsiasi forma e comunque prodotta - provoca nella resa della parte.
L’attore deve resistere al sentimento fittizio con una «volontà di ferro»,
compiendo un’assoluta rinuncia a riempire i suoi gesti e le sue espressioni
con ogni scampolo di emotività.15
Di fronte a una prescrizione così perentoria e nonostante il carattere assoluto
della regola gli argomenti di Diderot, così come quelli di Antoine-François
Riccoboni, non riuscivano in realtà ad escludere l’adesione emotiva come
una delle possibili componenti della recitazione. Dimostravano che la
partecipazione interiore non era sufficiente perché non soddisfaceva alcune
importanti esigenze dell’interpretazione attorica: il controllo espressivo, la
difesa da interferenze emotive estranee alla resa della parte, la varietà dei
personaggi da rappresentare, la necessità di esibire in ogni momento del
dramma l’espressione richiesta. Ma tutto ciò non spiegava perché non
potesse costituire almeno un sostegno per rendere più efficaci i gesti e le
espressioni dell’attore, sia pur impostati, studiati, meditati e
meticolosamente eseguiti con procedure diverse. Se poi era vero che l’empito
emotivo portato a un estremo livello era comunque dannoso perché
Ivi, pp. 82, 87,111.
F. H. d’Aubignac, La pratique du théâtre, Paris, Antoine de Sommaville, 1657, p. 281.
12 J. D. d’Aigueberre, Seconda lettera del suggeritore della Comédie di Rouen, tr. it., introduzione e
note di V. De Gregorio Cirillo, Napoli, Acting Archives, 2012, p. 232, www.actingarchives.it
(Books).
13 A. Hill, Lettera a Marshall, 24 ottobre 1733, in The Works of the Late Aaron Hill, 4 voll., London,
Printed for the Benefit of the Family, 1753, vol. I, p.158.
14 A. F. Riccoboni, Art du Théatre à Madame ***, cit., p. 183.
15 D. Diderot, Paradosso sull’attore, cit., pp. 87, 111.
10
11
4
�Claudio Vicentini, Il distacco dell’attore dal personaggio
distorceva e bloccava l’espressività dell’attore, non era detto che dovesse
sempre arrivare a questi eccessi. Come spiegava John Hill in The Actor, pochi
anni dopo l’uscita del testo di Riccoboni, un bravo attore deve essere in grado
di regolare la propria sensibilità evitando «di sentire in modo tale da perdere
l’uso della voce», e dimostrarsi capace di «controllare le sue passioni in modo
che queste non disturbino le sua espressione».16
Posta in questi termini – la partecipazione emotiva non è sufficiente per
recitare una parte – la nozione di distacco si riduceva a un’ovvietà. Ma nel
dibattito teorico del tempo la regola del distacco, nella sua formulazione
assoluta e radicale, assumeva un’importanza determinante. Nel 1728 Luigi
Riccoboni, padre di Antoine-François, aveva infatti pubblicato Dell’arte
rappresentativa, e illustrando le regole da seguire sulla scena aveva posto
l’adesione emotiva come fondamento dell’arte dell’attore, base primaria di
ogni altra operazione tecnica necessaria alla resa della parte. Veniva così
inaugurata la moderna concezione emozionalista della recitazione, poi
ampiamente sviluppata nel Comédien di Rémond de Sainte-Albine.17
La regola del distacco formulata da Antoine-François e da Diderot si
presentava come critica diretta a questa concezione.18 Se l’adesione emotiva,
per la propria instabilità, richiedeva un essenziale ricorso ad altre risorse
della tecnica attorica, non poteva evidentemente essere posta a fondamento
della recitazione. Ma qui si apriva un problema di ampia portata. Liquidata
la posizione di Luigi Riccoboni e Rémond de Sainte-Albine, l’opposizione
antiemozionalista si trovava impegnata a delineare una diversa teoria della
recitazione, fondata su altre basi, e soprattutto, come prescriveva la
formulazione della regola del distacco, escludendo ogni apporto
dell’emozione dell’attore alla resa del personaggio. Era un compito improbo
e destinato al fallimento. L’esigenza che lo muoveva finiva però con
l’orientare per tutto l’ottocento e il primo novecento una parte della
discussione sull’arte dell’attore in una direzione sostanzialmente sterile:
discutere se la recitazione dovesse valersi di strumenti esclusivamente
emotivi, o esclusivamente razionali.19 Una contrapposizione in cui, nel pieno
J. Hill, The Actor, London, R. Griffiht, 1755, p. 54.
L. Riccoboni, Dell’arte rappresentativa. Capitoli sei, London, 1728; P. Rémond de SainteAlbine, Le comédien, Paris, Dasaint & Saillant et Vincent fils, 1747.
18 Antoine-François fa esplicito riferimento alla teoria paterna (esposta dopo il trattato del ’28
nelle Pensée sur la déclamation, Paris, Briasson, Delormel, Praul, 1738) in una nota dell’Art du
théâtre, di tono ambiguamente rispettoso: «So che in questo articolo sono completamente
all’opposto dell’opinione di mio padre, come si può veder nei suoi pensieri sulla
declamazione. Il rispetto che devo alla sua decisione, riconoscendolo come mio maestro
nell’arte del teatro, e sufficiente a persuadermi che ho torto; ma ho creduto che la mia
riflessione, vera o falsa, non sarebbe stata inutile al lettore» (cit. p. 183). Ed è in diretta
polemica con un’opera derivata dal Comédien di Rémond de Sainte-Albine (Garrick ou les
acteurs anglais) che Diderot compone il Paradoxe. Per la ricostruzione della vicenda e la
consultazione dei relativi testi vedi il «Catalogue» di Acting Archives (www.actingarchives.it)
alla voce Paradoxe sur le comédien.
19 È interessante notare che Luigi Riccoboni e Rémond de Sainte-Albine fondando la
recitazione sull’adesione emotiva non escludevano affatto il ricorso, quando necessario, al
16
17
5
�AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
del dibattito, George Henry Lewes ravvisava acutamente una sorta di
irrisolvibile «antinomia», resa in questi termini:
se l’attore perde ogni potere sulla propria arte sotto l’influsso disturbante
dell’emozione, perde anche ogni potere sulla sua arte in proporzione alla sua
insensibilità all’emozione. Se davvero sente, non può recitare; ma non può
recitare se non sente». 20
L’antinomia, appunto, in cui restavano per lungo tempo impantanate senza
troppo costrutto le appassionate schiere degli emozionalisti e degli
antiemozionalisti.
La differenza di attore e personaggio, l’illusione e la regola della quarta
parete
Di ben altra importanza era invece la seconda serie di argomenti contro
l’impiego dell’adesione emotiva esposti nel Paradoxe. Erano basati sulla
differenza tra le condizioni della vita reale e della rappresentazione teatrale.
Già l’ampiezza del palcoscenico e della sala, spiegava Diderot, richiedono
una portata espressiva superiore a quella impiegata negli interni della realtà
quotidiana. La voce o il gesto spontaneamente prodotti dal sentimento
dell’attore che si immerge nelle circostanze immaginarie del dramma (un
colloquio in un salotto borghese, un dialogo sussurrato in segreto) risultano
insufficienti e devono essere sostituiti da una voce e un gesto appositamente
costruiti. Ma ciò che soprattutto rende inutilizzabile l’adesione emotiva è la
differenza che riguarda i personaggi, che sono diversi, osservava Diderot,
dai concreti individui umani: sono creature fantastiche create dall’autore,
«fantasmi immaginari della poesia» o «ippogrifi, con i loro movimenti, il loro
portamento, le loro grida».21
La differenza riguarda sia i personaggi della commedia che quelli della
tragedia. Questi sono dotati di straordinaria potenza e di grandezza, sono
ragionamento e alle risorse tecniche per mettere a punto l’espressività dell’interprete, e
talvolta per rendere a freddo il comportamento del personaggio mediante la semplice
imitazione esteriore. Un solo testo, rimasto praticamente sconosciuto, L’art du comédien di
Tournon de la Chapelle del 1783 (tr. it., introduzione e note di V. De Gregorio Cirillo, L’arte
dell’attore, Napoli, Acting Archives, 2013, www.actingarchives.it (Books), sembra forse
seguire un’impostazione emozionalista «pura». Anche nella bibbia novecentesca della
dottrina emozionalista, Il lavoro dell’attore su se stesso, Stanislavskij dedicava diverse pagine al
«controllo scenico» spiegando che i gesti che vanno bene nella vita quotidiana, a teatro, «con
migliaia di persone», non appaiono abbastanza precisi e completi. Di qui il lungo lavoro
tecnico prescritto dell’attore per rendere i gesti della recitazione adatti alla scena (Il lavoro
dell’attore su se stesso, edizione riveduta e corretta a cura di F. Malcovati, Roma-Bari, Laterza,
2004, pp. 483-490). La polemica antiemozionalista si era insomma fin dagli inizi costruita un
falso bersaglio sul quale si era paradossalmente riconosciuta anche una parte dello
schieramento emozionalista, impegnata a sostenere una tesi (la totale sufficienza
dell’adesione emotiva) che non era mai stata formulata.
20 G. H. Lewes, Gli attori e l’arte della recitazione, tr. it. e cura di Edoardo Giovanni Carlotti,
Milano, Costa e Nolan, 1999, p.110.
21 D. Diderot, Paradosso sull’attore, cit., p. 84.
6
�Claudio Vicentini, Il distacco dell’attore dal personaggio
percorsi da passioni infinitamente più intense di quelle delle persone reali, e
richiedono perciò espressioni smisurate rispetto a quelle prodotte dai
semplici sentimenti umani. I personaggi della commedia, anche se
apparentemente più simili a noi, sono figure tipiche, che condensano in sé i
tratti specifici di un’intera categoria di persone. Devono perciò dotarsi di
espressioni caratteristiche, differenti da quelle dettate dai moti dell’animo
del semplice individuo umano.22
Diderot delineava quindi una teoria della recitazione fondata
sull’imitazione, scandita in un processo che comprendeva precisi passaggi.
L’attore, studiando il testo del dramma, forma nella sua immaginazione la
figura del personaggio. Le indicazioni del testo non sono però sufficienti per
la resa scenica che richiede la definizione di toni, pause, gesti, movimenti e
dettagli d’ogni genere. L’attore ricrea perciò nella propria mente la figura
ricavata dal testo. Nei casi migliori, ad opera dei grandi attori, l’immagine
ricreata può rivelarsi più potente ed efficace di quella fornita dall’autore, nei
casi meno felici, più inerte e scolorita. Comunque, fissata questa immagine
mentale, l’attore la imita con il proprio corpo e la propria voce, studiando e
memorizzando toni, gesti ed espressioni che ripete con la massima
precisione di fronte al pubblico.
Una simile teoria non sfuggiva ovviamente ad alcune obiezioni. Era difficile
pensare che il processo di ricostruzione fantastica del personaggio potesse
svolgersi senza una qualche partecipazione emotiva dell’attore. E poi
l’imitazione del personaggio tramite gesti ed espressioni fisiche non poteva
non comportare una corrispondente reazione interiore dell’interprete. Su
quest’ultima questione Diderot, come si è visto, interveniva appellandosi
alla «volontà di ferro» dell’attore che avrebbe respinto l’affiorare di
un’emozione fittizia. Però la faccenda era di ben altra portata, e destinata a
inaugurare un importante capitolo della teoria della recitazione otto e
novecentesca. A partire da Lessing che com’è noto già nel 1754, sulla
Theatralische Bibliothek ne aveva percepito l’estrema importanza. L’anima,
aveva scritto, «mediante l’impressione ricevuta dai sensi si porrà da sola in
quello stato conforme ai suoi movimenti, atteggiamenti e toni». E aveva poi
ripreso l’argomento nella Hamburgische Dramaturgie, scorgendovi un
presupposto per la definizione di una «grammatica» del linguaggio del
corpo, parte essenziale dello studio della recitazione.23
Ivi, pp. 106-107, 123.
G. E. Lessing, Auszug aus dem ‘Schausplieler’ der Herrn Rémond de Sainte-Slbine, in Theatralische
Bibliothek, I, Berlin, Voss, 1754, p. 249; e Drammaturgia d'Amburgo, tr. it. a cura di P. Chiarini,
Roma, Bulzoni, 1975, pp. 21-23. Il progetto lessinghiano veniva com’è noto realizzato nelle
Ideen zu einer Mimik di J. J. Engel, 2 voll., Berlin, Mylius, 1785-1786. Il naturale riflesso emotivo
provocato dalle espressioni, dai gesti e dagli atteggiamenti del corpo veniva considerato
anche nella trattatistica inglese, nell’Inchiesta sul bello e il sublime di Edmund Burke (tr. it. a cura
di G. Sertoli e G. Miglietta, Palermo, Aesthetica, 2006, pp. 139,140), e negli Elements of
Elocutions di J. Walker (2 vollumi.,London, Printed for the Author, 1781, vol. II, pp. 278-280 e
288-290).
22
23
7
�AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
Ma non meno importanti erano le conseguenze della differenza stabilita da
Diderot tra la concreta umanità dell’attore e l’universalità e la potenza
espressiva del personaggio. L’attore deve rappresentare un essere
profondamente diverso da sé, evitando in particolare l’esibizione dei
prodotti dell’emotività personale, «troppo umani» per la figura del
personaggio. Deve dunque lavorare a freddo, costruendo senza parteciparvi
le espressioni adatte alla parte. Se poi la recitazione è perfetta, spiegava
Diderot, il pubblico si lascerà trarre in inganno e riterrà che le espressioni del
personaggio non siano finte, ma prodotte da sentimenti reali. 24 E qui l’intera
costruzione del Paradoxe finiva con l’inciampare in una singolare
contraddizione. I sentimenti «reali» che il pubblico avverte dietro le
espressioni recitate sono assolutamente identici a quelli che prova un concreto
essere umano, quale è l’attore che le recita, tant’è vero che è difficile sradicare
la convinzione diffusa (contro cui tutto il il Paradoxe è diretto) che sia proprio
il sentimento vivo e presente nell’interprete a produrre le espressioni esibite
al pubblico. Insomma, per quanto la qualità meramente umana
dell’interprete debba essere occultata dietro l’apparenza di un essere
«diverso», e il suo patrimonio emotivo annullato, il prodotto finale della
recitazione apparirebbe agli occhi degli spettatori un impossibile ibrido, in
cui si ritroverebbero strettamente combinati lo scarto (espressivo) e la
sovrapposizione (emotiva) tra essere umano e immagine fantastica, tra attore
e personaggio.
Il tentativo operato da Diderot nel Paradoxe si impigliava così in un
complesso di convinzioni radicate nella cultura teatrale settecentesca. Il
personaggio era concepito – e da Diderot non meno che da tutti gli altri
autori - come una macchina emotiva, diretta a provocare le più immediate e
autentiche reazioni sentimentali dello spettatore. Questa non era sua unica
funzione, ma l’efficacia di ogni altro compito o significato che gli veniva
assegnato appariva proporzionale agli effetti emotivi che la sua figura
riusciva a produrre. Il bombardamento emotivo provocato dalla recitazione
costituiva poi un contributo essenziale all’illusione drammatica, l’effetto per
cui la rappresentazione teatrale doveva indurre lo spettatore ad attribuire
una qualche forma o livello di realtà a ciò che era di fatto una finzione.25 Non
a caso la letteratura teatrale del tempo conservava un ampio repertorio di
aneddoti in cui i risultati estremi dell’illusione drammatica venivano riferiti
alla straordinaria bravura degli attori, in momenti di particolare tensione.
Negli Anecdotes dramatiques Clément e La Porte raccontavano come la Clairon
in una scena dell’Ariane di Thomas Corneille, nella parte della protagonista,
si dovesse dolorosamente tormentare chiedendosi chi mai potesse essere la
sua rivale, e uno spettatore commosso, le lacrime agli occhi, non si fosse
D. Diderot, Paradosso sull’attore, cit., p. 81.
Sull’illusione drammatica e la sua costruzione vedi più avanti, in questo stesso numero di
«Acting Archives Review», le considerazioni dell’articolo di L. Mango, Lo sguardo di Nataša.
L’identità del personaggio come macchina scenica, «Acting Atchives Review», n. 11, maggio 2016,
pp. 16-38.
24
25
8
�Claudio Vicentini, Il distacco dell’attore dal personaggio
trattenuto. Proteso verso di lei, con voce soffocata, l’avvertiva: «è Fedra, è
Fedra!».26 Ma capitava di peggio, come l’incidente descritto da d’Hannetaire,
occorso alla Dumesnil nella parte della scellerata Cleopatra della Rodogune
di Pierre Corneille. Mentre sta per spirare in preda alla rabbia tra orribili
maledizioni viene colpita da un pugno poderoso sferrato «da un vecchio
militare» che esplode: «va cagna, vattene al diavolo!».27
Non possiamo ovviamente sapere se questi episodi fossero realmente
avvenuti o se appartenessero solo alla leggenda. Ciò che importa è però che
fossero coltivati dalla letteratura teatrale settecentesca, che attribuiva loro un
preciso significato. Per Clément e La Porte l’intervento dello spettatore che
avverte la Clairon è un elogio «particolarmente lusinghiero» alla sua arte,
mentre d’Hannetaire aggiunge che la Dumesnil, terminata la
rappresentazione, ringraziava il manesco militare: la sua interpretazione, gli
dichiarava, non avrebbe potuto ricevere elogio migliore.
Ma perché l’illusione drammatica potesse realmente decollare, innescata
dalla capacità emotiva della recitazione, era necessario che la figura scenica
del personaggio coincidesse totalmente con la figura dell’attore in modo che
questo finisse con lo scomparire di fronte agli occhi del pubblico. Era la
convinzione che si affermava in modo perentorio nello sviluppo della
trattatistica settecentesca segnando il definitivo passaggio dalla concezione
«oratoria» alla concezione «drammatica» della recitazione.28 L’errore
caratteristico, che comprometteva la perfetta coincidenza delle due figura
era, ammonivano i trattati dell’epoca, lo spostamento del raggio d’attenzione
dell’attore, che si allontanava dall’azione recitata per dirigersi sul pubblico
in sala. Si moltiplicano così le raccomandazioni: l’attore non deve mai vagare
con lo sguardo sui palchi o la platea, ammiccare, accennare e rivolgersi a
questo o quello spettatore, perché si mostra allora «altro» rispetto al
personaggio. Già nella prima metà del secolo l’insistenza su questo punto
era diventata un luogo comune, costituendo il presupposto su cui verrà
definita la nozione di «quarta parete», introdotta agli inizi dell’ottocento da
Leigh Hunt. In un pezzo dedicato a John Bennister, attore e manager del
Drury Lane, Hunt osservava come questi non sembrasse curarsi
assolutamente degli spettatori. Quando applaudono, scriveva Hunt,
Bannister non si ferma per godersi l’applauso e se non può proseguire nel
dialogo continua nell’azione: il palcoscenico sembra essere «la sua stanza»
di cui il pubblico costituisce «la quarta parete». Il palcoscenico deve essere
appunto considerato «una stanza reale», o un qualsiasi altro ambiente
J. M. Clément e J. de La Porte, Anecdotes dramatiques, 3 vol., Paris, Duchesne, 1775, vol. I, p.
90.
27 J. N. d’Hannetaire, Observations sur l’art du comédien, s.l., Aux dépens d’une société
typographique, 1774, p. 280.
28 Così, ad esempio, l’elogio tributato da Marmontel a Baron, alla voce Déclamation théâtrale
nel quarto volume dell’Encyclopédie. La sua bravura consisteva nell’indurre lo spettatore a
«dimenticare» l’interprete che svaniva nella figura rappresentata. Ma l’affermazione di questo
principio è comunque motivo ricorrente nei trattati dell’epoca.
26
9
�AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
«astratto dalla moltitudine che osserva». Proprio, proseguiva Hunt, come la
stanza in cui adesso sto scrivendo», e un attore che si permette di guardare
il pubblico e apprezzarne visibilmente gli applausi «è ridicolo, come lo sarei
io se guardassi ad ogni momento il riflesso dei miei sorrisi in uno specchio,
o mi inchinassi alle case dall’altra parte della strada».29
Di fronte al complesso di queste convinzioni, incardinato sull’esigenza
dell’illusione drammatica, sulla necessità di produrre emozioni vive e
immediate e sulla richiesta di mantenere una perfetta coincidenza tra la
figura dell’attore e quella del personaggio, teorizzare una differenza
sostanziale tra la realtà umana dell’interprete e quella immaginaria del
personaggio, e poi renderla in una concreta pratica recitativa costituiva, per
Diderot come per qualsiasi altro autore, un compito impossibile.
L’effetto di dislocazione
In una prospettiva assai diversa da quella di Diderot il problema della
irrappresentabilità del personaggio mediante i mezzi espressivi della
recitazione umana si ripresentava nel saggio di Charles Lamb, On Garrick,
and acting; and the plays of Shakespeare, considered with reference to their fitness
to stage, pubblicato su «The Reflector» nel 1811.30 Per Lamb la recitazione
consisteva essenzialmente nell’ impersonare «la passione e i rivolgimenti
della passione», esponendone gli effetti esteriori «agli occhi e agli orecchi
degli spettatori».31 Non gli sembrava un’operazione particolarmente
complicata: «si tratta soltanto», spiegava, «di alzare o abbassare di un tono o
due la voce, di sussultare con aria presaga per annunciare l’approssimarsi
dell’effetto drammatico», e «la finzione di qualsiasi emozione è così
contagiosa che, quali che siano le parole, basteranno l’aspetto e il tono per
renderla accettabile e farla passare per profonda abilità nel rappresentare le
passioni».32 Il carattere delle impressioni visive e uditive ricevute dallo
spettatore è del resto tanto forte e istantaneo da imprimere nel suo animo la
figura rappresentata in un’immagine densa di emozioni che perdura nel
tempo e nella memoria. In questa immagine interprete e personaggio sono
fusi in una forma inscindibile che si iscrive in modo incancellabile nella
mente dello spettatore.
Per chi va spesso a teatro è difficile dissociare l’idea di Amleto dalla persona e
dalla voce del signor K. [Kemble]; parliamo di Lady Macbeth, ma in realtà
L. Hunt, Critical Essays, London, Printed for John Hunt, 1807, pp. 60-61.
C. Lamb, On Garrick, and Acting; and the Plays of Shakespeare, considered with Reference to their
Fitness to Stage, «The Reflector», n. 4, 1811. Il saggio veniva ripubblicato da Lamb con un
nuovo titolo On the Tragedies of Shakespeare, considered with Reference to their Fitness for Stage
Representation nell’edizione delle sue opere, The Works of Charles Lamb in Two Volumes, London,
C. and Jollier, 1818. La traduzione italiana di G. Melchiori, Sulle tragedie di Shakespeare
considerate dal punto di vista della loro possibilità d’essere rappresentate si trova nel primo dei due
volumi curati da G. Baldini, La fortuna di Shakespeare, Milano, Il Saggiatore, 1965.
31 Ivi, p.217, 219.
32 Ivi, p. 222.
29
30
10
�Claudio Vicentini, Il distacco dell’attore dal personaggio
pensiamo alla signor S. [Siddons]. Né questa confusione è commessa soltanto
da persone illetterate […], è anzi un errore dal quale le persone per altro verso
assi colte trovano quasi impossibile liberarsi. 33
Il personaggio creato dall’autore, materializzandosi nella figura concreta e
presente dell’attore, moltiplica dunque la capacità di impatto su quanti ne
vengono a contatto. Ma qui emerge il primo limite della recitazione.
Attraverso gli strumenti dell’espressione fisica possono essere rese solo
poche e semplici passioni, come «l’ira o il dolore». Ciò non appare troppo
importante per il teatro perché «più la passione è rozza e materiale, e più
presa l’attore ha sugli occhi e sull’orecchio del pubblico».34 Impoverisce però
i personaggi che nella configurazione originaria prodotta da un grande
autore, e trasferita nelle più sottili sfumature del testo scritto, possiedono una
superiore profondità di carattere, pensieri e passioni. Nel tessuto verbale del
testo è infatti possibile ritrovare non solo le più elementari passioni provate
dai personaggi, ma anche «le operazioni e i moti interiori» del loro animo»,
il «quando, il perché e il come essi siano commossi», ossia «l’intima struttura»
del loro mondo interiore.35
Materializzandosi nelle capacità espressive dell’attore il personaggio perde
insomma la sua profondità interiore, si spoglia di ogni grandezza e si mostra
come «un uomo nella sua semplice ed evidente forma umana». Re Lear
diventa «un vecchio barcollante sulla scena, scacciato dalle figlie in una notte
di pioggia», una figura che produce nel pubblico la più semplice ed
elementare reazione: «vorremmo offrigli un ricovero e offrirgli aiuto».
Mentre ben altra è la sua autentica dimensione originaria:
La grandezza di Lear non sta nelle sue dimensioni fisiche, ma in quelle
intellettuali […] È la sua mente che viene messa a nudo. La guaina di carne e di
sangue appare troppo insignificante perché ci si possa pensare; ed egli stesso
infatti non la cura. Sulla scena noi non vediamo altro che infermità e debolezze
fisiche, l’impotenza dell’ira; leggendo invece, noi non vediamo Lear, noi siamo
Lear, siamo nella sua mente, siamo sostenuti da una grandezza che sconcerta
la malizia delle figlie e le tempeste; nelle aberrazioni della sua ragione
scopriamo una possente e irregolare capacità di raziocinio, non ridotta a
metodo dagli scopi ordinare della vita, ma che esercita le proprie facoltà al pari
del vento che soffia dove vuole, libero contro la corruzione e gli insulti
dell’umanità.36
Un secondo limite della recitazione risiede nella sua stessa impostazione, per
cui un interprete fisicamente presente deve esibire tutto ciò che fa e dice al
pubblico che l’ascolta e l’osserva. Il che rende il personaggio raffigurato,
quando pronuncia le sue battute, una sorta di «oratore». Ogni sua parola,
moto, affetto per quanto nascosto, solitario o segreto nelle situazioni
Ivi, p. 218.
Ivi, pp. 217, 219.
35 Ivi, pp. 217, 222-223.
36 Ivi, p. 229.
33
34
11
�AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
delineate dal dramma, si spoglia di intimità, e le sue riflessioni, anche
quando sono private e inconfessabili, risultano di fatto dette a qualcuno. I
colloqui amorosi di Romeo e Giulietta, «quella musica dolce e argentina dei
dialoghi notturni degli amanti», la dolcezza «intima e sacra «del colloquio
nuziale fra Otello e Desdemona, tutte «queste cose» per «il difetto intimo
della rappresentazione teatrale», per il fatto di essere esposte a un vasto
pubblico, sono «intorbidate e allontanate dalla lor vera natura». E se «i nove
decimi di quel che Amleto fa» è «un dibattito fra lui e il suo e senso morale,
effusioni delle sue solitarie meditazioni che sfoga ritirandosi negli angoli,
nelle segrete stanze, nelle più recondite parti del palazzo», tutto ciò non può
essere rappresentato dall’attore «che gesticola, che viene a gridarle a un
pubblico, a confidarsi con quattrocento persone alla volta». Il personaggio di
Amleto «patisce» così, «a venir messo in mostra a guisa di pubblico maestro
di scuola per dar lezioni alla folla».37
Sulla scena, dunque, solo i personaggi semplici, superficiali e
immediatamente melodrammatici possono vivere convenientemente,
mentre le figure più profonde, sfumate, ricche, complesse come quelle del
corpus shakespeariano si sviliscono e deturpano: creature dell’immaginario,
destinate a schiudersi solo nella lettura privata e solitaria del testo, risultano
di fatto irrappresentabili.
Il saggio di Lamb poteva indubbiamente apparire un’anacronistica
condanna del teatro, arte dagli strumenti rozzi e approssimativi di fronte alla
più sofisticate possibilità della parola letteraria. Poteva inoltre sembrare
legato alla visione dello stile di recitazione impiegato in quegli anni sulle
scene inglesi, destinato più tardi a trasformarsi assumendo strumenti
espressivi sempre più sofisticati. Ed è questo il rilievo che verso la fine del
secolo gli sarebbe stato mosso da Percy Fitzgerald, curando la raccolta degli
scritti teatrali di Lamb.38 Ma in realtà Lamb conduceva un’operazione teorica
estremamente importante. Muoveva infatti da una concezione decisamente
attardata della recitazione, tipica della visione settecentesca (impersonare
attraverso le facoltà fisiche dell’attore la passione e i rivolgimenti della
passione), mettendo però in discussione due parametri essenziali di questa
visione. Innanzi tutto la pretesa che l’attore potesse (dovesse) scomparire
dietro il personaggio. In ciò Lamb non scorgeva nulla di buono: vi ravvisava
solo un’ingombrante fusione, in cui se le due figure apparivano
indistinguibili, il personaggio si «materializzava» perdendo le sue qualità. E
poi la convinzione che l’attore, fuso nel personaggio, potesse (dovesse)
immergere tutta la sua concentrazione nella situazione drammatica, mentre
di fatto, per la natura stessa della recitazione, la sua intera prestazione era
strutturalmente rivolta al pubblico presente in sala. Nel dimostrare
l’irrappresentabilità dei personaggi shakespeariani ciò che entrava in
Ivi, pp. 219-221.
P. Fitzgerald, A Commentary, in C. Lamb, The Art of the Stage, as set out in Lamb’s Dramatic
Essays, with Commentary by Percy Fitzgerald, London, Remington, 1885, pp. 167-198.
37
38
12
�Claudio Vicentini, Il distacco dell’attore dal personaggio
questione erano insomma i due parametri su cui, per la concezione
settecentesca, si costruiva l’effetto dell’illusione drammatica.
Non era una faccenda da poco. I suoi risultati sarebbero emersi alcuni anni
dopo, favoriti dall’osservazione dello stile recitativo degli migliori interpreti
della comedy of manners, genere, lamentava Lamb, ormai quasi sparito dalle
scene. Si trattava di una recitazione capace di «derealizzare» il personaggio
in modo da disegnarne la figura senza conferirgli la pesante concretezza
dell’individuo umano e conservargli invece la dimensione di «creazione
fantastica» dell’autore.39 Era il caso di John Bannister che nella parte di Ben
in Love for love di Congreve rendeva il personaggio «una deliziosa
apparizione», evitando l’ovvia soluzione di ridurlo a un «uomo reale», la cui
più adeguata collocazione sarebbe, osservava Lamb, «non dietro il sipario»
ma tra il pubblico, «nella prima o seconda galleria».40
Nelle pagine del saggio venivano rilevate due procedure adatte a favorire
l’effetto di derealizzazione. La prima consisteva nel sottolineare il carattere
«recitato» degli atteggiamenti dell’attore, come faceva, ricorda Lamb, Palmer
nell’interpretazione di Joseph Sufarce in The school for scandal. La sua
recitazione evidenziata, con «modi altamente artificiali», neutralizzava la
spiacevole impressione che avrebbe potuto produrre la subdola ipocrisia del
personaggio se le sue azioni e i suoi comportamenti avessero assunto una
più evidente dimensione «reale». Trattata in questo modo, la figura
rappresentata si sottraeva all’immediato giudizio morale dello spettatore,
prestandosi invece senza alcuna difficoltà al suo piacevole divertimento. La
seconda procedura era creare un canale diretto di comunicazione con il
pubblico. L’attore poteva infatti «sdoppiarsi», recitare per gli spettatori
mentre la figura che incarnava parlava agli altri personaggi, e assumere due
voci, «ambedue plausibili», di cui una, «supplementare» e più «decisamente
istrionica» era diretta soltanto al pubblico.41 Per Lamb esistevano insomma
modalità recitative, almeno per i personaggi di un particolare repertorio, in
cui l’efficacia dell’interpretazione dipendeva dalla capacità dell’interprete di
distanziarsi dalla figura rappresentata e di infrangere, nell’atto stesso in cui
faceva agire il personaggio sulla scena, il confine della quarta parete.
Mediante queste due procedure, che lavorano in direzione opposta alle
esigenze dell’illusone drammatica, si ponevano le basi per costruire l’effetto
di dislocazione. E proprio in un saggio successivo, significativamente
Sono le osservazioni esposte in The Old Actors , apparso in tre parti sul «London Magazine»
nel febbraio, aprile e ottobre del 1822. Il saggio veniva successivamente ripreso e pubblicato
da Lamb con tre diversi titoli, On Some of the Old Actors; On the Artificial Comedy of the Last
Century; On the Acting of Munden. Cito da The Works of Charles and Mary Lamb, edited by E. V.
Lucas, vol. II, Elia and the Last Essays of Elia, London, Methuen, 1903.
40 Ivi, pp. 140-141.
41 Ivi, pp. 140, 144-145.
39
13
�AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
intitolato Imperfect dramatic illusion, Lamb procedeva alla loro precisa
definizione.42
L’argomento centrale del saggio era, di nuovo, l’irrappresentabilità di alcuni
personaggi teatrali. Ma si trattava ora di personaggi assai diversi da quelli
del saggio shakespeariano. Irrappresentabile non era più il personaggio
profondo e articolato nei meandri della sua interiorità. Era il personaggio
macchiato da vizi morali, o comunque caratterizzato da atteggiamenti in
grado di provocare il disgusto e la repulsione dello spettatore. Il problema,
in questa chiave, non era nuovo: era stato ripetutamente discusso dai teorici
della scena e appariva difficile da risolvere, soprattutto quando riguardava
qualche perfido malvagio. L’unico rimedio sembrava essere la perizia
dell’autore che organizzava sapientemente il testo per ridurre la carica di
spiacevolezza del personaggio. D’Hannetaire si dichiarava certo che Molière
avesse introdotto Tartuffe solo nel terzo atto perché il pubblico non lo
avrebbe sopportato per tutta la commedia.43 Ducis nell’aggiustare l’Otello di
Shakespeare per la scena francese, dopo aver trasformato Iago in un compito
gentiluomo veneto amico dl Moro, arrangiava la trama in modo che la
scelleratezza dell’infame venisse rivelata agli spettatori solo alla fine, dopo
la morte di Desdemona.44 E via dicendo. Ma in tempi recenti il problema
aveva investito anche la resa attorica e nel 1807 Iffland aveva dedicato alla
questione un apposito saggio sulle pagine dell’«Almanach fürs Theater»
spiegando come dovesse essere recitato il personaggio di Franz Moor dei
Masnadieri di Schiller.45
I personaggi considerati da Lamb non erano certo tanto torbidi e truci. Ma i
termini della questione non cambiavano e per Lamb riguardavano
direttamente gli effetti dell’illusione drammatica. Secondo l’opinione
comune, osservava, un dramma è recitato bene o male in proporzione
all’illusione scenica che viene prodotta. Ma bisogna distinguere fra la
tragedia, in cui il necessario, intenso impatto emotivo è strettamente legato
alla consistenza dell’illusione scenica, e la commedia in cui l’impatto
emotivo viene mediato e orientato dal divertimento che è chiamata a
produrre. E ciò è facilmente dimostrabile. La tristezza, il dispiacere che la
narrazione di un evento doloroso provoca, spiegava Lamb, si dissolvono non
appena si comincia a dubitare del fatto e della sincerità di chi lo racconta: «le
nostre lacrime si rifiutano di scorrere». Quando invece si tratta di un storia
divertente chi ascolta può ridere allegramente anche se dubita o non crede
C. Lamb, Imperfect Dramatic Illusion, «The London Magazine», August 1, 1825; poi
ripubblicato con il titolo Stage Illusion in The Last Essays of Elia, London, Edward Moxon, 1833.
43 D’Hannetaire, Observations sur l’art du comédien, cit., pp. 246
44 Avertissement in Othello ou Le More de Venise, tragédie par le citoyen Ducis, Chez André, Paris
s.d., p. V.
45 A. W. Iffland, Sulla rappresentazione del malvagio e del macchinatore, in Teoria della recitazione,
tr. it., introduzione note di D. Minichiello, Napoli, Acting Archives, 2012, pp. 290-301,
www.actingarchives.it (Books).
42
14
�Claudio Vicentini, Il distacco dell’attore dal personaggio
affatto alla realtà dell’accaduto.46 Perciò mentre la rappresentazione della
tragedia esige una recitazione che tende al massimo livello di illusione
drammatica, la commedia consente una recitazione che la riduce,
derealizzando quando è necessario il personaggio sulla scena. Il che si rivela
quanto mai opportuno quando si tratta di figure odiose, o imbarazzanti,
incisivi esempi di ipocrisia, avarizia e soprattutto di viltà. Derealizzate,
erodono l’emotività repulsiva che ispirerebbero, e presentandosi come figure
immaginarie, creazioni artificiali, possono assumere un aspetto divertente e
piacevole agli occhi dello spettatore.
Per raggiungere questo effetto è però necessaria «un’arte squisita» in cui
l’attore dà prova «della sua più alta abilità».47 La tecnica consiste in
un’operazione, in buona parte nascosta, che agisce sugli spettatori senza che
questi ne divengano pienamente consapevoli. L’attore, con una continua
emissione di sotto-segnali – sguardi e gesti particolari - prodotti anche nei
momenti più accesi dell’interpretazione e sempre eseguendo quello che è
richiesto per rendere esattamente la figura del personaggio, mostra al
pubblico di essere in pieno possesso del suo autocontrollo tecnico e
psicologico, e che dunque tutto quello che fa e dice non è altro che
«recitazione».48 I sotto-segnali non devono mai essere vistosamente espliciti,
non devono mai compromettere la coerenza del profilo delineato, in modo
che lo spettatore possa scorgere nella figura rappresentata ogni preciso
«sintomo» del carattere del personaggio e dei suoi atteggiamenti. Il prodotto
finale, realizzato con gli strumenti del tutto materiali dell’interprete
fisicamente presente, sarà allora un’immagine che alla percezione del
pubblico apparirà perfettamente «somigliante» al reale, ma artificiale e priva
di effettiva realtà. Dunque staccata dalla presenza concretamente umana
dell’attore e «diversa» da lui. E per quanto riguarda l’irrappresentabile
personaggio macchiato da vizi morali, il pubblico resterà pienamente
consapevole che l’attore che lo recita non sarà «neppure la metà» spregevole
quanto la figura che rappresenta.49
C. Lamb, Stage Illusion, in The Works of Charles and Mary Lamb, vol. II, cit., pp. 164-165.
Ivi, p. 163.
48 Ivi, pp. 163-164.
49 Ivi, p. 163.
46
47
15
�
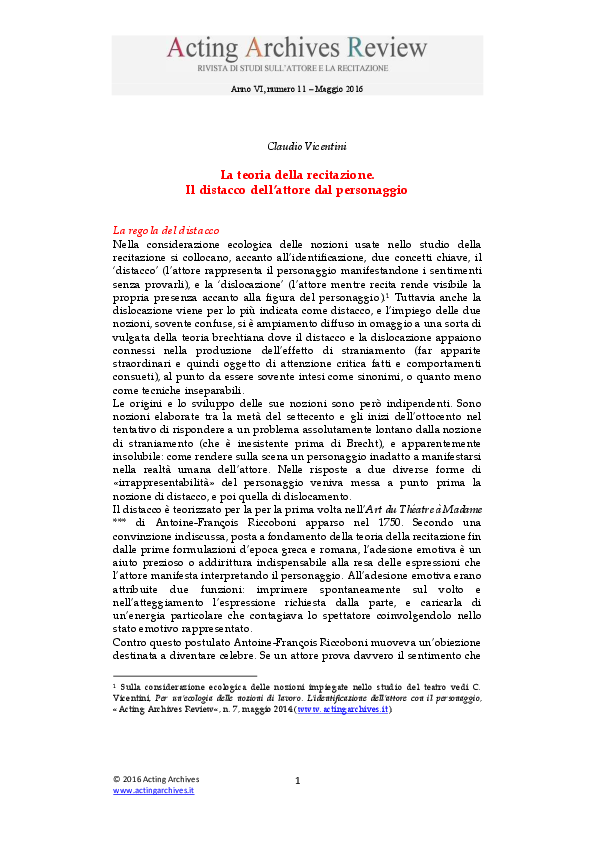
 claudio vicentini
claudio vicentini