Paolo Morando e la caccia di Calabresi agli anarchici in 1969 - il caso di Clara Mazzanti e altri - raccolta di interviste ed altro materiale
Tirate sull’anarchico. Intervista a Paolo Morando 21 MARZO 2020
LEOPOLDO SANTOVINCENZO
È il 25 aprile 1969. Sono le ore 19:03, manca mezz’ora alla chiusura ufficiale della 47esima Fiera Campionaria di Milano alla presenza delle autorità. Al padiglione FIAT, mentre è in corso la proiezione di una serie di diapositive su antichi modelli di automobili, c’è una violenta deflagrazione. Mentre si prestano i primi soccorsi ai numerosi feriti, non gravi, alle 20:40, alla Stazione Centrale, nell’Ufficio Cambi della Banca Nazionale delle Comunicazioni, si susseguono altre tre esplosioni. Molti danni, nessun ferito. Solo poche ore dopo gli inquirenti dell’Ufficio Politico della questura di Milano, diretto da Antonino Allegra, segnalano senza esitazioni la pista anarchica. Nei giorni successivi il commissario Luigi Calabresi procede al fermo e poi all’arresto di alcuni giovani, cani sciolti vicini ai movimenti anarchici. L’inchiesta si conclude con il rinvio a giudizio di otto persone e coinvolgerà, con l’accusa di falsa testimonianza, anche l’editore militante Giangiacomo Feltrinelli. Si apre così un lungo processo nel quale è possibile leggere in filigrana tutte le dinamiche – indagini a senso unico, imputati pre-confezionati, ricorso a infiltrati e falsi testimoni, depistaggi – che torneranno poi nelle drammatiche sequenze della strage di piazza Fontana: come se i fatti di aprile costituissero solo la “prova generale” del disegno eversivo che sarà perfezionato nel dicembre dello stesso anno. Un quadro che emerge in tutta la sua evidenza leggendo Prima di Piazza Fontana. La prova generale edito da Laterza, opera del giornalista trentino Paolo Morando, già autore di alcuni originali saggi che scandagliano la storia recente del paese. Una ricostruzione documentata e serissima di un episodio rimasto quasi in ombra nella pur ricchissima pubblicistica sulla strategia della tensione.
Prima di Piazza Fontana. La prova generale ricostruisce nel dettaglio gli eventi dell’aprile 1969, retrodatando di diversi mesi, dunque, rispetto a Piazza Fontana il grave vulnus della democrazia registrato al tempo nel nostro Paese. Perché questa storia non era stata mai raccontata – non in forma così esaustiva – pur essendo strettamente collegata a quello che accadrà dopo il 12 dicembre e cosa aggiunge alle vicende già note?
Per più ragioni. Primo, perché dal punto di vista giudiziario è stata risolta da tempo: è infatti del 1982 la sentenza di Cassazione che conferma la condanna di Franco Freda e Giovanni Ventura per gli attentati del 25 aprile, per quelli sui treni di agosto e per diversi altri. Secondo, perché da allora l’attenzione si è concentrata sulla strage del 12 dicembre: dal punto di vista della giustizia e, viste le sentenze insoddisfacenti, da quello storico e giornalistico. Terzo, perché tutto ciò che è avvenuto da allora in poi ha ovviamente travolto il resto: appunto la strage, la manovra contro gli anarchici, la morte di Pinelli, una vicenda giudiziaria infinita. Dopo di che, oggi continuo a chiedermi quello che mi chiedevo mentre scrivevo il libro: come è possibile che in cinquant’anni anni nessuno si sia accorto della rilevanza di questa storia? La vicenda del 25 aprile, io credo, aggiunge infatti un tassello importante all’infinita questione di Piazza Fontana. Anzi, illumina un quadro più ampio: in particolare, i modi e i tempi della macchinazione antianarchica, che non nasce all’indomani della strage, ma che era stata già avviata. E che anzi, per attecchire nell’opinione pubblica prima ancora che a livello investigativo, aveva bisogno proprio di un contesto già messo a punto.
L’Ufficio Affari Riservati di Federico Umberto D’Amato (ovvero i servizi segreti interni), con il suo uso spregiudicato delle fonti confidenziali e dei testimoni, appare sulla scena con mesi di anticipo rispetto la presenza, di recente documentata, all’interno dell’Ufficio Politico della questura di Milano nei giorni immediatamente successivi al 12 dicembre. Come e quando è iniziata l’operazione che attraverso i treni e la Fiera di Milano condurrà poi a piazza Fontana?
Formalmente inizia poche ore dopo il secondo attentato del 25 aprile, perché la bomba alla Stazione centrale esplode alle 20:40 e il primo rapporto della polizia, firmato dal capo dell’Ufficio politico della Questura di Milano, Antonino Allegra, è datato ancora 25 aprile. Quindi siamo a prima di mezzanotte. Nella sostanza, però, inizia molto prima. Sono numerosi gli elementi che documentano come l’attività dei giovani anarchici poi incriminati fosse da tempo sotto osservazione, anche attraverso l’utilizzo di infiltrati. In più però, nel mio libro, documento come l’intera operazione sia iniziata molto prima, addirittura nel 1968, quando ad agosto e a dicembre alla Rinascente di Milano vennero rinvenute inesplose due bombe che vennero attribuite agli anarchici. E proprio quelle due bombe, nel primo rapporto di Allegra, vengono messe in connessione con quelle del 25 aprile. Ma una serie di circostanze fin qui mai analizzate, e a cui dedico un intero capitolo, suggerisce che i mancati attentati alla Rinascente fossero di tutt’altra mano: nel migliore dei casi una classica operazione “di seconda linea”, come le chiamava Freda, nel peggiore una manovra ordita proprio dagli Affari Riservati.
Nel libro si parla del “Documento Greco”, apparso sulla stampa estera pochissimi giorni prima della strage di piazza Fontana. Che cosa conteneva questo rapporto e quale funzione doveva avere?
Si tratta di una presunta informativa di un agente segreto greco, di stanza in Italia, al capo della giunta militare di Atene, il colonnello Georgios Papadopoulos, e da questi girato all’ambasciatore greco in Italia Dimitrios Pampuras, con lettera accompagnatoria datata 15 maggio 1969 e firmata dal direttore del ministero degli Esteri Michail Kottakis. Tutto questo arriva nelle mani di un giornalista inglese, Leslie Finer, in formato microfilm, da una fonte coperta appartenente all’ambiente della resistenza moderata al regime dei colonnelli. Il documento è lungo e ricchissimo di elementi impossibili da sintetizzare, ma in sostanza tratteggia un disegno di golpe militare sull’esempio greco da attuare anche in Italia. In più, nella seconda parte intitolata “Azione specifica”, si legge questo: “Le azioni che erano previste per un’epoca anteriore non hanno potuto essere realizzate che il 25 di aprile. La modifica dei nostri piani è stata necessaria perché si è presentata difficoltà per quanto riguarda l’accesso al padiglione della Fiat. Le due azioni hanno avuto un notevole effetto”. Si tratta quindi delle bombe del 25 aprile. La Corte d’assise di Catanzaro, nel primo processo per Piazza Fontana, concluderà che il rapporto è un falso, realizzato probabilmente dai servizi segreti britannici, ma un ottimo falso, perché mescola circostanze effettivamente riscontrabili ad allusioni con più di un fondamento, nel tipico stile dei servizi segreti. Se così fosse, l’obiettivo attraverso la sua pubblicazione era far sapere in Italia che oltre Manica la situazione era seguita, e che non era il caso di esagerare. Comunque sia, tale documento sarà oggetto di un dibattimento giudiziario ben prima del processo di Catanzaro: avviene infatti proprio in quelle per le bombe del 25 aprile, quando Finer viene chiamato a testimoniare.
Nel novembre 1962 la sentenza del processo ai giovani anarchici milanesi che avevano sequestrato a Milano il viceconsole spagnolo Isu Elias riconosceva l’alto valore morale dell’atto condannando gli imputati a pene che andavano dai 20 giorni ai 7 mesi di reclusione. Sette anni dopo gli anarchici diventano belve sanguinarie a cui addebitare propositi stragisti. Cosa è successo in questi sette anni?
Intanto va detto che quel sequestro non fu in alcun modo cruento: fu un’azione dimostrativa unica e irripetibile, che duro pochissimi giorni, messa in atto da un gruppo di giovani senza alcun apparato organizzativo eversivo alle spalle, con l’obiettivo di mobilitare l’attenzione pubblica contro il regime franchista e le condanne a morte che aveva emesso nei confronti di alcuni giovani anarchici. Cosa diversa erano le azioni dei mesi tra il 1968 e il 1969, numerose, con attentati che restavano dimostrativi, dunque senza la possibilità di ferire nessuno e con obiettivi politici precisi e rivendicazioni puntuali, ma sempre di esplosioni si trattava. Questa pratica consolidata, diciamo così, che comunque non era dell’intero movimento anarchico ma di una sua sola parte, forniva un capro espiatorio perfetto a cui addossare la responsabilità di azioni dimostrative che non erano tali: appunto bombe in luoghi pubblici non rivendicate, pensate apposta per seminare il terrore ovunque nella popolazione. Ma più in generale, in quei sette anni, era il quadro politico a essere cambiato, e con esso la società italiana: i governi del centrosinistra, la contestazione giovanile, le lotte operaie… Qualcuno a un certo punto deve aver pensato che era il caso di metterci un freno.
Che profilo avevano gli imputati del processo per le bombe alla Fiera di Milano e che percorsi hanno poi fatto? Sembrano come svaniti nel nulla, la loro voce finora non era stata mai ascoltata…
È così. Nessuno finora aveva mai dato loro voce: lo faccio nell’ultima sezione del libro, con lunghe interviste. In tutti questi anni quei giovani non sono rimasti ai margini del discorso pubblico, non ne hanno proprio mai fatto parte. Il solo Paolo Braschi, negli ultimi anni di vita, ha avuto occasione di riparlare di quella vecchia storia che lo aveva coinvolto, ma in incontri un po’ “underground”, in ambienti anarchici. Paolo Faccioli è da anni apicoltore, anche scrivendone in libri e riviste di settore, e solo lo scorso anno ha pubblicato una autobiografia per un piccolo editore, in cui però la vicenda del 25 aprile è citata come uno tra i tanti elementi della propria vita. Angelo Della Savia vive appartatissimo in Lunigiana, quasi da eremita. Tito Pulsinelli si è da tempo trasferito in Venezuela, pur conservando un profilo militante come commentatore della politica sudamericana, soprattutto in Internet, con taglio “bolivariano”. Giuseppe Norscia è scomparso nel 2006, in Olanda. Mentre la sua compagna di allora, Clara Mazzanti, solo qualche mese fa ha pubblicato un libro bellissimo fin dal titolo, Venga con noi (Colibrì, 2019), in cui racconta la sua odissea giudiziaria. Ne ho curato la prefazione e lo consiglio a tutti. Ecco, il suo caso è quello che rappresenta al meglio la parabola di questi giovani, in qualche modo triturati dalla grande storia e poi gettati al di fuori della grande narrazione pubblica. Con conseguenze personali, in alcuni casi, pesantissime.
Negli atti del processo ricorrono allusioni alla sessualità degli imputati, sempre rappresentata come promiscua o “contronatura”, come se lo stigma di una sessualità non conforme alla morale del tempo si dovesse inevitabilmente sovrapporre con la “devianza” nella pratica politica e viceversa. Cosa ci racconta questa ossessione per il sesso nelle aule giudiziarie italiane del tempo?
Più che nelle aule giudiziarie, direi nei verbali di polizia e nelle sentenze istruttorie. A dibattimento, un giovane pubblico ministero come Antonino Scopelliti e avvocati di grande valore come Giuliano Spazzali fecero piazza pulita di queste, come chiamarle?… propensioni della macchina repressiva. Però sì, il clima era quello. Ne è testimonianza un tragico fatto di cronaca che proprio negli stessi mesi ebbe un’incredibile risonanza: l’uccisione di Ermanno Lavorini e l’incredibile affresco, soprattutto mediatico, della pineta di Viareggio e dei suoi frequentatori. In un clima del genere, suggerire rapporti omosessuali tra i giovani anarchici era mettere altra carne sul fuoco della loro “mostrificazione”, e uso questo termine non a caso, pensando a Pietro Valpreda e naturalmente al film “Sbatti il mostro in prima pagina”, per il quale il regista Marco Bellocchio si ispirò anche alla vicenda delle bombe del 25 aprile.
Fino al film di Marco Tullio Giordana Romanzo di una strage del 2012 il cinema italiano non aveva mai affrontato direttamente Piazza Fontana. Ma la ricostruzione offerta sembra procedere ricorrendo all’equilibrismo ed evocando, per esempio, la discutibile teoria della “doppia bomba”. Più in genere si rileva un approccio cauto e “moderato”. Qual è il nodo oscuro che, anche oggi a distanza di tanti anni, non si può ancora sciogliere pubblicamente?
Il nodo oscuro è evidente: la mano di uomini dello Stato dietro a quella della manovalanza neofascista. È questo il punto su cui non si è mai riusciti a fare piena luce, anche se gli elementi accumulatisi soprattutto negli ultimi anni sono incontrovertibili. Poi, se vogliamo, l’eredità pesante di altre vicende stratificatesi sopra alla strage. E mi riferisco al delitto Calabresi. Nel film di Giordana, le due figure di Giuseppe Pinelli e del commissario Luigi Calabresi sono in qualche modo allineate l’una con l’altra, ognuno con il proprio ruolo (anarchico uno, poliziotto l’altro), entrambi alla fine vittime. Ed è così, entrambi lo sono ed è un punto che non va mai dimenticato. Ma le loro morti, con le rispettive dinamiche e i rispettivi esiti giudiziari, non possono essere accomunate. E non credo che ci sia bisogno di spiegarne il perché. Nelle indagini sulle bombe del 25 aprile, e su tutti i diciotto attentati che vennero attribuiti ai giovani anarchici, l’operato dell’Ufficio politico della Questura di Milano e del commissario Calabresi fu tutt’altro che limpido, e lo si scoprì clamorosamente solo due anni dopo a dibattimento, gettando ulteriori ombre sulla morte di Pinelli. Calabresi compare però personalmente nell’inchiesta, e mi riferisco alla sua presenza durante gli interrogatori dei giovani fermati stando ai verbali, a partire dal pomeriggio di lunedì 28 aprile. Ma già dalla sera del 25 il suo capo Allegra aveva indirizzato tutto verso gli anarchici. Calabresi è dunque un funzionario che riceve un’indicazione da un superiore, che esegue con zelo, anche troppo secondo gli imputati, ma non è il “motore” della macchinazione. Che muove invece da un livello superiore.
“Mezzo secolo dopo credo che finalmente si possa essere liberi di ricordare questi due uomini senza più contrapporli” scrive in un post Mario Calabresi il 15 dicembre scorso, ricordando suo padre Luigi e Giuseppe Pinelli. Il livellamento simbolico operato nel tempo tra due vicende e due storie personali legate tra loro ma molto diverse, appare funzionale anche a un livellamento sul piano storico. Un episodio in un progetto di rimozione del conflitto in atto già da tempo. Quali sono secondo lei gli esiti di questo progetto di rimozione del conflitto oggi in Italia e quali gli antidoti?
L’esito mi sembra palmare: l’annegare vicende complicatissime che hanno segnato la storia del Paese, oltre che tante storie personali in maniera tragica, in un unico grande calderone indistinto. Con il risultato, per esempio, di far sì che una quindicina d’anni fa la maggioranza di un campione di studenti milanesi delle scuole superiori, in un sondaggio sulla loro conoscenza di Piazza Fontana, rispose attribuendo la strage alle Brigate Rosse, con al secondo posto la mafia e con gli anarchici al terzo, addirittura davanti ai fascisti. L’antidoto è uno solo: coltivare la memoria. Anche attraverso i libri. Sulla reale efficacia dell’antidoto, e penso alle cronache quotidiane, per esempio recenti ricerche sul giudizio che gli italiani hanno di Mussolini e del fascismo, sulla loro conoscenza della Shoah, ho purtroppo dubbi sempre maggiori. Ma è uno sforzo che va comunque fatto.
Nella recentissima fiction Io ricordo, Piazza Fontana, trasmessa in prima serata su Rai 1, si raccontano, pur facendo ricorso agli usuali espedienti emotivi, alcune delle responsabilità accertate e delle reticenze che hanno accompagnato l’inchiesta, dai servizi segreti al neofascismo fino allo Stato. Resta invece ancora sfumato il ruolo della polizia che quasi appare incorsa in un errore giudiziario piuttosto che parte attiva, nei limiti delle sue funzioni, di un piano di più ampio respiro politico. Il processo per le bombe alla Fiera di Milano da lei documentato sembra raccontare una storia molto diversa.
Sì. Ed è una storia che non si capisce fino in fondo se prima non si mette un punto fermo, relativo alla gerarchia in cui allora operavano gli Uffici politici, che non rispondevano al questore, bensì direttamente all’Ufficio Affari Riservati del Ministero degli Interni. Allegra, per essere chiari, era un terminale milanese di D’Amato e Russomanno, non era un “dipendente” dei vari Parlato e Guida, i questori che si succedettero a Milano in quel 1969. Questo è un punto fondamentale, peraltro certificato inequivocabilmente dalla ricerca di Gabriele Fuga ed Enrico Maltini sulla morte di Pinelli: tra il 12 e il 16 dicembre, in questura a Milano, comandavano gli Affari riservati, non il questore. Quindi gli ipotetici errori giudiziari della polizia sono da addebitare a chi muoveva i fili, gli Affari Riservati. E dunque parlare di errori giudiziari è del tutto improprio. D’altra parte l’ostinazione appunto degli Affari Riservati nell’imbastire e sostenere la pista anarchica a partire dal 25 aprile e fino a Piazza Fontana, al di là del buon senso e arrivando al punto di costruire false prove, come, per esempio, l’incredibile vicenda dei vetrini nella borsa della bomba inesplosa alla Banca Commerciale, ci indica tutto fuorché la buona fede. E non cito l’interminabile sequela delle prove nascoste o sottratte alla magistratura, perché non finiremmo più.
Il nuovo libro integra il lavoro sulla memoria paese da lei intrapreso con Dancing Days (Laterza, 2009) e proseguito con ’80. L’inizio della barbarie (Laterza, 2016). È una modalità di ricerca originale che riempie i vuoti, rintraccia connessioni più o meno sotterranee o apparentemente marginali all’interno della storia recente del paese, connessioni che illuminano sui percorsi mai casuali attraverso i quali si arriva agli scenari attuali. Il problema italiano della memoria sembra aggravarsi con il tempo lasciando fluire inesattezze e bugie, omettendo, aggiustando… dal suo punto di vista lo ritiene l’effetto di una patologia culturale o di una gestione “politica” della memoria attraverso il lucido controllo della comunicazione e dell’intrattenimento?
Non saprei dire se si tratta di esiti effettivamente perseguiti come tali o se si tratta di eterogenesi dei fini. Il risultato però è quello che ho già detto, cioè nel migliore dei casi l’annacquamento, e gli strumenti sono appunto quelli, le omissioni e gli aggiustamenti. Patologia culturale o lucido disegno? E nel secondo caso, da parte di chi? I “poteri forti”, il “grande vecchio”? Anche i vecchi a un certo punto muoiono, quindi bisognerebbe presupporre quanto meno una staffetta dichiarata, ovviamente occulta. È una tesi affascinante, che ci porterebbe molto lontano. Se vogliamo, potremmo farla partire da Portella della Ginestra, passando per la morte di Enrico Mattei e altre che con quest’ultima sono state messe in connessione, per arrivare alla P2 e a chi davvero la creò, fino a giungere a Silvio Berlusconi, quindi appunto alla sfera che fonde irrimediabilmente in sé la comunicazione e l’intrattenimento, una sfera in cui l’informazione è appunto annacquata. E poi eccoci ai giorni nostri della disintermediazione, dell’uno vale uno, dell’agorà dei social che tutto livella. Ma siamo in Italia, non dimentichiamolo. Siamo un popolo che sa essere cinico e furbo, ma siamo anche un popolo di grandissimi cialtroni. Ipotizzare l’esistenza di un “grande vecchio” appaga la sete di senso, e pensando a tutto quello che è accaduto e accade in questo sciagurato Paese ce n’è un gran bisogno, ma può anche essere altamente deresponsabilizzante. Detto questo, l’unica cosa da fare è aprire bene gli occhi e guardarsi attorno: anche i “grandi vecchi”, specie se italiani, quindi anche loro un po’ cialtroni, qualche traccia la lasciano sempre.
Clara Mazzanti
VENGA CON NOI
DAGLI ATTENTATI DEL ’69 A PIAZZA FONTANA
2019, 312 pagine, 14 euro
formato 16x24 cm, copertina a colori con alette
isbn 978-88-9726-61-3
L’autrice esorta affermando che la frase che più la fa inorridire è
“Ho fiducia nella giustizia”
frase che ogni giorno sentiamo e leggiamo su tutti i media.
Nell’aprile 1969, Clara Mazzanti viene prelevata dalla casa e portata all’Ufficio Politico della Questura di Milano dove viene interrogata dal Commissario Calabresi e dalla sua squadra. Nel novembre 1969, viene arrestata e rinchiusa nel carcere milanese di San Vittore con il suo compagno, Giuseppe Norscia. La chiave che gira nella serratura della cella segna l’inizio del racconto autobiografico, incentrato sulla tragedia di chi si trova a passare, da innocente, 18 mesi della propria vita in carcere. L’illusione che si fosse trattato di un equivoco si dissolve velocemente.
Viene processata per strage come possibile esecutrice di uno degli attentati dinamitardi avvenuti nel 1969. Il processo vede incriminati, a diverso titolo, ma tutti per strage, Norscia, gli anarchici Tito Pulsinelli, Paolo Braschi, Paolo Faccioli e Angelo Pietro Della Savia; Giangiacomo Feltrinelli e la moglie Sibilla Melega sono accusati di falsa testimonianza.
I personaggi di questa storia sono tanti, il giudice Antonio Amati (ritratto in copertina) è il consigliere istruttore dell’inchiesta, Antonino Scopelliti è il pubblico ministero (morirà per mano della mafia nel 1991), Enzo Tortora il giornalista che segue più da vicino le vicende di Clara Mazzanti (resterà incredibilmente vittima di un analogo tritacarne giudiziario) e tanti altri.
Nella sezione femminile del carcere di San Vittore Clara prende gradualmente coscienza delle dinamiche e della condizione delle detenute, documentando un’epoca che precede le prime vere cronache sulle donne carcerate e ci rende partecipi, oltre che del suo calvario, di uno spaccato della società e dei costumi dell’Italia degli anni ’50 e ’60.
Clara Mazzanti aveva ventidue anni quando fu prelevata all’improvviso dalla polizia a casa sua a Viareggio (da quell’episodio nasce il titolo, perché le fu proprio detto Venga con noi), insieme al suo compagno Giuseppe Norscia, senza nessuna giustificazione, senza nessuna accusa formalizzata, per essere trasferita a Milano, all’inizio addirittura in isolamento nel carcere di San Vittore, trattata da criminale bombarola. Fu infatti accusata di strage.
Ventidue anni. E’ davvero difficile immaginare come possa aver vissuto quell’esperienza una ragazza di provincia che si trova all’improvviso proiettata in una situazione assurda e dolorosa, assurta alle cronache dei giornali nazionali e dei telegiornali, additata come colpevole fin da subito, privata della propria libertà e della propria dignità. Ma l’autrice ci aiuta proprio in questo: grazie alla sua testimonianza – vividissima nonostante, o forse proprio grazie agli anni e i decenni in cui ha tentato di metabolizzare la propria esperienza – ci conduce in quelle che furono le sue percezioni, i suoi sentimenti, il suo travaglio interiore.
Forse è proprio questo approccio quel che fa di questo libro una lettura speciale: a differenza di tanti altri testi che concentrano l’attenzione sulle manovre politiche, sul contesto socio-culturale, sui depistaggi e sui giochi di potere che attanagliarono l’Italia nella cosiddetta strategia della tensione, la Mazzanti ci conduce per mano lungo la sua esperienza umana. Una sorta di testimonianza dall’interno. Dall’arresto, ai diciotto mesi in carcere, ai rapporti con se stessa e i propri pensieri, ma anche con le coinquiline della sezione femminile di San Vittore, le guardie, le suore carcerarie, i magistrati, i poliziotti, gli avvocati, i coimputati, fino al processo: evento in cui la tensione si fa massima, ma che sfocerà poi finalmente, dopo questi mesi che appaiono proprio lunghissimi e indelebili, nell’assoluzione. Già. Dopo tutto, Clara Mazzanti era innocente. Era stata arrestata, imprigionata e processata sulla base di indizi e testimonianze praticamente inesistenti che furono infatti smontate una per una durante il processo.
Cinquant’anni vissuti con questo tarlo in testa che continua a scavare, senza alcuna possibilità di lasciarsi quel tragico passato alle spalle e voltare decisamente pagina. Racconta la Mazzanti di come ricucire quelle due parti della sua vita, quel prima e quel dopo separati dai diciotto mesi di ingiusto carcere, non le sia mai riuscito, nonostante il passare del tempo (oggi ha settantadue anni). Racconta in modo molto efficace di come abbia provato a riattaccare, riincollare quei due lembi della sua vita…
Ma sotto quell’incollatura approssimativa, ci sarà, per tutto il tempo che mi resta da vivere, una voragine o più ancora un pozzo senza fondo e senza fine di emozioni, di sofferenze, di disperazione, di annichilimento, di spersonalizzazione, di sradicamento, di speranze, di illusioni, di lacrime.
Si possono grossolanamente identificare quattro sezioni progressive nel testo: L’arresto e l’arrivo in carcere; l’esistenza carceraria; il processo; il dopo. Un dopo nel quale non riuscirà mai a staccarsi di dosso l’etichetta di “carcerata” che le rimarrà appiccicata addosso per sempre e che continuerà a condizionare il suo rapporto con gli altri, specialmente nel suo paese, Altopascio. Sono tutte incalzantemente godibili per il lettore, queste sezioni del libro. Ma alla fine della lettura rimane un attaccamento particolare a quei capitoli in cui l’autrice descrive l’esistenza carceraria. Sia come osservazione di quel che le succede attorno che come spietato resoconto delle proprie intime sensazioni.
Dopo l’iniziale rifiuto di tutto e di tutti, la Mazzanti comincia ad aprirsi a chi le sta intorno, a comunicare, a conoscere le storie di chi si trova a condividere quegli spazi angusti. Un ritratto delle condizioni carcerarie lucido e agghiacciante.
Nello spesso dolore di una cella, nel tetro odore di muffa, mentre il vento della morte entra nell’animo a togliere anche l’ultima volontà di respiro, in quella condizione di assoluta frustrazione, ecco risuonare un toc toc, tanto ovattato quanto consolatore. Non ci vuole molta fantasia. E si chiama umana solidarietà. Uno sputo di umana solidarietà, ma pur sempre un appiglio, cui aggrapparsi per non morire.
Ci sono pochi, pochissimi momenti in cui l’autrice riserva parole di gratitudine, di affetto o di simpatia per alcuni personaggi positivi della sua storia. Ci sono le suore del carcere, oppure il Pubblico Ministero del processo, quell’Antonino Scopelliti che, pur rappresentando la pubblica accusa, fu il principale artefice dell’assoluzione di quasi tutti gli imputati, anche in ragione della vacuità della fase istruttoria. O Enzo Tortora, allora giornalista della Nazione di Firenze, incaricato di seguire il processo e poi, anni dopo, vittima a sua volta di una ingiusta carcerazione. Ma anche Giuseppe Norscia, suo compagno di allora e padre di suo figlio. Nonostante quella storia sia poi finita, Clara Mazzanti non manca mai di rievocare con affetto quell’amore osteggiato praticamente da tutti: dal padre di lei, dal pensare comune (il Norscia era sposato e a quei tempi non c’era ancora il divorzio) e anche dagli inquirenti che usarono quella relazione immorale per tratteggiare un ritratto negativo dell’imputata.
Parole aspre ed amare, invece, per il giudice istruttore Antonio Amati e per il commissario Luigi Calabresi, fra i principali artefici della sua tragica vicenda.
Cinquant’anni passati a ripensare, rielaborare, poi più recentemente a cercare di ricostruire quel che accadde e perché. Si percepisce chiaramente dalla lettura come durante questi cinquant’anni ogni singola esperienza, ogni lettura, ogni incontro, ogni stimolo esterno abbiano quasi automaticamente rievocato quell’esperienza in carcere da innocente. Il libro è costellato di citazioni di tutti i generi: romanzi gialli, poesie, canzoni, testi di filosofia… Quasi che in quella frase o in quel verso poetico incontrati lungo la propria esistenza la Mazzanti non abbia potuto fare a meno di trovare un preciso riferimento a ciò che ha vissuto.
E’ una lettura angosciante ed appassionante al tempo stesso. Avvincente ed avvilente. Ma soprattutto questo libro lo si legge con piacere perché si tratta di una scrittura di qualità. Per sua stessa ammissione, l’autrice ha dovuto rivedere, ripensare, limare e correggere le varie versioni precedenti del suo resoconto con l’aiuto del figlio. Per smorzarne i toni rabbiosi e rancorosi, per rendere finalmente la sua storia una lettura pienamente godibile. E così è stato: quelle revisioni hanno prodotto un libro davvero di alta qualità. E nel leggere questa prosa scorrevole e piacevole (nonostante i temi trattati) e le tante citazioni di cui è costellata, è sorto in mente quasi dal nulla un esametro (dopo tutto la Mazzanti ha una formazione liceale classica) dedicato alla sua scrittura: Liquida, lucida, limpida: dotta senza presunzione.
https://enezvaz.wordpress.com/2019/12/12/venga-con-noi-clara-mazzanti-incarcerata-innocente-a-ventidue-anni-cinquantanni-dopo-racconta/
CONTRO GLI ANARCHICI. UNA STORIA ITALIANA LUNGA E ATTUALE.
di minima&moralia pubblicato venerdì, 19 Marzo 2021 · 1 Commento
di Paolo Morando
La polizia l’aveva chiamata “Operazione Renata” e in rete se trovano ampie tracce, soprattutto consultando siti di ambiente anarchico. Nel febbraio 2019 furono sette a finire in carcere, appunto sette anarchici, cinque uomini e due donne tra i 28 e i 45 anni. L’accusa mossa loro dalla Procura di Trento era pesantissima: associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, con la contestazione di una mezza dozzina di episodi, tra i quali il danneggiamento del laboratorio di matematica industriale e crittografia dell’Università di Trento, l’attentato fallito a nove veicoli della polizia locale (attraverso molotov che però non esplosero) e la collocazione di due ordigni (anche qui uno fece cilecca) nei pressi della sede della Lega ad Ala, sempre in Trentino. Alla fine di quel 2019, a dicembre, la sentenza di primo grado sconfessò l’impostazione della Procura che, se accolta, avrebbe comportato pene fino a una dozzina di anni di carcere a testa. Ci fu anche un’assoluzione, mentre le sei condanne arrivarono per aver prodotto documenti falsi (2 anni ad altrettanti imputati, una pena di poco inferiore a un terzo) e, soprattutto, per due soli degli episodi contestati: 2 anni e 6 mesi per danneggiamento e violazione della legge sulle armi a un imputato, 1 anno e 10 mesi agli ultimi due, per un unico episodio (quello alla sede della Lega). La Procura ricorse però in appello, dove il procuratore generale tornò a sostenere l’aggravante della finalità eversiva con conseguente ricalcolo delle pene e condanne complessive per circa 25 anni di carcere. La sentenza, emessa tre settimane fa, ha nuovamente sconfessato l’accusa, limitandosi a confermare il verdetto di primo grado, con solo lievi rialzi di pochi mesi di pena nei confronti di due imputati.
Senza rifare qui la storia del procedimento giudiziario, o delle numerose manifestazioni anarchiche che in Trentino per mesi l’hanno punteggiato (e con ampia copertura militante nel web), è una vicenda che dice molto dell’incrollabile vocazione italiana a dargli addosso agli anarchici: una vocazione che precede addirittura la vicenda di Piazza Fontana, di Valpreda, di Pinelli, che proprio nei giorni della prima sentenza trentina viveva il proprio cinquantesimo anniversario. La precede perché risalgono all’aprile e maggio del 1969 gli arresti di cinque anarchici, tre dei quali giovanissimi (Paolo Braschi, Angelo Della Savia, Paolo Faccioli), per le bombe milanesi del 25 aprile appunto del ’69 alla Fiera campionaria e alla Stazione centrale, la prima delle quali provocò una ventina di feriti, fortunatamente lievi: la strage, dunque, sarebbe potuta avvenire diversi mesi prima del 12 dicembre. Altri tre arresti seguirono fra agosto e novembre (Tito Pulsinelli, Giuseppe Norscia, Clara Mazzanti), così come due scarcerazioni: riguardarono i primi due anarchici arrestati, Giovanni Corradini ed Eliane Vincileoni, una coppia di intellettuali milanesi ritenuti i vertici della cellula eversiva, che vennero poi addirittura prosciolti in istruttoria. Con la surreale conseguenza di un processo ai sei giovani rimasti in carcere, nel frattempo divenuti imputati, accusati di aver messo in piedi un’associazione sovversiva i cui presunti capi erano però già usciti dal processo. Non solo: di quei 18 episodi terroristici, avvenuti soprattutto a Milano tra il 1968 e il ’69 (ma anche a Roma, Torino, Genova, Padova, Livorno e alla base Usa di Camp Darby), ben 12 erano rubricati come stragi, benché non avessero provocato alcun ferito: il codice penale, infatti, se viene provata la volontà di uccidere prevede comunque tale reato. E con esso la pena dell’ergastolo. Curiosamente, tra quei 12, non figurava quello alla Fiera di Milano: l’unico che aveva fatto scorrere sangue. Una bomba che era stata collocata nello stand della Fiat personalmente da Franco Freda: la prima della lunga catena di terrore neofascista che avrebbe portato a Piazza Fontana.
Perché rievocare oggi questa lontana vicenda? Intanto, perché tra pochi giorni scoccherà un altro cinquantesimo anniversario: quello dell’apertura, davanti alla Corte d’assise di Milano, del processo che vide alla sbarra i sei giovani anarchici. Iniziò il 22 marzo 1971, un lunedì, e tra gli accusati (ma a piede libero, oltre che in contumacia) figuravano anche l’editore Giangiacomo Feltrinelli e la moglie Sibilla Melega, per il reato di falsa testimonianza in favore di Della Savia e Faccioli (che erano con loro la sera del 25 aprile), dopo però che l’Ufficio politico della Questura di Milano le aveva provate tutte per indicarli come i “burattinai” dei giovani anarchici. Cioè i mandanti e i finanziatori degli attentati. Il vero motivo è però più immediatamente percepibile: cioè l’assoluta similitudine dei due procedimenti giudiziari, con accuse pesantissime regolarmente crollate a dibattimento. La sentenza milanese arrivò il 28 maggio, dopo oltre due mesi di udienze una più clamorosa dell’altra. Tra i testimoni sfilarono infatti un po’ tutti i protagonisti della vicenda di Piazza Fontana (oltre che della morte di Pinelli): il commissario Calabresi, il suo capo Allegra, il suo sottoposto Panessa, la vedova Pinelli, naturalmente Valpreda, addirittura Sottosanti, cioè quel “Nino il fascista” a lungo indicato come il presunto sosia di Valpreda che salì sul taxi di Rolandi per essere portato davanti alla Banca Nazionale dell’Agricoltura quel maledetto venerdì pomeriggio. E poi la leggendaria Rosemma Zublena, la “supertestimone” che, si scoprì in aula, aveva un passato di calunniatrice seriale.
Alla fine il pubblico ministero Scopelliti, che molti anni dopo verrà ucciso dalla mafia, chiese alla Corte una raffica di soluzioni. E le ottenne. Assolti Pulsinelli, Norscia, Mazzanti, Feltrinelli, Melega, assolti pure Della Savia e Faccioli per le bombe del 25 aprile, da cui tutto era partito, e per un’altra decina (e con loro anche Braschi). Chiese anche delle condanne, Scopelliti, e ottenne pure quelle: pene minori per Braschi, Della Savia e Faccioli, ritenuti colpevoli di due attentati il primo e quattro il secondo, il terzo invece solo di porto di esplosivo (ma nel suo caso i giudici propenderanno invece per il concorso in uno degli attentati romani). Tutte pene più che dimezzate in Appello e poi confermate in Cassazione. Al netto dell’ultimo grado di giudizio, che ancora manca, il processo trentino sembra una fotocopia di quello milanese di mezzo secolo fa. Con tutto ciò che ne ha costituito l’abbrivio, a partire dalla spettacolarizzazione degli arresti e dalla grancassa mediatica. Certo, gli anarco-insurrezionalisti dei giorni nostri ci avranno messo un po’ del loro, come peraltro i loro compagni oggi ultrasettantenni, ma il riflesso condizionato c’è tutto, temprato evidentemente da una pratica di lunga data: incriminazioni su larga scala non in grado di reggere a dibattimento. Se per insufficienze investigative o per forzature ideologiche, ecco, quello valutatelo voi.
https://www.minimaetmoralia.it/wp/altro/contro-gli-anarchici-una-storia-italiana-lunga-e-attuale/#comment-2011638
Intervista con Clara Mazzanti, autrice del libro ‘Venga con noi’ e finalista del concorso Un Certain Regard – Mediolanum
Ottobre 9, 2020 wp_1410866 0 commenti
Expo Magazine incontra Clara Mazzanti, autrice del romanzo autobiografico “Venga con noi”, finalista e vincitrice del terzo posto in classifica del concorso Un Certain Regard, Mediolanum.
A proposito di ‘Venga con noi’. Il libro narra in modo appassionante e rivelatorio le vicende giudiziarie di una giovane ragazza di 22 anni, arrestata e processata per strage come possibile esecutrice di uno dei noti
attentati del 1969, per cui fu erroneamente seguita la pista anarchica. Detenuta in carcere per 18 mesi prima di essere riconosciuta innocente, Clara Mazzanti, ben 50 anni dopo ha trovato il coraggio di raccontare i personaggi e le personalità coinvolte nella vicenda oltre ad aprire una importante finestra sul mondo della carcerazione femminile negli anni ’70 che documenta con dettaglio di cronaca. Un libro coinvolgente, capace di raccontare con schiettezza un periodo storico essenziale dell’Italia moderna.
Il libro è alla sua Seconda Edizione.
A proposito di “Venga con noi”, che cosa l’ha spinta a voler raccontare un’esperienza personale così intima e difficile?
Due ragioni mi hanno spinto a raccontare la vicenda narrata nel libro. La prima è stata la necessità di liberarmi di un fardello che portavo da 50 anni: per mezzo secolo ho cercato di occultare la vicenda che mi aveva visto protagonista, per la vergogna e per le difficoltà che poteva crearmi nel paese in cui vivevo. Una volta uscita dal mondo del lavoro, ho potuto vuotare il sacco. La seconda è stata la necessità di dare la mia versione dei fatti, corroborata da documenti e testimonianze. La vicenda, infatti, destò un clamore enorme all’epoca, ma fu quasi dimenticata dopo Piazza Fontana, pur costituendo un importantissimo tassello della storia degli anni del terrore in Italia.
Che cosa ha provato al momento dell’arresto?
Durante il fermo nella Questura di Milano e l’interrogatorio da parte della squadra del Commissario Calabresi, che precedettero di qualche mese l’arresto, provai dapprima inquietudine e poi paura, indotta dall’atmosfera che si respirava in quegli uffici, dai rumori, dalle voci, dagli urli di altri fermati. Al momento dell’arresto vero e proprio, senza conoscerne il motivo, provai incredulità e sgomento, perché pensavo di aver già chiarito la mia posizione, rispondendo a tutte le domande degli inquirenti in modo esauriente, benché fossi molto spaventata. Quando seppi, già in carcere, che ero accusata di strage provai terrore, perché la pena prevista era l’ergastolo. Senza considerare che negli stessi uffici della questura dov’ero stata interrogata morì, in maniera non accidentale, l’anarchico Pino Pinelli, come narra anche Dario Fo.
Può raccontarci, se dovesse sintetizzare in due parole, l’atmosfera generale del carcere?
Assolutamente disumana. Anche se molti si soffermano sulla parte relativa agli attentati e alla strategia del terrore, quella del libro è la prima testimonianza diretta sulle condizioni delle detenute in un carcere femminile italiano tra la fine degli anni ’60 e gli inizi degli anni ’70.
Delle personalità che ha incontrato quale l’ha più coinvolta?
Impossibile citarne solo una. In senso letterale, chi mi ha coinvolto nella vicenda, senza alcun fondamento oggettivo, ma solo sulla base delle farneticazioni di una superteste mitomane, fu il giudice istruttore Antonio Amati, guidato da cieco pregiudizio e non solo. Riguardo al carcere, conservo un ricordo significativo soprattutto delle suore di Carità, in particolare di Suor Giulia, che riuscì a penetrare nel mio cuore e nella mia mente, pur essendo io atea. Tra le carcerate la personalità di spicco, cui era assegnato un ruolo importante, che la distingueva tra le altre, era una ‘vedova nera’ che aveva ucciso il marito, con l’aiuto del giovane amante, in maniera così grottesca da finire su tutte le cronache dell’epoca. Con lei ebbi una feroce discussione poco dopo essere entrata in carcere. Dal punto di vista processuale, conservo un ricordo indelebile del Pubblico Ministero, che rappresentava l’accusa, il Dott. Antonino Scopelliti. A lui va il merito di aver compreso l’intricata situazione e di aver messo in atto, paradossalmente, la migliore difesa possibile. Dal punto di vista personale, il giornalista Enzo Tortora, inviato del quotidiano “La Nazione”, che cambiò idea durante il processo e non ebbe timore a scriverlo. Da lui fui invitata a cena la sera stessa della scarcerazione. Accomunati, questi gli ultimi due, da una tragica fine, l’uno ucciso per mano di mafia e l’altro ucciso per mano di malagiustizia. Importantissimo non dimenticare Pietro Valpreda, testimone al mio processo, incarcerato innocente per la strage di Piazza Fontana.
Può raccontarci il ‘lato umano’ che si instaura fra le carcerate?
Purtroppo, non ho trovato un lato umano in senso stretto. Ho trovato, fra le carcerate, una solidarietà opportunistica e di convenienza, dettata dalla necessità di sopravvivere in quelle pessime condizioni di cattività. Queste condizioni, nella sostanza, non sono cambiate.
Oggi, qual è la sua opinione sulla giustizia italiana?
La esprimo così nel libro, in epigrafe:
“ a tutti coloro che almeno una volta nella vita hanno pronunciato le parole «ho fiducia nella giustizia», augurando loro di non doverla provare mai, questa giustizia”
Dalla quarta di copertina del libro Venga con noi
Aprile 1969, Clara Mazzanti, ventidue anni, viene prelevata dalla casa
dove viveva, a Viareggio, portata all’Ufficio Politico della Questura di
Milano e interrogata dal Commissario Calabresi e dalla sua squadra.
Novembre 1969, viene arrestata e rinchiusa nel carcere milanese di
San Vittore con il suo compagno, Giuseppe Norscia. La chiave che
gira nella serratura della cella segna l’inizio del racconto autobiografico,
incentrato sulla tragedia di chi si trova a passare, da innocente, 18
mesi della propria vita in carcere. L’illusione che si fosse trattato di un
equivoco si dissolve velocemente.
Viene processata per strage come possibile esecutrice di uno degli
attentati dinamitardi avvenuti nel 1969. Il processo vede incriminati,
a diverso titolo, ma tutti per strage, Norscia, gli anarchici Tito
Pulsinelli, Paolo Braschi, Paolo Faccioli e Angelo Pietro Della
Savia; Giangiacomo Feltrinelli e la moglie Sibilla Melega sono
accusati di falsa testimonianza.
I personaggi di questa storia sono tanti, il giudice Antonio Amati
(ritratto in copertina) è il consigliere istruttore dell’inchiesta,
Antonino Scopelliti è il pubblico ministero (morirà per mano della
mafia nel 1991), Enzo Tortora il giornalista che segue più da vicino
le vicende di Clara Mazzanti (resterà incredibilmente vittima di
un analogo tritacarne giudiziario) e tanti altri.
Nella sezione femminile del carcere di San Vittore Clara prende gradualmente
coscienza delle dinamiche e della condizione delle detenute,
documentando un’epoca che precede le prime vere cronache
sulle donne carcerate e ci rende partecipi, oltre che del suo calvario, di
uno spaccato della società e dei costumi dell’Italia degli anni ’50 e ’60.
Clara Mazzanti è nata nel 1947 ad Altopascio, comune della provincia di Lucca, in cui vive. Si è diplomata al liceo classico Machiavelli di Lucca, iscrivendosi poi alla facoltà di Lettere Classiche a Firenze.
La studentessa Clara verrà travolta da una vicenda giudiziaria di rilevanza nazionale e non solo.
In questo suo lavoro ha trovato il coraggio di, come lei è solita dire, “sputare il rospo”, dopo una vita passata cercando di nascondere i suoi trascorsi e tentare, inutilmente, di rimuoverli.
La stesura di questo libro è stata un’impresa dura, costata dieci anni di ricerche, di centinaia di documenti e fonti da esaminare, di appunti, di ricordi ormai avvolti dalla crosta del tempo, da districare, liberare e reinterpretare per metterli finalmente nero su bianco. Cinquant’anni dopo
Gli anarchici imputati per gli attentati del 25 aprile 1969 al processo 1970. Da sin. Paolo Braschi, Paolo Faccioli, Tito Pulsinelli, Angelo Piero Della Savia, Giuseppe Norscia e Clara Mazzanti
https://www.expomagazine.eu/2020/10/09/intervista-con-clara-mazzanti-autrice-del-libro-venga-con-noi-e-finalista-del-concorso-un-certain-regard-mediolanum/
segnalo anche
Eliane Corradini anarchiste milanaise -- video 18 déc. 1969 2289 vues 15min 19s
Suite aux sanglants attentats à Milan et à Rome le 12 décembre dernier, interviews d’Ernesto TRECCANI, peintre militant communiste, d’Enzo LEONI, secrétaire du parti néo-fascite Le Mouvement Social Italien, et d’Eliane CORRADINI, anarchiste milanaise.
https://www.ina.fr/video/CAF86015458/eliane-corradini-anarchiste-milanaise-video.html �
Paolo Faccioli «Quando Calabresi mi accusava di strage» di Paolo Morando
TRENTO 7 maggio 2012
Ha 19 anni, quando lo arrestano a Pisa il 27 aprile del 1969. L’accusa gli viene formalizzata solo nei giorni successivi a Milano, durante gli interrogatori della polizia. Ed è pesante: far parte di un’organizzazione terroristica responsabile di decine di attentati, in pratica tutti quelli che allora si registrano da mesi un po’ in tutta Italia. Una sequenza di botti che culmina proprio nel capoluogo lombardo il 25 aprile del ’69: una data che già avrebbe dovuto suscitare negli inquirenti qualche dubbio sulla matrice anarchica degli ordigni. Perché lui, il giovane bolzanino, è appunto un anarchico. Le bombe milanesi esplodono nel giorno del 24° anniversario della Liberazione: la prima alla Fiera campionaria, il pomeriggio al padiglione della Fiat, la seconda alla Stazione centrale, la sera all’Ufficio cambi. Totale: una ventina di feriti lievi. Con il bolzanino vengono fermati altri anarchici, una quindicina: quasi tutti subito rilasciati, tranne Paolo Braschi, Angelo Piero Della Savia e Tito Pulsinelli, poco più che ventenni. Qualche anno in più lo hanno invece l’architetto Giovanni Corradini e la moglie Eliane Vincileone (traduttrice di Bakunin), indicati come i leader del gruppetto ma poi prosciolti in istruttoria. Finiranno tutti a processo quasi due anni dopo, con l’accusa di strage (per il codice penale il reato è infatti tale anche senza morti) assieme a due giovani comunisti, Giuseppe Norscia e Clara Mazzanti: «Era una coppietta toscana emigrata a Milano, il loro unico torto era l’amicizia con Braschi…», ricorda oggi, che di anni ne ha 63. E tutti alla fine assolti, almeno per le bombe milanesi del 25 aprile.
Rievocare oggi quella vicenda significa raccontare dove affonda le radici un bel pezzo di storia d’Italia. Pochi mesi più tardi, il 12 dicembre 1969, la strage di piazza Fontana apre un libro a cui manca ancora il finale: quello dell’elenco dei colpevoli. Tre giorni dopo l’attentato, la morte dell’anarchico Giuseppe Pinelli, caduto (suicida? spinto? malore attivo?) da una finestra del quarto piano della Questura di Milano, dove si trovava da oltre 72 ore in violazione delle norme sullo stato di fermo. E ancora l’incriminazione di un altro anarchico, Pietro Valpreda. Altri tre anni e, nel maggio ’72, l’assassinio di chi stava interrogando Pinelli, il commissario Luigi Calabresi: tre anni in cui il funzionario finisce nel tritacarne della campagna stampa di Lotta Continua. Piazza Fontana, Pinelli, Valpreda, strage di Stato e giustizia negata: anche da qui, hanno raccontato tanti brigatisti, prese le mosse il terrorismo di sinistra. Un salto all’estate dell’88 ed ecco l’arresto del leader di Lc Adriano Sofri, di Giorgio Pietrostefani e di Ovidio Bompressi, accusati dall’ex compagno Antonio Marino della morte di Calabresi. Poi un processo dall’iter sterminato, un unicum nella storia giudiziaria italiana, conclusosi con condanne definitive. E un dibattito che continua.
Nel corso degli anni, a prescindere dalle sentenze, il profilo di Calabresi è stato “riabilitato”: chi ha visto il recente film di Marco Tullio Giordana “Romanzo di una strage” (vedi in alto) ne è testimone. Ma Calabresi se lo ricorda bene anche il nostro bolzanino: tanti anni fa lo aveva di fronte negli interrogatori. E assieme al commissario, i suoi questurini: gli stessi che, quella maledetta notte del 15 dicembre 1969, erano nella stanza assieme a Pinelli.
Un primo contatto via mail sortisce questa risposta: «Vivo la santificazione in atto del commissario Calabresi come una delle tante quotidiane molestie di cui farsi una ragione, e siccome ognuno di noi ha ombre e luci, non mi sento di collocare Calabresi solo in una zona d’ombra (se non per quello che riguarda me personalmente), mi rode un po’ il fatto che la sua figura pubblica non sembri ormai più contenere parti d’ombra».
Raccontata a Bolzano durante una lunga notte, e al netto di tantissimi particolari sui quali lo spazio non consente di dilungarsi, l’ombra cui fa riferimento è quella dei maltrattamenti subiti durante gli interrogatori. Che fruttano ampie confessioni. Poi tutte ritrattate. Perché? Da un verbale reso in istruttoria: «Per tre giorni in Questura sono rimasto senza dormire e mi veniva imposto di stare in piedi quando le mie risposte non corrispondevano alla volontà degli agenti. Essi non hanno mai cessato un minuto di interrogarmi e per questo si davano il cambio. Solo al terzo giorno mi è stato concesso di mangiare.(…) Ma quello che più ha influito nel farmi firmare i verbali scritti dalla polizia sono state le percosse e le minacce. Sono stato schiaffeggiato, colpito alla nuca, preso a pugni, mi venivano tirati i capelli e torti i nervi del collo. (…) Quanto alle minacce, consistevano nel terrorizzarmi annunciandomi, codice alla mano, a quanti anni di carcere avrei potuto essere condannato, cioè fino a vent’anni. Tali minacce mi furono ripetute in carcere dal dottor Calabresi». Sottolinea oggi, l’anarchico bolzanino («perché mi considero ancora tale: è una visione della vita»), che né allora né mai venne denunciato per diffamazione. Ma visto che non si sa mai, pur fornendo molti dettagli («Calabresi mi ripeteva “tanto siete quattro gatti, nessuno vi difenderà”»), sul suo rapporto con il commissario rimanda al verbale citato. A suo tempo pubblicato anche nel celebre volume di controinformazione a più mani “La strage di Stato”. E aggiunge, 43 anni dopo: «Mi dicevano “sei nelle nostre mani e nessuno lo sa, possiamo farti ciò che vogliamo”: se ti senti dire queste cose a 19 anni, e sei lì impotente con l’imputazione di strage… Non erano spacconate, ma una tecnica per terrorizzare». E basta pensare al G8 del 2001, a Bolzaneto, per cancellare di colpo quasi mezzo secolo. Tutto accadeva prima di piazza Fontana. Prima di Pinelli, prima di Valpreda. E tutto, oggi, si può leggere così: contro gli anarchici, a senso unico, la Questura di Milano indaga ancora prima di piazza Fontana.
Benché pure il nostro protagonista ci metta del suo: nel ’68, l’anno della sua maturità, con altri due giovani colloca una bomba carta dimostrativa in ucan confessionale del Duomo di Bolzano, in occasione di una visita dell’allora ministro della Pubblica istruzione Luigi Gui. Nessun ferito, è poco più di un petardo: processato per direttissima, se la cava con 20 giorni con la condizionale e 15 mila lire di ammenda. Pena e reato poi cancellati dall’amnistia del ’70. Ma a Milano la preda è più grossa di lui. Il coinvolgimento dei Corradini porta infatti a Giangiacomo Feltrinelli, loro amico, che morirà nel marzo del ’72 in circostanze pure controverse, ai piedi di un traliccio a Segrate: che forse voleva far saltare, ai piedi del quale forse portato da altri, camuffando il tutto per far pensare a un attentato. Anche lui è tra gli imputati per il 25 aprile, con il roveretano Sandro Canestrini a difenderlo con successo dall’accusa di falsa testimonianza: l’editore dichiara infatti di aver trascorso quella serata con gli anarchici accusati. Lo conferma oggi lo stesso bolzanino: «Sì, stavo a cena con lui: era appena la seconda volta che lo vedevo…». Il 28 maggio ’71 tutti assolti, ma solo per le bombe alla Fiera e alla Stazione: per alcune altre invece 8 anni a Della Savia, quasi 7 a Braschi, 3 e mezzo al nostro, a quest’ultimo per detenzione di esplosivo e per aver scritto un volantino di rivendicazione. Ricorreranno in tutti i gradi, dicendosi innocenti, ma ottenendo solo sconti (ampi) di pena.
Per la giustizia i colpevoli delle bombe milanesi del 25 aprile sono gli estremisti neri Franco Freda e Giovanni Ventura, responsabili di 17 attentati fra il 15 aprile e il 9 agosto ’69. Cassazione, 27 gennaio 1987: è la sentenza definitiva di condanna. Ma a che prezzo: è la stessa che li assolve per la strage di piazza Fontana.
https://stragedistato.wordpress.com/2014/07/14/7-maggio-2012-trentino-corriere-delle-alpi-paolo-faccioli-quando-calabresi-mi-accusava-di-strage-di-paolo-morando/
«Quando Calabresi mi accusava di strage» 25 aprile ’69, bombe a Milano: anarchici nel mirino prima di piazza Fontana Il bolzanino Paolo Faccioli e una pagina ancora oscura della storia d’Italia
Classe 1949, maturità classica al liceo Carducci dove insegnava latino e greco la madre Carla Gorini, oggi 96enne (il padre Franco, scomparso nel 1999, era invece primario di chirurgia all’ospedale civile), Paolo Faccioli nel 1975 si è laureato a Pisa in Lettere. Ha poi vissuto a lungo in India (ma anche in Oregon, negli Usa), come membro delle comunità spirituali di Rajneesh, più celebre come Osho, ribattezzandosi Rajendra. Proprio in India, a Poona, incontrò tra gli altri anche Mauro Rostagno, ex leader della contestazione alla facoltà di Sociologia di Trento. Tornato in Italia a fine anni ’80, vive ora da tempo in Toscana, nella campagna senese, dove si occupa di apicoltura.
di Paolo Morando ◗ BOLZANO Ha 19 anni, quando lo arrestano a Pisa il 27 aprile del 1969. L’accusa gli viene formalizzata solo nei giorni successivi a Milano, durante gli interrogatori della polizia. Ed è pesante: far parte di un’organizzazione terroristica responsabile di decine di attentati, in pratica tutti quelli che allora si registrano da mesi un po’ in tutta Italia. Una sequenza di botti che culmina proprio nel capoluogo lombardo il 25 aprile del ’69: una data che già avrebbe dovuto suscitare negli inquirenti qualche dubbio sulla matrice anarchica degli ordigni. Perché lui, Paolo Faccioli, è appunto un anarchico. Le bombe milanesi esplodono nel giorno del 24˚ anniversario della Liberazione: la prima alla Fiera campionaria, il pomeriggio al padiglione della Fiat, la seconda alla Stazione centrale, la sera all’Ufficio cambi. Totale: una ventina di feriti lievi. Con il giovane bolzanino vengono fermati altri anarchici, una quindicina: quasi tutti subito rilasciati, tranne Paolo Braschi, Angelo Piero Della Savia e Tito Pulsinelli, poco più che ventenni. Qualche anno in più lo hanno invece l’architetto Giovanni Corradini e la moglie Eliane Vincileone (traduttrice di Bakunin), indicati come i leader del gruppetto ma poi prosciolti in istruttoria. Finiranno tutti a processo quasi due anni dopo, con l’accusa di strage (per il codice penale il reato è infatti tale anche senza morti) assieme a due giovani comunisti, Giuseppe Norscia e Clara Mazzanti: «Era una coppietta toscana emigrata a Milano, il loro unico torto era l’amicizia con Braschi...», ricorda oggi Faccioli. E tutti alla fine assolti, almeno per le bombe milanesi del 25 aprile. Rievocare oggi quella vicenda significa raccontare dove affonda le radici un bel pezzo di storia d’Italia. Pochi mesi più tardi, il 12 dicembre 1969, la strage di piazza Fontana apre un libro a cui manca ancora il finale: quello dell’elenco dei colpevoli. Tre giorni dopo l’attentato, la morte dell’anarchico Giuseppe Pinelli, caduto (suicida? spinto? malore attivo?) da una finestra del quarto piano della Questura di Milano, dove si trovava da oltre 72 ore in violazione delle norme sullo stato di fermo. E ancora l’incriminazione di un altro anarchico, Pietro Valpreda. Altri tre anni e, nel maggio ’72, l’assassinio di chi stava interrogando Pinelli, il commissario Luigi Calabresi: tre anni in cui il funzionario finisce nel tritacarne della campagna stampa di Lotta Continua. Piazza Fontana, Pinelli, Valpreda, strage di Stato e giustizia negata: anche da qui, hanno raccontato tanti brigatisti, prese le mosse il terrorismo di sinistra. Un salto all’estate dell’88 ed ecco l’arresto del leader di Lc Adriano Sofri, di Giorgio Pietrostefani e di Ovidio Bompressi, accusati dall’ex compagno Antonio Marino della morte di Calabresi. Poi un processo dall’iter sterminato, un unicum nella storia giudiziaria italiana, conclusosi con condanne definitive. E un dibattito che continua. Nel corso degli anni, a prescindere dalle sentenze, il profilo di Calabresi è stato “riabilitato”: chi ha visto il recente film di Marco Tullio Giordana “Romanzo di una strage” ne è testimone. Ma Calabresi se lo ricorda bene anche Faccioli: tanti anni fa lo aveva di fronte negli interrogatori. E assieme al commissario, i suoi questurini: gli stessi che, quella maledetta notte del 15 dicembre 1969, erano nella stanza assieme a Pinelli. Un primo contatto via mail sortisce questa risposta: «Vivo la santificazione in atto del commissario Calabresi come una delle tante quotidiane molestie di cui farsi una ragione, e siccome ognuno di noi ha ombre e luci, non mi sento di collocare Calabresi solo in una zona d’ombra (se non per quello che riguarda me personalmente), mi rode un po’ il fatto che la sua figura pubblica non sembri ormai più contenere parti d'ombra». Raccontata a Bolzano durante una lunga notte, e al netto di tantissimi particolari sui quali lo spazio non consente di dilungarsi, l’ombra cui fa riferimento Faccioli è quella dei maltrattamenti subiti durante gli interrogatori. Che fruttano ampie confessioni. Poi tutte ritrattate. Perché? Da un verbale reso in istruttoria: «Per tre giorni in Questura sono rimasto senza dormire e mi veniva imposto di stare in piedi quando le mie risposte non corrispondevano alla volontà degli agenti. Essi non hanno mai cessato un minuto di interrogarmi e per questo si davano il cambio. Solo al terzo giorno mi è stato concesso di mangiare.(...) Ma quello che più ha influito nel farmi firmare i verbali scritti dalla polizia sono state le percosse e le minacce. Sono stato schiaffeggiato, colpito alla nuca, preso a pugni, mi venivano tirati i capelli e torti i nervi del collo. (...) Quanto alle minacce, consistevano nel terrorizzarmi annunciandomi, codice alla mano, a quanti anni di carcere avrei potuto essere condannato, cioè fino a vent’anni. Tali minacce mi furono ripetute in carcere dal dottor Calabresi». Sottolinea oggi, l’anarchico bolzanino («perché mi considero ancora tale: è una visione della vita»), che né allora né mai venne denunciato per diffamazione. Ma visto che non si sa mai, pur fornendo molti dettagli («Calabresi mi ripeteva di continuo “tanto siete quattro gatti, nessuno vi difenderà”»), sul suo rapporto con il commissario rimanda al verbale citato. A suo tempo pubblicato anche nel celebre volume di controinformazione a più mani “La strage di Stato”. E aggiunge Faccioli, 43 anni dopo: «Mi dicevano “sei nelle nostre mani e nessuno lo sa, possiamo farti ciò che vogliamo”: se ti senti dire queste cose a 19 anni, e sei lì impotente con l’imputazione di strage... Non erano spacconate, ma una tecnica per terrorizzare». E basta pensare al G8 del 2001, a Bolzaneto, per cancellare di colpo quasi mezzo secolo. Tutto accadeva prima di piazza Fontana. Prima di Pinelli, prima di Valpreda. E tutto, oggi, si può leggere così: contro gli anarchici, a senso unico, la Questura di Milano indaga ancora prima di piazza Fontana. Benché pure Faccioli ci metta del suo: nel ’68, l’anno della sua maturità, con altri due giovani colloca una bomba carta dimostrativa in un confessionale del Duomo di Bolzano, in occasione di una visita dell’allora ministro della Pubblica istruzione Luigi Gui. Nessun ferito, è poco più di un petardo: processato per direttissima, se la cava con 20 giorni con la condizionale e 15 mila lire di ammenda. Pena e reato poi cancellati dall’amnistia del ’70. Ma a Milano la preda è più grossa di lui. Il coinvolgimento dei Corradini porta infatti a Giangiacomo Feltrinelli, loro amico, che morirà nel marzo del ’72 in circostanze pure controverse, ai piedi di un traliccio a Segrate: che forse voleva far saltare, ai piedi del quale forse portato da altri, camuffando il tutto per far pensare a un attentato. Anche lui è tra gli imputati per il 25 aprile, con il roveretano Sandro Canestrini a difenderlo con successo dall’accusa di falsa testimonianza: l’editore dichiara infatti di aver trascorso quella serata con gli anarchici accusati. Lo conferma oggi lo stesso Faccioli: «Sì, stavo a cena con lui: era appena la seconda volta che lo vedevo...». Il 28 maggio ’71 tutti assolti, ma solo per le bombe alla Fiera e alla Stazione: per alcune altre invece 8 anni a Della Savia, quasi 7 a Braschi, 3 e mezzo a Faccioli, a quest’ultimo per detenzione di esplosivo e per aver scritto un volantino di rivendicazione. Ricorreranno in tutti i gradi, dicendosi innocenti, ma ottenendo solo sconti (ampi) di pena. Per la giustizia i colpevoli delle bombe milanesi del 25 aprile sono gli estremisti neri Franco Freda e Giovanni Ventura, responsabili di 17 attentati fra il 15 aprile e il 9 agosto ’69. Cassazione, 27 gennaio 1987: è la sentenza definitiva di condanna. Ma a che prezzo: è la stessa che li assolve per la strage di piazza Fontana. -------------------------------------------
Così il processo spazzò via il teorema della Questura Le violenze negli interrogatori, i verbali irregolari, la teste chiave inattendibile Dopo 37 udienze choc anche la parte civile credette all’innocenza degli imputati -- Oggi si parlerebbe di processo show. Ma sfogliando i giornali di allora, la parola che tiene tutto è “sdegno”. In due sensi: quello trattenuto a stento da alcuni cronisti di fronte alle piazzate degli anarchici (uno su tutti: Enzo Tortora, 40 anni fa inviato di Nazione e Resto del Carlino, che contestato dal pubblico dovrà uscire dall’aula scortato dalla polizia), ma anche quello del lettore davanti al progressivo sbriciolarsi del castello di accuse costruito dalla Questura e dal giudice istruttore Antonio Amati. Insulti ai magistrati, interminabili ritiri della Corte d’assise in camera di consiglio, il presidente che esasperato si toglie la toga: nelle 37 udienze, la prima il 22 marzo del ’71 (con gli imputati da quasi due anni in detenzione preventiva), accade di tutto. E il caso viene seguito con attenzione anche all’estero, fin dall’inizio: l’8 novembre ’69, per dire, un gruppo di anarchici occupa per protesta la Nunziatura vaticana a Parigi. E pochi giorni dopo il leader del Maggio francese Daniel Cohn-Bendit sarà protagonista di un sit-in davanti al Consolato italiano di Francoforte. Mentre Camilla Cederna, sull’Espresso, fa notare come il giudice istruttore, forzando il codice, si sia “spogliato” dell’indagine delegandola pressoché per intero alla polizia giudiziaria. È un processo che ancora prima di partire fa registrare battute d’arresto: il 9 dicembre ’69 ad esempio, dopo 7 mesi in cella, i coniugi Corradini vengono definitivamente rilasciati per carenza di indizi. E dal carcere gli anarchici hanno già denunciato maltrattamenti subiti nei primi interrogatori. Per non parlare della clamorosa informativa dei servizi segreti del regime militare di Atene, pubblicata dal britannico Observer alla vigilia di piazza Fontana (e mai acquisita in istruttoria, benché ripresa da Espresso e Unità), da cui emerge la matrice di destra degli attentati del 25 aprile: «Le azioni la cui realizzazione era prevista per epoca anteriore non hanno potuto essere realizzate prima del 20 aprile - vi si legge - La modifica dei nostri piani è stata necessaria per il fatto che un contrattempo ha reso difficile l'accesso al padiglione Fiat. Le due azioni hanno avuto un notevole effetto». L’autore dello scoop, Leslie Finer, verrà anche ascoltato al processo. Ma solo dopo che il presidente della Corte Paolo Curatolo («non leggo i giornali») rivelerà di non saperne nulla. L’inchiesta comunque procede e nel luglio ’70 arrivano i rinvii a giudizio per i sei imputati. L’accusa è strage, per aver organizzato 18 attentati, a partire dal 30 aprile ’68 a Padova. Un primo testimone eccellente è Pietro Valpreda, su cui da mesi grava l’accusa della strage di piazza Fontana: e smentisce d’aver saputo da Braschi di attentati in preparazione. Ma davanti ai giudici è già sfilato il direttore delle cave da cui sarebbe stato trafugato l’esplosivo per le bombe. Ed è il primo colpo di scena: no, spiega, da noi non è mai stato rubato nulla. Nella stessa udienza si parla delle violenze ed emerge una circostanza sorprendente: Faccioli non venne sottoposto alla rituale visita medica all’ingresso in carcere. Arrivò di notte, è la giustificazione, a mattinale già chiuso. Domanda del suo legale, il bolzanino William Barchi: perché non compare neppure in quello del giorno dopo? Risposta: il suo nome ci sfuggì... E circa il labbro spaccato del giovane, sarà lo stesso Calabresi a derubricare il tutto parlando di «una pustoletta che si toccava in continuazione». Sarà proprio la deposizione del commissario a sollevare i dubbi maggiori. Il 22 aprile afferma infatti che, nel corso degli interrogatori, non tutto veniva trascritto: «Solo le parti accertate, dopo avere valutato tutti gli elementi». Risultato: nei verbali, di buona parte delle false confessioni di Faccioli non c’è alcuna traccia. In spregio della legge. E pochi giorni dopo si arriverà addirittura alla denuncia di Calabresi, da parte dei difensori degli imputati, per falso ideologico e subornazione del teste chiave. Che è una donna, la famigerata Rosemma Zublena, la cui attendibilità verrà meno col procedere delle udienze. Tanto che gli avvocati, parlando di «delirio ossessionato da fantasie sessuali», decideranno di non porle più domande. E alla fine del dibattimento la parte civile si ritirerà dal processo, dicendosi «vivamente turbata» dalle sue dichiarazioni in aula e sostenendo che «gli attuali imputati sono persone estranee ai fatti delittuosi del 25 aprile 1969». (p.mor.) http://www.edizionimontaonda.it/intranet/libretti/0/100-AltoAdigeprimopiano7maggio2012.pdf

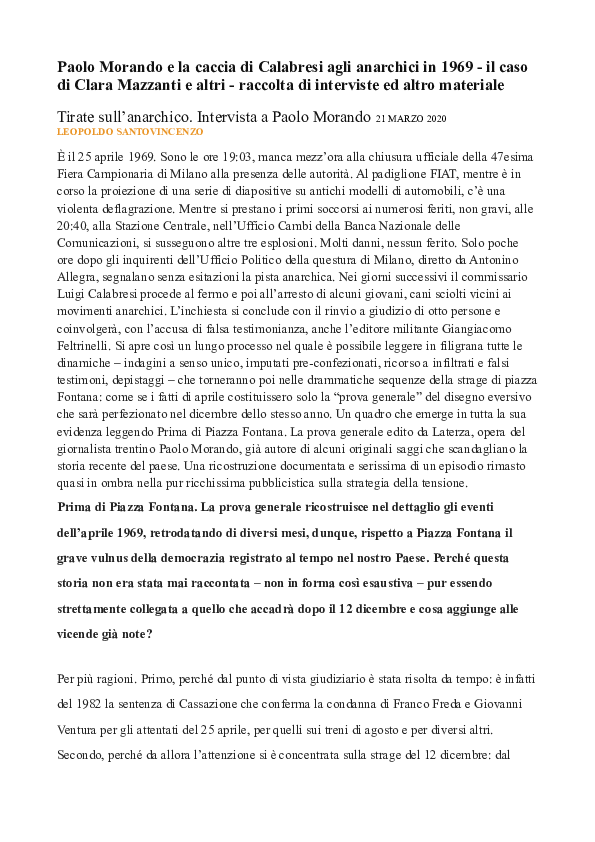
 Tom Welschen
Tom Welschen