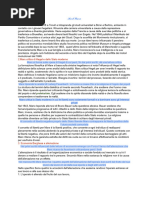0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
4 visualizzazioni2 Gli Anni Della Sinistra Hegeliana (3)
2 Gli Anni Della Sinistra Hegeliana (3)
Caricato da
lollo powerCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PPTX, PDF, TXT o leggi online su Scribd
2 Gli Anni Della Sinistra Hegeliana (3)
2 Gli Anni Della Sinistra Hegeliana (3)
Caricato da
lollo power0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
4 visualizzazioni26 pagineCopyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
PPTX, PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PPTX, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Scarica in formato pptx, pdf o txt
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
4 visualizzazioni26 pagine2 Gli Anni Della Sinistra Hegeliana (3)
2 Gli Anni Della Sinistra Hegeliana (3)
Caricato da
lollo powerCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PPTX, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Scarica in formato pptx, pdf o txt
Sei sulla pagina 1di 26
Gli anni della sinistra hegeliana
Critica alla filosofia hegeliana del diritto
pubblico (1843)
• Testo influenzato da Feuerbach
• Propone due tesi:
• 1)Critica lo Stato hegeliano;
• 2)elabora il concetto di “classi sociali”(borghesia-
proletariato) sostituendolo ai «ceti»
• 1) Rifiuta la divinizzazione hegeliana dello Stato
• Propone come base della vita umana non lo Stato ma la
“società civile”
• L’errore di Hegel è avere confuso il soggetto (il concreto)
con il predicato (l’astratto)
La metafisica capovolge il rapporto soggetto
predicato
Hegel divinizza lo Stato e toglie importanza
al dato reale
• Hegel con la sua dottrina politica trasforma i soggetti
reali (famiglia e società civile) in momenti astratti
• e l’ideale (lo Stato) in soggetto concreto della storia
• In questo senso elabora una statolatria: una
sacralizzazione dello Stato, una sua divinizzazione
• Così facendo, è come se avesse posto l’uomo a testa
in giù, costringendolo a camminare con le mani e
collocandogli i piedi in aria
La rivoluzione francese favorisce la nascita
delle classi sociali
• Occorre quindi restituire dignità alla vita umana e alla società
togliendo contemporaneamente importanza allo stato
• 2) dopo la Rivoluzione francese i ceti (Clero, Aristocrazia e
Terzo Stato) vengono sostituiti dalle Classe sociali (Borghesia e
Proletariato)
• La differenza tra ceto e classe sta nel grado di consapevolezza
dei suoi componenti: gli appartenenti ai ceti sono individui
isolati che non sanno di condividere la stessa condizione con
altri soggetti
• viceversa, i proletari sanno di condividere con i propri
omologhi le stesse condizioni materiali di vita
Successivamente correggerà il tiro sulla
nascita delle classi sociali
• A partire dal “Manifesto”, Marx su questo secondo punto
cambierà idea:
• Non è la rivoluzione francese (in quanto rivoluzione
borghese), ma la rivoluzione industriale a determinare la
nascita delle classi sociali;
• Inoltre, la borghesia non è una vera e propria classe
sociale in quanto tra i suoi componenti dominano
l’individualismo, la concorrenza, la competizione
• Essa, per Marx, non è coesa, solidale e organica, in
quanto composta da individui in perenne competizione
tra loro
Primato dei Bourgeois
• Per i rivoluzionari francesi, anche i proletari sono,
come i borghesi, “Citoyen”, cioè individui in possesso
di diritti
• Ma tali diritti giuridici sono formali, non in grado di
incidere sulle reali condizioni di vita dei poveri
• Ad esempio, i proletari non possono votare né farsi
eleggere
• Viceversa, i Bourgeois, i borghesi, possono
partecipare alla vita politica,
• Ma questo va a detrimento della democrazia
Manoscritti economico-filosofici (1844)
• Con questo testo avviene l’incontro tra la
filosofia e le dottrine economiche
• Anche qui Marx continua la sua polemica
antihegeliana
• L’opera è divisa in tre parti:
• a) critica all’economia classica
• b) descrizione del comunismo
• c) critica della dialettica hegeliana
Contro i liberisti alla Adam Smith (contro la
«mano invisibile»)
• A) critica all’economia classica:
• Non esiste nessuna mano invisibile (Smith, La
ricchezza delle nazioni) che guidi l’economia verso
una crescita indeterminata o verso il superamento
delle crisi economiche
• La proprietà privata non è un dato naturale, ma un
furto perpetrato dai pochi a danno dei molti (qui
Marx riprende sia Rousseau sia Proudhon)
• La condizione operaia è alienata, cioè disumanizzata,
poiché agli operai viene tolto il frutto del loro lavoro
Prima (e ultima) descrizione del comunismo
• B) descrizione del comunismo
• qui Marx fornisce la prima descrizione di
comunismo
• Con tale termine egli indica la socializzazione
dei mezzi di produzione e la soppressione
della proprietà privata
• Dopo il 1848 egli non definirà più tale termine
Revisione della dialettica hegeliana
• C) critica della dialettica hegeliana
• Marx accetta la dialettica di Hegel, ma la sviluppa in modo
personale
• La accetta in quanto crede che il conflitto sia il motore della
storia
• Rifiuta però l’idea secondo cui la dialettica sarebbe il
movimento dello Spirito
• Al contrario, crede che la dialettica sia caratterizzata dallo
scontro tra classi sociali
• Qui Marx critica esplicitamente ogni forma di religione e
assume una posizione dichiaratamente atea
Contro la sinistra hegeliana, contro i
socialisti francesi
• L’utilizzo di categorie economiche allontana Marx
dalla sinistra hegeliana e dal socialismo francese
• Egli accusa i suoi vecchi maestri di essere
metafisici mascherati da materialisti
• E i socialisti francesi che non analizzano i dati
economici ma agiscono per motivi umanitari di
essere degli utopisti
• Da qui in avanti, inizia la sua resa dei conti con la
sinistra hegeliana
Sacra famiglia (1845)
• Prima opera scritta insieme a Engels
• Pamphlet rivolto:
• contro Bauer
• contro la dialettica hegeliana
• A Bauer imputa di essere un falso materialista
• Di essere un metafisico
• Di trascurare l’importanza della svolta storica
avvenuta in Inghilterra con l’industrializzazione
(evento che taglia in due la storia dell’umanità)
La frutta non esiste, esistono mele, pere,
fragole
• Alla dialettica hegeliana imputa l’astrattezza
• Imputa cioè di non partire da situazioni concrete,
bensì astratte
• Rendendola inoffensiva
• È come se abbiamo mele, pere, fragole, mandorle,
ecc
• Ma anziché chiamarle con il loro nome le chiamiamo
“frutta”
• Frutta è solo un nome, un concetto, un’idea astratta
che non ci permette di conoscere i vari tipi di cibo
Tesi su Feuerbach (1845)
• Scrive 11 tesi destinate a confutare il pensiero di
Feuerbach
• Falsamente antihegeliano
• Falsamente materialista
• In realtà profondamente hegeliano e metafisico in
quanto si limita a criticare Hegel dal punto di vista
teorico
• Ma ogni critica filosofica a Hegel, in quanto critica
teorica, ne conferma le conclusioni (finendo per
diventare una semplice antitesi da superare)
Non interpretare bensì trasformare il
mondo
• Non si tratta di criticare il pensiero hegeliano, ma di
capovolgerlo
• Il futuro programma politico di Marx è condensato
nell’undicesima tesi:
• “I filosofi hanno finora solo interpretato
diversamente il mondo, ora si tratta di
trasformarlo”
• Qui Marx sostituisce il theorein, l’atteggiamento
contemplativo-speculativo con la praxis, con
l’azione concreta
Ideologia tedesca (1846)
• Per Marx “ideologia” significa “falsa coscienza”,
“illusione”, “errore”
• Egli accusa di ideologismo alcuni esponenti della
sinistra hegeliana:
• Feuerbach
• Bauer
• E soprattutto Stirner
• Oltre a ciò, qui elabora alcuni concetti-guida del
suo pensiero quali:
La polemica antistirneriana
• Materialismo storico
• Lavoro alienato
• Struttura e sovrastruttura
• Ma prima la critica a Max Stirner
• Costui viene visto come il fondatore
dell’anarco-individualismo (assai diverso
dall’anarchismo su base sociale di Bakunin)
• Nel testo “L’unico e le sue proprietà”(1844)
L’unico di Stiner è la caricatura del soggetto
borghese
• Nella sua opera, Stirner attacca lo Stato, la società, la famiglia
• La politica: la democrazia, il liberalismo, il comunismo
(definito “la società degli straccioni)
• E ogni valore: la religione, l’etica, la razionalità
• In quanto gabbie che imprigionano gli uomini impedendo
loro di esprimersi liberamente
• Contemporaneamente, rifiuta l’idea di soggetto, troppo
condizionata da quella di “oggetto”, sostituendola con la
categoria di “unico” (Einzige)
• Ciò che conta, per Stirner, è l’unico, l’individuale, il solitario,
il ribelle
E ne esalta l’egoismo
• Marx dietro il soggettivismo assoluto di Stirner
non vede l’immagine di un rivoluzionario, di
un sovvertitore dell’ordine costituito,
• Ma scorge la silhouette dell’egoismo borghese
• Insomma, Stirner, pur criticandoli, non
abbatterebbe gli idoli borghesi, ma li
innalzerebbe [non a caso, molti studiosi nella
figura del “Einzige” scorgono un’anticipazione
dello Übermensch nietzscheano]
Materialismo storico
• È la visione materialistica della storia
• Marx conserva la prospettiva dialettica, ma ritiene che motore
della storia non sia lo Spirito, o Dio, ma la lotta di classe
• Ovverosia lo scontro tra gruppi sociali per il controllo dei
mezzi di produzione
• La sua prospettiva risente dello scontro hegeliano tra servo e
padrone
• Per lui c’è sempre un ceto (o una classe) che detiene i mezzi di
produzione
• E un’altra che viene usata come forza lavoro e produce beni
per l’altra
Il materialismo storico riscrive la filosofia
della storia
• Nel corso della storia umana ci sono stati diversi
esempi di lotta di classe:
• Liberi e schiavi in età classica
• Aristocratici e servi nel medioevo
• Borghesi proletari in epoca moderna
• Tuttavia Marx individua anche un modello diverso di
lotta di classe:
• Quello tra nazioni (nazioni predatorie vs. colonie)
• A essa Engels affianca anche quello tra maschi e
femmine
Lavoro e lavoro alienato
• Per Marx, l’essenza dell’uomo risiede,
hegelianamente, nel lavoro
• Tramite la trasformazione, cioè l’umanizzazione,
della natura l’uomo conquista la propria essenza
umana
• A differenza di Hegel, che vede il lavoro come il
livello più basso della soggettività, Marx lo ritiene
come l’atteggiamento umano per eccellenza
• Proprio per questo l’uomo si costituisce in quanto
tale tramite il suo rapporto con l’oggetto
Il lavoro come “merce”
• Ora, se questo oggetto gli viene tolto e trasformato
in merce, egli non può più riconoscersi in esso
• L’uomo diventa allora “alienato”, cioè altro a se
stesso
• Privato cioè di quella dimensione umana alla quale
egli avrebbe diritto
• Ma per Marx c’è di peggio: l’uomo è alienato anche
perché il sistema capitalistico modifica il concetto di
lavoro
Il lavoro come merce
• La forza lavoro viene trasformata dal
capitalismo in una merce tra le altri
• Non dunque l’attività umana per eccellenza,
bensì qualcosa che ha un prezzo, che può
essere acquistato come qualsiasi altra merce
• La mercificazione del lavoro è la forma più
radicale di alienazione (cioè di
disumanizzazione dell’uomo)
Forme di proprietà nella storia
• dopo ciò, Marx passa ad analizzare le varie forme di proprietà che
si sono succedute nella storia:
• Tribale (va dalla raccolta spontanea di frutti della terra
all’agricoltura stanziale; con l’agricoltura nasce la schiavitù in
quanto forza lavoro gratuita)
• Antica (è tipica del mondo greco-romano; ed è basata sulla
dialettica proprietario-schiavo; si sviluppano i commerci e la
tendenza all’accumulo di beni e denaro)
• Feudale (prevalenza dell’agricoltura; dialettica feudatario-servo;
dopo il 1.000 tendono a svilupparsi le prime forme di capitalismo)
• Moderna (lavoro salariato, commerci, accumulo di capitale,
industrializzazione, capitale finanziario)
Potrebbero piacerti anche
- Riassunto Confini e Frontiere. La Moltiplicazione Del Lavoro Nel Mondo GlobaleDocumento39 pagineRiassunto Confini e Frontiere. La Moltiplicazione Del Lavoro Nel Mondo GlobaleMartinaCampajola100% (3)
- Marx SintesiDocumento9 pagineMarx SintesiMichela MaroniNessuna valutazione finora
- Appunti - Dopo Hegel, Feuerbach, MarxDocumento5 pagineAppunti - Dopo Hegel, Feuerbach, MarxAndrea GiubellinoNessuna valutazione finora
- 3 La Svolta de Il Manifesto (2)Documento22 pagine3 La Svolta de Il Manifesto (2)lollo powerNessuna valutazione finora
- La Critica Della Filosofia Del Diritto Di HegelDocumento20 pagineLa Critica Della Filosofia Del Diritto Di HegelVerdiana MortillaroNessuna valutazione finora
- Appunti Filosofia Marx Ipbum52Documento3 pagineAppunti Filosofia Marx Ipbum52Luca VallaNessuna valutazione finora
- MarxDocumento10 pagineMarxnicolasgueraNessuna valutazione finora
- Karl MarxDocumento6 pagineKarl MarxMattia Macor100% (1)
- Riassunto Marx - Reale AntiseriDocumento3 pagineRiassunto Marx - Reale AntiseriAlessandro NdingueNessuna valutazione finora
- Karl MarxDocumento5 pagineKarl MarxGiulia CanellaNessuna valutazione finora
- Karl MarxDocumento6 pagineKarl MarxLaura RomanoNessuna valutazione finora
- Karl Marx - Critica All'economia BorgheseDocumento5 pagineKarl Marx - Critica All'economia BorgheseImma CilibertiNessuna valutazione finora
- Carl MarxDocumento13 pagineCarl MarxClarissa SilvestrelliNessuna valutazione finora
- Riassunto Su Marx.Documento2 pagineRiassunto Su Marx.Mattia Lai100% (2)
- MarxDocumento3 pagineMarxq4zm76zshbNessuna valutazione finora
- Appunti Su MarxDocumento5 pagineAppunti Su Marxstirpe.2141431Nessuna valutazione finora
- MarxDocumento6 pagineMarxncl cprNessuna valutazione finora
- MarxDocumento4 pagineMarxsherondaloisioNessuna valutazione finora
- Marx 1Documento7 pagineMarx 1Marco FerrariNessuna valutazione finora
- MarxDocumento6 pagineMarxMichele CorradinoNessuna valutazione finora
- MARX - Appunti (Liceo Galvani)Documento6 pagineMARX - Appunti (Liceo Galvani)turturroNessuna valutazione finora
- La Scuola Di FrancoforteDocumento4 pagineLa Scuola Di FrancoforteImma CilibertiNessuna valutazione finora
- MarxDocumento3 pagineMarxfedericotantari6Nessuna valutazione finora
- Marx - SociologiaDocumento2 pagineMarx - Sociologiaddafox100% (1)
- Riassunto Marxismo PDFDocumento6 pagineRiassunto Marxismo PDFSimone MaucciNessuna valutazione finora
- Destra e Sinistra Hegeliana, Feuerbach, Marx, WeberDocumento15 pagineDestra e Sinistra Hegeliana, Feuerbach, Marx, WeberSara RuiniNessuna valutazione finora
- Filosofia Quinta SuperioreDocumento15 pagineFilosofia Quinta SuperioreMartina BavilaNessuna valutazione finora
- Karl MarxDocumento6 pagineKarl MarxMaryna100% (2)
- Karl Marx SintesiDocumento3 pagineKarl Marx SintesitotimaggyNessuna valutazione finora
- Karl MarxDocumento2 pagineKarl MarxDaniele D'AciernoNessuna valutazione finora
- MarxDocumento6 pagineMarxsusanna boktorNessuna valutazione finora
- MARXDocumento10 pagineMARXcorreggialessiaNessuna valutazione finora
- Filosofia Marx, PositivismoDocumento11 pagineFilosofia Marx, PositivismoviolalaniniNessuna valutazione finora
- Riassunto Della Filosofia Di Marx Di Sara Scasseddu e Carla AtzoriDocumento9 pagineRiassunto Della Filosofia Di Marx Di Sara Scasseddu e Carla AtzoriGianfranco Marini100% (6)
- MarxDocumento6 pagineMarxMariassunta MinonneNessuna valutazione finora
- MARXDocumento13 pagineMARXSara occhiniNessuna valutazione finora
- Marx Con TestiDocumento29 pagineMarx Con Testimicol.guffantiNessuna valutazione finora
- Introduzione MignoloDocumento13 pagineIntroduzione Mignolo9kfnw548ywNessuna valutazione finora
- Marx e FeuerbachDocumento5 pagineMarx e FeuerbachPierpaolo ManniNessuna valutazione finora
- Marx 2Documento3 pagineMarx 2Giovanna PasquasioNessuna valutazione finora
- KIERKEGAARDDocumento4 pagineKIERKEGAARDframerola3Nessuna valutazione finora
- La Scuola Di FrancoforteDocumento23 pagineLa Scuola Di Francoforteveronica.donati006Nessuna valutazione finora
- Horkheimer La Società Di TransizioneDocumento76 pagineHorkheimer La Società Di TransizioneValeria VaccaNessuna valutazione finora
- MARXDocumento3 pagineMARXannaroma07Nessuna valutazione finora
- Antonio Gramsci FilosofiaDocumento16 pagineAntonio Gramsci FilosofiaMarco MulasNessuna valutazione finora
- Sociologia Generale PDFDocumento48 pagineSociologia Generale PDFGiulio PignatelliNessuna valutazione finora
- Filosofia MarxDocumento6 pagineFilosofia MarxolasaccoNessuna valutazione finora
- 8 FreudDocumento8 pagine8 FreudsofiaNessuna valutazione finora
- Scuola Di FrancoforteDocumento8 pagineScuola Di Francoforte_fiacoNessuna valutazione finora
- Riassunto Di MarxDocumento7 pagineRiassunto Di Marxbonaccibenedetta9Nessuna valutazione finora
- Sociologia 1 LibroDocumento8 pagineSociologia 1 Librosimona.silvestri11Nessuna valutazione finora
- Lo spettro del Dio mortale: Hobbes, Schmitt e la sovranitàDa EverandLo spettro del Dio mortale: Hobbes, Schmitt e la sovranitàNessuna valutazione finora
- L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello StatoDa EverandL'origine della famiglia, della proprietà privata e dello StatoNessuna valutazione finora
- Singolarità e istituzione: Antropologia e politica oltre l'individuo e lo statoDa EverandSingolarità e istituzione: Antropologia e politica oltre l'individuo e lo statoNessuna valutazione finora
- La democrazia e la legge ferrea dell’oligarchia. Saggi sulla classe politicaDa EverandLa democrazia e la legge ferrea dell’oligarchia. Saggi sulla classe politicaNessuna valutazione finora
- Manifesto del Partito Comunista: Guida, Manifesto e DizionarioDa EverandManifesto del Partito Comunista: Guida, Manifesto e DizionarioNessuna valutazione finora
- Il Grande Esule Di Acquafredda.: Francesco Saverio Nitti Tra Pedagogia, Politica e Impegno CivileDocumento32 pagineIl Grande Esule Di Acquafredda.: Francesco Saverio Nitti Tra Pedagogia, Politica e Impegno CivileGoldenGamerNessuna valutazione finora
- Costanzo Preve - Il Tempo Della Ricerca - PDF Vangelista (1993)Documento251 pagineCostanzo Preve - Il Tempo Della Ricerca - PDF Vangelista (1993)Orazio Flacco100% (1)
- "Dinamiche Della Ragione", Michael FriedmanDocumento5 pagine"Dinamiche Della Ragione", Michael FriedmanEle NealNessuna valutazione finora
- Positivismo, Comte e MillDocumento17 paginePositivismo, Comte e MillAngela DonnoNessuna valutazione finora
- 3.3 Stefano Catucci PDFDocumento7 pagine3.3 Stefano Catucci PDFSusanrtsNessuna valutazione finora
- Sociologia-Riassunto Il Mondo in QuestioneDocumento25 pagineSociologia-Riassunto Il Mondo in QuestioneSilvia Momo d'OvidioNessuna valutazione finora
- Umberto PostiglioneDocumento107 pagineUmberto PostiglioneflerziNessuna valutazione finora
- Tesi Teatro Dell'OppressoDocumento68 pagineTesi Teatro Dell'OppressoGiulio VanzanNessuna valutazione finora
- Riassunto - Manuale Sociologia RutiglianoDocumento13 pagineRiassunto - Manuale Sociologia RutiglianoMatteo De FaziNessuna valutazione finora
- Marxismo Leninismo MaoismoDocumento60 pagineMarxismo Leninismo MaoismoEbreo1975Nessuna valutazione finora
- La Seconda Rivoluzione IndustrialeDocumento2 pagineLa Seconda Rivoluzione IndustrialeTommaso RocchiNessuna valutazione finora
- Gesell - L'Ordine Economico NaturaleDocumento723 pagineGesell - L'Ordine Economico NaturaleAlex Walk100% (1)