Che cosa è di nostro diritto?
di Giuseppe Scandurra e Leonardo Tancredi1
Introduzione
Sono arrivato a Bologna nel 2004 dopo aver concluso un dottorato di ricerca in “Antropologia della
Contemporaneità” all’Università di Milano-Bicocca. Ho preso la mia prima stanza in affitto in città
durante la campagna elettorale del sindaco Sergio Cofferati. Bologna usciva dalla prima
amministrazione comunale di centro-destra dal secondo Dopoguerra e l’atmosfera era festosa, come di
liberazione, dopo i quattro anni di Giunta del sindaco Giorgio Guazzaloca.
Nel 2004 ho iniziato a insegnare Antropologia culturale all’Università di Bologna continuando a
interessarmi, come nel caso della ricerca di Dottorato (Scandurra 2007), di temi legati agi studi urbani
nell’ambito dell’antropologia (Sobrero 1992; Signorelli 1996; Callari Galli 2007; Barberi 2010;
Cancellieri e Scandurra 2012); non conoscevo Bologna e per deformazione professionale non vedevo
altro modo di “sentirmi a casa” se non studiandola, se non facendola oggetto di ricerche etnografiche di
media/lunga durata.
Quando sono arrivato avevo ovviamente delle rappresentazioni su questa città (Fabietti 1999). Nella
classifica sulla qualità della vita pubblicata su «Il Sole 24 ore» nel 2004 – e così anche nei dieci anni
successivi – Bologna appariva tra le prime città italiane per “qualità della vita”. Nel 2004, però, io
conoscevo di questa realtà urbana solo il sottopassaggio della stazione centrale, dove, durante i tre anni
del Dottorato (2001-2004), ho passato molto tempo ad aspettare i treni che andavano a Roma – dove
ho abitato fino al 2004 – e a Milano – dove, per l’appunto, svolgevo l’attività di ricerca dottorale. In più
occasioni, proprio in questo spazio di attesa, sono stato oggetto di richieste da parte di senza fissa
dimora – sigarette e monetine per lo più – i quali facevano su e giù tra i binari della stazione; in più di
un’occasione, quando ciò accadeva, mi sono chiesto che relazione ci fosse tra le statistiche de «Il Sole
24 ore» e la presenza di così numerosi senza casa.
Nel settembre 2004, quando mi sono trasferito a Bologna per iniziare a insegnare, ho realizzato un
progetto di ricerca finalizzato a produrre una mappa delle realtà riguardanti l’emarginazione sociale in
città – dormitori, politiche per l’inclusione sociale, storie di vita di senza fissa dimora –, al fine di capire
che tipologie di persone sono quelle che vivono in strada considerando il fatto che quasi mai si tratta di
una libera scelta. Soprattutto, quali sono i circoli viziosi che non permettono ancora oggi a queste
persone, nel contesto cittadino bolognese, di cambiare vita (Scandurra 2005). Sempre dentro il contesto
degli studi urbani, concentrando però l’attenzione su specifici processi di esclusione sociale (Bonadonna
1
Giuseppe Scandurra è Professore Associato all’Università di Ferrara - Dipartimento di Studi Umanistici. Leonardo
Tancredi è Direttore del mensile «Piazza Grande». L’Introduzione e il primo paragrafo sono opera di Giuseppe Scandurra; il
secondo paragrafo è da attribuirsi a Leonardo Tancredi. Le conclusioni sono state scritte a quattro mani.
�2001; Barnao 2004; Bergamaschi, Guidicini e Pieretti 2004; Tosi Cambini 2005), ho iniziato a
interessarmi alla formazione di “nuove povertà” e alle pratiche di vita quotidiana di persone che
rivendicano una “cultura” di strada, la qual cosa mi ha costretto a interrogarmi sulla relazione tra
«cultura di strada» e «cittadinanza» (Riccio e Scandurra 2008).
Nello specifico, ho studiato le pratiche di un gruppo di senza fissa dimora ospiti del dormitorio
pubblico di Bologna “Massimo Zaccarelli” ampliando poi lo sguardo a specifici territori periferici del
capoluogo emiliano-romagnolo con la volontà di capire se è possibile ancora oggi parlare in città di
fenomeni di impoverimento collettivo; e ancora, se questi processi colpiscono tutti o solo determinati
attori sociali che vivono in città (Scandurra 2012).
Durante la ricerca su dormitorio pubblico “Massimo Zaccarelli” ho incontrato Leonardo Tancredi, il
quale dirigeva il giornale mensile «Piazza Grande», giornale che si è sempre speso per migliorare la
qualità della vita delle persone senza fissa dimora che vivono nel capoluogo emiliano denunciando
specifici processi di esclusione sociale che hanno caratterizzato Bologna negli ultimi venti anni. Nello
stesso periodo ho iniziato a collaborare con il gruppo di studio sulle “Nuove e Vecchie Povertà” diretto
dall’antropologa Matide Callari Galli presso l’Istituto Fondazione Gramsci-Emilia Romagna
occupandomi, inizialmente, della relazione tra determinati territori periferici cittadini e pratiche di vita
di gruppi di uomini e donne senza casa (Scandurra 2007a); e, successivamente, facendo attività di
ricerca su come, dopo la conclusione del mio studio sul dormitorio pubblico “Massimo Zaccarelli”,
fossero cambiate le pratiche di vita quotidiane dei senza fissa dimora che hanno vissuto, e in parte
vivono ancora, a Bologna negli ultimi anni (Scandurra 2013).
Come gruppo di lavoro Istituto Fondazione Gramsci – gruppo di ricerca a cui ha iniziato a
collaborare anche Leonardo Tancredi – a cominciare dal 2006 abbiamo iniziato una serie di studi
partendo dal presupposto che molte ricerche nazionali e internazionali pubblicate recentemente che
hanno come oggetto di studio specifici processi di esclusione sociale rischiano di essere lette solo
dentro la “comunità” scientifica. Concentrando l’attenzione sul territorio bolognese, eravamo a
conoscenza del lavoro che tantissime persone, a diverso titolo e con diverse competenze fanno ogni
giorno per migliorare le condizioni di vita quotidiana di uomini e donne che vivono in condizione di
disagio economico e sociale; un lavoro, però, che li mette davanti a continue emergenze e spesso
l’impossibilità, di conseguenza, di riflettere sul proprio operato e migliorarsi dal punto di vista
professionale. Allo stesso tempo, già nel 2006 osservavamo come l’Amministrazione Comunale non
riuscisse a intervenire sempre al meglio davanti questi problemi nel momento in cui i processi sociali
avvengono più velocemente delle decisioni politiche che vorrebbero governarli.
Di conseguenza, ci ponemmo come obiettivo finale del nostro primo lavoro triennale promosso
dall’Istituto Gramsci – 2008-2011 – quello di fare da collante tra questi tre mondi – quello di chi opera,
�di chi studia, di chi amministra – offrendo interpretazioni che volevamo fossero utili per tutti questi
attori sociali al fine, da una parte, di ipotizzare delle azioni utili a contrastare determinati processi di
disagio e marginalità urbana; dall’altra, di capire quanto gli studi che noi stessi avevamo condotto su
questi temi fino ad allora incorressero nel rischio di replicare stereotipi e favorire politiche neoliberiste
– ovvero tese a aumentare il disagio e la marginalità in cui vivono queste persone denunciando come le
loro condizioni di vita siano sempre conseguenza delle loro scelte di vita individuali (Wacquant 2002).
Già in quella fase di lavoro – 2008/2011 – eravamo consapevoli di come per esempio molti “vecchi”
e “nuovi” poveri che vivevano in città non costituissero una classe sociale, un gruppo omogeneo al suo
interno, ma piuttosto una massa dai contorni indefiniti che non dispone di una propria autorappresentazione. La presenza nel gruppo di ricerca di Leonardo Tancredi ci aiutò anche perché ancora
oggi il mensile «Piazza Grande» è l’unico strumento di cui queste persone dispongono per autorappresentarsi. Eravamo altresì consapevoli, inoltre, con la formazione di ciò che la stessa
Amministrazione Comunale bolognese chiama oggi «nuove povertà» (Pavarin 2006), di come i percorsi
di impoverimento fossero sempre più caratterizzati da una profonda individualizzazione, e fosse quindi
possibile osservare situazioni di vita molto diverse tra loro, con forme di disagio che vanno ben oltre la
comune deprivazione economica.
Fin dall’inizio delle nostre attività di ricerca abbiamo sempre creduto che utilizzare strumenti legati
all’antropologia culturale e alla ricerca qualitativa, a cominciare dal metodo etnografico, avrebbe
permesso a queste persone, “vecchi” e “nuovi” poveri mossi da dinamiche strutturali, di emergere
come esseri umani in carne e ossa che danno forma al proprio futuro all’interno del dibattito teorico sul
rapporto tra «struttura e azione», ovvero all’interno della relazione tra «responsabilità individuale e
vincoli strutturali». (Bourgois 1996) Le azioni e le traiettorie di vita di queste persone non sono infatti
quasi mai riconducibili deterministicamente alla struttura sociale in cui sono inseriti ma avvengono
sempre dentro «un ventaglio di possibilità» condizionato da determinate relazioni di potere e dentro
una storia che le influenza. (Colombo 1998)
Durante questo primo triennale lavoro di ricerca avemmo modo di intervistare e realizzare focus group
con operatori, dirigenti, amministratori pubblici e “vecchi” e “nuovi” poveri. Due furono allora le
questioni che fra tutte ci stupirono nell’interpretare i dati raccolti sul campo, tanto da volerle poi
approfondire nel lavoro di ricerca successivo di cui questo saggio è conseguenza diretta. Da una parte
quasi tutti i “nuovi poveri” con cui avemmo modo di parlare – per lo più giovani, con un tasso medioalto di alfabetizzazione – tendevano sempre più a confondere i propri diritti come concessioni e aiuti
che lo Stato, nello specifico l’Amministrazione comunale faceva loro. Da questo punto di vista era
evidente come molti di essi pensassero che la colpa della loro situazione fosse da attribuirsi unicamente
alle loro cattive scelte, e che di conseguenza, l’unica possibilità di uscita dalla povertà dipendesse
�unicamente dalla loro forza di volontà. Durante quei focus group emergeva infatti come un buon
rapporto con i servizi, secondo loro, fosse possibile solamente quando l’utente si comportava bene –
“fa il bravo” –, ovvero mostrava di meritarselo.
Su cento persone se ne salva... una persona, mezza persona su novantanove si salva adesso per
come vanno i servizi. Una persona si salva solo se è lucido di testa, se ha una volontà di ferro, in
quel momento lì si salva. I servizi non c’entrano, perché loro hanno un meccanismo talmente
stigmatizzato, fanno sempre la stessa cosa. (utente, focus group 2011, Callari Galli 2013)
Uno deve solo cercare di essere gentile carino simpatico al proprio assistente sociale per riuscire
a prendere tutto quello che può, tipo il rinnovo del semestre etc... non è possibile questo, perché se
non gli sei simpatico “No, no tu hai avuto il tuo periodo te ne puoi anche andare”... la tesserina per
mangiare al centro diurno se non gli sei simpatico non te la dà... poi se gli sei simpatico anche per
vent’anni, questo vi assicuro che funziona così. Questo vale per tutto il resto non mi riferisco solo
al dormitorio e al centro diurno per qualsiasi altra cosa funziona così. (utente, focus group 2011,
Callari Gali 2013)
Dall’altra parte c’era una seconda questione che ci spinse a continuare per altri tre anni il lavoro di
ricerca con l’Istituto Gramsci. Seppur spesso con una famiglia alle spalle, tra i “nuovi poveri” che, pur
tra mille difficoltà e scetticismo, avevano ricorso aiuto a questi servizi vi erano tantissimi adolescenti e
ragazzi tra venti e trent’anni. Per loro non era previsto nessun servizio, nessuno aiuto, anche perché
spesso considerati come maggiormente colpevoli rispetto ad altre persone in stato di disagio, vista la
loro età, il loro essere figli di persone che potevano aiutarli e il fatto di essere non elettori attivi.
Direi che oggi i nuovi poveri sono i lavori poveri, e un lavoro povero che rende dà una
redditività bassa. Il povero che non lavora da sempre è fuori dal mercato, oggi i nuovi poveri sono
quelli che lavorano e prendono 700 euro al mese, questa è la nuova povertà, che non è solo quella
tradizionale: sono nuovi poveri anche certe fasce di intellettuali, i precari più precari, quelli che
lavorano sul computer, quelli che fanno i co.co.pro., quelli che lavorano con piccole partite iva,
quelli che stanno nella gestione separata dell’Inps, che hanno meno di 5.000 euro all’anno di
reddito, anche gli intellettuali sono i nuovi poveri. (sindacalista, focus group 2011, Callari Galli 2013)
Tutti parlano dei trentenni. Sono l’80%, 90%, sono dentro questa fascia... anche in questo caso
stanno sempre calando i soldi per questo tipo di interventi; si è arrivati al punto che di nuovo
vogliono percorsi brevissimi in cui devono guarire in frettissima e costare poco, in sostanza e di
nuovo i giovani sono penalizzati. (operatore, focus group 2011, Callari Galli 2013)
�Sono sfigati ma già hanno una sfiga che è contenuta dalla famiglia. (operatrice, focus group 2011,
Callari Galli 2013)
C’era un’antica risposta... non votano. (operatore, focus group 2011, Callari Galli 2013)
Come dire in qualche modo sono problemi che non dipendono dalla volontà, tutti i ragazzini
problematici come tutti i problemi di dipendenza, afferiscono un po’ nell’immaginario collettivo al
fatto che uno se l’è cercata la sfiga; mentre invece l’anzianità e la disabilità è qualcosa che non
dipende da te. (operatrice, focus group 2011, Callari Galli 2013)
Cioè la fascia undici, quattordici e quindici, ti frega nel passaggio dalla terza media alla prima
superiore, che è il passaggio più delicato, dove succedono più casini, dove i ragazzi mollano, si
perdono... mollano la scuola media che è territorializzata e arrivano nei mega istituti ghetto e là
scoppiano. (tutor d’aula in un corso di formazione, focus group 2011, Callari Galli 2013)
Tra questi “giovani nuovi poveri” la fascia che ci sembrò più in difficoltà sembrava quella dei minori
che avevano abbandonato la scuola una volta finita l’età dell’obbligo e non riuscivano poi ad entrare nel
mondo del lavoro né in quello della formazione professionale. Tra questi molti stranieri che
frequentano solo i primi anni degli istituti professionali.
Tali questioni ci spinsero, come gruppo di ricerca sulle nuove povertà a Bologna, a realizzare una
ricerca sui giovani tra i 18 e i 34 anni per indagare meglio le loro aspettative, i loro bisogni, le loro
pratiche di vita quotidiane in una città come Bologna. Ciò, secondo noi, era necessario per almeno due
motivi. Da una parte per bilanciare i nostri precedenti lavori come gruppo di ricerca che non avevano
mai avuto come chiave di lettura esplicita la questione generazionale; dall’altra perché, sempre
rimanendo dentro il campo delle scienze sociali e della ricerca etnografica, sempre più spesso gli studi
sulle “nuove povertà” si sono concentrati su situazione di radicale disagio economico e sociale – i senza
fissa dimora su tutti – non concentrando quasi mai l’attenzione su processi di impoverimento che negli
ultimi anni hanno colpito la classe media, e in particolare i più giovani (Callari Galli 2013).
1. Il campo di ricerca
Quando nel 2006 presso la Fondazione Gramsci nacque il nostro Laboratorio di Ricerca scegliemmo
da subito di intraprendere due strade: da una parte quella della transdisciplinarietà, invitando a far parte
del Gruppo ricercatori e ricercatrici con competenze differenti; dall’altra quella della ricadute
applicative, data la nostra volontà di raccogliere dati e sviluppare interpretazioni che potessero da subito
essere utili all’Amministrazione comunale e, più in generale, chi ha per compito quello di realizzare
politiche al fine di risolvere problemi legati ai diversi processi di esclusione sociale che tutt’ora si
�registrano in città.
Dopo aver indagato la questione relativa alle “vecchie” e “nuove” povertà (Callari Galli 2013)
scegliemmo di approfondire il tema concentrando l’attenzione sulle nuove generazioni che abitano
Bologna – i residenti compresi tra i 18 e i 34 anni registrano la quota significativa di 70.000 presenze in
città; e scegliemmo di fare ciò con la consapevolezza che tale campione comprendesse una fascia di
cittadinanza molto eterogena, oscillando tra coloro che si affacciano al mondo adulto e chi adulto lo è
già a tutti gli effetti. Scegliere in questo senso un taglio transdisciplinare ha voluto dire per noi realizzare
inizialmente due questionari. Il primo, anagrafico, rivolto per l’appunto a un campione estratto
dall’anagrafe comunale pesato statisticamente sulla base di determinate caratteristiche – genere, età,
cittadinanza, quartiere di residenza. Il secondo, che abbiamo voluto chiamare “generalista”, rivolto
sempre alla stessa fascia di età e solo alla popolazione residente, ma ottenuto inoltrando il questionario
via posta elettronica e attraverso i social networks a imprese, associazioni del territorio e singoli cittadini.
Sapendo quanto questo tipo di lavoro si potesse offrire a un livello di approssimazione rilevante
privilegiando le tendenze e gli orientamenti più vistosi – su questo aspetto rimandiamo i lettori agli altri
capitoli di questo volume che spiegano in maniera più approfondita come abbiamo affrontato la sfida
metodologica che avevamo davanti – scegliemmo, come abbiamo già scritto, di far dialogare i dati
quantitativi con quelli che avremmo raccolto attraverso il nostro lavoro qualitativo, ovvero conducendo
interviste mirate e discussioni di gruppo. Sapevamo fin dall’inizio, infatti, che le risposte al questionario
trasmesso sul web ci avrebbero offerto dati relativi solo a una parte di popolazione; non avrebbero cioè
compreso categorie che le nostre conoscenze della realtà bolognese derivanti dalla ricerca precedente
(Callari Galli 2013) indicavano essere di notevole rilievo nel momento in cui volevamo tracciare un
quadro capace di rendere conto della complessità che caratterizza i mondi sociali oggetto del nostro
lavoro. Anche per questo, una volta interpretati le risposte ai due questionari abbiamo scelto di
ascoltare, attraverso le interviste, tutte le storie e le rappresentazioni di coloro i quali, per livello di
istruzione, per famiglia di appartenenza, ci sembrava non emergessero dai dati raccolti attraverso i due
questionari.
Nell’intraprendere la ricerca ci siamo posti da subito molte domande su come rappresentare al
meglio i due attori sociali protagonisti del nostro lavoro: da una parte i responsabili politici – attori non
protagonisti, ma evocati continuamente nelle parole dei nostri interlocutori –, i quali non sempre
sembrano conoscere l’esistenza ordinaria dei loro concittadini; dall’altra parte tutti quei giovani uomini
e donne che denunciano, oggi più che ieri, un “mal di vivere” e sempre più pochi mezzi per comunicare
il loro stato di disagio – ovvero i veri protagonisti della nostra ricerca. Eravamo d’altronde consapevoli,
nell’iniziare questo lavoro, di come i primi, i politici, fossero molto interessati ai sondaggi d’opinione, e
di come i secondi fossero sempre più chiusi nel proprio malessere; proprio ciò ci spinse a far dialogare i
dati quantitativi con un lavoro di ricerca qualitativa che facesse emergere il punto di vista dei
�protagonisti della nostra ricerca e costringesse i lettori – tra cui la classe politica bolognese – a non
prendere in considerazione solo i numeri che emergevano dai nostri questionari.
L’obiettivo generale, in questo senso, è stato quello di voler comprendere le condizioni di
produzione delle forme contemporanee di povertà sociale; per questo, soprattutto nelle attività di
interviste, abbiamo voluto domandare ai nostri interlocutori come vivessero i loro mondi periferici, la
scuola, l’inserimento al mondo lavorativo, la famiglia, ovvero tutti quei contesti in cui emerge dalle loro
parole, in sintesi, uno stato di sofferenza.
In questo senso possiamo fare nostre, a posteriori, le parole dei sociologi Petrillo e Tarantino che
recentemente hanno curato e tradotto per la casa editrice Mimesis il lavoro curato da Bourdieu “Misère
du Monde” pubblicato in francese per la prima volta nel 1993. Tali parole raccolte nel loro lavoro
(Petrillo e Tarantino 2015) permettono ai lettori di capire, possiamo dire oggi a ricerca conclusa, quale è
stata la specificità del nostro lavoro, ovvero la volontà di comprendere come determinati processi di
impoverimento sono apparsi oggi all’orizzonte di gruppi sociali che hanno inizialmente impostato la
loro vita, e quella dei propri figli – al centro di questo volume -, su prospettive di un sicuro e raggiunto
benessere.
È inutile cercare qui il povero, il vagabondo o altri classici della miseria. Non c’è un pitocco, un
accattone, un picaro o altro esponente della progenie del barbone; neanche un folle, emblema e
sintesi di tutte le povertà. […] Sono praticamente assenti le figure tradizionali, epiche, gloriose e
tragiche, che da sempre abitano via della povertà e villa miseria. […] Il presepe della miseria della
sociologia non prende mai forma; neanche uno storpio o un rom che va a caritare. Sono
integralmente rimosse le figure facili e comode dell’assistenza, così utili a riempire le targhette delle
porte della percezione dei ministeri e degli assessorati. Niente vecchi e nuovi poveri, dunque. […]
In queste pagine non c’è la miseria nera e non ci sono i miserabili. Chiaramente la Grande miseria
non è scomparsa dalle nazioni della ricchezza. Chi non può permettersi il lusso delle metafore
muore ancora letteralmente di freddo e di fame. Da qualche tempo però, almeno in questa parte
dell’Occidente, il mondo dei vinti non corrisponde più integralmente al paese della fame. (Petrillo e
Tarantino 2015, 11-12)
Nel libro “Miserè du Monde” (1993), pubblicato quando la crisi economica era non solo lontana da
venire ma immaginabile, Pierre Bourdieu e gli altri ricercatori e le altre ricercatrici che hanno scritto il
volume con lui, denunciavano come l’arretramento della Grande miseria già allora stava facendo
proliferare le forme della Piccola miseria; ovvero come, se la guerra alla povertà degli anni Cinquanta e
Sessanta avesse provocato numerosi effetti, primo tra tutti il confinamento della grande misera fuori
dall’Occidente (Castel 1978), forme molteplici di piccole miserie andavano proliferando e
radicalizzandosi proprio all’interno delle nostre città. Al termine di un’indagine sull’economia
�dell’abitare lo stesso Bourdieu, sempre un quarto di secolo fa, riprenderà questo tema scrivendo come
questa nuova borghesia in declino «certo non ispira spontaneamente la simpatia, la compassione o
l’indignazione che suscitano i grandi rigori della condizione proletaria o sottoproletaria» (Bourdieu
1990, 2). Uno dei due curatori della traduzione italiana di “Misère du Monde” scriverà al proposito:
Questa miseria minore, su cui la violenza strutturale non si è – o non si è ancora – richiusa in
dominio assoluto, per cui gli agenti conservano un margine di libertà, svela la matrice stessa di ogni
miseria, che è, in essenza, miseria di possibile; impotenza dell’atto o, meglio, indisponibilità della
potenza/possibilità di non agire. (Tarantino 2014)
A distanza di venticinque anni possiamo dire che ancora oggi le scienze sociali fanno fatica a
concentrare lo sguardo su queste piccole miserie, su queste molteplici possibilità di non azione. A
distanza di venticinque anni possiamo dire, ancora di più di ieri, come i discorsi retorici del pensiero
positivistico – che potremmo riassumere nel “Si può fare”, “Basta volerlo” – continuano ad essere
egemonici anche dentro l’Accademica. Sono, come vedremo nel prossimo paragrafo, gli stessi attori
sociali da noi intervistati, coloro che appartengono a tutti gli effetti a questa Nuova Piccola Miseria, a
interpretare il Positive Thinking, ovvero a credere che «il mondo sociale ha la forma di un universo dei
possibili ugualmente possibili per ogni soggetto possibile» (Bourdieu 2005, 101), nonostante già un
quarto di secolo, quando la maggior parte di loro non era ancora nata, fosse già evidente, anche
all’interno dell’Occidente, tale “crisi di possibilità” (Tarantino 2014).
La totale assenza di un discorso relativo ai loro diritti – sul lavoro, nel mondo della scuola, come figli
e minori - che emerge dalle parole dei nostri interlocutori nel prossimo paragrafo, ci aiuta a capire come
in questi ultimi anni non solo tali piccole miserie non siano state combattute ma rappresentino sempre
più la condizione in cui vivono la maggior parte delle nuove generazioni che abitano le nostre città
occidentali – o almeno certamente il capoluogo emiliano. I diritti, in questo senso, sono da loro
interpretati come concessioni e, nella maggior parte dei casi, sostituiti da aiuti che denotano, all’interno
di questi vasti mondi sociali, il ritorno alla trasmissibilità familiare dei redditi, dei capitali, dei titoli
scolastici, delle posizioni lavorative e degli status sociali, ovvero una riconnessione del futuro alle
condizioni di nascita. Lo stesso curatore alla versione italiana di “Misère du Monde”, concentrando la
sua attenzione sugli ultimi venticinque anni, scriverà: «restaurazione progressiva della componente di
democrazia ereditaria, avallata e incentivata dalle politiche di rachitismo della proprietà sociale»
(Tarantino 2013).
L’assenza totale di un discorso si loro diritti, come vedremo sempre nel prossimo paragrafo, ci ha
fatto capire, mentre conducevamo la ricerca, quanti sono i ragazzi e le ragazze, i giovani adulti, oggi
�incapaci di mettere a fuoco esattamente il proprio bersaglio, quanti sono, purtroppo, coloro che «non
sanno esprimersi né sanno come esprimersi» (Petrillo e Tarantino 2015, 14).
Da questo punto di vista – e anche in questo caso una parte della letteratura scientifica, tacciata
spesso di catastrofismo e accusata di non essere “scientifica” (Bourdieu e Wacquant 1992), aveva già
intravisto quello che sarebbe successo – se era evidente anche negli anni Novanta come la volontà
politica fosse quella di convincere tutte e tutti, compresi i poveri, di come la povertà fosse una colpa
individuale, sta diventando chiaro solo oggi come le classi politiche che hanno governato l’Europa in
questo ultimo quarto di secolo, e continuano oggi a governarla, hanno previsto per la Piccola Miseria
procedure di privatizzazione di condizione, che incentivano «la “piccola felicità privata” e alimentano la
“politica privata” delle discriminazioni e delle recriminazioni: di diritti nessuno in questo senso parla
più» (Petrillo e Tarantino 2015, 15).
Quando abbiamo intrapreso questa ricerca più volte ci siamo domandati quali debbano essere oggi
gli obiettivi di un ricercatore e quali quelli, di conseguenza, delle “scienze del Presente”. La scelta di
questo oggetto di studio è conseguenza della nostra risposta, ovvero della convinzione che i saperi,
dentro e fuori l’Accademia, dovrebbero oggi concentrare lo sguardo soprattutto su questi temi
reclamando finanziamenti necessari al fine di realizzarli; e più volte, come abbiamo già scritto, ci siamo
detti, nell’iniziarla, come sia sempre più necessario, oggi, far uscire queste ricerche dal Palazzo
Accademia e privarle della loro ormai purtroppo naturale autoreferenzialità.
Ciò giustifica le due scelte che abbiamo fatto nell’affrontare questo lavoro. La prima, ovvero la
necessità, come detto, di far dialogare i dati che sarebbero emersi dai questionari con quelli ottenuti sul
“campo”. La seconda, ovvero la scelta di condurre interviste mirate accordandoci, prima, su alcuni
criteri da rispettare. Questo lavoro, infatti, non doveva avere in nessun modo un valore ancillare, di
completamento, rispetto ai dati che sarebbero emersi dal questionario. Queste dovevano essere niente
d’altro che testimonianze di giovani uomini e donne circa il loro disagio a vivere questo Mondo. Tali
testimonianze – e qui la volontà di fissare dei criteri condivisi prima di realizzarle – non potevano allora
che essere conseguenziali allo stabilirsi di un rapporto di fiducia tra l’intervistato e l’intervistatore.
Per far questo abbiamo voluto da subito che a condurre le interviste fossero persone “vicine” – e
riconosciute tali dai nostri interlocutori e interlocutrici – ai protagonisti della ricerca. Solo in questo
modo avremmo potuto cogliere ciò che gli stessi autori e autrici di “Misère du monde” venticinque anni
fa denunciavano come obiettivo specifico della loro ricerca, ovvero «l’essenziale al cospetto della
molteplicità del reale, delle sottigliezze quasi infinite che gli agenti sociali dispiegano nella condotta
comune della loro esistenza» (Petrillo e Tarantino 2015, 18-19).
Per cogliere ciò, infatti, non potevamo replicare, durante il nostro lavoro qualitativo, il dirigismo del
questionario, e, allo stesso tempo, non potevamo, se il fine era quello di avere delle ricadute applicative
�e fornire dati utili per influenzare le politiche amministrative in materia di inclusione sociale, condurre
interviste governate da un puro lassair-faire, come alle volte capita nella pratica etnografica (Petrillo e
Tarantino 2015). I nomi delle persone al centro del prossimo paragrafo ovviamente non corrispondono
al reale. Si tratta in fondo di confidenze, anche di minori, che ci raccontano diverse e molteplici
difficoltà di esistere. Sono confidenze che da private, mettendole qui per scritto, rendiamo pubbliche.
Per questo siamo stati costretti per prima cosa a trovare dei modi per proteggere chi si è affidato a noi –
cambiando per esempio i nomi di luogo e di persona e mettendo loro al riparo dei pericoli ai quali
avremmo esposto la loro parola abbandonandola, senza protezione, ai travisamenti di senso. Non
abbiamo d’altronde mai voluto considerare i nostri interlocutori delle cavie, degli oggetti da laboratorio
e la nostra non è mai stata una «curiosità entomologica» (Petrillo e Tarantino, 2015, 38). Allo stesso
tempo, però, come vedrete nel prossimo paragrafo, non potevamo nemmeno appiattirci alle parole dei
nostri interlocutori, ma dovevamo metterle dentro un ordine del discorso laddove loro stessi avevano
difficoltà a inquadrale da un punto di vista «culturale» (Gertz 1973).
2. Che cosa è un diritto?
Io credo che il precariato sia uno status sociale. È un male che ci accompagna e ci
accompagnerà e bisogna conviverci e sopportarlo.
Questa frase è stata pronunciata da Angelo, ventinovenne impegnato col Servizio Civile, nel corso di
un’intervista riguardante il suo rapporto con il lavoro, le sue esperienze e le sue percezioni. Quest’
intervista, come altre rivolte ad alcune donne e uomini di età compresa tra i 18 e i 34 anni residenti a
Bologna, ha avuto la funzione d’integrare i dati raccolti attraverso i questionari, come già detto.
Un’integrazione intesa come rapporto dialettico tra la parte quantitativa e quella qualitativa della ricerca,
dove quest’ultima ha approfondito, cercando conferme, smentite o diverse sfumature, i temi principali
emersi dalla lettura dei questionari restituiti. La stessa funzione hanno avuto i tre focus group condotti
dai ricercatori con due gruppi di studenti medi di istituti professionali bolognesi e uno con ragazze
straniere per nascita o per origine familiare e frequentatrici del Centro interculturale Zonarelli di
Bologna.
Oltre all’indagine sul tema generale, un passaggio comune a tutte le interviste e ai focus group è stato
il coinvolgimento dei soggetti in una sorta di “gioco partecipativo” in cui a ognuno veniva chiesto di
scrivere tre parole che meglio di altre, a parer loro, intercettavano le percezioni personali sul tema
lavoro; dalla scelta delle parole è sempre nata una discussione tra intervistati e ricercatori. Nei primi due
casi in cui il gioco è stato sperimentato nel corso della ricerca – i due focus group con gli studenti
d’istituti professionali –, nessuno dei componenti del gruppo ha pensato di associare la parola “diritti”
al concetto di lavoro. Rilevata la pregnanza di questo esito, abbiamo deciso di porre l’attenzione su
�questo dato in tutte le interviste e i focus che ci restavano da realizzare. Come nei primi due casi così in
tutti quelli successivi, nessuno ha associato spontaneamente i concetti “diritti” e “lavoro”; di
conseguenza chi ha condotto le interviste ha provato “artificiosamente” a stimolare una discussione e a
raccogliere osservazioni sul rapporto tra i due concetti.2
Torniamo ora alla frase iniziale e proviamo a spiegare perché abbiamo da subito considerato i
pensieri di Angelo sul precariato come una buona sintesi del modo in cui i giovani oggetto della nostra
ricerca percepiscono e sperimentano il rapporto tra diritti e lavoro. Nelle sue parole la condizione di
lavoratore precario non viene considerata transitoria e eccezionale ma è accettata con serena
rassegnazione come si fosse davanti a un fenomeno naturale. Una relazione contrattuale con il datore di
lavoro che non prevede una serie di tutele previdenziali e assistenziali ed è invece segnata dalla
conoscenza della data di estinzione della relazione stessa, secondo Angelo non rappresenta più una
deroga. È bensì uno status sociale, quindi una situazione che deborda il mero rapporto di lavoro per
identificare una condizione esistenziale. Il rapporto con essa ha perso il carattere della conflittualità per
fare posto alla convivenza e alla sopportazione. Non possiamo dire che Angelo sostenga questo
cambiamento, ma si è arreso all’evidenza dell’ineluttabilità. Quanti sono a pensarla come Angelo? E
come sono arrivati a pensarla così?
Il 54% delle persone che hanno risposto al questionario aveva un’occupazione nel momento in cui
lo compilava. Di questi il 46.8% aveva un contratto a tempo indeterminato, il 19.2% era occupato a
tempo determinato. L’impiego più diffuso è nel settore del commercio – 19.9% – seguito a breve
distanza dalla pubblica amministrazione – 18.6%. Come ha già evidenziato Matilde Callari Galli nel
capitolo di apertura a questo volume, alla domanda “Qual è il tuo lavoro ideale?” il 35,5% ha dichiarato
“di non avere preferenze e che giudicherà in base alle alternative che gli si presenteranno.” Solo il 9,7%
ha indicato un’attività imprenditoriale, contro il 27% delle preferenze verso un lavoro dipendente.
Un lavoro purché sia, meglio se dipendente; scarso il fascino dell’imprenditorialità. Un quadro che si
potrebbe commentare così: al rischio d’impresa i giovani preferiscono il rischio di avere un lavoro
dipendente “qualsiasi”, anche distante dalle proprie aspirazioni professionali e dalle aspettative
retributive e previdenziali. Il sentimento che prevale e che ha serpeggiato in tutte le interviste individuali
e di gruppo è quello della rassegnazione consapevole a un mercato del lavoro ostile e poco penetrabile
soprattutto per le nuove generazioni.
2.1 I giovani, i diritti e l’odio per la politica
2
Uno dei ricercatori si è inserito nel gioco e ha proposto anch’egli delle parole associate all’idea di lavoro; una di queste era
“diritti” sottolineando il fatto che nessuno l’avesse scelta e chiedendo all’intervistato o ai componenti del focus group di
commentare il fatto.
�Nel corso del primo focus group, condotto con dieci studenti dell’Istituto professionale Fioravanti
di Bologna, il momento del sopracitato “gioco delle tre parole” era stato preceduto da una discussione
connotata da un atteggiamento di sfiducia degli studenti verso la situazione economica, sociale e politica
italiana. In prima battuta molti attribuivano alla mancanza di fondi e a una generale inadeguatezza
dell’istituzione scolastica l’impossibilità di disporre di attività laboratoriali necessarie a una formazione
pratica indispensabile a una migliore preparazione per il mercato del lavoro.
Tutt’oggi se hai voglia di fare tanto e di imparare sempre di più un posto di lavoro lo trovi in
Italia, anche con la crisi. Se vado in azienda e dico non so far niente e arriva quell’altro che ha voglia
di fare, sa già qualcosa, ha già le basi per migliorare, prendono l’altro ovviamente. (Matteo,19 anni)
Conta più la mancanza di fondi, perché se sei preparato trovi lavoro anche se c’è crisi. (Luca, 18
anni)
Nondimeno, la critica ha spesso toccato lo stato delle cose nel Paese che induce molti a sposare
progetti migratori verso altri paesi – Stati Uniti, Canada, Germania –, se non addirittura verso il Sud
Italia considerato più accogliente e solidale. La difficoltà ancora maggiore di trovare lavoro nel
Meridione, secondo gli studenti, viene compensata infatti da una più agevole sussistenza. Un
ragionamento che fa precipitare l’orizzonte delle aspettative dalla realizzazione professionale alla mera
sopravvivenza.
Io ho due possibilità: il Nord che è Bologna e il Sud dove sono nato. Vorrei provare a mandare
qualche curriculum anche a Foggia. Giù anche se vai lavorare nei campi, a raccogliere i pomodori, le
olive, riesce a prendere qualcosa, riesci a campare. Da mangiare trovi, chi ti da un piatto di cime di
rape lo trovi. A Bologna non è così. (Michele, 20 anni)
Il clima generale della discussione con e tra i partecipanti al focus group non è cambiato quando
l’attenzione è stata spostata dalle aspettative e dalle prospettive al retroterra individuale e familiare.
Abbiamo registrato un apprezzamento ossequioso per gli sforzi dei propri genitori, unito a una piena
consapevolezza delle difficoltà economiche familiari. Sono emersi casi in cui problemi lavorativi
personali si intrecciano con la spietatezza del mercato del lavoro all’epoca della crisi economica globale
e con la mancanza di scrupoli di alcuni datori di lavoro: storie di diritti negati senza possibilità di tutela,
così come vengono raccontate dagli studenti intervenuti al focus group.
Mio padre è in una ditta che sta fallendo e gli hanno pagato i contributi gli hanno tolto dei soldi
in busta paga. Mia mamma continua a lavorare in un posto dove viene trattata male, ha un
�problema alla pelle per il lavoro che fa, ma ha 54 anni ha la terza media, non può andare da nessuna
altra parte. Stessa cosa mio padre, non può licenziarsi, ha la terza media, ha fatto sempre il
muratore, il camionista non può licenziarsi, ha bisogno di portare i soldi a casa per riuscire a
mangiare […]. Mia madre ha portato i certificati che non può fare quel lavoro le hanno detto o le va
bene così o si può cercare un altro lavoro […]. Mio padre mi sono accorto che non ha più quel
sorriso che aveva quando ero bambino per colpa di quella persona [il datore di lavoro. N.d.a.] mi
viene voglia di andare là e di sputargli in faccia. Sono 17 anni che è la, non ha mai fatto un giorno di
mutua, si è tagliato un dito con una sega circolare, gli sono caduti 500 chili su una mano, era l’unico
che aveva la patente di camion e ha lavorato sempre non è mai stato aumentato di livello gli sono
stati tolti dei soldi che prendeva fuori busta e lui ha deciso di non guidare più il camion e il camion
è stato sequestrato perché questa persona ha 20 milioni di buco. Ha tolto 500 euro in busta paga a
mio padre e poi si è comprato una villa da due milioni di euro. (Giacomo, 19 anni)
Questa storia è stata per esempio accolta con acquiescenza dai partecipanti al focus group: alcuni
hanno annuito in silenzio, altri hanno esplicitato esperienze comuni. Appare evidente che fragilità
economiche e difficili condizioni di lavoro appartengano al bagaglio familiare di ognuno. Altrettanto
palese è il malcontento che ha sempre serpeggiato nei loro discorsi, un quadro che lascia presagire
espressioni di rabbia sociale – verbali, nel contesto del focus group – indotti da un vissuto condiviso di
diritti negati; ma, come detto in apertura, alla richiesta di associare pensieri a quello del lavoro se sono
emersi concetti quali “sacrificio”, “impegno”, “preparazione” sono sempre mancati invece riferimenti ai
diritti. Sollecitati a esprimersi su questo tema gli studenti si sono mostrati tutt’altro che estranei
all’argomento, e, nonostante la giovane età – nessuno supera i 20 anni –, a prevalere è sempre stato un
senso di “sconfitta preventiva” che inibisce qualunque forma di rivendicazione.
Siamo abituati a quello che c’è adesso, i diritti sono quelli che ci sono e non puoi cambiarli.
(Michele, 20 anni)
A queste parole di Michele hanno fatto eco quelle di tutti gli altri partecipanti al focus group, e la
discussione è spesso diventata un’esternazione corale di consapevolezza dell’impossibilità del
cambiamento. Le considerazioni che abbiamo registrato non sono solo una riproposizione di discorsi
origliati, ma partono da un’osservazione del proprio tempo e della realtà politica non solo nazionale.
Infatti non mancano i riferimenti critici a politiche aziendali e sindacali e a leggi statali, ma l’esito
conclusivo rimane la sfiducia nella possibilità di cambiamento.
Le aziende usano le limitazioni dei diritti; adesso come adesso non ti puoi lamentare, il tuo
diritto è di stare zitto e accettare quello che ti viene dato. Adesso che c’è il Job Act, non puoi
lamentarti che il tuo datore di lavoro ti licenzia. Gente è stata licenziata per una protesta. È un
�modo per avere più potere e schiavizzare la gente. Fino a poco tempo fa funzionava, mio padre era
un lavoratore un onesto cittadino che paga le tasse se si doveva lamentare si lamentava, Cgil e tutte
queste cose qua. Ma adesso co’ ‘sti governi non so se la gente può dire “Ho il diritto di fare quello
ho il diritto di fare l’altro”. Non hai più quelle libertà. In Germania invece che pompano soldi dalla
mattina alla sera, non hai neanche bisogno di lottare perché sai che stai lavorando per il tuo Paese.
In Italia non ha senso lottare perché ai piani alti non ti ascoltano. (Giacomo, 19 anni)
Tra gli studenti intervenuti era presente un giovane di origine marocchina, evidentemente informato
sulle vicende politiche dei paesi del Nord Africa e arabi in generale. Per argomentare il suo giudizio
sull’ineluttabilità della situazione italiana e sull’inutilità di atti di ribellione per ristabilire principi di
giustizia sociale ha chiamato in causa le rivolte della Primavera araba.
Per esempio vedi che è successo con la Primavera araba, la gente si è ribellata ci son stati scontri,
sono morte persone. È andata, in Libia c’era una dittatura la gente si è ribellata e adesso che
succede? C’è un’altra dittatura. Cos’è successo in Egitto c’è stata una rivolta, elezioni liberatorie, ha
vinto una persona, dopo tre mesi l’han tolta. In Tunisia stessa cosa, anzi peggio perché sono morte
delle persone. (Bilal, 19 anni)
Il campione di giovani residente a Bologna coinvolto nella parte quantitativa della ricerca ha dovuto
rispondere nel questionario alla seguente domanda: “L’attuale situazione del nostro Paese è
comunemente definita come una situazione di crisi: quanto ritieni che i seguenti elementi influiscano su
di essa?” Il 100% del campione ha risposto “I politici e la politica” con percentuali così distribuite: il
75,8% “molto”, il 20,4% “abbastanza”, il 3,8% “poco”. Nessuno ha risposto “per nulla”. Altrettanto
netto il giudizio sulla corruzione, “molto responsabile” per l’88%; sull’illegalità – 65% “molto
responsabile”; sull’evasione fiscale – 72% “molto responsabile”. Altri due dati relativi a questo item
possono essere utili a individuare meglio l’approccio dei giovani al tema lavoro e diritti: l’85% ritiene
che la responsabilità della crisi sia attribuibile alla crescita delle disuguaglianze – il 50% “molto”, il 35%
“abbastanza”; il 74,2% – 36,3% “molto”, 37,9% “abbastanza” – vede un’influenza nel “fatto che le
generazioni precedenti non lascino spazio ai giovani”.
La crisi che impedisce di trovare lavoro, vista con gli occhi dei giovani bolognesi, è frutto del
malgoverno di una classe politica di cui non è possibile fidarsi. L’avversione verso politica e politici
colora una visione della società molto negativa, un contesto senza regole, dove le istituzioni sono
troppo lontane per sanare le disuguaglianze e domina la legge del più forte. E per la maggioranza i più
forti sono “i più vecchi”, le generazioni precedenti che hanno goduto di privilegi che non sono stati in
grado di trasmettere e che ora non favoriscono l’accesso alle opportunità di realizzazione professionale
dei giovani. Forse è proprio questo ultimo aspetto a dare meglio il senso della lontananza del tema dei
�diritti nel paradigma interpretativo delle giovani generazioni della situazione di crisi. Il conflitto è
generazionale mentre quello “naturale” tra lavoratore e datore di lavoro è neutralizzato da precarietà e
interventi legislativi e sempre più spostato da un piano collettivo oggettivo normato a un piano
soggettivo esistenziale individuale dove i diritti hanno difficile cittadinanza.
Non sono solo i giovani studenti dell’istituto professionale Fioravanti a pensarla così. L’incontro con
gli studenti di un altro professionale a indirizzo chimico, il Belluzzi, porta risultati simili. La parola diritti
anche in questo caso non è stata associata spontaneamente al lavoro, ma solo in seguito alla
sollecitazione di noi ricercatori. Le esperienze individuali appaiono meno connotate dall’asprezza di
difficoltà economiche familiari, ma ciò non basta a mitigare il senso di sfiducia verso il riconoscimento
del diritto al lavoro. Questo emerge soprattutto in relazione all’ipotesi di emigrazione a fini lavorativi.
In Italia avrei un lavoro sottopagato dove non posso dimostrare le mie capacità, dove sarei
discriminata in ambito lavorativo perché persone con più conoscenze [intese come relazioni, n.d.a.]
di me avrebbero un lavoro migliore. La situazione economica e politica non è delle migliori. Mi
dispiace lasciare Bologna, ma preferirei vivere all’estero per poter avere un bello stipendio, una bella
casa, fare una famiglia e non avere problemi dal punto di vista economico. (Arianna, 18 anni)
Vorrei rimanere in Italia e stare vicina alla mia famiglia. In Italia si starebbe bene, ci sarebbe
lavoro, ma chi gestisce la politica non pensa agli altri, non crea opportunità, se ne frega diciamo.
(Barbara, 18 anni)
Come i loro colleghi dell’istituto Fioravanti anche gli studenti del Belluzzi intervenuti al focus group
chiamano in causa il Job’s Act e investono l’attuale classe politica dirigente di responsabilità circa la
scarsa fiducia nel loro futuro professionale. Il deus ex machina è una generica “rivoluzione” che metta
fine al malaffare di quella che viene percepita come una casta prevaricatrice e menzognera. Il
giornalismo televisivo di inchiesta è ritenuto più affidabile dei governanti.
Renzi nei suoi comizi o nelle presentazioni di progetti di governo, come il Job’s Act, lui da
quanto dice sembra essere molto propositivo e che l’Italia grazie alle sia manovre riuscirà a uscire
dalla crisi ma programmi come “Report” o “Presa Diretta” hanno di fatto vedere, anche grazie ai
dati Istat che le percentuali che lui prometteva sull’occupazione non si sono ricreate. In questo
modo i cittadini vengono influenzati dalla politica, si instaura un pensiero di rinascita dell’economia
italiana ma alla fine tutto quello che viene detto non è quello che succede. (Barbara, 18 anni)
In Italia la costituzione dice che ogni cittadino italiano deve avere un lavoro e una casa, ma
nonostante sia una delle prime leggi della Costituzione non viene rispettata. (Arianna, 18 anni)
�Ci vorrebbe una rivoluzione qua in Italia qualcuno che smuova tutto perché non se ne può più.
Ci vuole qualcosa di nuovo che migliori tutto. Cosa fanno i politici? Dicono di dare un lavoro alla
gente, ma adesso rubano. Quanti disoccupati ci sono adesso? Troppi, più della metà della
popolazione disoccupata, va contro i diritti dell’uomo. Non c’è lavoro, la gente si suicida o va a
rubare, spaccia… . (Alice, 18 anni)
2.2 I diritti e il merito
Il tema dei diritti si intreccia con quello del merito, componendo con esso una dicotomia apparente.
Alla domanda presente nel questionario “Cosa potrebbe esserti utile per migliorare le tue prospettive
future?” Il 63,7% – nel questionario era possibile dare più risposte – ha risposto “una società più
meritocratica”, mentre il 50% ha risposto una riforma del mercato del lavoro. I giovani si sentono
deprezzati, non valorizzati nelle loro capacità e, come abbiamo visto, percepiscono una società corrotta
e dominata dall’illegalità dove le relazioni contano più delle competenze. Sanare questa disfunzione è
nell’orizzonte comune dei giovani intervistati più che far valere i propri diritti in ambito lavorativo. A
tutto questo fa cenno anche una donna molto ben inserita nel mercato del lavoro e pienamente
soddisfatta della sua condizione come la digital manager. In un contesto di guerra tra poveri, tutti contro
tutti, il merito si confonde con l’asservimento, con buona pace dei diritti.
Purtroppo questo per me è una conseguenza di questo mercato del lavoro di adesso, nel senso
che è assolutamente un mercato del bestiame, purtroppo, e che quindi ti porta a tra virgolette
sacrificare tutto pur di avere un posto che ti dà uno stipendio, motivo per cui si sono degradate
parecchie professioni, parecchi lavori che richiedono anche un certo tipo di preparazione e
competenze molto verso il basso e quindi si accetta di tutto e di più. Secondo me i diritti vanno
assolutamente rispettati nel senso che non è merito il fatto di stare lì fino alle 9 di sera, ma, secondo
me, nell’arco della giornata lavorativa lavorare sodo e portare a casa quelli che sono gli obiettivi che
gli sono stati affidati […] Questa è una logica molto italiana-barra-milanese, bisogna stare lì fino alle
9 di sera perché bisogna dimostrare che… secondo me è una logica un po’ contorta perché se
andiamo a guardare cosa succede nei paesi del Nord ad una certa ora alle 4 del pomeriggio cade la
penna, tutti vanno a casa anche perché comunque c’è il rispetto di quello che è la vita privata, la vita
familiare e la vita che uno deve fare al di fuori dell’ambiente lavorativo. (Adele, 33 anni)
Sul rapporto di lavoro inteso come sfruttamento e sulla competizione al ribasso tra i giovani
possiamo richiamare in causa Angelo, il ventinovenne che abbiamo citato in apertura di questo
paragrafo.
�Credo che più che lavoro si tende a sfruttare l’attività di una persona, non c’è la logica del
rapporto di lavoro inteso come momento in cui uno da il proprio tempo per una determinata
attività e quella deve essere ricompensata. Anche il contratto a tempo indeterminato ora è
indeterminato solo sulla carta. Il datore di lavoro tende a sfruttare le occasioni che la
regolamentazione del lavoro propone e quando le agevolazioni finiscono vai via e vieni sostituito da
un’altra persona che è disposta a accettare quelle condizioni.
2.3 Lo sguardo dei giovani stranieri
Allo scopo di sopperire parzialmente alla esiguità di risposte al questionario da parte di giovani
stranieri, sono state condotte alcune interviste e focus group con donne e uomini tra i 18 e i 34 anni
stranieri di nascita o di origine familiare. Così come i giovani italiani anche tali interlocutori sono stati
sollecitati sulla relazione tra lavoro e diritti. Nelle loro osservazioni si leggono le influenze di esperienze
determinate dalla cultura del paese di origine.
Il focus group in questione è stato realizzato al Centro Interculturale Massimo Zonarelli di Bologna
e ha visto la partecipazione di sei ragazze di età compresa tra i 18 e i 24 anni originarie di Marocco,
Egitto e Somalia. La discussione in questo caso è stata incentrata, per loro scelta, sul modo in cui ha
influito sulle esperienze lavorative la decisione di ognuna di loro di indossare l’hijab, il velo che copre il
capo delle donne musulmane praticanti. In particolare due ragazze hanno raccontato di essere state
messe davanti a una scelta dai datori di lavoro: togliersi il volo o rinunciare al posto. Entrambe hanno
deciso di tenere fede a una scelta che definiscono non religiosa ma identitaria e cercare lavoro altrove.
Lavoravo da Y. [negozio di abbigliamento, n.d.a.] da un anno, quando hanno visto che avevo il
velo mi hanno richiamato e mi hanno detto che non si poteva perché il lavoro nei negozi è tutto
basato sull’aspetto e dato quello che è successo in Francia e tutto mi hanno chiesto di toglierlo.
Allora ho fatto altri lavori, come baby sitter e adesso sono a casa. (Zaineb, 19 anni)
Se vai da un’estetista a chiedere lavoro ti dice nel negozio conta la presenza, puoi pesare anche
200 kg, ma il velo conta. A me ha detto mi dispiace sei tanto carina, ma il velo ti penalizza. Io non
mi faccio fermare e gli ho detto se io il lavoro lo faccio bene a te cosa te ne frega se ho il velo e lei
mi ha risposto da me vengono molte vecchie e sai parlano… . (Malika, 18 anni)
Come quelle ascoltate da Angelo e dai ragazzi dell’istituto Fioravanti anche le loro storie raccontano
diritti negati, come quelle di Zaineb e Malika. Diverse perché fortemente connotate da aspetti peculiari
dell’identità culturale di queste ragazze. Il mercato del lavoro rimane “il mercato del bestiame” di cui
parlava Adele, ma le ragazze dello Zonarelli non sono disposte a tutto pur di lavorare; il ricatto del
mercato del lavoro bloccato che spinge, almeno idealmente, i giovani bolognesi ad accettare condizioni
di lavoro difficili si ferma davanti alla forza di una scelta identitaria. Piuttosto, quello che accomuna le
�loro storie a quelle dei loro coetanei è la percezione della tutela dei diritti come un episodio individuale
e non come un’esperienza collettiva; anche in questo caso la rivendicazione non si sposta nel campo del
diritto al lavoro.
Se le esperienze di discriminazioni subite dalle ragazze dello Zonarelli hanno quasi sempre tenuto il
discorso su lavoro e diritti nello stesso solco tracciato nelle altre interviste citate, la discussione con una
giovane russa, Oksana, arrivata a Bologna insieme al suo compagno studente, ci ha offerto uno sguardo
del tutto differente.
In Russia non esiste per sempre. A me fa ridere che qua c’è questa idea di lavorare per sempre,
in Russia nessuno vuole lavorare per sempre nello stesso posto. È al contrario, se tu lavori per
sempre nello stesso posto vuol dire che sei una persona poco dinamica. Nessuno vuole firmare un
contratto per sempre, ma comunque non è proprio possibile. In Russia è molto facile licenziare una
persona, puoi avere anche un contratto a tempo indeterminato, ma non significa niente. Qua non si
trova facilmente lavoro anche perché è troppo difficile licenziare una persona, troppa burocrazia,
troppe spese per l’imprese […]. Un impiegato costa troppo per l’impresa, uno che guadagna 1000
euro ne costa 2000 […]. Per questo il proprietario ha paura di assumere e i giovani non trovano
lavoro. Però è vero che in Italia è normale lavorare gratis per un anno, fare tirocini ecc. in Russia
non è possibile. (Oksana, 27 anni)
Nel momento in cui è stata realizzata l’intervista, Oksana era arrivata a Bologna da pochi mesi e
dopo una breve ricerca era riuscita a trovare una combinazione di due occupazioni che riusciva a
soddisfare le sue esigenze di dinamicità, di neo-madre e di retribuzione. Il punto di vista sul rapporto
tra lavoro e diritti anche in questo caso non è scaturito spontaneamente ma è stato sollecitato dai
ricercatori. Come abbiamo visto per le ragazze del Centro Interculturale, il pensiero di Oksana è
fortemente influenzato dalla condizione di straniera e dal retroterra culturale del suo paese d’origine. Il
legame tra lavoro e diritti esiste ed è problematico, ma in una prospettiva ribaltata poiché sono le
eccessive tutele dei lavoratori a bloccare il mercato del lavoro e a creare l’imbuto nel quale i giovani non
riescono a passare. La visione di Oksana è figlia di una società che, dopo la fine dell’era socialista
dell’Unione Sovietica, sta vivendo pienamente una fase neoliberista con la conseguente
deregolamentazione del mercato del lavoro3; ma, secondo la giovane russa, è proprio questo
alleggerimento delle regole a creare quella mobilità in entrata e in uscita che favorisce chi è in cerca di
una prima occupazione. Al di là delle considerazioni ideologiche, colpisce la differenza di prospettiva di
Olga rispetto ai suoi coetanei italiani.
3
La fine dell’Urss, l’avvento del capitalismo e il suo impatto sulla società russa è un tema che per la sua complessità non è
possibile affrontare in questa sede. Prova ne sia il fatto che, secondo alcuni osservatori, l’attuale governo russo stia
riconsiderando l’adozione delle ricette economiche neoliberiste, come è possibile leggere in questo articolo di Paul Craig
Roberts e Michael Hudson http://www.counterpunch.org/2016/08/11/will-russia-reject-neoliberalism/
�L’85,6% – 41,2% “abbastanza”, 44,4% “molto” – del campione anagrafico si è detto d’accordo con
l’affermazione che oggi non è possibile avere “tutto e subito”. Come abbiamo visto i giovani bolognesi
pensano che dovranno accontentarsi di una serie di lavori intermedi coltivando la speranza, spesso
vana, del lavoro ideale che, in qualche modo, corrisponde ancora all’idea del “posto fisso”. Per Oksana,
invece, l’insicurezza strutturale del mercato del lavoro russo si traduce in una moltiplicazione delle
opportunità, un rischio che non viene vissuto come tale in uno scenario in cui le tutele sono scomparse
all’orizzonte.
Gli studenti del Fioravanti e del Belluzzi hanno visto nelle nuove leggi sul lavoro una parte di
responsabilità della crisi occupazionale manifestando l’amara consapevolezza dell’irreversibilità di un
processo in cui si sentono vittime predestinate. Mettendo a confronto questo punto di vista con i
commenti di Oksana sulla situazione italiana, questi sembrano avere il carattere della visione profetica.
Come se la ragazza russa vivesse in una proiezione futura di quello che i coetanei italiani vivono oggi:
lei a proprio agio con l’incertezza, gli altri in bilico tra consapevolezza e rassegnazione.
Conclusioni
Il ritratto che emerge, in questa direzione, assomiglia molto a quello che, venticinque anni addietro,
con assoluto sguardo anticipatore, ci consegnarono i ricercatori e le ricercatrici di “Misère du Monde”:
In Francia […], la situazione era diversa; a partire dagli anni Sessanta, una lunga serie di
inchieste, rapporti, studi e analisi aveva ricordato bruscamente ai francesi il carico di promesse non
mantenute dello Stato sociale postbellico: uno di loro ogni dieci (se ci si limitava al disadattamento
sociale) e uno ogni cinque (se si tenevano in conto anche gli stati più gravi di malattia fisica e
mentale) faceva parte dell’“altra nazione”, gli “esclusi” (Lenoir 1974) […]. Ma non è questa la
Francia che parla ne “La miseria del mondo”: a prendere parola sono qui “cittadini” che, pur
avendo conseguito l’accesso a tuti i livelli almeno basici di benessere e di diritti (casa popolare,
pensione, salario minimo, istruzione gratuita), cominciano a intravedere dinnanzi ai propri occhi lo
sgretolarsi dei miti novecenteschi di integrazione e mobilità sociale e avvertono di essere spinti
sempre di più verso i margini della vita civile e politica: “miseria di posizione”. (Petrillo e Tarantino
2015, 22)
Allora, ci siamo detti, perché non anticipare anche noi lo sguardo su quello che potrebbe riservarci il
futuro come abitanti di questa parte del mondo occidentale.
Quando vedrete la tensione accumulata nelle periferie delle grandi città esplodere in rabbia
sorda, dentro il vicinato forzato di individui appartenenti a generazioni, culture, condizioni sociali
ed “etnie” differenti: quando osserverete i primi effetti del ritrarsi dello Stato e della nozione di
�“pubblico” dall’esperienza sociale o gli esiti della ristrutturazione del mercato del lavoro in termini
di disoccupazione e precarizzazione e ne misurerete la forza d’urto e i costi esistenziali e psicologici
sulle biografie singolari non solo di operai e contadini, ma anche di commercianti, artigiani e piccoli
imprenditori; quando ascolterete studenti e insegnanti raccontare il naufragio annunciato della
scuola di massa e coglierete i sintomi della tensione strutturale che pervade le famiglie, nello sforzo
impossibile di conciliare i modelli di consumo e reddito, l’educazione dei figli con una mobilità
sociale sempre più bloccata […]. Queste e altre riuscite “profezie” - la disillusione dei “salariati” nei
confronti di partiti e sindacati, l’irresistibile ascesa di partiti e movimenti sciovinisti e xenofobi, la
banalizzazione e la progressiva caduta di tono del discorso dei media, la personalizzazione della
politica (“i futuri dirigenti sono designati nei dibattiti televisivi e nei conclavi di apparato”),
l’avvento dei tecnocrati nel governo della cosa pubblica… . (Petrillo e Tarantino, 2015, 23)
Cosa è successo in questi ultimi venticinque anni? Oggi, come allora, non conosciamo il nostro
futuro. Per questo, come gruppo di ricerca, dobbiamo chinarci umilmente ad ascoltare il reale poiché
solo così possiamo coglierne l’invisibile, ossia ciò che, pur reale, visibile non è ancora; e quale soggettooggetto migliore allora se non quello delle nuove generazioni che abitano le nostre città?
Le parole dei protagonisti della ricerca, come abbiamo visto nel precedente paragrafo, toccano
diversi temi pur avendo scelto noi di concentrare lo sguardo sul concetto di “diritto”. Ci riportano a un
mondo complesso e molteplice e sono cariche di contraddizioni e visioni alle volte inconciliabili tra
loro. In questa direzione abbiamo da subito scelto di ridare al lettore tale complessità poiché questa,
secondo noi, non ha nulla a che fare con un relativismo estremo; all’opposto le parole dei protagonisti
della ricerca rimandano tutte a un unico mondo, quello per l’appunto delle piccole e giovani miserie.
Quando abbiamo discusso con loro il tema dei diritti ci siamo da subito resi conto di come, in più di
un caso, la persona intervistata approfittasse dell’occasione per interrogarsi su se stessa, ovvero
esattamente l’opposto dell’effetto che produce su di loro l’inchiesta condotta attraverso il sondaggio e il
questionario che, nell’illusione di perseguire una neutralità, forzano l’interlocutore a rispondere in modo
artefatto. In questo senso possiamo dire che forse, come studiosi e ricercatori, dovremmo cominciare a
svolgere il nostro lavoro come fossimo veri e propri medici se vogliamo capire quello che sta
succedendo nella nostra città.
Si è spesso paragonata la politica alla medicina. Basta rileggere la ‘collezione ippocratica’, come
ha di recente fatto Emmanuel Terray, per scoprire che, come il medico, anche il politico coerente
non può accontentarsi delle informazioni fornite dalla registrazione di dichiarazioni che, in più di
un caso, sono letteralmente prodotte da un’interrogazione inconscia dei suoi effetti: “La cieca
registrazione dei sintomi e delle confidenze dei malati è alla portata di tutti: se questo fosse
sufficiente per intervenire efficacemente, non ci sarebbe bisogno di medici”. Il medico deve
impegnarsi a scoprire le malattie non evidenti, ossia, precisamente, quelle che non può “né vedere
�con i suoi occhi, né sentire con le sue orecchie”: infatti le lamentele dei pazienti sono vaghe e
incerte; i segnali emessi dal corpo sono oscuri e rivelano il loro senso solo molto lentamente. E,
quindi, al ragionamento che bisogna chiedere la rivelazione delle cause strutturali […]. La vera
medicina, sempre secondo la tradizione ippocratica, comincia con la conoscenza delle malattie
invisibili, ossia dei fatti di cui il malato non parla, o perché non ne è consapevole, o perché si
dimentica di confidarli. Lo stesso vale per una scienza sociale preoccupata di conoscere e
comprendere le vere cause del disagio, che si manifesta solo attraverso segni sociali difficili da
interpretare, perché apparentemente troppo evidenti”. (Petrillo e Tarantino, 2015, 852-853)
�Bibliografia
Barberi P., a cura di, 2010, È successo qualcosa alla città, Roma, Donzelli
Barnao C., 2004, Sopravvivere in strada: elementi di sociologia della persona senza dimora, Milano, Franco
Angeli
Bergamaschi M., Guidicini P., Pieretti P., 2004, L’urbano, le povertà: quale welfare: possibili strategie di lotta
alle povertà urbane, Milano, Franco Angeli
Bonadonna F., 2001, Il nome del barbone: vite di strada e povertà estreme in Italia, Roma, Derive Approdi
Bourdieu P., 1990, Un signe des temps, in “Actes de la recerche en sciences sociales”, n.81-82,
L’économie de la maison
Bourdieu P., 2005, Il senso pratico, Armando, Roma; ed. or. Le Sens pratique, Minuit, Paris
Bourdieu P., Wacquant L.J.D., 1992, Risposte. Per un’antropologia riflessiva, Torino, Bollati Boringhieri,
ed. eor. Réponses. Pour un’anthropologie réflexive, Paris, Seuil, 1992
Bourgois P., 1996, In Search of Respect: Selling Crack in El Barrio, Cambridge, Cambridge University
Press; (trad. it. 2003)
Callari Galli M., a cura di, 2007, Mappe Urbane. Per un’etnografia della città, Rimini, Guaraldi
Callari Galli M., 2013, a cura di, Vedere la povertà, Milano, Unicopli
Cancellieri A., Scandurra G., a cura di, 2012, Tracce Urbane, Roma, Franco Angeli
Castel R., 1978, La “guerre à la pauvreté” aux États-Unis : le statut de l’indigence dans une société d’abondance,
in “Actes de la recerche en sciences sociales”, n.19, La guerre à la pauvreté, pp. 47-60
Colombo A. (1998) Etnografia di un’economia clandestina. Immigrati algerini a Milano, Bologna, Il Mulino
Fabietti U., 1999, Antropologia culturale, Roma-Bari, Laterza
Geertz C., 1973, Toward an Interpretative theory of culture, in the Interpretation of Cultures, New York, Basic
Books; trad. it. Interpretazione di culture, Bologna, Il Mulino, 1987
Lenoir R., 1974, Les exclus. Un Français sur dix, Seuil, Paris
Pavarin R.M., a cura di, 2006, Disagio sociale e marginalità a Bologna, Roma, Carocci
Petrillo A., Tarantino C., 2015, a cura di, Pierre Bourdieu. La miseria del mondo, Milano, Mimesis
Riccio B., Scandurra G., 2008, Citizenship: anthropological approaches to migration and social exclusion, in
Koen De Feyter, Georhe Pavlakos, eds., The Tension Between Group Rights and Human Rights. A
Multidisciplinary approach, Oxford, Hart Publishing
Scandurra G., 2005, Tutti a casa. Il Carracci: un’etnografia dei senza fissa dimora in Italia, Rimini, Guaraldi
Scandurra G., 2007, Il Pigneto. Un’etnografia fuori le Mura di Roma, Padova, Cleup
Scandurra G, 2007a, Il Carracci: memorie di un rifugio urbano, in Mappe urbane, a cura di, M. Callari Galli,
Rimini, Guaraldi
Scandurra G., 2012, Esiste una “cultura” della povertà, in “Archivio antropologico Mediterraneo”,
�anno XV (2012), 14 (2)
Scandurra G., 2013, Che cosa è la povertà, in Matilde Callari Galli, a cura di, Vedere la povertà, Milano,
Unicopli
Signorelli A., 1996, Antropologia urbana. Introduzione alla ricerca in Italia, Milano, Guerini
Sobrero A., 1992, Antropologia della città, Roma, Nuova Italia Scientifica
Tarantino C., 2013, L’ascesa tendenziale del saggio di profitto. Preliminare a uno studio sulla democrazia
proprietaria, in G. Cosenza, E. Fadda, A. Givigliano (a cura di), Un’idea di Bourdieu. Campi e pratiche tra
filosofia e scienze, Aracne, Roma, pp. 77-91
Tarantino C., 2014, Lo In e lo Im. Particole di sociologia, in ID., A. Givigiano (a cura di), La possibilità
sociale, Quodlibet, Macerata, pp. 15-31
Tosi Cambini S., 2005, Gente di sentimento: Per un’antropologia delle persone che vivono in strada, Roma, Cisu
Wacquant L., 2002, Scrutinizing the Street: Poverty, Morality, and the Pitfalls of Urban Ethnography, in
“American Journal of Sociology”, 107(6)
�
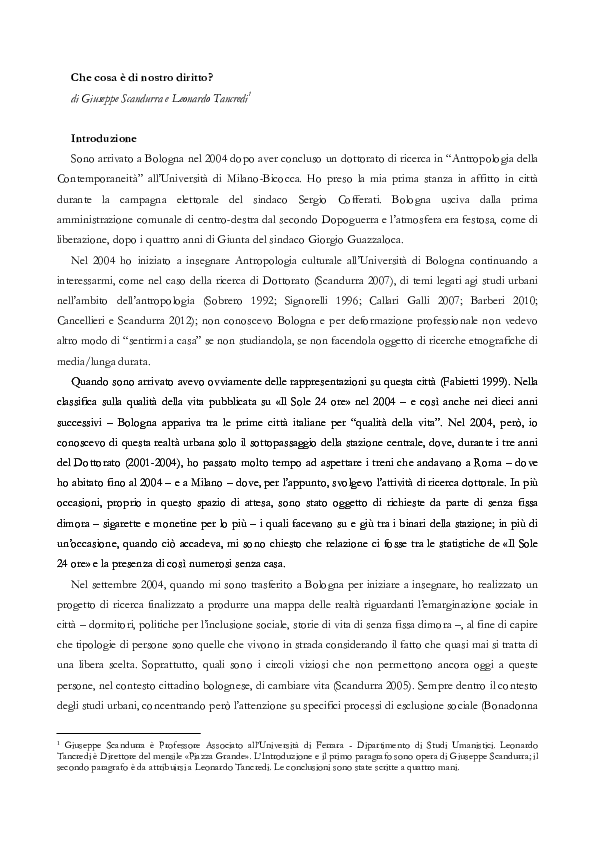
 Giuseppe Scandurra
Giuseppe Scandurra