La parola e il discorso, il silenzio e il grido
nel cinema di Pier Paolo Pasolini
Nel cinema di Pasolini il nucleo della parola si presenta nelle spoglie amare
del grido, si articola e si distende nell’ordine del discorso diffondendo la
pienezza di un senso, si ripiega nei gorghi di un irrequieto silenzio e si innalza
con accenti profetici e oracolari; in questo autore, la parola rientra a pieno titolo
nell’impasto materico dell’immagine, configurando il peso di una oscura
sostanza che attinge le vette di liriche risonanze, mantenendo la sua gravità.
I paragrafi con il numero dispari sono di Paolo Lago, e quelli con il numero
pari di Paolo Landi.
1 - Il logos e il sogno
In Teorema (1968) e in Porcile (1969) la parola erompe prima della sigla di
testa del film precedendo, per utilizzare un termine di Gérard Genette applicato
alla letteratura, la “soglia” incipitaria dell’opera. Se nel primo, la parola stessa
si sfalda in una dimensione dialogica, nel secondo essa giunge come dall’alto
fino a infrangersi su una pesante e granitica superficie che la riveste di
autoritaria sacralità. Nei due film ci troviamo di fronte ad una sorta di ‘limbi’
profilmici; due spazi dove si concentra la potenza di una parola che,
successivamente, nel corso della narrazione, verrà franta e quasi annullata ed
annichilita. In Teorema, tale limbo iniziale rappresenta quasi un epilogo
(rappresenta infatti un’azione che verrà compiuta alla fine del film), poiché, di
fronte ad una fabbrica, un intervistatore fa delle domande agli operai a
proposito della donazione di quella stessa fabbrica; veniamo a sapere, infatti,
che il padrone (che solo dopo scopriremo essere il personaggio dell’industriale
alto borghese Paolo) ha donato la sua fabbrica agli operai. Di fronte a questo
atto - afferma il giornalista intervistatore – la borghesia, nonché la stessa classe
operaia, devono porsi nuove domande per un futuro che vedrà rompersi le
barriere di classe e che creerà una sorta – si potrebbe pensare – di indefinito
‘calderone’ sociale (quasi una sorta di profezia del mondo globalizzato). Il
suono della voce è chiaro e logicamente scandito; le parole del giornalista e
1
�quelle degli operai sono dominate da un logos chiarificatore, un ordo razionale
che intende creare chiarezza e offrire spiegazioni razionali. Esattamente
l’opposto dell’involucro ‘sottomarino’ in cui veniamo proiettati, dopo la sigla di
testa, nelle primissime sequenze del film. Esse, però, sono precedute
dall’inquadratura di un luogo desertico (le pendici dell’Etna, che torneranno
nelle sequenze finali) sul quale si staglia una voce che recita, ben scandite, le
parole dell’Esodo biblico (“Dio fece quindi piegare il popolo per la via del
deserto”). Queste parole geometricamente scandite sono simili a quelle che
appartengono all’universo profilmico di Porcile. Nelle prime inquadrature del
film, dopo appunto l’omen dell’apparizione del deserto astorico, i suoni sono
allontanati, ci troviamo come in un universo acquoreo in cui il colore è
sostituito da un plumbeo seppia; i personaggi si muovono e parlano in ambienti
urbani ma i suoni non ci sono, vengono negati e soffocati. Parlano, al posto
delle parole e dei luoghi, solo le immagini, solo le ambientazioni che, appunto
come uno sconosciuto universo subacqueo, sono quasi incomprensibili.
Vediamo dapprima Paolo che esce in Mercedes dalla sua azienda; poi i figli
Pietro e Odetta appena usciti da scuola, il prestigioso liceo Parini di Milano;
successivamente la moglie Lucia impegnata in una toeletta nella sua elegante
camera da letto, nella villa di famiglia; poi la domestica Emilia e, infine, il
postino-messaggero Angiolino che porta un telegramma. Quest’ultimo
annuncia l’arrivo dell’Ospite ed è solo quando questo entra in scena che si
squarcia il mondo subacqueo e silenzioso.
In Porcile, invece, prima della sigla di testa giunge allo spettatore non una
frantumazione dialogica della voce, bensì una parola netta e scandita – simile a
quella che pronunciava la frase biblica in Teorema – che cade dall’alto di una
qualche sacra imposizione. Infatti, mentre ascoltiamo le parole le vediamo
anche inscritte su una marmorea epigrafe come se fossero alcune regole di
natura divina (in tal modo esse fungono anche da epigrafe per tutto il film).
Come in Teorema, ci troviamo proiettati su uno sfondo dell’alta borghesia; le
ambientazioni, infatti, sono quelle della villa di un ricchissimo industriale il
quale, dopo aver collaborato con il nazismo producendo ordigni bellici, ha
riconvertito la propria azienda. Dopo la sigla iniziale si alternano le immagini
afone e silenziose dello sfondo materico di un imprecisato medioevo e quelle
degli spazi aperti della campagna tedesca degli anni Sessanta. La parola, in
entrambe le ambientazioni, si è come perduta; i personaggi che si muovono
2
�nelle lande desertiche e ‘barbariche’ sono privi di parola, silenziosi e ambigui
alfieri della gestualità, mentre quelli che compaiono poco dopo nelle
ambientazioni della villa, Julian e Ida, alternano al silenzio il vuoto rincorrersi
in serie di parole macinate in una sorta di catena di montaggio. In entrambi i
film abbiamo quindi una struttura simile: un limbo profilmico in cui erompe
una parola materica e potente (dialogica in Teorema, narrativa e solenne in
Porcile), la sigla di testa, le sequenze iniziali dominate dal silenzio. La parola
materica del dialogo e quella solennemente scandita e caduta dall’alto si
perdono, dopo poco, in annichilenti silenzi. Le “soglie” strutturali in cui esse si
collocano rappresentano quindi dei momenti completamente avulsi dalle
narrazioni e dalle loro strutture; sono momenti e luoghi ‘altri’ dal punto di vista
della loro collocazione temporale e spaziale. La fonè e il suono delle parole
verranno, nel corso dei due film, completamente annichiliti. Teorema, infatti, si
chiude con l’urlo prolungato di Paolo, in cui il logos viene destrutturato, mentre
Porcile con un invito al silenzio da parte di Herdhitze (“e allora, shhh, non dite
niente a nessuno”). Ciò che nei limbi iniziali era stato, per certi aspetti,
prefigurato e annunciato, la forza quasi sacrale e magica di una parola, verrà
invece totalmente riconsiderato e rovesciato. Sembra che in entrambi i film le
immagini e le ambientazioni sostituiscano le parole: in Teorema la placida,
nordica campagna della provincia milanese; in Porcile, quasi in
contrapposizione fra di essi, gli spazi desertici e barbarici, materici, ‘sporchi’ ed
‘opachi’ e la campagna tedesca dove si staglia la villa dell’industriale signor
Klotz, rappresentata in immagini vitree e patinate. Il logos della soglia
profilmica cede il posto all’immagine, alla visualità, regno del sogno e
dell’immaginazione.
2 – Il verbo profetico e il grido della condanna
Nell'ambito del cinema, la parola è un registro sovrapposto al registro
dell'immagine, e come tale opera in un modo eterogeneo, portando con sé
svariate complicazioni e linee di suggestione; e un tale intervento del
linguaggio verbale, in quanto viene articolato con il regime dell'immagine, è
suscettibile di illuminare con una modalità diversa il suo terreno, e oltre a
3
�delineare delle condizioni che rendono più evidente un certo contesto, mette in
gioco degli elementi che sono alla base di istanze problematiche ulteriori
rispetto a quanto è inscritto nella percezione visiva. E un caso canonico e in
qualche modo primario di questa resa eterogenea che attiene alle componenti
narrative delle opere d'arte – e in particolare del cinema, anche in rapporto alle
sue premesse od ai suoi elementi di sfondo a carattere letterario – è dato
dall'intervento del cosiddetto autore onnisciente, e dalla linea di forza con la
quale egli pronuncia il suo punto di vista, esponendo il proprio sapere
compiuto. Inoltre, l'autore onnisciente fornisce un luogo di inizio ad un certo
svolgimento narrativo, od interviene in alcune congiunture sensibili di
quest'ultimo – le quali, peraltro, si legano in un modo variamente economico
alle accentuazioni caratteristiche dell'inizio stesso, o della conclusione di un
certo complesso testuale.
Su queste basi, possiamo osservare come il pronunciamento del dettato
biblico che figura in Teorema possieda il carattere singolare di riflettere la
dimensione dell'autore onnisciente in un modo traslato. Ed a tale proposito, al
posto di quest’ultimo abbiamo una voce che recita un verbo profetico, che a sua
volta testimonia la volontà o la deliberazione di un divino, il quale si annuncia
con il tratto originario di una funzione che sublima quella dell'autore medesimo,
irradiando il proprio vestigio di onnipotenza; o ancora, sotto questo profilo, al
posto dell'autore onnisciente abbiamo la sembianza appena accennata di un Dio
onnipotente, che viene adombrato con una movenza tanto decisa o determinata
quanto repentina o fuggevole, e per mezzo di una voce profetica. E questa voce
da un lato rimanda alla istanza religioso-metafisica e letteraria della profezia
relativa all'autore biblico, e da un altro lato rinvia alla esecuzione impassibile
del gesto teatrale di una lettura, che ne pronuncia la facies lapidaria, eseguendo
un dettato inscritto in alcune parole inerenti alla tradizione in questione. E nel
tracciato di queste parole si possono rilevare i seguenti elementi: in primo luogo
l'autore, che tuttavia si presenta in un modo indiretto, attraverso una serie di
mediazioni, e in qualche misura coincide con il dettato che viene pronunciato,
sulla base di una interpretazione adeguata che ne decifra e ne traspone il senso
in una maniera ben circoscritta, e adeguata al senso complessivo dell'opera; in
secondo luogo, il divino che si annuncia mediante una tale cadenza, e la sua
accentuazione collocata in qualche misura al di fuori del tempo; in terzo luogo
la sembianza profetica di colui che ha redatto o inciso il senso espresso da
4
�queste parole, e che funge quale autore di una formazione testuale, quale è
quella biblica, che a sua volta rimanda ad un legame con l'impegno di una
testimonianza rivolta al divino, la quale oltrepassa il registro della espressione
estetico-letteraria, ed i suoi confini psicologici; infine, la voce di colui che
legge, o appunto l'istanza della lettura e della resa sonora e uditiva dei contenuti
che vengono espressi e declamati nel modo più fermo e privo di risonanze
emotive od affettive inerenti alla nostra esperienza di vita – nonché al gioco
delle sue vibrazioni, ed alle colorazioni molteplici e variegate delle sue fasi di
incertezza, e dei suoi stati di sospensione. E allora, alla dimensione elementare
dell'immagine – confinata in uno scorcio insieme angusto, vagamente limbico e
attraversato da uno stato di angoscia privo di ogni preciso riferimento –,
corrisponde il sigillo di un pronunciamento orale entro il quale è riposta una
serie complessa di strati di enunciazione; e infatti, colui che enuncia queste
parole per un verso è l'autore, ma quest'ultimo rimanda al pronunciamento
divino, che a sua volta viene raccolto, testimoniato o dichiarato dall'istanza
profetica dell'autore biblico, e viene portato a compimento dal gesto della
lettura e della declamazione. E quest'ultima, dal canto suo, invita ad una
meditazione sul senso di quello che verrà mostrato nel seguito dell'opera, e nella
sua tessitura visiva, circoscrivendo e anticipando con un preciso enigma
custodito nella tradizione metafisico-religiosa il significato a sua volta ambiguo
ed enigmatico che verrà tracciato nel corso della narrazione, sino alla sua
conclusione, ed alla sua corrispondenza simmetrica con questo dettato iniziale.
Dobbiamo poi notare come la distanza che l'autore assume sulla base di
questi elementi di mediazione, corrisponda con il suo tratto al carattere
complesso e parimenti indiretto della mediazione secondo la quale il senso del
dettato biblico – e della sua articolazione nel flusso di una tradizione variegata
ma ben definita – viene trasposto e modificato, nonché, per certi versi,
capovolto o invertito rispetto alla istanza comunque rassicurante di un divino
che interviene nei confronti del popolo richiamato; e infatti, assumendo e
dilatando le istanze angosciose della ipoteca di una condanna possibile che è
comunque legata alla immagine biblica evocata, l'autore anticipa i lineamenti di
quella che sarà la condanna definitiva dei personaggi di questa storia, i quali
subiranno una profonda e irreversibile istanza di negazione. E in particolare, il
personaggio del padre verrà condannato ad una sorta di reclusione o di
espulsione volontaria in quel deserto che ha raccolto il suono delle parole
5
�pronunciate all'inizio – le quali, in questo contesto, acquisiscono il senso della
condanna medesima, nell'accezione di una sorta di annullamento, che viene
riflesso dalla purezza avvolgente di quel deserto, che adesso acquisisce
l'impronta di una compiuta mancanza di vita. E se del resto un tale effetto di
privazione è teso a manifestare l'inenarrabile sofferenza che deve conseguire
alla coscienza compiuta di un proprio effetto di privazione – o della mancanza
di un proprio essere autentico, riflessa nell'abito di una menzogna -, allora, alla
presenza dello stesso deserto, invece della parola irradiata da un luogo di
trascendenza – e dalla radente incombenza del suo dettato – dovrà conseguire la
forza d'urto del grido, e di una torsione che è priva di una possibile fine; e la
mancanza di una cesura conclusiva di tale esplosione sonora testimonia il
termine di un'opera per immagini, che ne interrompe la regolata cadenza,
profilando una sorta di commistione fra un assoluto silenzio, ed un assoluto
rumore che ne profana la quiete, restituendolo al proprio senso (il quale
rimanda all'assenza di una risposta possibile).
Inoltre, per quanto riguarda il grido finale – che in questo film risuona come
una sorta di apoteosi d’angoscia allo stato puro, quale può essere immaginata
nelle sembianze delle anime e magari dei corpi che subiscono la tortura
dell’inferno cristiano, e che è degnamente coronata dall’immagine del deserto e
dalla corporeità villosa e sulfurea del personaggio -, abbiamo una specie di
ripresa dell’io narrante che si è pronunciato con la prima apparizione del
deserto, travestendosi e distanziandosi mediante gli strati attanziali che abbiamo
indicato; infatti, questo grido emerge e si impone in modo definitivo, come
lascito di una condanna che l’autore esegue nei confronti del personaggio
stesso, giudicando la sua indegnità antropologica, e stabilendo un adeguato
contrappasso di solitudine, quale marchio di infamia e testimonianza di un
impossibile lavacro, che corrispondano alla sua esistenza precedente, risolta
nella funzione di un potere il quale si è reso responsabile di una dimensione
sociale e comunicativa fallace e inautentica. E d’altra parte in questo caso
l’autore non demanda la sua presenza indiretta alla irruzione lapidaria di una
voce fuori campo, ma la consegna alla trasparenza stessa del grido, che sembra
conseguire con forza quanto tale voce ha prescritto - quale prolungamento
possibile del suo intervento, che testimonia in modo irrevocabile l’istanza del
suo giudizio.
6
�3 – Parole annientatrici
In Teorema, sul silenzio che avvolge pressoché tutto il film, si stagliano, ad
un certo momento, gli inserti di un verbo poetico e teatrale che rompe la patina
limbica delle immagini. Se, come si è visto, l’annichilimento della parola, nel
film, permette all’immagine stessa, allo stesso ambiente di svolgere quasi una
funzione protagonistica, è vero anche che la parola, a cominciare dal verbo
biblico iniziale, assume vesti divine e quasi velate di una indiscutibile
onnipotenza. Quasi come le ideali continuazioni svolte in forma mimetica della
solenne parola iniziale, i personaggi pronunceranno parole dal taglio netto e
preciso, dal contorno fonico levigato e terrificante nella sua perfezione (come
perfetto e terrificante è lo stesso svolgersi di un teorema). Nella forma letteraria
di Teorema queste parole si presentano come delle poesie inserite nella
narrazione in prosa, contraddistinte dalla veste grafica del corsivo. Il cambio di
veste grafica, nella versione letteraria, vuole forse alludere alla forza insita nelle
parole; se l’intera narrazione in forma diegetica è affidata ad uno stile nitido,
rarefatto, oggettivo ed uniforme, gli inserti mimetici, come lacerti di scrittura
tragica, rappresentano l’irruzione sulla scena dell’io segreto dei personaggi che,
svelato, esce finalmente allo scoperto.
I monologhi dei membri della famiglia, nel film, vengono innescati dalle
parole dell’Ospite sacro che, con lo stesso piglio solenne delle parole bibliche
iniziali, afferma: “devo partire – domani”, laddove l’ultima parola – “domani” preceduta da una breve pausa, suona come il rintocco di una inesorabile
condanna. È solo adesso, quindi, che i personaggi borghesi esprimono parole
annientatrici, pervase contemporaneamente di un pathos tragico e di un logos
razionalizzante. Le parole sono l’eruzione fonica della modalità annientatrice
che investe i corpi e le sembianze dei personaggi: tutti, infatti, ‘colpiti’
dall’Ospite, non riconosceranno più se stessi e compiranno delle azioni che mai
avrebbero compiuto, incalzati dal Sacro che, all’improvviso, ha fatto irruzione
nella loro vita di borghesi tutta consacrata alla valorizzazione capitalistica della
merce. Lo sconvolgimento, perciò, è totale; la parola sacra iniziale, quel verbo
biblico che suona come una condanna, ha un suo strascico per l’intero film, per
l’intera disposizione fonica delle parole dei personaggi. Sembra infatti che
7
�queste ultime giungano da un altrove; fisicamente possiamo identificare questo
altrove con la sala di doppiaggio. I personaggi, infatti, sono doppiati; le loro
voci sono allontanate in una dimensione eterea e materialmente presente. Come
fulmini che cadono dall’alto, da un inquietante e oscuro vuoto, le parole dei
monologhi giungono da un nulla che suona come l’espressione di un tenebroso
destino. Il suono, la fonè di quelle parole sono i rintocchi di una condanna che il
Sacro porta con sé: quella vita votata al valore della merce, nella prospettiva
pasoliniana di matrice marxista, è condannata al deserto dove solo il vento e i
suoi sibili sussistono; un deserto che, del resto, in immagini prefigurative,
silenziose ed inquietanti come omina, era apparso più volte nella narrazione
filmica, prima di esplodere nel finale, laddove il personaggio di Paolo ne solca
le magmatiche lande con la sua fisicità dirompente. Se l’esistenza borghese ha
perduto la propria fisicità nell’adorazione feticistica della merce, è proprio ad
una fisicità estrema che il Sacro può condannarla: un corrusco deserto barbarico
attraversato da flussi di lavico magma. Anche in Porcile vengono opposti
l’ordine borghese della nuova industria votata alla merce e legata ad
inenarrabili orrori nazisti e il deserto barbarico e astorico, dove invece l’orrore e
la morte avvengono in modo quasi biologicamente scandito, quasi fossero le
naturali conseguenze di un ordo superiore.
La potenza annientatrice della parola viene, in un certo senso, rafforzata
dalla musica di Mozart che accompagna i monologhi: il Requiem scaturisce
solennemente quasi insieme alla forza della voce, conducendo quei corpi verso
vite ormai definitivamente annientate nella loro esistenza pregressa. Tutta la
forza viene demandata al suono, sia della parola che della musica: il corpo,
come entità fisica, sembra ormai allontanato verso limbi dove risuona crudele e
scandito il verbo della condanna. Quelle livide immagini atone, senza colore,
senza luce che precedevano l’arrivo dell’Ospite rappresentavano corpi quasi
senza forza, irretiti in un’esistenza opaca e vitrea. Dopo l’irruzione del Sacro,
ecco che il Logos, il Verbo rende, letteralmente, ‘di carne’ quei corpi per
condurli a nuove esistenze ferite. La concretizzazione del deserto, così materica
e magmatica, dove quell’unico corpo – quello del capostipite della famiglia e
anche dell’accumulazione delle merci – così fisicamente presente nella sua
nudità si aggira, segna il disfacimento e, contemporaneamente una sorta di
rinascita di tutti i corpi della famiglia. Le parole annientatrici hanno plasmato
nuove fisicità, più crude, più ferite, più angosciose, più consapevoli,
8
�estremamente lontane da quelle parvenze umane che, come tanti burattini, si
aggiravano nelle atone e opache immagini iniziali.
4 – Voce disumana e voce evangelica
Il vangelo secondo Matteo (1964) di Pasolini si incentra sulla funzione di
quella parola del Cristo, la quale, come è noto, è riconducibile al Logos divino
di cui parla il vangelo di Giovanni. Così la figura in questione pronuncia parole
che scandiscono un senso il quale ha la pretesa di un assoluto: si tratta di parole
che si ergono indipendenti e trionfali sulle malinconie di un mondo, dove il
Cristo stesso oltrepassa ogni stadio del suo cammino, incidendo il loro segno e
procurando il loro lascito senza l'esitazione di un pensiero che esponga a sua
volta un qualche problema, od articoli le linee di un progetto fornito di un
ordine, il quale inviti al conseguimento di un obiettivo preciso. La durezza del
monito che viene irradiato mediante l'afflato di questa comunicazione è dunque
un portato di un Logos, che può essere concepito come la forma di una
comprensione suprema, i cui contorni tuttavia da Pasolini vengono illuminati
nel registro impassibile di una leggenda che non lascia lo spazio per una
interpretazione definita nei termini di una certezza canonica e dogmatica,
storica e confessionale. E se questa certezza, in qualche modo, è ancora
condizionata da una certa forma di empirismo, o da una trasposizione analogica
di un nostro essere al mondo nel modo dell'essere felici od appagati, in Pasolini
– che non ne condivide il dettato - non abbiamo nemmeno una negazione
altrettanto precisa, che riguardi una tale alternativa.
Ma la voce profetica del Cristo nel film si impone come la pietra angolare
di una parola che si riflette sul volto mediterraneo, a partire dal quale il suono
che la pronuncia viene emanato; e nonostante che venga incisa dai tratti di un
movimento vocale chiaramente visibile nella cadenza teatrale della immagine
che espone la sua gestazione, tale voce risulta trasposta in una specie di empireo
poetico, il quale abbraccia ogni possibile direzione. E tale parola emerge al di
fuori di ogni logica selettiva, che specifichi l'ordine di qualche destinatario, e lo
spazio di qualche luogo nel quale un ricevente specifico sia in attesa, per
prenderne un possesso esclusivo, od afferrarla con le sue mani.
9
�Sotto questo profilo, le immagini che trascrivono il discorso sulla montagna
procurano una silloge la quale racchiude degli scarti di tempo, che hanno il
privilegio di sfuggire al calcolo di una misurazione, e corrispondono agli
ondeggiamenti fermi di una parola che sommerge il possibile destinatario come
un mare senza fine. Abbiamo così questi elementi: da un lato, tali scarti
temporali non hanno confini precisi, e tracciano quasi le articolazioni non
temporali di un tempo i cui lineamenti oggettivi sono confinati ai singoli
frammenti di questo compendio; da un altro lato, in qualche modo la parola che
emerge viene scolpita al di fuori o al di sopra del fluire temporale medesimo, e
discende nel tessuto dell'immagine, in modo analogo a come le cesure fra un
brano e l'altro imprimono nel tessuto del tempo il loro sortilegio e la loro linea
sovrana.
Così, in Teorema abbiamo una linea di senso che è marcata sotto il profilo
dell'angoscia, della disperazione e di un'ipoteca di annullamento che procede
senza rimedio; e invece, Il vangelo secondo Matteo presenta l'invito a misurarsi
nei confronti dell'essere ed a conseguirlo. E se in entrambi i film abbiamo un
fondo di amarezza e viene attraversato il momento della tragedia, nella seconda
di queste opere la tragedia stessa non è l'ambito che circoscrive il suo sviluppo,
né il sigillo che ne determina l'impronta; e parimenti, in Teorema la voce
biblica risuona estranea, atona e disumana, ed emerge con il tratto celere di una
inclinazione diretta all’orizzonte di restrizione e di negazione che grava su tutta
la storia, mentre Il vangelo secondo Matteo dischiude una voce evangelica
parimenti disposta in un altro luogo rispetto a quello delle sembianze che
vengono presentate, ma nel contempo dotata di una pienezza che avvolge
l'ambito dell'ascolto. Potremmo così dire che il dettato di Giovanni, per il quale
la Parola si fece carne, nel film di Pasolini viene tradotto nei modi di una
presenza linguistica e verbale perentoria e fisicamente piena, ed al contempo
sollevata e trasposta nel lirico alone della sua risonanza diretta al di là di ogni
possibile limite; e del resto, il carattere fortemente segnato in termini corporali
con il quale la parola pronunciata del Cristo modula la voce del suo teatro e la
materica forza d'appello della sua tessitura, invece entrare in contrasto con la
torsione sublime che la sospinge nel proprio cammino, o di rendere improprio
l'aereo richiamo a uno spirito universale, incontra quest'ultimo, come
riempiendolo di se stessa, ed attribuendo alla sua possibile luce una linea di
forza maggiore.
10
�Possiamo inoltre osservare che gli attanti, in un film come Teorema,
risultano prigionieri nell'ambito di una struttura; e qualcosa di analogo si
riscontra nelle modalità enunciative del film, relative al linguaggio verbale, ed
alla sua resa sonora in rapporto alle immagini. Infatti, il film scandisce le fasi di
un destino che segue la linea di una discesa, segnata da tappe che hanno un
carattere necessario, inerente ad una serie di personaggi che formano una
disposizione precisa, circoscritta nell'ambito familiare, ed emblematica rispetto
ad un repertorio preciso di condizioni sociali. Ne Il vangelo secondo Matteo,
invece, nonostante un certo richiamo alla disposizione prescritta di un cammino
che è piegato nella direzione di un'opera da eseguire in un breve e precipitoso
arco di tempo, abbiamo quel genere di apertura che è legata ad un principio di
rettitudine, ed al richiamo sferzante, lucido e parimenti severo nei confronti
della nostra coscienza. Ne deriva che il rapporto fra la parola e l'immagine nel
primo film possiede un carattere geometrico e strettamente razionale, che
corrisponde alla disposizione della storia, nonché alla sua impronta disperata,
immessa nell'alveo di un processo di distruzione o di dissoluzione; ed invece,
nel secondo film questo rapporto ha una dimensione fluente, dotata di scansioni
che corrispondono all'aura indefinita della leggenda, nonché ad una certa
inclinazione magmatica, consapevolmente deliberata dall'autore, e
corrispondente alla varietà accentuata dei suoi motivi e dei suoi reperti stilistici.
Accade allora che in Teorema la voce profetica risuoni metallica e del tutto
inappellabile nel suo lascito momentaneo, e l'eloquio dei personaggi risulti
sospeso in una specie di atmosfera viscosa, nella quale è destinato ad implodere
– come si evidenzia nel finale, dove la parola stessa trascolora o si frantuma
nella violenza atona di un grido senza rimedio e senza confini possibili -; ed
invece, nel Vangelo la voce del Cristo risuona in ogni angolo dove si trovi un
possibile luogo d'ascolto, e le altre voci si dispongono attorno ad essa come una
serie di liriche consonanze, che si adunano in un loro concerto, anche se il
dramma si erige con la sua forza, o irrompe l'animus della tragedia. E d'altra
parte, nel primo di questi film il carattere vitreo ed opaco delle immagini ed il
timbro livido della storia che viene narrata, come recita il titolo, corrispondono
alla scansione di una struttura che simula il movimento di una deduzione
possibile, ed il suo rigore mortale; laddove, al contempo, le voci assumono gli
accenti di una soffocata immanenza, e il loro discorso espone in maniera
concisa e sintetica il decorrere di un pensiero che deve manifestarsi, secondo
11
�l'ordine determinato di una coscienza costretta a prendere atto degli effetti di
distruzione. E quanto al secondo film, abbiamo il libero trascorrere dei
passaggi, e nel contesto di questa fluenza, il carattere delle voci erompe segnato
dal pathos che insegue la forma di una comunicazione, risolta nel compito di
liberare dalle angustie dell'esistenza.
5 - La voce mitica nella laguna
Il Centauro, all'inizio di Medea (1969), si rivolge a Giasone bambino con
delle parole che sono legate all'universo mitico e sacrale; esse narrano infatti un
mito in modo 'semplificato', eppure ancora troppo complesso per un bambino
piccolo. Si tratta di parole esplicative e didascaliche, legate appunto alla
funzione di didaskalos, di maestro quasi socratico che svolge il Centauro.
Perché esse, quindi, possano mettere in circolo il sistema dell'insegnamento è
necessario che siano dominate da logicità e razionalità. Le parole del Centauro
sono quindi quelle dominate dal logos del maestro, dell’insegnante ma sono
anche quelle che srotolano un mythos, una narrazione che si perde nel passato e
che è stata tramandata oralmente nel corso del tempo. Quella del Centauro è
una voce del racconto, una voce mitica che si espande nel paesaggio quieto e
solare della laguna di Grado, dove queste prime sequenze sono ambientate. La
voce fluttua libera nello spazio della natura, si spande nell’aria crepuscolare, si
trasforma in colore del cielo e del mare recando in sé la leggerezza fluttuante
del racconto non scritto, della tradizione orale, della semplicità e
contemporaneamente della complessità di vicende soprannaturali legate alla
sfera del sacro. Quella del Centauro è quindi anche una voce sacra, poiché
quasi si identifica in quella natura che, appunto, denomina come sacra e
‘innaturale’. Infatti, se nei primi momenti della sequenza, mentre ascoltiamo la
voce vediamo anche il primo piano del Centauro, successivamente essa si libera
dall’immagine iconica del volto, la sua fonte, e fluttua leggera nell’aria
avvolgente. Mentre la voce si libra vediamo infatti inquadrature della laguna,
del mare, dell’erba e dei prati circostanti; essa, infatti, sembra unirsi in modo
indissolubile con il paesaggio, quell’ambiente che diviene più sacro quanto la
voce stessa continua nel suo profluvio di parole sacrali. La voce mitica si
12
�spande tutt’intorno, simile allora alla parola evangelica di Cristo ma non con la
sua stessa valenza salvifica e catartica; la voce mitica, infatti, non erompe per
portare alla salvazione gli esseri umani, ma per metterli al corrente, per spiegare
loro le vicende del mythos. Le parole sono scandite, semplici, reali, a volte
anche pesanti e materiche, e gravano tutt’intorno come l’acqua stagnante e
oleosa della laguna nel pomeriggio d’estate; se “solo ciò che è realistico è
mitico”, la parola, quanto più è reale e terrea, è anche più mitica e sacra.
Ben diverse saranno le parole pronunciate nello spazio della piazza dei
Miracoli di Pisa, che nel film rappresenta la reggia di Corinto, dal secondo
Centauro, quello sconsacrato. Non è più il Centauro in veste mitica e sacra a
parlare, quello che parlava a Giasone bambino nello spazio ‘amniotico’ e
regressivo della laguna, luogo sacro dell’infanzia perduta, ma è quello dell’età
adulta, dell’occhio che vede tutto senza poesia, senza commozione, senza
partecipazione sacrale alla realtà. Il Centauro mitico è quindi condannato al
silenzio, forse perché ha lasciato per sempre le sue dolci parole del mito, là, in
quella laguna lontana e rarefatta, grembo e custodia di un’infanzia solare e
sacra, fluttuanti in un luogo dimenticato dal tempo, divenute sole, mare, terra,
erba, luce. A parlare, adesso, è il Centauro dell’età adulta e la sua voce si
spande nello spazio razionale e razionalista dell’architettura cinquecentesca
della piazza, apoteosi della società mercantile che ricerca il bello e il sublime
nella geometria della forma perfetta, stupefacente, forma che diviene cattedrale
da innalzarsi verso una nuova, geometrica divinità che per sempre ha sostituito i
miti pagani. La voce fluttua fra prato e mura bianche e levigate, è essa stessa
forma geometrica perfetta, incastonata in lucidi e cristallini intarsi. Tutto è già
stato spiegato, non c’è più niente da scoprire tramite la forza del mythos, del
racconto orale che dipana vicende lontane e avventurose. Tutto, adesso, è
geometricamente legato al filo di quella voce che risuona per Giasone come una
lucida e consapevole presa di coscienza.
13
�6 – La pienezza sonora e il dominio del senso
Nel cinema di Pasolini abbiamo dunque una polarità negativa della parola,
che si dispone al pronunciamento di un giudizio di negazione o di condanna, o
subisce a sua volta il processo di una dissoluzione, il quale, a tratti, consegue
alla condanna medesima. E infatti, in Teorema, se da un lato la parola del
divino e quella implicita dell’autore lasciano presagire il carattere inappellabile
del loro giudizio, da un altro lato la parola stessa consegue la sorte spietata della
sua mutazione nei termini di quel rumore, che espone semplicemente la valenza
del grido; e quest’ultimo sottrae alla pienezza del nostro linguaggio il tratto di
una coscienza che renda ragione, ed il suo connubio con i movimenti del nostro
pensiero. Ma in Pasolini abbiamo parimenti una valenza positiva della parola;
infatti, sia ne Il vangelo secondo Matteo che nel prologo di Medea essa si
espone come il registro al quale è affidata la pienezza del senso, che è
suscettibile di avvolgere le condizioni primarie della nostra esistenza, od i
risvolti più decisivi che essa sostiene nel corso del suo cammino. Così abbiamo
due componenti materiche le quali segnano la consistenza del suono, al quale è
affidata la sorte della parola medesima, nella sua dimensione sorgiva, o nel suo
tratto genetico dell’origine: da un lato, quel carattere materiale dei nostri suoni,
il quale li espone alle vibrazioni atone di una emissione che è priva di ogni
sostengo da parte del nostro pensiero – come accade nel finale di Teorema, e si
evidenzia nel prorompere di un grido al quale non è assegnata alcuna fine
possibile -; da un altro lato, la resa parimenti materica delle nostre parole,
laddove esse risultano articolate mediante la forza avvincente del nostro
discorso, e mettono in gioco le componenti della nostra espressione e della
nostra comunicazione. E quest’ultimo aspetto si evidenzia negli altri film
richiamati, e delinea i tratti suadenti del nostro nascere al mondo (come accade
in Medea), od il rigore dell’esistenza, che lascia emergere il proprio nucleo
profondo, laddove viene investita dagli ultimi interrogativi (come avviene ne Il
vangelo secondo Matteo, e nelle occasioni entro le quali i personaggi sono
chiamati a decidere il proprio destino, comprendendo loro medesimi in modo
compiuto). Così, nel primo caso la forza materica della parola si pone in antitesi
con il dispiegamento del nostro pensiero e la messa in gioco della nostra
coscienza, ed il suono propaga la propria forza di appello, facendo coincidere le
14
�linee della sua direzione con il carattere meramente fisico di un dominio nel
quale non è possibile trovare una dimensione che orienti la nostra esistenza; e
infatti, il personaggio risulta privato di ogni elemento che possa guidare
qualcosa come un cammino, od un movimento che sia dotato di senso, e la
sembianza levigata del deserto che lo circonda e nel quale è immerso in modo
compiuto non presenta elementi di differenza o di rilevanza, che possano
corrispondere ai variegati accenti del nostro linguaggio, e ad una qualche
modalità di apertura della nostra esistenza. Ed invece, negli altri due casi la
dimensione materica della parola oltrepassa ovviamente la soglia impassibile ed
atona del rumore, e si affida al registro di una articolazione del senso, che si
avvale del suo carattere di pienezza; in altri termini, a tale proposito la forza
avvincente del suono, invece di richiamare meramente alla sequela delle proprie
emissioni che stanno sotto la soglia della nostra significazione – e lasciano
impresso nel loro tessuto l’abisso di un moto del nostro animo attraversato
soltanto da un lancinante dolore -, compone nel proprio ordine il disegno di un
orizzonte, il quale a sua volta risolve od affronta il problema della nostra
esistenza. Ed in particolare, mentre nel prologo di Medea abbiamo l’incanto di
un gioco di affabulazione il quale consegna al proprio destinatario il benefico
effetto di una certezza primaria – od anche, dipinge di fronte al suo sguardo
appena tracciato i lineamenti di un mondo ancora pervaso dal tremito
dell’origine ,- ne Il vangelo secondo Matteo abbiamo alcune modalità di
richiamo, che rivolgono il loro appello ad una serie di persone le quali
attraversano il culmine della loro esistenza, e sono guidate di fronte all’attimo
responsabile di una scelta che deve impegnare fino alla morte – o richiede di
pronunciarsi davanti alla morte medesima. Ed in entrambi i casi, la dimensione
materica del suono dilata od allarga il proprio respiro, conciliandosi con
l’impronta di una significazione insieme leggera e profonda, che viene investita
dalle benefiche ondate delle emissioni sonore, ed insieme le attrae nel proprio
gioco di riflessione.
Inoltre, se in Teorema abbiamo l’esempio di una disposizione sonora del
nostro linguaggio ridotta nei limiti del rumore – ovvero, di quella variabile del
linguaggio medesimo che porta l’espressione del senso alla soglia del proprio
limite negativo -, negli altri due film abbiamo alcuni moti della nostra
significazione, che si conciliano con quella pienezza sonora, la quale a suo
modo risulta incisa nel disegno dello stesso rumore; e d’altra parte, rispetto a
15
�questi presupposti, in Edipo re (1967) emergono invece alcune versioni
attinenti al rapporto fra il nostro pensiero ed il nostro linguaggio, che sono
vicine a quelle di questi ultimi casi, ma presentano del risvolti peculiari; infatti,
in questo film abbiamo delle circostanze nelle quali il carattere strettamente
materico - nonché dispersivo - del suono che viene messo in azione con le
nostre parole, risulta marcato secondo il principio di una violenza la quale,
piuttosto di occludere la messa in gioco del senso, rende possibile l’assunzione
di alcuni attimi culminanti, nei quali la coscienza è attraversata da un moto
possente. Ed a tale proposito, abbiamo due circostanze cruciali di questo film:
da un lato, quella nella quale l’oracolo prospetta ad Edipo la propria sorte,
investendo e oscurando al contempo la sua coscienza, con la prorompenza
sonora di un discorso ravvolto attorno a un messaggio il quale non può essere
decifrato; da un altro lato, quella in cui Edipo maledice la propria sorte,
esponendo il sentimento di una condanna infinita rivolta nei propri confronti, e
diretta alle azioni che lui ha compiuto, secondo la linea di un disegno coerente
il quale si è dipanato a partire dal messaggio di origine, ormai disvelato nel
proprio senso definitivo. Possiamo allora notare come nel primo caso il
carattere materico del suono racchiuda dei toni cavernosi che delimitano il
registro delle emissioni sonore nel circuito di una sorta di implosione, entro la
quale il tratto dispersivo e volatile dei fonemi refluisce nel limbo opaco di una
voce che soltanto atterrisce e sgomenta, in quanto è protesa al di fuori dei limiti
dell’umano, e li sovrasta con la forza incombente della sua provenienza; ed
invece, nel secondo caso la voce assume un tono esplosivo, ma parimenti
circoscritto nei limiti di una coazione che oltrepassa le misure di un sentimento
comune, ed al contempo pronuncia l’imposizione di un senso, in base al quale
l’animo del soggetto viene compiutamente determinato. E possiamo dire che
nel primo caso la coscienza dell’individuo viene oscurata, poiché è sottoposta
alla luce abbagliante o abbacinante disposta da una sorgente che non rende
possibile la percezione di un qualche contorno; e d’altra parte, nel secondo caso
tale coscienza esprime il proprio dolore, e manifesta la sua evidenza con
l’urgenza di una ossessione tracciata senza alcuna possibile fine; ma ancora,
questa evidenza porta racchiuso nel proprio seno la traccia di quella oscura
radice, la quale ha disposto il movimento della tragedia, ed interdice comunque
l’uscita di una parola, che possa emergere dalla pienezza di un atto di
comprensione.
16
�Occorre poi sottolineare che le circostanze della parola che abbiamo
illustrato a proposito di Medea e de Il vangelo secondo Matteo circoscrivono i
due limiti dell’inizio della nostra esistenza, e della sua possibile conclusione – o
del suo senso a carattere ultimativo, che si espone alla tematica della morte, ed
al problema del sacrificio possibile della persona -; e d’altra parte, per quanto
riguarda questi due stadi culminanti di Edipo re, abbiamo parimenti un disegno
che circoscrive l’itinerario globale inerente alla sorte di un’esistenza; ma a
questo proposito, oltre al carattere stringente di un rapporto che lega comunque
le due circostanze fra loro entro l’insieme di una vicenda – e della sua unità
peculiare, richiesta dal genere di coerenza caratteristico della tragedia antica -,
emerge quel tipo di connessione, che è dovuto ad un rapporto a carattere
necessario, il quale circoscrive fin dall’inizio l’impronta della chiusura finale. E
del resto, un tale carattere lascia emergere un movimento, il quale risulta
comunque oscuro nel proprio motivo di origine – laddove, i toni cavernosi del
primo di questi messaggi, e la distensione infinita del dolore lancinante di
Edipo, rivestono con l’alone della propria forma sonora il tratto irrisolto di un
contenuto del nostro pensiero, che non attinge alcuna chiarezza possibile.
(una versione abbreviata di questo saggio è uscita su “Cinecritica”, 74-75,
aprile-settembre 2014)
17
�18
�
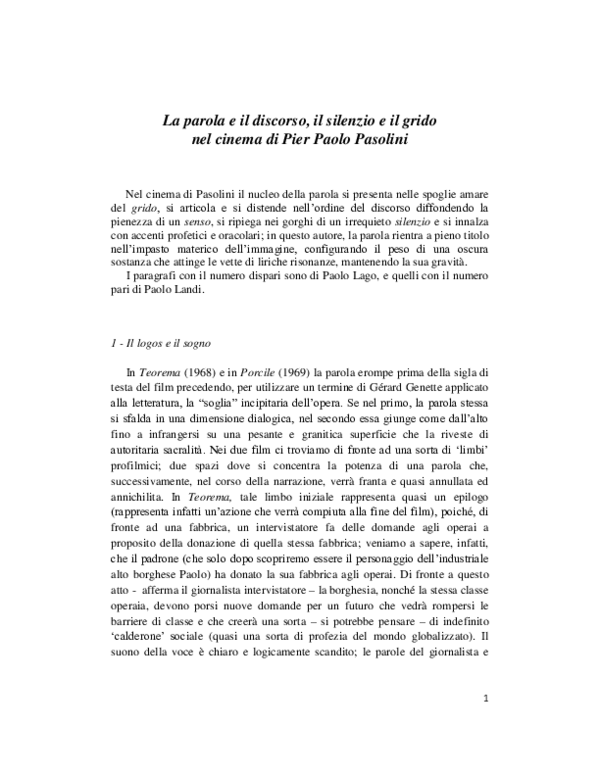
 Paolo Lago
Paolo Lago