ENDOXA/PROSPETTIVE SUL PRESENTE
5, 25, 2020
MAGGIO 2020
www.endoxai.net
ISSN 2531-7202
�2
�3
Endoxa – Prospettive sul presente, 5, 25, MAGGIO 2020
IDIOSINCRASIE
7
RICCARDO DAL FERRO
Editoriale
11
MATTEO BONICIOLLI
Idiosincrasie di uno sportivo professionista
15
LUKHA B. KREMO
Idiosincrasie sensuali
23
GABRIELE CROZZOLI
Sofferenza della luce (i colori sono azioni)
27
PIER MARRONE
Epidemie emotive
33
RICCARDO DAL FERRO
L’influencer contro il wrang-wrang: il valore
di ciò che detestiamo
37
GIANFRANCO CARBONE
L’anagramma impossibile
43
CRISTINA RIZZI GUELFI
Stato di repellenza
47
ULDERICO POMARICI
Agamben e l’idiosincrasia della morte: stato di
eccezione e nuda vita nell’epidemia di
coronavirus
51
SILVIA D’AUTILIA
Il virus e la paralisi della mente
59
FRANCO FERRANT
La scienza degli idioti
65
GENNARO CARILLO
“In ira e malevolenza”:
idiosincrasia comica
73
SAVERIO FATTORI
Il virus e la carpa a specchio
77
PEE GEE DANIEL
Cuckold lockdown
di
qualche
�4
85
JURI CAMBARAU
Pandemia, distopia, idiosincrasia
89
DAVIDE ASSAEL
L’idiosincrasia dell’Occidente
97
GIANPIERO COLETTA
I discorsi d’odio e le strategie adottate nel
nostro paese per contrastarli
101
PAOLO CASCAVILLA
Questa non è una guerra
107
MICHELANGELO DE BONIS
Ma quale idiosincrasia: chissà come si
divertivano
111
PIER GIUSEPPE PUGGIONI
Relazioni repulsive: legge, natura e musica in
un’opera buffa di Rousseau
117
ANDREA RACITI
Tanto peggio per i fatti: l’idiosincrasia del
positivismo giuridico
127
MATTIA ZANCANARO
Ortega y Gasset e le masse: un’intolleranza
lungimirante
131
GIULIANA VENDOLA
Emergenza e filosofia dell’estraneo: cosa può
insegnarci Bernhard Wandelfels
137
MASSIMO FILIPPI
Una particolare mescolanza
143
INFORMAZIONI
RIVISTA
SULLA
�5
�6
IDIOSINCRASIE
�7
Endoxa – Prospettive sul presente, 5, 25, Maggio 2020, pp. 7-9
IDIOSINCRASIE - EDITORIALE
RICCARDO DAL FERRO
La repulsione, il rifiuto e il rigetto sono forze talmente potenti da stare al di fuori
del nostro controllo. In effetti, sono quasi tutti termini che si riferiscono ad un
respingimento istintivo, organico: si rigetta un organo trapiantato, si prova
repulsione per un agente alieno, patogeno, si rifiuta ciò che è incompatibile non
solo intellettualmente, ma anche e soprattutto fisiologicamente.
Per questo “idiosincrasia” è una parola tanto potente, presa a prestito dal greco
antico e riportata in auge durante il Rinascimento, soprattutto nel gergo medico.
L’idiosincrasia è l’atto di rifiuto più basilare, fondamentale e inestirpabile, e
designa ciò che raggiunge un grado quasi ontologico di incompatibilità.
Ogni individuo, ogni cultura, ogni società, persino ogni elemento chimico
possiede le sue idiosincrasie, ed è soprattutto attraverso di esse che quell’individuo,
quella cultura, quell’elemento chimico può essere definito nella sua identità:
�8
RICCARDO DAL FERRO
cos’altro è l’identità se non la serie di elementi diversi da noi che rigettiamo senza
possibilità di appello?
Idiosincratica è la parola che ci fa ribrezzo e che desideriamo espellere dal
nostro vocabolario, la parola che determina lo spirito linguistico di un popolo
soprattutto attraverso ciò che quel popolo rifiuta di dire. Idiosincratica è l’idea
politica che una comunità desidera espungere dal proprio territorio e discorso
collettivo perché ripugna l’idea che essa stessa ha auto-prodotto e che perciò
determina quello che è. Idiosincratico è l’individuo che non faremmo mai entrare
in casa nostra e che proprio per questo definisce più di qualsiasi altra cosa la qualità
del focolare domestico che vogliamo proteggere.
L’idiosincrasia è il confine entro il quale ci sentiamo di poterci definire “umani”
per quanto un’epoca possa permetterci, oltre il quale desideriamo lanciare tutti gli
elementi che non fanno parte dell’immagine auto-prodotta di noi stessi, sia come
individui che come comunità.
Perciò noi di Endoxa abbiamo voluto proporre le riflessioni sul concetto di
“Idiosincrasia” da un punto di vista filosofico e non solo. E se qualcuno, leggendo
queste pagine, proverà una repulsione atavica e innominabile, probabilmente
saremo noi ad aver delineato quel confine e quel limite così fecondo per il pensiero.
Ma non odiateci troppo, anche noi abbiamo le nostre idiosincrasie.
Foto di Kaboompics .com da Pexels
�9
Idiosincrasie - editoriale
�10
�11
Endoxa – Prospettive sul presente, 5, 25, Maggio 2020, pp. 11-14
IDIOSINCRASIE DI UNO SPORTIVO
PROFESSIONISTA
MATTEO BONICIOLLI
Sono un privilegiato.
Dal 1988, una vita, il mio lavoro è la mia passione. Insegnamento e
pallacanestro sono le due cose che ho amato di più e l'essere diventato un allenatore
professionista di questo sport mi ha concesso di coniugare questi due elementi
facendoli diventare il mio mestiere.
In più, complice qualche successo, il lavoro mi ha consentito non soltanto di
viaggiare molto, ma addirittura di vivere continuativamente, per periodi più o
meno lunghi, in tre continenti diversi, Europa, Asia e Nord America.
Questo percorso mi ha fatto vivere personalmente ciò che l’antropologo Orin
Sfarn ha definito transculturation, ossia l'adattamento di un’attività sportiva,
normata da regole e gesti che dovrebbero essere sostanzialmente identici,
all'ambiente all'interno dei quali si manifesta.
�12
MATTEO BONICIOLLI
Per cui, anche se può sembrare stranissimo, la pallacanestro insegnata e
praticata nei Paesi dell'ex Unione Sovietica è radicalmente diversa da quella
insegnata negli Stati Uniti o in un Paese europeo come il Belgio o la Francia.
Ho utilizzato questa premessa, mi auguro non troppo lunga e noiosa, per arrivare
a raccontare brevemente come questo lavoro magnifico sia venuto sviluppandosi
nel nostro Paese.
L'aspetto più affascinante del coaching è, senza ombra di dubbio, quello della
costruzione. O meglio: della progettazione e della costruzione di un giocatore, di
un Club, qualche volta addirittura di un successo, persino di una vittoria.
È facilmente intuibile che l'alleato più forte per chi costruisce sia il tempo. È
solo un progetto di medio o lungo periodo quello che ti consente di costruire
partendo da solide fondamenta, fondamenta che ti consentiranno di rimanere in
piedi in periodi di difficoltà, che inesorabilmente si avvicenderanno ai risultati
positivi.
Soltanto un giocatore fortemente consapevole dei suoi mezzi e delle sue
capacità potrà resistere, senza scoraggiarsi, ad un periodo in cui le sue prestazioni
sportive non saranno aderenti alle aspettative di tifosi, stampa, sponsor e
proprietari, così come soltanto una Società solida potrà far fronte a quei momenti
critici, in cui le sconfitte sono piuù frequenti delle vittorie.
Purtroppo, invece di proporsi come esempio virtuoso, gran parte dello sport
professionistico italiano è andato omologandosi a quella caratteristica oramai
dominante nel nostro Paese, drammaticamente rappresentata dal mondo politico,
che è quella della ricerca del risultato, spesso del tutto fragile, nel qui e ora.
La prospettiva, se così possiamo chiamarla, del qui e ora, e mi limito a parlare
di sport (anche se sono convinto che questo valga in qualsiasi ambito), porta con
sé delle conseguenze molto difficilmente gestibili da chi vive in questo mondo.
Se il filtro attraverso il quale il lavoro di un gruppo di persone viene valutato è
il risultato di una singola partita, o, nel migliore dei casi, di un breve periodo,
spesso non superiore a uno, due mesi, è evidente che le scelte e le modalità
operative di un allenatore saranno orientate a privilegiare l'impiego di risorse
umane immediatamente utilizzabili, senza quindi occuparsi del futuro del proprio
club, della crescita di qualche giovane giocatore, le quali inevitabilmente dovranno
passare attraverso prove ed errori.
Se si adotta la prospettiva del risultato immediato, i soldi necessari ad allestire
una squadra sportiva saranno sempre "spesi", e mai "investiti". con conseguenze
negative facilmente intuibili per gli stessi risultati che si desiderano raggiungere.
A questo già complicatissimo aspetto si aggiunge un altro elemento,
giustamente ritenuto fondamentale nello sport professionistico, ossia la
comunicazione.
Rispetto ad un passato nemmeno troppo lontano, in cui a tener desta l'attenzione
degli appassionati durante la settimana erano interessantissime interviste di grandi
allenatori che si provocavano, si sfidavano pubblicamente, esplicitavano le
�13
Idiosincrasie di uno sportivo professionista
ambizioni loro e dei loro Club, siamo passati ad una comunicazione per la massima
parte omologata, che ha il sapore di un prodotto artefatto, in cui vengono ripetuti
all'infinito concetti banalissimi, non impegnativi e deresponsabilizzanti per
l'allenatore, più volti a scaricare sugli altri "l'obbligo" di vincere, piuttosto che a
trasmettere un sano desiderio di arrivare al successo.
A questo proposito mi piace ricordare quanto scritto qualche anno fa da un vero
intellettuale dello sport italiano, Gianluca Vialli, attaccante della Sampdoria
Campione d'Italia e della Nazionale, a riguardo alla sua esperienza inglese come
giocatore e successivamente allenatore del Chelsea.
Vialli, mettendo a confronto le sue esperienze di sportivo di alto livello in Italia
e in Inghilterra, scrisse che “in Inghilterra vincere è una gioia, in Italia vincere è
un sollievo”.
Questo concetto, che mi colpì moltissimo e che, per certi versi, l’ho sempre
reputato l'epitaffio più adatto da imprimere sulla pietra tombale del nostro sport in
Italia, mi porta a concludere questo mio intervento accennando ad un ultimo
aspetto, importantissimo, dello sport professionistico, che da sempre comporta
degli aspetti molto complessi.
Mi riferisco al ruolo del pubblico, cioè del principale fruitore dello spettacolo
sportivo.
Negli Stati Uniti, la patria della pallacanestro, come del baseball e del football,
le stagioni sportive delle singole discipline vengono proposte al pubblico in
maniera tale da non accavallarsi nella programmazione televisiva, se non per
brevissimi periodi. Le persone arrivano all'impianto sportivo spesso con addosso i
colori della squadra del cuore, si siedono in magnifici impianti e, seduti fianco a
fianco con gli altri tifosi della squadra avversaria, a loro volta vestiti con i colori
sociali, tifano per la loro squadra.
Il tifo è molto coinvolgente, soprattutto nello sport universitario, che è vissuto
con grande partecipazione. Al termine della partita gli spettatori si alzano e se ne
vanno.
Nel nostro Paese è invece accaduto spesso che le Questure proibissero l'arrivo
di tifosi ospiti, oppure che questi venissero relegati e rinchiusi in spazi
appositamente dedicati all'interno degli impianti sportivi, per evitare che le opposte
fazioni venissero a contatto.
Quando ciò è accaduto, spesso ci siamo ritrovati a fare la conta dei feriti, dei
contusi, se non addirittura dei morti.
È palese che giocare in un clima del genere, perché di gioco si tratta, rappresenta
una contraddizione sin troppo stridente, anche qui con conseguenze evidenti sulla
qualità del gioco proposto a pubblico e televisioni.
Sotto questo aspetto il ruolo negativo dei social media è stato cruciale, perché
hanno esacerbato frustrazioni e ostilità che non avrebbero ragione di esistere se lo
sport, anche quello professionistico, recuperasse in Italia, la sua dimensione di
progetto e di costruzione, che io penso abbia anche un fondamentale spessore
�14
MATTEO BONICIOLLI
educativo. Mi chiedo anche come, in un paese sin troppo pieno di leggi come il
nostro, non ci si sia ancora decisi ad obbligare i frequentatori della rete a firmare i
propri commenti con nome e cognome, anziché con improponibili nickname.
Progetto, costruzione, comunicazione, rapporto con il pubblico sono, nella mia
esperienza, aspetti che possono e devono andare insieme. Le alternative, per quello
che ho potuto sperimentare, non sono altro che devastanti e non solo per la pratica
sportiva.
Foto di David Mark
�15
Endoxa – Prospettive sul presente, 5, 25, Maggio 2020, pp. 15-21
IDIOSINCRASIE SENSUALI
LUKHA B. KREMO
Norma ha voglia di cioccolata. Sì, quella fantastica sostanza vischiosa che
d’estate si spiattella sul pane e d’inverno s’ingromma sul coltello e si fa fatica a
spalmare. Quella che tutti amano. La Nutella, o una delle tante imitazioni. O,
perché no?, un bellissimo blocco di cioccolato fondente. Nero, consistenze, amaro.
Pazzesco.
Sì, perché Norma non ha mai amato la cioccolata, figuriamoci il cacao. Non
ricorda bene il motivo, probabilmente da piccola l’aveva associata a qualcosa di
spiacevole, insieme a molti altri alimenti. Da bambini, si sa, contano più il colore
e la forma che il gusto. E qualcosa era andato per il verso sbagliato. Poi, con gli
anni, aveva superato questi blocchi psicologici per quasi tutti i cibi. Tranne la
cioccolata. Per quella le era rimasta un’idiosincrasia: si allontanava già sentendo
l’aroma speziato e amarognolo del cacao, ma anche l’odore intenso e dolce della
cioccolata.
�16
LUKHA B. KREMO
Ma ora basta, oggi si è svegliata così: ha voglia di cioccolata. La sua magrezza
non si offenderà. Ha anche il sospetto che tutto dipenda da com’è andata la notte
precedente con Furio, il suo amante. Sette ore sotto le lenzuola, sudatissime, a suon
di carezze, manate, strizzate da paura, rovesciamenti di fronte con la stoffa che si
avvinghiava ai corpi rendendoli dei bozzoli umani. E alla fine niente. Cioè, niente
orgasmo. E questo non poteva che innervosirla, dopo sette ore di ginnastica
sconclusionata. Non era la prima volta che Furio faceva cilecca. Stava diventando
preoccupante.
E allora, cosa le poteva fare di male una sostanza dolciastra che non aveva quasi
mai assaggiato?
Scorre sul cellulare. Internet gli propone una quantità di creme e barrette di ogni
tipo, alla nocciola, ai pinoli, alle arachidi, agli anacardi, allo zenzero. L’incredibile
cioccolato al peperoncino. E ancora, alle bacche di goji, al cardamomo, alla
paprika, al… sale?
Norma chiude tutto. Inutile esplorare il vaso di Pandora del web. Lei ha voglia
di assaggiare la cioccolata subito. Non può aspettare che qualche corriere glielo
porti sotto casa o, come succede oggi, un drone glielo lasci sul balcone.
C’è una pasticceria pregiata poco lontano da casa. Una pasticceria vintage. Di
quelle con i dolci infiocchettati in vetrina, il nome in corsivo anni Trenta e le
praline dappertutto. Tra le arti culinarie, la pasticceria è sempre stata la parte più
affezionata al kitsch. Già negli anni Cinquanta andavano di moda torte rosa, gialle
e violette, anche a più piani, ma per confermarlo basterebbe un tortino con la foto
sfocata del festeggiato stampata sull’ostia, o il cartone animato più in voga, o
finanche un pokémon che spara un raggio dal deretano. Norma, si è capito, non è
mai stata una grande amante della pasticceria in generale. Crescendo, ha sempre
sospettato che la sua ritrosia nei confronti della cioccolata avesse più che altro a
che fare con la consistenza e il colore.
Insomma, Norma entra. La pasticceria sa di dolciastro, il bancone trasparente
bombato simula l’abbondanza, mostrando le torte poggiate su splendenti piedistalli
di acciaio. Queste opere di alto artigianato o, verrebbe da dire, oreficeria, sono
perfette e colorate, ma danno un’idea ambivalente di sé: da una parte c’è la
freschezza della panna appena munta, la leggerezza dell’impasto spugnoso, il pan
di Spagna pregno di rum (o di crema catalana, alla faccia dei secessionismi
postmoderni). Dall’altra appaiono anche oggetti immobili, consistenti, cementati
quasi, di stucco (stuccosi e stucchevoli) come fossero lì da decenni, delle specie di
fossili, allo stesso modo di come le statue di cera imitano le persone di ciccia.
Un posto particolare è riservato per le torte alla frutta e quelle vegane, per chi si
sente sano o per sopire un po’ il senso di colpa. Solitamente sono immerse in
gelatine trasparenti colorate, glasse vitree che sembrano imbalsamare i pezzi di
frutta, immobilizzati come insetti nell’ambra.
A fianco ci sono i pasticcini più esosi, ciambelloni con glasse fluo, krapfen bolsi
e infarinati dai cui fori s’intravede la crema pasticcera pronta a trasferirsi nello
�17
Idiosincrasie sensuali
stomaco. Solitamente questo posto è riservato alla pasticceria regionale, vero
sprezzo a ogni regola alimentare, creme, ricotte e marmellate, cannoli da prendere
a due mani, maritozzi che rigurgitano panna, babà pantagruelici che sanno di alcool
etilico e ogni variante provinciale e municipale che si distingue per un ingrediente,
il nome o anche una lettera soltanto, disprezzando il suo simile come la cosa più
immangiabile al mondo.
Infine i pasticcini di ordinanza, diplomatici, obbligatori, bignè, qualche babà
ridotto, per signorine, e i soliti frutti mummificati.
Infine, l’ultima parte, quella vicino alla cassa, è riservata alla pasticceria secca,
biscottoni di pasta frolla, cialde sbriciolone, spesso con colori innaturali, o forse
troppo naturali.
La pasticciera è sempre molto carina e gentile, ma professionale; ecco, non
dev’essere propriamente dolce, per non aumentare la glicemia psicologica al
cliente.
Norma è entrata pochissime volte, quasi sempre per accompagnare un’amica o
comprare dei biscotti. E si sente imbarazzata come se fosse ancora una ragazzina.
Per fortuna sa cosa vuole.
Ci sarebbero quei biscotti che sembrano bocche da cui sbava la cioccolata. Baci
di Dama si chiamano, nientemeno. Oppure quegli enormi grossi blocchi neri coi
quadratoni stampati, che sembrano armi da impugnare contro malintenzionati. Con
le varianti con nocciole o pistacchi, che dovrebbero servire per scarificare
l’eventuale vittima.
Epperò: lei è uscita di casa con l’idea di quel vaso ricolmo di pasta marrone, la
cioccolata piemontese alla nocciola. E quel barattolone confezionato
artigianalmente la conquista definitivamente. Compreso il vetro, peserà un chilo.
— Sono 14 euro.
Norma non sente nemmeno il prezzo. Ha già deciso. Se è cara vuol dire che è
buona. Passa la carta di credito e la pasticciera sorride, mostrando l’ottimo lavoro
di sbiancamento del suo dentista.
— Mi dispiace. Non posso venderle questo prodotto.
Norma rimane un po’ interdetta. Chiede perché con l’espressione.
— Idiosincrasia di terzo tipo — legge la tizia sulla cassa.
Norma fa mente locale. — Ma io non sono allergica al cacao.
— Mi dispiace — dice la pasticciera riconsegnando la carta. Non ha certo voglia
di mettersi a sindacare sulle allergie o le intolleranze di tutti. Sulla carta risulta così
e lei non può vendergli la cioccolata. Punto.
Norma valuta se comprarsi qualcos’altro. Ma è evidente, è faticosamente entrata
qui per quel motivo e in qualche modo otterrà la sua cioccolata.
La donna esce dalla pasticceria e comincia a pensare. Ricorda: aveva
un’intolleranza al cacao. Non una vera allergia. Così era stata classificata dal
Ministero della Salute. A dire la verità non sa nemmeno quali sintomi abbia, dato
che non la mangia da una vita. Forse l’aveva fatto una volta, come può ricordare?
�18
LUKHA B. KREMO
Va al Centro Commerciale. La sfilza di venticinque casse le mette sicurezza.
Non ci faranno caso, pensa. Entra, va diretta al reparto delle confetture e prende la
sua pesante boccia di cioccolata. Questa volta è proprio Nutella. Industriale, ma
sempre ottima, a quanto dicono.
Quando Norma arriva in cassa, la scena è la stessa. Non posso venderle questo
prodotto.
Questa volta Norma si ferma a chiederle quale sia il motivo.
— Intolleranza al cacao. Effetti registrati: amenorrea e ritenzione idrica.
Norma non può che assentire abbandonando il vasetto.
Ritenzione idrica? Amenorrea! Ma questa è follia. Torna a casa e fa una ricerca
connettendosi al sito del Ministero.
Trova la data e il luogo in cui ha assunto cioccolato. In base a quell’esperienza,
le sono stati vietati l’acquisto e l’assunzione di cacao. La donna cerca di ricordare:
l’indirizzo e il calendario le suggeriscono che si trovava da sua madre, durante un
pranzo pasquale. Qualche parente su di giri per un limoncello di troppo le aveva
messo in bocca un pezzo di uova di cioccolato. Ricorda solo il disgusto per quel
pezzo di stucco marrone, probabilmente cioccolato di pessima qualità.
Non ha idea di come abbiano fatto a registrare amenorrea e ritenzione idrica.
Certamente, in un certo periodo della sua vita, come quasi tutte le donne, aveva
sofferto di ritardi mestruali, e non esitava a pensare che avesse ancora sintomi di
ritenzione idrica, ma che la presunta intolleranza al cioccolato le provocasse quegli
effetti era abbastanza ridicolo.
Decide di chiamare Marika. — Avrei bisogno di un favore…
Marika porta il boccione di Nutella a casa di Norma.
— Ecco qua — dice lei tutta orgogliosa. — Non so come hai fatto finora a vivere
senza.
— Grazie — dice lei. — Non mi è mai piaciuta. Ma uno strappo alla regola si
può fare, no?
Marika era una sua amica di vecchia data. Norma non ricorda nemmeno perché
l’avesse conosciuta. Aveva idee un po’ diverse dalle sue. Norma era la perfettina
che seguiva le regole e le leggi e non aveva mai fatto male a una mosca in vita sua.
Marika non era certo una fuorilegge, ma era sempre stata sospettosa nei confronti
di politici, banchieri e in generale tutti i potenti; era una specie di vegana con
eccezioni a proprio piacimento, animalista senza contatti con animali, no-vax
pourparler. Per cui non aveva mai affrontato certi discorsi con lei.
— No che non si può — risponde alla fine l’amica.
Lo stupore di Norma dura un istante, è chiaro che sia ironica.
— Lo sai come la penso, — si affretta infatti a precisare l’amica, — ma sei tu
quella che segue le regole.
— Io non sono intollerante alla cioccolata. Non mi è mai piaciuta, tutto qui. E
ora ho deciso di mangiarla.
�19
Idiosincrasie sensuali
— Vedi, Norma, non dovrei essere io a dirtelo. Ma se hai una reazione negativa
al cacao potresti aver bisogno di cure, che pesano sulle spese del Paese. Per cui
non puoi.
— Ok, ma questa è una decisione che spetta a me.
— Non più, da quando hai consegnato ogni tuo minimo dato alle autorità
pubbliche. “Io non ho niente da nascondere” dicevi. Ricordi?
Certo che lo ricorda, Norma. Aveva fatto una specie di manifesto per il fatto di
essere onesta e trasparente. Gli altri avevano qualcosa da nascondere, non lei.
Ma Marika è inesorabile: — Eppure tutti noi abbiamo qualcosa da nascondere.
Ma non perché siamo dei delinquenti. Ma perché esiste una sfera privata e una
addirittura intima, che quella pubblica non possono violare.
— Mi hai già fatto questi discorsi.
— Ma forse mi prendevi per una complottista...
Ora Norma dà un nuovo significato alle parole dell’amica. L’orgoglio di
mostrarsi sempre pulita e trasparente si scontra con l’evidenza dell’ingiustizia che
sta subendo. E ora si trovava nella situazione di riconoscere che qualcosa non
doveva essere così trasparente, in quanto appartenente alla propria privacy.
— Lo Stato sa quante volte mangi, quante volte fai la pipì in un giorno e quanta
cacca fai. Sa quante volte scopi — insiste Marika. — Tutto criptato, cioè scollegato
dal tuo nome. Ma lo sa. E se qualcuno decritta, ha in mano la tua vita.
Norma riconosce che il discorso dell’amica ha un senso, ma lei vorrebbe
rimanere fedele alla sua idea di donna genuina e trasparente.
— Grazie, Marika. Ti farò sapere se mi piace — taglia corto. — E se veramente
mi sono persa qualcosa nella vita.
Lei sghignazza. — Di niente, se ne vorrai ancora chiamami.
Norma rimane da sola osservando il vasetto.
— E ora a noi due.
Il cucchiaio da tè è il migliore: ha la lunghezza sufficiente per affondare nella
crema e la capacità giusta per estrarre un bolo sferico e turgido, all’apparenza
procace. Una specie di topolino marrone con la coda che si allunga verso il basso.
Norma apre la bocca vogliosa e vi penetra la palla di crema. Le sue papille
registrano la pasta zuccherina dalla consistenza molle e piacevole. Subito dopo
sente il retrogusto amaro del cacao e quello legnoso della nocciola. È quello il
sentore che gli crea l’idiosincrasia. Le mandibole le si bloccano. Sente i ricordi
delle urla della madre. Vede il vasetto a terra, il vetro rotto da cui fuoriesce la
crema, spaparacchiata sul pavimento come la macchia di un delitto. E poi il tonfo
dello schiaffo sulla guancia. Il dolore, le lacrime, il momento dolce e idilliaco che
si trasforma nella tragedia di lei bambina.
Fine. Norma apre gli occhi come se si fosse risvegliata.
Ha ancora quella materia semisolida marrone in bocca. Sente ancora lo schiaffo,
il dolore. Ma si concentra sul gusto. Il dolce, l’amarognolo. E ingurgita la melassa.
�20
LUKHA B. KREMO
Infine espira, come se avesse concluso una delle fatiche maggiori della propria
vita.
Nessun’altra reazione.
Per l’amenorrea e la ritenzione idrica devo aspettare. Norma ride.
— Buona — dice alla fine.
Osserva il cucchiaino infossato nella cioccolata. E le viene voglia di fare un
secondo boccone. Lo fa, ma poi chiude. Meglio non esagerare.
La donna è soddisfatta. Era certa che la sua non fosse un’intolleranza ma
un’idiosincrasia infantile che si era trascinata troppo nel tempo. Ricorda
vagamente quel momento, come un flash, in cui il vasetto cadde dal tavolo e si
ruppe in mille pezzi. E lo schiaffo della madre. E le urla. E la cioccolata a terra
come uno spruzzo di diarrea.
Norma decide di uscire.
Vuole festeggiare l’evento con una passeggiata.
Dopo un centinaio di metri, un agente la ferma.
— Lei è in contravvenzione.
Norma apre la bocca. Non riesce nemmeno a esprimere il suo stupore per quello
che è evidentemente un errore.
— In base ai suoi spostamenti e a quelli di Marika Caproni, sappiamo che lei ha
mangiato un alimento a lei vietato. E ne possiede una quantità a lei pericolosa.
Sono quattrocento euro per l’assunzione e altre quattrocento se non mi consegna il
vasetto integro entro dieci minuti.
— Ma... ma io non sono allergica! E nemmeno intollerante al cacao, infatti
adesso... mi guardi! — dice lei allargando le braccia come a mostrarsi sana in viso.
Lui non l’ascolta nemmeno e compila qualcosa sul cellulare. — Per firmare
tocchi lo schermo, grazie.
Norma insiste. — Mi ha sentito? Io non sono intollerante al cacao! — grida.
L’agente la guarda con gli occhi di fuoco. — Prima di tutto, non urli. Il cellulare
ha registrato i decibel e ora dovrò aggiungerle cinquanta euro per mancanza di
rispetto a Pubblico Ufficiale.
A Norma verrebbe da gridargli dietro ancora, e tirargli uno schiaffo. A lui e a
tutti gli uomini. Compreso Furio, che parla in pubblico di sesso e poi non combina
niente. Ma la donna sa controllarsi. Soprattutto con i tutori dell’Ordine. È la sua
caratteristica.
— È un errore — dice semplicemente, mentre tocca lo schermo dell’agente
— Se vuole può rivedere la sua posizione prenotando una visita al Ministero a
sue spese per abilitarla all’assunzione delle intolleranze. Per ora è tutto, se vuole
evitare le seconda contravvenzione consegni il vasetto alla più vicina stazione di
Polizia entro dieci minuti.
Il vigile se ne va e Norma rimane immobile, sul marciapiede, a guardare la gente
che passa col capo chino sul cellulare. Le è passata la voglia di passeggiare e le è
tornata quella d’ingurgitare Nutella.
�21
Idiosincrasie sensuali
Torna a casa. Prende il vasetto e affonda il cucchiaino nella pasta come la spada
in una roccia. Ha deciso che pagherà anche l’altra multa. Ottocentocinquanta euro
per uno sfizio!
Norma si sente ingannata. Si rende conto di essere stata ingenua, si aspettava
una ricompensa ed è arrivata la punizione. Ma non può credere di essere davanti a
un castello di carte. È stato solo un errore, cerca di convincersi.
Mentre le sue fauci sono impastate di cioccolata, qualcuno suona al citofono. È
Furio.
— Sali — dice con un ghigno Norma. Norma ha più di un sassolino nella scarpa.
Gli deve spiegare cos’è successo e vediamo se capisce la causa di tutto ciò.
Furio sale, la saluta con un mugugno. Non sembra abbia nemmeno voglia di
parlare.
Lei si mostra con la bocca sporca di cioccolata e il vasetto al centro del tavolo
con il cucchiaio ficcato dentro.
— Allora? Non dici nulla?
Lui scuote la testa.
— Ma non vedi? Sto mangiando Nutella! Una confezione intera!
Lui annuisce, come fosse la cosa più normale del mondo.
Allora Norma comincia a intuire che forse c’è qualcosa di più grave.
— Mi hanno interdetto — dice chinando la testa, come se avesse perso ogni
energia.
Norma fa la faccia di chi non capisce. — In che senso interdetto?
— Interdetto, interdetto! — grida lui quasi isterico. — Non posso più fare sesso.
Sono classificato intollerante al sesso.
— Ma...
— Sì, grazie ai tuoi “non ho niente da nascondere” ora non possiamo più fare
nulla, nemmeno provarci!
Norma ha ancora un piccolo bolo di cioccolata in bocca. E lo sputa a terra. La
forma della macchia sul pavimento le fa davvero schifo. Come quella volta da
bambina. Osserva Furio. Vorrebbe gridargli che è un mezzo uomo, un inutile essere
impotente. Ma non ne sarebbe capace. E non sarebbe giusto.
La donna invita Furio a sedersi, gli avvicina il boccione di cioccolata, estrae il
cucchiaio immerso nella melassa marrone e, mentre si lecca avidamente le labbra
sporche, lo infila nella bocca dell’uomo.
Foto di Miguel Á. Padriñán da Pexels
�22
�23
Endoxa – Prospettive sul presente, 5, 25, Maggio 2020, pp. 23-26
SOFFERENZA DELLA LUCE
(I COLORI SONO AZIONI)
GABRIELE CROZZOLI
Camminare, osservare, camminare e osservare senza smettere mai di credere
che dietro l’angolo ci sarà l’emozione, perché non sono io a trovare le foto, sono
loro che cercano me, io devo solo essere pronto a scattare l’otturatore.
�24
GABRIELE CROZZOLI
�25
Sofferenza della luce (i colori sono azioni)
�26
GABRIELE CROZZOLI
�27
Endoxa – Prospettive sul presente, 5, 24, Maggio 2020, pp. 27-31
EPIDEMIE EMOTIVE
PIER MARRONE
Le emozioni sono generalmente connotate in senso positivo dal senso comune.
Basta farsi un giro su Facebook per vedere la quantità di like che attirano foto di
gattini e esibizioni autoincensanti della propria emotività, per lo più da parte di
mature signore. Per non parlare poi dell’esibizione sentimentale in ambito politico,
che è l’argomento che qui mi interessa.
Questa iperconsiderazione delle emozioni ha le sue ragioni. Infatti, molto prima
dell’esplorazione del mondo attraverso il nostro pensiero razionale, noi ci
rapportiamo a quanto sta al di fuori della nostra mente attraverso le nostre
passioni, come le chiamava la filosofia moderna in Occidente, ossia attraverso
quelle che noi comunemente chiamiamo emozioni. Forse non è nemmeno esatto
dire che ci sia qui un prima (le emozioni) e un dopo (il pensiero razionale), perché
dal punto di vista evolutivo non c’è una reale soluzione di continuità tra questi due
strumenti per comprendere cosa diavolo sta accadendo là fuori.
�28
PIER MARRONE
Ma dal punto di vista evolutivo una ragione forse c’è per mantenere questa
distinzione. Noi siamo l’unica specie apparsa sul nostro piccolo pianeta a
possedere un linguaggio così riccamente articolato. Impossibile che le nostre
capacità linguistiche non abbiamo retroagito sulla nostra esplorazione del mondo
attraverso le emozioni. Il linguaggio non serve certamente soltanto per parlare del
mondo nei termini di quelle attività che normalmente associamo a criteri di
razionalità (come le discipline scientifiche e tutte le attività tecniche), ma viene
articolato principalmente per intrattenere un rapporto emotivo con il mondo.
Quello che viene ritenuto il padre del razionalismo moderno, Descartes poco
prima di morire, pubblicò nel 1649 nei Paesi Bassi, un trattato sulle passioni, Le
passioni dell’anima, che non manca di mostrare una continuità tra passioni e
ragione, che credo da molti sarebbe sottoscritta.
Descartes, ha un’attitudine sospettosa verso le passioni, proprio come ce
l’avevano molti filosofi prima di lui. Quando scrive che la funzione della saggezza
(la nostra capacità di orientarsi nel mondo attraverso la ragione) è principalmente
quella di renderci capaci di dominare le passioni “con tanta bravura, che i mali
che esse causano sono del tutto sopportabili, e si può perfino trarne qualche
gioia”, Descartes ripete un luogo comune della riflessione filosofica, che riteneva
molte passioni un pericolo dal quale guardarsi e che occorre cercare di
padroneggiare, dal momento che, sfortunatamente, non possiamo farne a meno.
Ma alcune sue intuizioni sono prodigiosamente attuali, come quando scrive che
“quando la Speranza è così forte da scacciare interamente il Timore, essa
cambia natura e si chiama Sicurezza o Certezza”. Se con “speranza”
intendiamo il grado di probabilità che noi attribuiamo a un evento futuro, quanto
più questa stima della probabilità è vicina ad 1, tanto maggiore sarà la nostra
aspettativa che questo evento si verifichi. Poiché non puoi avere un’assoluta
certezza che il sole sorgerà domani, l’unica mossa è approssimarsi
probabilisticamente alla verità. Questa approssimazione è la speranza di
raggiungere un alto grado di sicurezza.
Nel corso della storia del pensiero sono state elaborate varie strategie per
raggiungere gradi elevati di certezza, cioè di conoscenza affidabile, ossia, come si
dice con espressione tecnica, di “credenza vera giustificata” (assured true belief
aka ATB). Affidarsi alle “sensate esperienze e necessarie dimostrazioni”, come
diceva Galilei, ad esempio, oppure affidarsi a chi ne sa più di noi, che poi sarebbero
i cosiddetti esperti. Quando ci affidiamo agli esperti, inevitabilmente
riconosciamo loro un determinato potere sulle nostre scelte, anche se ci peritiamo
di avere una mente supercritica che non si fa influenzare da nessuno. Ma rimane il
fatto che è ben difficile precisare che cosa mai giustifichi una credenza vera
giustificata, se non l’appello a un determinate contenuto emotivo, per quanto
edulcorato e apparentemente anestetizzato, come ad esempio la fiducia.
Se non hai motivi strettamente ed esclusivamente razionali per credere che il
sole sorgerà domani, figuriamoci se ne hai per dare credito, a prescindere, agli
�29
Democrazia oscura e algocrazia
esperti. Eppure di qualcuno ti devi pur fidare. Ognuno di noi lo fa continuamente.
Saliamo sugli autobus nella convinzione che l’autista non sia un fanatico
religioso che si farà saltare in aria con una cintura esplosiva. Compriamo da
mangiare al supermercato convinti che le nostre marche preferite non hanno
avvelenato il cibo perché gli stiamo antipatici. Sembrano essere opzioni del tutto
ragionevoli ed addirittura con un elevatissimo grado di certezza, ma solo nel senso
che indica Descartes.
Quindi, verrebbe da dire: la razionalità è solo un’emozione frigida. Eppure io
non credo sia del tutto vero, perché anche l’altra idea di Descartes, che gli derivava
da una tradizione filosofica antecedente, ha una sua parte di verità. Questa non
deve essere sottovalutata e potrebbe essere espressa così: le emozioni distorcono
la realtà, le passioni ti fanno credere che esista qualcosa che non esiste.
Questa distorsione del reale la sperimentiamo molto spesso nella nostra vita.
L’osservazione di Descartes implica qualcosa di importante, ossia che noi
preferiamo tutti vivere nella verità, per quanto ci è possibile. Questo ha due chiare
conseguenze.
(1) non vogliamo essere manipolati dall’esibizione delle emozioni di altre
persone;
(2) non vogliamo che le emozioni che proviamo noi stessi ci manipolino.
Vogliamo che la nostra fiducia sia ben riposta, perché pensiamo che il nostro
interlocutore è una persona affidabile. Non vogliamo che la nostra fiducia sia
assegnata a una persona che ci pugnalerà alle spalle. Non vogliamo che la persona
che amiamo ci dimostri un affetto falso. Non desideriamo provare attrazione per
qualità di una persona che immaginiamo soltanto noi. Non vogliamo tutte queste
cose perché è meglio vivere nella verità (salvo casi molto speciali).
Tuttavia, dobbiamo anche chiederci che cosa c’è di così speciale nell’idea di
vivere nella verità. Non deve esserci necessariamente e soltanto qualcosa di
speciale e raro, ma anche qualcosa di molto comune, perché nessuno potrebbe mai
vivere, se non avesse un larghissimo bagaglio di credenze che si dimostrano vere.
Avere delle credenze vere è un ausilio indispensabile alla nostra sopravvivenza
come individui e come specie. I Darwin Award sono gli ironici riconoscimenti che
vengo attribuiti a chi ha tolto di mezzo il proprio genoma, ammazzandosi spesso
grottescamente per la propria stupidità.
Avere entro certi limiti un controllo delle proprie emozioni non ha, però, a che
fare unicamente con la conoscenza, bensì anche con la sofferenza. Poiché le
emozioni spesso ingannano, perché ci fanno credere che esistano eventi che nella
realtà non esistono, controllarle, per quanto ne siamo capaci, è un farmaco contro
la possibilità di incrociare il dolore nelle nostre vite più di quanto sia necessario.
Le emozioni sono una colla che ci fa attaccare spesso in maniera del tutto non
desiberabile alle situazioni. Si pensi alla rabbia o alla gelosia o alle pulsioni
naricisistiche: emozioni con un forte contenuto negativo, che hanno un effetto
distorcente sulla nostra esperienza della realtà. Questo è riconosciuto anche in una
�30
PIER MARRONE
certa misura da espressioni del linguaggio comune, che parlano di “esame
spassionato” e di “ragionare a mente fredda”, così come di “teste calde” e di
“ormoni impazziti” (con una bella virata dalle passioni alla neurobiologia).
Le passioni, quindi, ci manipolano. Gli autori della manipolazione possiamo
essere noi stessi oppure gli altri. Spesso, l’altro che ci manipola con il sapiente
dosaggio delle emozioni è il potere politico. Il potere sollecita sempre, in ogni
luogo, per perpetuarsi, e soprattutto in momenti critici, il sorgere di emozioni che
devono avere la funzione di riunire i cittadini attorno a sé per sostenerlo.
Questa è una vecchia storia, vecchia come il sorgere di aggregati politici tra gli
uomini. Nella Roma antica il pianto era tanto strumento di crontrapposizione tra
fazioni quanto strumento di sollecitazione diplomatica. Durante la seconda
Guerra Punica, i peteliani, alleati dei romani insediati a Bruttium nell’estremità
meridionale della penisola italiana, si recano nel Senato romano riempiendolo di
lamenti e di pianti per sollecitare Roma al rispetto dell’alleanza, suscitando
secondo Tito Livio grandissima afflizione tra il popolo e i senatori.
Il 26 gennaio 1996, la prima frase che pronuncia Silvio Berlusconi per
annunciare il suo ingresso ufficiale nella contesa politica, ingresso che di fatto era
già avvenuto, sin da quando nella competizione per il sindaco di Roma aveva
dichiarato che avrebbe votato Gianfranco Fini, allora segretario di un partito neofascista chiamato Movimento Sociale Italiano, non ha nulla a che fare con
programmi politici e nemmeno è un appello diretto a sentimenti del suo uditorio,
ma è l’esibizione di un sentimento personale, anche se non privato. “L’Italia è il
paese che amo”, dice Berlusconi aprendo così una campagna elettorale che in
pochi mesi lo porterà alla guida del Paese. In poche ore il videomessaggio di
Berlusconi, che, inizialmente deriso dalla maggior parte dei partiti politici,
dominerà la politica italiana per i seguenti vent’anni, è visto da più di venti milioni
di italiani.
In questi esempi, l’esibizione di emozioni, che sospettiamo non essere del tutto
vere, sono in funzione del raggiungimento di obbiettivi politici determinati:
cementare un’allenza con una potenza, candidarsi alla guida di una nazione.
Nei due esempi che ho citato l’idea è che l’empatia venga suscitata come
funzione positiva. Ma certamente non è questa l’unica strategia che il potere ha per
utilizzare le emozioni. Esiste anche una funzione politica delle emozioni negative,
prima tra tutte la paura, che può essere trasformata in empatia negativa. In
situazioni percepite come altamente critiche, la paura è un potente filtro
distorcente. Credo lo si veda molto bene proprio in questi giorni, quando alla
diffusione epidemica in alcune nazioni di un virus precedentemente sconosciuto si
è assistito anche alla diffusione epidemica di paure irrazionali alimentate da
governi nazionali e locali. Infatti, ci sono nazioni che della recente epidemia di
Covid-19 sono state toccate solo in maniera estremamente marginale, ma che
hanno messo in atto strategie di comunicazione terrorizzanti. A fronte di poche
centinaia di morti (molti di meno di quante ne generano guerriglia armata e
�31
Democrazia oscura e algocrazia
narcotraffico), circa la metà dei colombiani teme di morire di Coronavirus, un virus
che colpisce prevalentemente persone anziane con precedenti condizioni sanitarie
critiche.
Quando Montaigne visita nel 1580 la città di Augusta, è impressionato dalle
misure di sicurezza alle quali ogni visitatore deve sottoporsi per entrare dentro le
mura cittadine: quattro porte di legno riforzate con piastre di ferro, un ponte sul
fossato e un ponte levatoio prima di accedere a una stanza solitaria dove pagare un
pedaggio. Il clima di insicurezza era tanto diffuso quanto fondato. Come puoi
fidarti di chi non conosci? Il nostro mondo ha annullato apparentemente le
distanze, lo sappiamo tutti. In maniera istantanea possiamo venire a conoscenza di
quanto accade in posti molto distanti dal nostro. Questi posti possono diventare
improvvisamente vicini, perché la paura crediamo ce li renda familiari. Così, non
stupisce che il potere, qualsiasi potere, familiarizzi rapidamente con la paura
empatica che diviene endemica e la veda come uno strumento per annullare le
capacità di ragionamento che la maggior parte della gente possiede, al contrario di
quanto qualche snob spesso crede. Noam Chomski, un anarchico incredibilmente
ottimista sulla natura umana, come in effetti dovrebbe essere ogni libertario,
sosteneva che la presenza di queste capacità critiche diffuse nella popolazione
generale è provata dalla diffusa capacità di discutere di sport in modo argomentato.
Non sottovaluterei questa osservazione, non solo perché proviene da un
intellettuale tutt’altro che ingenuo. Ma questi non sono certo i giorni
dell’ottimismo per quanto riguarda le capacità critiche, che vengono annullate
dalle metafore delle guerra e da quelle del nemico invisibile, metafore che vengono
utilizzate per perseguire progetti ingengnerististi per plasmare situazioni future nel
lavoro, nell’istruzione, nei debiti dei quali ci caricheremo, come se noi fossimo
nelle condizioni di governare la realtà.
Foto di Enrique Lopez Garre
�32
�33
Endoxa – Prospettive sul presente, 5, 25, Maggio 2020, pp. 33-35
L’INFLUENCER CONTRO IL WRANGWRANG: IL VALORE DI CIÒ CHE
DETESTIAMO
RICCARDO DAL FERRO
Viviamo nell’epoca degli influencer e ciò ci convince che a spingerci verso un
ideale, una convinzione oppure un gesto, sia l’atto di persuasione dell’idolo verso
cui nutriamo stima e ammirazione. Se il nostro sportivo preferito, il nostro
youtuber prediletto o il politico di grande spessore ci dice che qualcosa è giusto,
noi siamo più propensi a seguire la sua indicazione.
Ne veniamo, per dirla spicciola, “influenzati”.
Ma le cose sono un po’ più complicate di così.
Kurt Vonnegut, nel suo capolavoro Ghiaccio-Nove ci presenta la figura del
“wrang-wrang”, ovvero di colui che, suscitando in noi un’atavica e irrazionale
antipatia, suo malgrado ci spinge verso il contrario di ciò che vorrebbe
proporci. Il wrang-wrang che Vonnegut ci narra è un “poeta nichilista” che
�34
RICCARDO DAL FERRO
vorrebbe convincere il protagonista dell’assoluta verità del nichilismo: per fare
questo egli ne devasta l’appartamento (gentilmente concessogli come alloggio),
copre di merda le pareti, distrugge frigorifero e mobilia e lascia post-it
incomprensibili sparsi per la stanza. Nonostante questo atto persuasivo volesse
spingere protagonista di “Ghiaccio-Nove” verso il nichilismo e la verità del
nonsense esistenziale, egli si sente al contrario spinto verso l’altra sponda e prova
un rifiuto totale nei confronti del nichilismo.
Vonnegut ci ricorda che gran parte delle nostre convinzioni non sono il frutto
di positivi atti di persuasione portati avanti dai nostri “idòla”, bensì negative
reazioni di idiosincrasia nutrite nei confronti di chi ci sta antipatico. È ciò che
odiamo che spesso ci spinge dall’altra parte.
Tutta l’economia comportamentale, e in particolare le opere di Richard Thaler
(“Nudge - La spinta gentile”), ci ricorda che il nostro sistema di valori si forma
grazie ad un complesso meccanismo di incentivi e disincentivi, spinte positive o
negative che sono rappresentate dalla marea di stimoli che ci circondano in ogni
istante della nostra esistenza: dalla persuasione del marketing all’educazione
ricevuta a scuola, dal modo con cui i piatti vengono ordinati in un menu al sistema
fiscale di una nazione, fino a giungere nei recessi più insospettabili della nostra
società, come le thumbnail dei video di YouTube (ovvero le immagini di anteprima
che vediamo prima di aprire il video) o l’ordine con cui ci vengono presentati gli
argomenti di cronaca in un quotidiano.
Non solo, l’economia comportamentale è giunta alla chiara conclusione che i
sentimenti negativi, quali la paura, l’avversione, l’antipatia e il sospetto, sono
estremamente più efficaci di quelli postivi, come l’amore, l’attaccamento, la
fiducia e la determinazione, nel farci seguire una strada al posto di un’altra, nel
farci prendere decisioni anche sostanziali sulla nostra vita.
Ciò significa che, se è vera l’idea secondo cui le nostre convinzioni politiche,
filosofiche, sociali ed economiche, ma anche i giochi che preferiamo, le amicizie
che ci scegliamo, i film che inseriamo tra i prediletti e i libri che leggiamo, sono
frutto delle “gentili spinte” di cui ci circondiamo ogni giorno, è allora vero che
l’influencer ha un ruolo ridicolo in questa strana economia delle idee, mentre
il wrang-wrang è estremamente potente nello spingerci verso una determinata
direzione, fosse o meno il suo obiettivo.
L’idiosincrasia, insomma, è molto più potente di qualsiasi idolatria, e l’odio che
proviamo nei confronti di qualcuno è un’energia molto più efficace nel persuaderci
dell’esatto opposto. Ciò che spesso ci sfugge è che il sentimento negativo,
l’angoscia o l’odio, l’antipatia o l’ossessività, è una forza persuasiva infinitamente
più potente e riesce in minor tempo e con minore difficoltà a spingerci verso ciò
che poi forma la nostra personalità.
Se tu sei un comunista, è molto più probabile che sia stato l’odio nei confronti
di Berlusconi o di Steve Jobs a spingerti verso quell’ideale, così come se sei un
liberale sarà stata l’antipatia nei confronti della barba di Marx o delle giacche di
�35
L’influencer contro il wrang-wrang: il valore di ciò che detestiamo
Bertinotti a farti aderire primariamente ad una certa convinzione. Dopodiché è
ovvio, l’approfondimento e lo studio ti permettono di conoscere a fondo le
ragioni dietro quelle idee: ciò che separa l’individuo stupido da quello intelligente
è la consapevolezza di dover osservare in modo autocritico le proprie convinzioni,
ricercandone sempre, quando possibile, le radici. Ma è indubitabile che la prima
spinta, quella superficiale e determinante, sia arrivata più per odio che per amore.
Il wrang-wrang è perciò il vero influencer poiché è l’influencer che ci sta sulle
balle a spingerci verso una determinata direzione. Ed è difficile sapere se quell’atto
sia stato deliberato (se il wrang-wrang abbia voluto farsi odiare per mandarci di là)
o se sia stato involontario (e lui volesse davvero portarci laddove diceva). Queste
sono questioni che non possiamo affrontare qui.
Ma se c’è una cosa che ho imparato è che il pragmatismo mi ha inizialmente
sedotto molto più per l’antipatia nei confronti di Hegel (mio wrang-wrang
preferito) che non per l’amore verso Peirce. Il fatto che io abbia poi trovato delle
ragioni più profonde per detestare Hegel e amare Peirce potrebbe essere frutto di
un approfondimento di quell’idiosincrasia, più che di una ricerca razionale e libera
dal mio wrang-wrang.
Quale conclusione dare a questo ragionamento? Difficile dirlo, anche perché
l’abbattimento che potremmo provare nell’osservare l’abisso della nostra
economia comportamentale è dietro l’angolo. Ciò che ho imparato però è che devo
stare molto più attento ai miei wrang-wrang che agli influencer di cui sembra
popolato il mondo. Sono molti di più coloro nei confronti dei quali nutriamo
idiosincrasia rispetto a coloro che potremmo eleggere, più o meno istintivamente,
nostri idoli.
E gli idoli, ci piaccia o meno, hanno molta meno influenza su di noi rispetto ai
wrang-wrang.
In fin dei conti, la libertà consiste non nello scegliere i giusti wrang-wrang,
ma nello sperare di essere scelti da quelli sbagliati. E imparare così a
riconoscerli, sapendo riflettere un po’ più lucidamente su quello che ci compone
come individui.
�36
�37
Endoxa – Prospettive sul presente, 5, 25, Maggio 2020, pp. 37-41
L’ANAGRAMMA IMPOSSIBILE
GIANFRANCO CARBONE
Idiosincrasia: sostantivo, elemento del sistema linguistico che designa una
persona o cosa qualsiasi (ente, concreto o astratto, singolo o collettivo) nei cui
confronti si esprime una valutazione o un giudizio che è, in sé, autosufficiente ad
esprimerli (a differenza dell'aggettivo che determina la qualità dei sostantivi se
qualificativo o la loro situazione nell'ambiente se pronominale).
La parola “idiosincrasia” ha un significato puntuale nel linguaggio
corrente: essa esprime “'forte avversione per qualcosa o qualcuno', 'ripugnanza
esasperata', profonda insofferenza, rifiuto assoluto, incompatibilità radicale che
causa repulsione' (definizioni di Zingarelli, Devoto-Oli, Sabatini-Coletti).
�38
GIANFRANCO CARBONE
Nel linguaggio medico rispecchia un concetto parzialmente diverso e indica
l'enfatizzazione negativa di un aspetto di contrasto fra la cura e la patologia. Per
molti medici determinare l’idiosincrasia fra cura e paziente comporta l’
'individuazione della natura della persona malata. È una scuola di pensiero antica.
Lo scrisse per primo Galeno in Methodus medendi.
La parola è composta da tredici lettere: (sette vocali e sei consonanti). Le
lettere sono: quattro i, due a, due esse, una erre, una ci, una di, una enne, una o.
In italiano non ci sono altre parole formate da queste lettere e così
“idiosincrasia” non ha anagrammi possibili.
Non ci sono anagrammi parziali (logogrifi : gioco enigmistico che consiste nel
formare parole di varia lunghezza utilizzando solo alcune delle lettere di una parola
di partenza) con 12 lettere.
C’è un solo anagramma, parziale, utilizzando 11 lettere: la parola “disarcionai”
(e restano in panchina le lettere i ed s .
I linguisti discutono se l'aggettivo più corretto per indicare chi è "affetto da
idiosincrasia" sia idiosincratico oppure idiosincrasico
I puristi preferiscono la variante con la lettera s (idiosincrasico) perché
sostengono che la variante con -t- sia meno rispettosa dell’etimo in quanto di
derivazione
inglese
( idiosyncratic),
coniata
sul
modello
di apostasia - apostatico, oppure enfasi – enfatico anche se gli aggettivi con
il suffisso derivazionale “ticus” derivano, normalmente, dal tardo latino e quindi,
i puristi, storcendo il naso agli anglicismi rimuovono la radice latina che, in tempo
di sovranismi, non è una scelta da poco ma a questa contraddizione ci conduce
l’eterogenesi dei fini come conseguenza non intenzionale di una scelta culturale
intenzionale.
Si vuole difendere la purezza tradizionale linguistica e ci si immerge,
implicitamente, nei meandri della contaminazione ma anche questa potrebbe
essere un’astuzia della ragione (così forse avrebbe pensato Hegel) in un mondo
globalizzato sempre più dipendente da un lessico omogeneizzato
But be careful!
Coloro che si addentrano in questa sottile riflessione etimologica sui terminanti
dell’aggettivo pronti a criticare o ad apprezzare la sua origine inglese non pensino
di avviare una discussione con un inglese vero che ascolterebbe allibito.
L’unico significato comune fra italiano e inglese è l’uso medico (ad esempio,
idiosyncrasy individual hypersensitiveness as to a drug or food) mentre
nell’uso corrente quello che per noi italiani è una forte avversione per qualcosa o
per qualcuno per un inglese è invece “a peculiarity of constitution or
temperament: an individualizing characteristic or quality” oppure
“characteristic peculiarity (as of temperament); broadly: eccentricity”.
Dal timore o dall’insofferenza all’originalità o al relativismo del “in linea di
massima”
Attenzione: siamo pieni di stranieri in patria, non se ne sente la mancanza.
�39
L’anagramma impossibile
Torniamo in Italia.
Quante persone conoscono esattamente il significato del termine e parlando fra
loro si capiscono?
Luigi Pirandello che, che si laureò in Germania dove fece analisi approfondite
sull’uso di termini nelle diverse lingue. nel dramma Sei personaggi in cerca
d’autore evidenzia il tema dell’incomprensione, e mette in risalto l’impossibilità
degli uomini di esprimersi e comunicare intendendosi in modo concreto.
È doverosa una citazione del testo:
“Ma se è tutto qui il male! Nelle parole! Abbiamo tutti dentro un mondo di
cose; ciascuno un suo mondo di cose! E come possiamo intenderci, signore, se
nelle parole ch’io dico metto il senso e il valore delle cose come sono dentro di
me; mentre chi le ascolta, inevitabilmente le assume col senso e col valore che
hanno per sé, del mondo com’egli l’ha dentro? Crediamo d’intenderci; non
c’intendiamo mai!”.
Ma qui tocchiamo un livello diverso di riflessione.
Ognuno di noi alla base della struttura del pensiero categorizza diverse idee,
oggetti e situazioni. Utilizziamo delle procedure mentali. Utlizziamo
(consapevolmente? Non credo) l’astrazione, ricercando gli aspetti che due o più
oggetti, idee, situazioni hanno in comune, e la generalizzazione con un
procedimento induttivo per associare ad una varietà di elementi o di esperienze lo
stesso significato.
In ognuno di noi i concetti derivano dall’esperienza e parlare con qualcuno di
qualche cosa è la capacità cognitiva che più ci caratterizza nella sua duplice
funzione comunicativa e simbolica, che consente di descrivere oggetti o eventi
attraverso simboli e concetti.
La mia avversione per qualcosa o qualcuno, quindi la mia “idiosincrasia” si
trasforma in concetto espresso dalle mie parole sulla base di un’esperienza
personalissima nella quale sono sedimentate le mie paure o le mie antipatie o i
giudizi che ho elaborato.
Se li esprimo in un discorso con un’altra persona trasmetto inevitabilmente il
significante, il tono acustico o l’immagine, ossia la faccia esterna del mio pensiero
per come viene percepita da un altro ma non il significato che ho interiorizzato
con la mia vita.
Comunico la mia “idiosincrasia” per qualcuno o qualche cosa ma chi parla con
me comprende la mia avversione ma non ne coglie l’emotività anche perché quel
“qualcuno” o quella “cosa” può essere per lui del tutto indifferente o, persino,
suscitarli una reazione positiva o di empatia.
La parole può assumere quindi sfumature di valore e significati ambivalenti;
nell’uso si opacizza e non sempre è riconducibile in senso stretto all’etimo. Mutata,
come un virus (riferimento attualissimo) nel gioco delle esperienze individuali può
esprimere rigetto o capriccio, ossessione, persino arbitrarietà.
�40
GIANFRANCO CARBONE
Molti intellettuali ne hanno piegato il senso alle proprie esigenze e sono
testimoni dell’adattabilità del termine al contesto, sulla base di una spinta del tutto
individuale con margini altissimi di soggettività.
L’idiosincrasia dei testi di Croce non è la stessa definita da Bacchelli così come
per Pavese spazia in un ambito differente da quello di Magris o Arbasino.
Ha forse ragione Edmondo De Amicis che nel suo libro L’idioma gentile la
prende di mira e ironizza considerandola “parola indegna” “Le declamazioni d'una
liberale e civile idiosincrasia. C'è chi ne va matto !".
Ma poi, nel linguaggio corrente, viene capita?
Siamo proprio sicuri che utilizzando la parola venga afferrato il concetto,
almeno quello elementare e definito dal dizionario di “profonda insofferenza” o di
“rifiuto assoluto”?
Non ne sarei tanto sicuro.
Gira un testo che descrive un corteggiamento.
Un giorno, un galante sagittabondo decise di tentare un esperimento: si vestì
come il peggiore degli sciamannati e uscì di casa, ben deciso a conquistare una
bella sgarzigliona.
Non
appena
intravide
la
predestinata,
tuttavia,
la
mente
del gaglioffo si obnubilò e lui commise un errore lapalissiano: le si
avvicinò meditabondo, le girandolò intorno e e la stordì con un discorso
talmente pleonastico da sembrare artefatto.
La fanciulla, trasecolata dall’aspetto bislacco dello smargiasso, dapprima si
spaventò, poi lo apostrofò con una bella ramanzina.
“Signorina, qui ci troviamo di fronte a un grosso granciporro! Non si lasci
ingannare dai miei abiti frusti e venga a cena con me.”
La donzella, ammaliata da quel lessico forbito, accettò un pasto luculliano, al
termine del quale il nostro amico –solipsista solo in apparenza- lasciò addirittura
una generosa buonamano.
Sottoposto a verifica in una ampia platea di lettori una percentuale
inimmaginabile non solo non conosceva il significato di tantissime parole (dalle
più inusuali come “frusto” o “solipsista” alle più intuitive come “meditabondo” o
“obnubilato”) ma non riuscì ad afferrare il senso della frase che altro non descrive
che un comunissimo corteggiamento.
È quindi assolutamente realistico il dialogo fra Sandy e Frenchy nel film
Grease.
“Dovrò vincere la mia idiosincrasia” afferma Sandy. “Che cos’è? Una
specie di psoriasi?” risponde Frency.
Nella confusione restano le mie paure, le mie repulsioni, i miei rifiuti assoluti
che io definisco “idiosincrasie”.
Mi sento come Lucrezio nella “De rerum natura” ed ho elaborato il mio
personalissimo tetrafarmaco nei suoi quattro componenti essenziali:: non si deve
�41
L’anagramma impossibile
aver paura della morte, non si deve aver paura degli dei, il bene è facilmente
raggiungibile, il male è facilmente evitabile.
Lo considero, direbbe Petrarca, un capitolo de remediis utriusque fortunae
della mia esistenza condito da un rassicurante Oderint dum metuant (Mi
odino, purché mi temano) che viene trattato dal Machiavelli nel Il principe a cui
dedica un capitolo intero, il XVII La crudeltà e la pietà; e se sia preferibile essere
amati piuttosto che temuti, o il contrario, e questa è la risposta del segretario
fiorentino: “Ma perché è gli è difficile accozzarli insieme, è molto più sicuro
essere temuto che amato, quando si abbi a mancare dell'uno de' dua. […] li
uomini hanno meno rispetto a offendere uno che si facci amare, che uno che
si facci temere: perché lo amore è tenuto da uno vinculo di obligo, il quale,
per essere gl'uomini tristi, da ogni occasione di propria utilità è rotto, ma il
timore è tenuto da una paura di pena che non ti abbandona mai.”
Ma è proprio così per noi sudditi timorosi? La mia cura è efficace nei
confronti di un singolo ma del “potere”?
Nel frontespizio della prima edizione del Leviatano di Hobbes, è riprodotto il
corpo a mezzo busto di un sovrano che incombe sulla città, che sorveglia i sudditi
ma che li protegge dai nemici e contiene numerosissime figure umane che
guardano in alto verso il loro re. È stata offerta un duplice interpretazione di questa
immagine, che ad un esame sommario sembra voler dire che il sovrano è tale per
volontà ed effetto dei sudditi, ma è stato aggiunto nell’interpretazione che «i
sudditi sono gli autori della loro propria paura ed è il loro sguardo spettrale a
rendere il viso del Leviatano, altrimenti benigno, non solo maestoso, ma anche
minaccioso» (così ne pensa Corey Robin, Paura. La politica del dominio).
E queste diventano le mie cure banali delle mie idiosincrasie contro
qualcuno: chi mi sta sul cazzo lo mando a fan culo.
Nei confronti del re o in generale del potere non mi dimentico che “è
nudo” sempre pronto a denunciarne i limiti perché, oltre a tutto, mi sento in
credito per tutte le volte che un potere ha reso me nudo.
E l’idiosincrasia per qualche cosa? Per un ragno o un serpente. Per questa
non ho un rimedio. Me la tengo. Mi rassicuro come Totò che dice nel suo
film Figaro: “Il coraggio non mi manca. È la paura che mi frega.”
Se vedo un serpente scappo, provo una ripugnanza esasperata, una vera
idiosincrasia.
Foto di Nino Carè da Pixabay
�42
�43
Endoxa – Prospettive sul presente, 5, 25, Maggio 2020, pp. 43-46
STATO DI REPELLENZA
CRISTINA RIZZI GUELFI
idiosincrasia
/i·dio·sin·cra·ṣì·a/
sostantivo femminile
[…] manifestazione di repellenza verso una sostanza, un soggetto, un luogo,
un’idea, ecc.; una manifestazione, anche astratta, di ipersensibilità emotiva o fisica.
L’amore è un perfetto esempio di idiosincrasia: lo si ricerca con convinzione
per tutta la vita e quando lo si trova cominciano a manifestarsi reazioni allergiche
insopportabili.
Sponsorizzato da testi sacri nelle piccole collettività, nelle borse anguste delle
famiglie, nei corridoi incerati degli appartamenti. Pubblicizzato sul piccolo
�44
CRISTINA RIZZI GUELFI
schermo da famiglie perfette, con tiritere assorbite a memoria nelle sere annoiate
adagiati su pavimenti a mattonelle con le gambe scoperte. Cantilene uscite da
famiglie stabili e numerose.
Sette figli con il muso scarlatto e orecchie a sventola e una successione eterna
di indumenti di passaggio nuovi e colorati. Famiglie che hanno creato la loro
agiatezza autoalimentandosi con sospiri di incitamento al lavoro. Benessere in
scodelle traboccanti di latte e lana sui giacigli.
Famiglie la cui fede nel quotidiano è sorretta da ordinari difetti di un’esistenza
di sgobbate spezza giunture e da una fanciullesca tirchieria portata con
disinvoltura. Quell’amore in PAL che guardo con idiosincratica espressione e con
la compostezza delle suore in lettura.
�45
Emergenza e filosofia dell’estraneo: cosa può insegnarci Bernhard Waldenfels
�46
CRISTINA RIZZI GUELFI
�47
Endoxa – Prospettive sul presente, 5, 25, Maggio 2020, pp. 47-50
AGAMBEN E L’IDIOSINCRASIA DELLA
MORTE: STATO DI ECCEZIONE E
NUDA VITA NELL’EPIDEMIA DI
CORONAVIRUS
ULDERICO POMARICI
1. Con alcuni interventi sull’epidemia in corso – ormai trasformata in
pandemia – pubblicati sul sito di Quodlibet tra febbraio e marzo, il filosofo
Giorgio Agamben, fa alcune affermazioni molto gravi e perentorie: l’epidemia
sarebbe un’invenzione indotta dal potere politico che non perderebbe occasione
per instaurare lo stato di eccezione, rendendolo permanente al fine di privare i
cittadini delle loro libertà fondamentali. ‘Strumento’ di diffusione di questa
sottomissione generalizzata al potere sarebbe l’idea di contagio, diffusa ad arte
per ingenerare panico nella popolazione e indurre alla sottomissione tacitando ogni
opposizione sociale e politica. Così, mentre l’Italia segue col cuore in gola il
drammatico decorso dell’epidemia di Coronavirus, Agamben ne teorizza la natura
politica, con una chiamata di correità per tutta la popolazione italiana, colpevole di
�48
ULDERICO POMARICI
sottomettersi al diktat del potere, disposta com’è a sacrificare tutte le libertà
fondamentali aggrappandosi miseramente alla ‘nuda vita’. Una provocazione
dadaista? Un’ovvietà? Non proprio. Due sono i concetti classici che risaltano in
questa interpretazione dell’evento epidemico, entrambi usati da Agamben in modo
fin troppo disinvolto. Nuda vita e stato di eccezione. Il primo, come si sa, frutto
del genio di Walter Benjamin, il secondo, invece, utilizzato, ma non creato, da
Carl Schmitt. Agamben è un grande esperto di entrambi questi pensatori, dunque
ancora più rilevante appare la topica nella quale mi sembra incorrere con questa
interpretazione dell’epidemia. Non si possono traslare concetti che hanno una
tradizione e una pratica storicamente determinata in qualsivoglia altro contesto.
2. In buona sostanza qui è in gioco un certo modo di fare filosofia, quando, come
appare nel caso di Agamben, la teoria si appropria della realtà, sequestrandola per
soppiantarla. La domanda è: cosa si interpreta se viene meno il fatto? Che cos’è la
filosofia, fin dalle sue origini, se non melete thanatou, meditatio mortis, riflessione
sul fatto – sul mistero – della morte? Su questo topos si è soffermata
prevalentemente, sebbene non esclusivamente, una parte importante del pensiero
occidentale. E cosa c’è di più mortifero di una pandemia? Definire quindi questa
epidemia un’invenzione è come rimuovere il fatto della morte. E, rimuovendola,
rimuovere la vita stessa. Come se l’istinto di conservarla non ne facesse parte, non
ne fosse alla base. Anzi, come se fosse un peccato. Peccato, sì, ma peccato mortale
del filosofo che rimuovendo la morte ne rimuove il senso proprio, riposto in
nient’altro che nella vita. Il fatto della morte. Al quale siamo esposti fin dalla
nascita e che ci accompagna, l’orizzonte degli eventi, per così dire, anche perché
rende uguali le nostre vite. “A morte o’ ssaj ched’é? ... è una livella”, diceva Totò.
Una grande livellatrice che pone tutti sullo stesso piano. Come e perché non
reagire, allora, alla minaccia della morte da parte di un nemico invisibile e
sconosciuto? Questo è anche nostro, porre innanzi la vita, porre la vita contro la
morte. La vita, non la nuda vita! Cosa c’è di più umano che contrapporre alla morte
il desiderio di restare vivi! Non la nuda vita, come vorrebbe Agamben, ma la salus,
la salute, che esprime salvezza e di cui si fa portatrice la nostra Costituzione in uno
dei suoi articoli più importanti, il 32 al primo comma: “la Repubblica tutela la
salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”. E
l’aggettivo fondamentale non è di poco peso, visto che ricorre lungo l’intero testo
solo in questa occasione.
3. E invece per Agamben non è così. Sfuggire il pericolo, la morte, ricercare la
salvezza abbandonando temporaneamente le consuete abitudini della socialità
(anche queste, evidentemente, salvifiche nello stato normale) è da vigliacchi: “gli
italiani sono disposti a sacrificare praticamente tutto, le condizioni normali di vita,
i rapporti sociali, il lavoro, perfino le amicizie, gli affetti e le convinzioni religiose
e politiche al pericolo di ammalarsi. La nuda vita – e la paura di perderla – non è
qualcosa che unisce gli uomini, ma li acceca e separa”. Questa ricerca quasi
spasmodica del particulare, del ripiegare nella propria abitazione privata, viene
�49
Agamben e l’idiosincrasia della morte: stato di eccezione e nuda vita
nell’epidemia di coronavirus
letta da Agamben come una sorta di asservimento volontario al potere, in un
modo che richiama lo splendido scritto di Étienne de La Boétie. Infatti la ‘peste’
come manifestazione perversa del potere, dice Agamben, è un fiume carsico, una
dynamis che l’epidemia ha solo resa reale. La peste dell’asservimento. É fin troppo
evidente, invece, che nelle situazioni ‘normali’ la vita al suo grado zero (non la
nuda vita !!), sia solo conditio sine qua non dell’esistenza e non certo conditio per
quam, fine al quale tendere. Tuttavia, quando ne va della vita stessa, è semplice
istinto di conservazione (ché noi siamo anche animali) difenderla contro tutto e
contro tutti, come nell’esempio classico che fa Kant dei due naufraghi attaccati a
un solo asse di legno: nel caso di eccezione è lecito salvarsi la vita anche a danno
di un altro. Non c’è giudice, afferma Kant, per un ‘reato’ del genere. Ma anche in
questo caso non è nuda vita ma solo il male estremo al quale la forma-di-vita può
ridursi. Quando la vita sociale è sospesa per necessità e regredisce alla sua essenza
come in questa epidemia, la forma-di-vita minimale diventa provvisoriamente una
conditio per quam solo perché c’è la minaccia concretissima di poterla perdere.
Ma non c’è alcuna colpa in ciò. Stato di eccezione sì, ma non politico bensì
esistenziale.
4. Idiosincrasia è l’avversione verso una determinata cosa, una incompatibilità
radicale a un certo elemento. A cosa è avverso Agamben? All’idea che non si possa
né si debba anteporre la nuda vita, la zoè, alla forma-di-vita, il bios. Ma possiamo
noi produrre la nuda vita o non siamo in presenza – visto che è opera dell’uomo –
sempre e ancora di una forma-di-vita? Allontanandoci apparentemente dal tema
vorrei argomentarlo muovendo da Walter Benjamin. Nel suo Il compito del
traduttore, Benjamin discute un concetto di nuda vita che potrebbe aprire una
riflessione ulteriore sul tema in questione. Nel parlare del rapporto fra originale e
traduzione Benjamin istituisce un parallelismo con la vita: “Come le
manifestazioni vitali sono intimamente connesse col vivente senza significare
qualcosa per lui, così la traduzione procede dall’originale, anche se non dalla sua
vita quanto piuttosto dalla sua sopravvivenza”. Su questa traccia, ma in modo più
radicale, Derrida sopraggiunge affermando che l’originale è irraggiungibile, nel
senso che è già da sempre esso stesso una ‘traduzione’ di altri testi sopravviventi.
La sopravvivenza è il modo di essere del testo. Ma questo cosa implica per il nostro
discorso sulla ‘nuda vita’? Che non si dà mai per l’umano un regresso al di là della
zoé per produrla. Anche la clonazione non è certo il raggiungimento di una
Herrschaft assoluta (un dominio) sulla vita così da imporre la forma dovunque. La
zoè, invece, può essere riguardata solo come quel limite invalicabile dove tace il
linguaggio. Non siamo noi che possiamo dominarlo, come questa epidemia
dimostra ad abundantiam. L’indicibile che esiste nonostante la nostra presenza.
La vita, pur nella degradazione, è sempre ancora forma-di-vita. Anche quella del
lager è una messa-in-forma della vita. Terribile, ma forma che infatti, in quanto
tale, implica la possibilità della pena. C’è un non-oltre. E qui ci soccorre un
�50
ULDERICO POMARICI
pensiero della Arendt: “È molto improbabile che noi, che possiamo conoscere,
determinare e definire l’essenza naturale di tutte le cose che ci circondano, di tutto
ciò che non siamo, possiamo mai essere in grado di fare lo stesso per noi: sarebbe
come scavalcare la nostra ombra” (Arendt, Vita activa, 9-10). L’idea di anteporsi
alla zoè, alla nuda vita come se potessimo elaborarla da noi appare un pensiero
onnipotente, che nega proprio ciò che invece dovrebbe essere affermato, che c’è
un limite per l’umano e che noi viviamo sempre all’interno di questo limite, che è
il limite del linguaggio. “È solo quando si riconosce vita a tutto ciò che si dà storia
e che non è solo lo scenario di essa, si rende giustizia al concetto di vita”
(Benjamin, Il compito del traduttore, 41). Noi non siamo centro, ma sempre e solo
de-centrati. Punto di vista. Misconoscerlo ci preclude il pensiero del limite. Non
volerlo accettare esprime dunque una seconda idiosincrasia, verso tutto ciò che non
posso raggiungere. La natura appare come l’indicibile fin quando non diventa una
forma. Prima non c’è per noi. Altrimenti davvero tutto diventerebbe possibile. La
vicenda dell’epidemia del Covid19 non dimostra nella sua assoluta imprevedibilità
esattamente questo? Ogni dialogo con la natura nello sviluppo tecnologico
contemporaneo è diventato un monologo terribile. E oggi la sempre più veloce
obliterazione della ‘natura’ da parte della tecnica ci rende responsabili verso noi
stessi e verso tutti coloro che verranno dopo di noi in modo incomparabilmente
superiore rispetto alle generazioni precedenti. Il nostro destino è sempre più nelle
nostre mani, così che non possiamo più appellarci come gli antichi all’immutabilità
della natura. La natura non ci fa più da schermo. Tuttavia, proprio per questo
dobbiamo essere in grado di trovare un limite a questa onnipotenza. Degradarla.
Non tutto ciò che tecnologicamente si può fare deve per ciò stesso essere fatto.
Dopo che per millenni hanno marciato divise e spesso contrapposte, negli ultimi
decenni i ritmi delle tecno-scienze hanno bruciato ogni distanza fra vita naturale e
tecnica. Stiamo assistendo oggi a una naturalizzazione della tecnica. E questo è un
processo che può condurre anche a risultati aberranti. Proprio per la natura neutrale
della tecnica. Esistono tutte le condizioni tecno-scientifiche affinché le forme di
vita future, inconoscibili oggi, possano manifestarsi in modo non catastrofico e
espandersi liberamente. Condizioni che, tuttavia, non possono crearsi in assenza di
“un quadro culturale e sociale in grado di reggerne il peso” (Aldo Schiavone).
Problema, questo, enorme, di legittimazione democratica.
�51
Endoxa – Prospettive sul presente, 5, 25, Maggio 2020, pp. 51-57
IL VIRUS E LA PARALISI DELLA
MENTE
SILVIA D’AUTILIA
A Massimo, per le possibilità di confronto
Non ci è dato per il momento sapere come muteranno le nostre vite fra
uno, due o cinque anni, in seguito a questa emergenza, ma una cosa è certa:
il vuoto di critica e pensiero che l’ha accompagnata produrrà effetti
considerevoli. Col diffondersi del Covid19, sono state adottate una serie di
misure di contenimento sociale che hanno comportato un restringimento,
quando non un annullamento, delle libertà personali. A partire da questo
momento e con un riduttivismo sbalorditivo, ha preso vita sulla scacchiera
sociale una grottesca contrapposizione tra sostenitori e detrattori dei
provvedimenti adottati a tutela della pubblica salute. Come se il discorso
attorno alla radicale trasformazione delle nostre vite possa essere
sbrigativamente ricondotto a un asfittico dualismo manicheo di favorevoli o
�52
SILVIA D’AUTILIA
sfavorevoli, mancando l’appuntamento con la complessità del dibattito che
la situazione ha generato.
A pagare il prezzo di questa demarcazione è stata innanzitutto la
riflessione sul soggetto e sulla condizione di eccezionalità che sta
attraversando. È la prima volta che stiamo facendo i conti con un io inedito,
non più padrone di sé, e non certo nella declinazione psicoanalitica della
questione, ma in relazione a uno sfilacciamento della sua autenticità politica,
sociale e culturale. Una materia che ha visto improvvisamente uscire di scena
fior fior d’intellettuali e attivisti dello spirito. Non solo. Anche i solerti
militanti delle passate cause sociali e dei diritti sacrosanti adesso, tutto d’un
tratto, preferiscono anestetizzare le coscienze dietro alla minaccia di un virus
che, a quanto pare, oltre agli effetti sul corpo, è anche in grado di paralizzare
le menti. La grave latenza di queste categorie è stata ed è tanto più
ingiustificabile quanto più prendono piede, nella più generalizzata
indifferenza sociale, politiche d’infragilimento del vecchio soggetto di
diritto, a favore di un mero “residuo di soggettività”. Sono divenuti
residuali: il diritto alla libertà personale, alla circolazione, alla libertà di
riunione, i rapporti economici, la salvaguardia dell’istruzione e della cultura,
della libertà di pensiero ed espressione, (il cui deterioramento sta toccando
soglie davvero allarmanti) e in generale un intero ordinamento repubblicano.
Il tutto in nome di un virus.
Si replicherà che è sbagliata la percezione, in quanto non si tratta di
decurtazioni della libertà personale, ma di indicazioni terapeutiche di
spessore sociale in un contesto di drammatica emergenza sanitaria. Ebbene,
l’occasione è buona per evidenziare una volta per tutte che il vero nodo del
problema è proprio questo: proprio perché si tratta di accadimenti mai vissuti
prima abbiamo l’indifferibile dovere di non assopire il pensiero, di non
abbassare per un solo istante la guardia, riducendo ogni attività sinaptica al
consenso o dissenso su quello che ci viene – cit. – consentito o non consentito
di fare, (con buona pace dei nostri vecchi diritti costituzionali!)
Dacché l’epidemia ha reso oggetto di decisionalità politica la ridefinizione
delle nostre quotidianità fin nei più privati particolari, andrebbero
rivendicate cornici di dibattito che si occupino per intero della questione.
Tutelando fino al capello la società dal Covid19, che pure ha mietuto e
continuerà a mietere innumerevoli vittime, la si lascia completamente
scoperta e sottotutelata dal resto dei problemi. A dimostrazione di questo
atteggiamento, si è visto come sia stata demandata quasi interamente la
gestione del problema alla figura dello specialista, divenuto il nuovo arbitro
biopolitico. Nei più noti salotti televisivi, dove si è prodotto il fenomeno
�53
Il virus e la paralisi della mente
sociale dell’attesa della pronuncia specialistica abissando i restanti aspetti
della discussione, non solo si è consumata una stagnante ripetitività dei
tecnici interpellati, ma nemmeno ci si è curato di esporre questi personaggi
al contraddittorio con colleghi di opinione differente.
Il livello di conoscenze attorno al virus e soprattutto alle modalità con cui
conviverci - perché è questo il vero tema - è al momento talmente esiguo da
richiedere a maggior ragione analisi di rango dialettico. Si è rivelata fin
troppo bene la debolezza di una decisionalità esclusivamente giocata sul
tavolo della titolata tecnicità. A febbraio uno dei più noti esperti in materia
ci ha perfino tranquillizzato sul rischio zero del contagio in Italia. Va da sé
che non si vuole fare il processo a un errore di calcolo pure lecito e
ammissibile in un clima d’incertezza e novità, ma a un atteggiamento
scientifico granitico e presuntuoso, nonostante appunto l’incertezza e la
novità. Quello dell’erronea previsione del contagio è solo uno dei numerosi
esempi per cui sarebbe immediatamente auspicabile un ridimensionamento
dell’ipse dixit specialistico davanti a un’epidemia che come un riflettore
ha repentinamente fatto luce su una lunga trafila di problemi di vecchia
data: dalle politiche di privatizzazione ai tagli sanitari, dalla generalizzata
carenza di personale medico nel SSN e negli ultimi anni proprio in quei
reparti che il virus ha messo in ginocchio al progressivo impoverimento della
ricerca, dalla debilitazione del turnover occupazionale al persistere di una
crisi economica che, con l’arrivo dell’epidemia, stando a quanto riportato
dall’Istituto per gli studi di politica internazionale ISPI, farà pagare all’Italia
il prezzo più alto nel contesto dell’Eurozona. Oseremo ancora dire che il
problema sia solo il virus o molto più onestamente affermeremo che di fronte
a un parassita si è in realtà esplicitata la cronica debolezza del sistema? Se
per salvarsi dal cancro al polmone si presta ascolto solamente all’invito a
smettere di fumare pronunciato dallo pneumologo, senza ricevere concrete
politiche di tutela dal contatto con i cancerogeni chimici a cui la stessa
persona è esposta per ragioni lavorative, ci sono ben poche speranze di
evitare la disgrazia.
C’è una sfida inderogabile che questa epidemia ha lanciato alla nostra
società ed è la sensibilizzazione del singolo nell’esercitare una coscienza
critica che vada ben al di là della passiva assimilazione della propaganda
mediatica. Tutto il contrario di quello che accade in questi giorni, quando si
lanciano grida di biasimo a chi, sprovvisto di competenze, non ha ragioni di
discutere di certi argomenti. Il non-tecnicismo è una colpa da espiare col
silenzio ossequioso. È uno scenario sociale non avulso e privo di paternità,
ma figlio diretto di quella moda ad uso e abuso di taluni esperti in materia
�54
SILVIA D’AUTILIA
incline al blastare, fino allo zittire, quanti non hanno titolo per avere un’idea
e poterla esprimere. Risale a poco più di tre anni fa la dichiarazione del più
noto virologo del web – e da qualche mese anche dello spettacolo - di
procedere a cancellare dalla sua pagina Facebook tutti i commenti
impertinenti, lasciando diritto di parola solo a chi ha studiato e non certo al
cittadino comune. Terminava col motto divenuto egida del suo personaggio
mediatico: “la scienza non è democratica.” La cosa dovrebbe destare forte
allarmismo rispetto al nuovo ritratto di scienza che ne sta emergendo: un
monolite che risponde di sé e delle due pratiche a nessuno meno che a sé
medesimo. Uno scivolone metodologico che lede non poco quell’immagine
di sapere basata sull’itinerante dialettica del dubbio, e che fa dello scambio
col sociale la condizione stessa del suo procedere. La scienza, infatti,
può/deve non essere democratica in laboratorio, ma lo deve necessariamente
essere in termini di analisi dei dati, raggiungimento delle conclusioni e
discussioni che ne derivano. Non potremmo nemmeno pensare all’aggettivo
“scientifico” senza l’imprescindibile operazione comunicativa, ovvero
quel momento in cui le conoscenze, venendo trasferite al pubblico, si
traducono in occasione di progresso e sviluppo sociale. Una divulgazione
scientifica efficace ha come prerequisito la capillarizzazione delle sue
informazioni fino all’ultimo attore del tessuto sociale.
È questo, tra gli altri, uno dei principali messaggi dell’UNESCO World
Report del 2005 Toward knowledge societies, attento a ridefinire le società
della conoscenza attraverso l’invito a una partecipazione attiva nei processi
divulgativi della scienza. Secondo i capisaldi della società della conoscenza
ciascun cittadino, nessuno escluso, con la sua formazione, il suo percorso e
la sua particolare interazione col sapere, può aggiungere altra conoscenza
alla conoscenza con cui s’interfaccia.
Sempre all’inizio degli anni 2000, anche da Oltremanica si fa pressante
l’esigenza di un legame più stretto tra scienza e società: il precedente
paradigma di Public Understanding of Science (PUS), che aveva segnato
alla fine degli anni ’80 un’iniziale apertura del mondo scientifico verso il
pubblico, viene ripensato alla luce di un rapporto meno frontale e più
inclusivo, di reale collaborazione tra esperti e non esperti, secondo un
modello che fu denominato Public Engagement with Science and
Technology (PEST). L’intento era quello di coinvolgere concretamente la
società nei traguardi scientifico-tecnologici e nella loro comunicazione,
al fine di colmare quella distanza tra specialisti e non specialisti che iniziava
a produrre una generale sfiducia dei secondi verso i primi. La lontananza tra
questi due mondi non era solo fisica e materiale ma rappresentativa del
�55
Il virus e la paralisi della mente
diverso atteggiamento con cui venivano approcciate tematiche d’interesse
pubblico e sociale.
Per rendere l’idea evochiamo brevemente lo studio di Brian Wynne sulla
crisi delle “pecore radioattive”. In concomitanza all’incidente nucleare di
Černobyl, nel 1986, alcuni allevatori inglesi, avendo osservato delle
anomalie nei terreni sui quali pascolavano le loro greggi, sostennero la
possibilità che gli animali potessero aver assorbito dal terreno la
radioattività. Il governo rispose inviando sul campo degli esperti che, una
volta effettuate tutte le analisi del caso, minimizzarono enormemente il
problema. Alla lunga le ricognizioni degli allevatori però si rivelarono
sensate: per ben due anni fu vietata la macellazione ovina proveniente da
quei territori e alle valutazioni degli esperti fu associata la volontà del
governo d’insabbiare velocemente la vicenda.
Episodi come questo hanno portato a un ripensamento delle politiche di
comunicazione della scienza, attraverso una valorizzazione della
cosiddetta lay knowledge, il sapere laico per intenderci, non più valutato
come debole o inferiore, ma semplicemente caratterizzato da expertise
qualitativamente diverse rispetto a quelle degli scienziati.
Ebbene, la vistosa esasperazione della competenza medica per il Covid19
rischia d’incappare in nuove logiche di distanziamento tra esperti e non
esperti se non s’interviene per tempo a modificare orientamenti scientifici
unidirezionali e autarchici. Già numerosi segnali s’intravedono nella volontà
del pubblico di sentire altre campane di tecnici, di ricercare un tipo
d’informazione diversa da quella suggeritaci come “ufficiale” e, guarda caso,
prontamente bollata come “disinformativa”. Nel calderone della
disinformazione oggi finiscono tutti coloro che stentano a uniformarsi con
le linee guida convenzionali o che solo accennano a volerne sapere di più.
Basti pensare a uno spot del mainstream, di un autoreferenzialismo
disarmante, che invita a fidarsi cit. “dei reali professionisti
dell’informazione”. Ora, stante la melensa biforcazione tra informazione
giusta e informazione sbagliata, la reale domanda è: ma chi stabilisce questi
valori? Il quesito ha un sapore per così dire postmoderno, nella misura in cui,
in un clima di generalizzata carenza di certezze, risulta abbastanza
improvvido rivendicare il possesso di un verum che altri invece non
avrebbero. Sicchè la questione arriva ai seguenti esiti: o i sedicenti depositari
dell’informazione inconfutabile sono realmente convinti di detenere questo
primato, il chè evoca una certa presunzione, per non dire onnipotenza,
oppure temono così tanto la contraddizione da tacciarla in partenza come
non-informazione. Forzare la credibilità, arrogandosi una superiorità non
�56
SILVIA D’AUTILIA
richiesta, è una strategia neppure troppo velata per avere il terreno libero da
impacci e avversari. Le masse, queste flotte di soggetti turbati e angosciati,
sono divenute gli strumenti privilegiati con cui condurre la battaglia
dell’impoverimento delle menti, dell’invito a pensare che non ci sia più
nient’altro a cui pensare. Il contraddittorio va combattuto con la negazione
dello stesso e non solo in termini linguistici ma anche ontologici: tutto quanto
non si conforma ad A non solo non è A, ma non è neppure B, C, D, E...
semplicemente non esiste! Il vuoto di critica e di analisi è la vittoria! Peccato
che ogni ricerca del consenso condotta nel segno della rigidità abbia sempre
rivelato un certo indice di timore. Giordano Bruno non aveva dubbi già nel
1600, quando, dopo la lettura della sentenza di condanna a morte per eresia,
affermò: maiore forsan cum timore sententiam in me fertis quam ego
accipiam, “forse tremate più voi nel pronunciare questa sentenza che io
nell'ascoltarla.” In ogni ambito, e a maggior ragione nella scienza, la libertà
di parola è un problema solo per chi la teme. Non la teme chi la considera
una più che valida occasione di confronto, da cui ricavare, a prescindere dal
risultato, un progresso scientifico. È il cosiddetto principio di falsificabilità
teorizzato dal filosofo Karl Popper, per cui una teoria è veramente
scientifica se si presta alla confutabilità, ovvero se è sottoponibile all’errore:
qualsiasi sia l’esito di questa falsificazione non potrà che dare utili contributi
all’avanzamento della questione.
Ma quanto l’epidemia ha reso abbastanza tangibile è ravvisabile nelle
riflessioni sul concetto di sapere che alla fine degli anni ’70 Jean-François
Lyotard elaborò nel testo La condizione postmoderna. Secondo il filosofo
francese, nel tramonto delle verità salvifiche nell’alveo dell’etica, della
politica e della religione, il destino del sapere è e sarà la sua vendibilità,
in un continuo sali e scendi di prezzi e stime. Come non sentire echeggiare
rumorosamente in queste parole gli interessi derivanti dallo stabilire
rigidamente cos’è informazione e cosa no?
Se, nell’imposizione del restare a casa, nel controllo a vista dei corpi e
nella militarizzazione dei territori, si evince una vera e propria esasperazione
del dominio biopolitico, va segnalato che una nuova declinazione del potere
sta affermandosi con forza: il condizionamento delle menti. Non basta più
che i corpi siano addomesticati, oggi più che mai occorre che lo siano anche
le menti, e non tanto disciplinandosi a pensare secondo modelli o stereotipi,
ma prendendo ad accettare che oltre alla comunicazione di una data
informazione non c’è proprio nient’altro a cui pensare. C’è chi a questo
proposito ha parlato non erroneamente di “psicopolitica”, asserendo che le
guerre delle nostre civiltà non hanno più connotati materiali e concreti, ma
�57
Il virus e la paralisi della mente
sono basate sul controllo del mentale e sulla prevenzione sorvegliata e
istituzionalizzata della loro attività.
Foucault metteva in guardia da questo rischio già nel 1971, quando nel
testo Nietzsche, la genealogia, la storia, stabilisce la distinzione tra la storia
degli storici e la storia effettiva. Se la prima è un sapere ordinato secondo un
continuum di senso e significato, la seconda è direttamente calata
nell’autenticità dei fatti. Non badare a questa differenziazione corrisponde dice Foucault- a non prendere atto che “il sapere non è tanto fatto per
comprendere, ma per prendere posizione”. Corrisponde a ritenere che non
ci sia alcun’altra conoscenza da rivendicare. E soprattutto corrisponde a
lasciare che, un domani, i nostri figli non abbiano più diritto ad alcuna libera
curiosità da esercitare.
Foto di Tumisu da Pixabay
�58
�59
Endoxa – Prospettive sul presente, 5, 25, Maggio 2020, pp. 59-64
LA SCIENZA DEGLI IDIOTI
FRANCO FERRANT
C’è un aggettivo che in italiano viene spesso usato in modo singolare, vale a
dire l’aggettivo “singolare”.
Il quale non va, dunque, ad indicare puramente la proprietà dell’uno, ma trova
implicita in questa unicità una certa stranezza. Infatti, in ogni vocabolario, i
sinonimi che vengono accostati a “singolare” sono “insolito. raro, bizzarro”
Sembra scontato, nel senso comune, che la condizione dell’unicità porti in sé
un’inevitabile stravaganza. Tanto che l’aggettivo “singolare”, nel senso di
“strano”, viene paradossalmente usato, talvolta addirittura al plurale, anche ad
indicare proprietà collettive di gruppi di individui
Ciò è ovviamente di grande aiuto all’autostima individuale, in una civiltà ormai
rassegnata a pensarsi come civiltà di massa; serve da protezione contro
l’insignificanza dell’esistenza singola e il rischio dell’omologazione coatta.
Però la rivendicazione della particolarità può avere anche risvolti fastidiosi,
particolarmente quando ad essa si associ una certa sofferenza; quando, cioè, alla
nostra unicità, che in fondo è anche la nostra stranezza, risulti intollerabile la
normalità statistica degli altri.
�60
FRANCO FERRANT
È il caso delle idiosincrasie, che, anche al di fuori di un ambito strettamente
medico, e della casistica, a volte tragica, delle reazioni allergiche e anafilattiche,
esprimono la nostra propria individuale insofferenza verso cose che,
apparentemente, per gli altri non sono dannose.
Vi è una dose di artisticità nelle idiosincrasie, una specie di poesia dell’esistenza
concreta, una rivendicazione dell’attualità del presente, liberata dalla dittatura della
specie e dalla biologia astratta delle tassonomie.
L’idiosincrasia, come repulsione e rigetto, è pura resistenza contro il dato, cotto
e mangiato. Sarà anche per questo che in linguistica l’idiosincrasia non descrive
l’intolleranza, a volte più noiosa della pedissequità, quanto piuttosto la creatività.
In linguistica essa è legata al singolo atto di “parole”, trasgressivo rispetto alla
norma linguistica immanente, ma proprio per questo creativo e innovativo.
Del resto la radice greca “idio-” è di uso comune in linguistica. Significa
letteralmente “che sta a parte, da sé” “che riguarda singoli individui” La
troviamo in termini come “idioma” e “idioletto”. L’idioma è l’espressione
linguistica particolare di un territorio o di un gruppo etnico. Può essere una lingua
nazionale, ma anche un dialetto o qualunque parlata caratteristica di una comunità
storico-sociale.
Il termine “idioletto” , usato in senso tecnico, restringe il campo: sarebbe,
infatti, la peculiarità d’uso di ogni singolo parlante del sistema linguistico di una
comunità. In altre parole, la marca individuale di utilizzo di un idioma.
Ma io sono interessato alla radice “idio-”, anche e soprattutto in un più largo
contesto. Fino a un certo punto, nonostante certe reazioni di avversione istintiva,
che si potrebbero anche considerare normali, da parte della maggioranza
silenziosa, nei confronti degli idiosincratici metaforici, vissuti come snob
schifiltosi e rompiballe, penso che l’idiosincratico sia visto da molti con simpatia.
Anzi, resto intimamente convinto che l’idiosincrasia emotiva sventoli il vessillo
della libertà.
Ma ancor più interessante è, oggi, lo specifico ruolo che la radice “idio-”
gioca nel termine “idiota”.
Con questo termine “idiòtes” nel mondo greco si indicava il privato cittadino
che non ricopriva cariche pubbliche. Il fatto che, nel corso del tempo, sia diventato
quasi sinonimo di “deficiente” indica, innanzitutto, in quale alta considerazione i
greci tenessero la politica, l’impegno di gestione della polis. E poi sembra anche
suggerire implicitamente che la prospettiva del singolo privato cittadino, per
quanto illustre, rischia, proprio per l’ ovvia ristrettezza dell’angolo visuale, la
grossolanità.
Naturalmente anche in questo caso non è necessario che l’“idiòtes” sia il
singolo, ma il concetto può essere esteso ad indicare, più in generale, prospettive,
angoli visuali particolari, o modelli interpretativi condivisi da interi gruppi o
categorie di individui.
Proprio di questo vorrei trattare brevemente.
�61
La scienza degli idioti
Mi rendo altresì conto che usare questo termine in italiano, invece che nella sua
originaria veste greca, potrebbe risultare insultante.
Ma anche su questo molti paladini del politically correct e del linguaggio
non-ostile hanno sparso più nebbia che enlightenment.
Ricordo, ad esempio, che all’University College Dublin, dove ferve una vivace
e autonoma attività studentesca, con circoli di indirizzo che organizzano dibattiti
tematici ed invitano personalità di rilievo a confrontarsi su temi caldi, non
mancavano mai proposte provocatorie.
Una di queste, che mi incuriosì molto, ipotizzava la legittimità dell’insulto,
in nome della difesa della libertà di parola. Non ho approfondito la cosa, ma lo
stesso fatto di porsi il problema mi sembrava già rilevante.
Al di là della calunnia o del bullismo o dell’aggressione verbale programmata,
tutte cose legalmente perseguibili, ancora oggi non sono sicuro che l’insulto debba
essere considerato un tabù. Io, ad esempio, non mi sento particolarmente lacerato
nel mio amor proprio da un insulto.
Ad ogni buon conto, specifico che in questo contesto l’aggettivo “idiota” è usato
in senso etimologico.
Vi è un genere di idiozia particolarmente diffusa nel mondo contemporaneo
e particolarmente pericolosa, legata alla mistificazione e all’uso equivoco del
concetto di scienza.
Lasciando da parte le scienze formali, come logica matematica e geometria, che,
per la loro natura assiomatica, conferiscono verità universali e necessarie, l’unica
scienza naturale rigorosa oggi è la fisica (comprendendo ormai anche la chimica).
Non fornisce verità universali e necessarie, ma non è disposta ad accettare
conclusioni falsificabili o a compromettersi con le eccezioni.
Poi ci sono tutti gli altri ambiti di ricerca e conoscenza, naturali e umane, ognuna
con i propri modelli di indagine, i propri indirizzi, le proprie metodologie di
verifica.
Tutti questi indirizzi sono validi ed ognuno di loro ha una sua utilità e un suo
ambito di applicazione
E possono, a buon diritto, chiamarsi scienze, ma quello che non debbono fare
è giocare sull’equivoco. Alcune di loro si servono dell’apporto ausiliario delle
scienze formali e della fisica, ma la loro attendibilità o è statistica o è condizionale
e, soprattutto, non fornisce parametri sicuri di falsificabilità.
Nel momento in cui surrettiziamente tendono a usurpare lo statuto delle scienze
formali o fisiche stanno implicitamente barando.
La questione si complica quando questa pretesa si combina con la sindrome
dell’idiota
È inevitabile che a un giocatore di poker professionista la vita sembri, un po’
tutta, una mano di poker o che a un commerciante al dettaglio situazioni di vita
reale ricordino dinamiche di negozio o strategie di vendita o che a un dietologo
risultino lampanti i benefici di una buona digestione e assimilazione dei nutrienti,
�62
FRANCO FERRANT
ma nessuno di loro avanzerà la pretesa di spiegare tutta la vita nelle sue complesse
manifestazioni come una partita di poker o una transazione soddisfacente o una
buona digestione e, soprattutto, nessuno di questi “privati cittadini” rivendicherà il
diritto di guidare la politica.
Invece oggi ci sono molti idioti in molti centri di ricerca ed elaborazione in
tutto il mondo che avanzano spudoratamente tali pretese e rivendicazioni.
L’obiettivo è assolutizzare il contenuto di verità delle loro asserzioni e
dimostrare l’inconsistenza e inutilità di altri approcci. In particolare è inquietante
quando l’obiettivo delle loro incursioni diventa non solo l’arte, o la religione, o la
filosofia, ma anche e soprattutto la politica.
Ci sono essenzialmente tre ambiti nei quali gli idioti imperversano: economia,
medicina e genetica, condizionando gran parte della logistica e dei finanziamenti
delle università a sostegno delle loro pretese.
In economia la tendenza è spacciare per leggi naturali quelle che sono prassi
condizionali, finalizzate all’acquisizione di un vantaggio. Oltre a tutto, sottoposte
a variabili marcatamente aleatorie. Le leggi economiche sono “leggi” più in senso
giuridico che in senso fisico. Ma il capitalismo trionfante, particolarmente nella
sua declinazione finanziaria globale, ne ha fatto un sistema dogmatico, con
profusione di spregiudicato abuso di strumenti matematici fuori contesto E, a
ruota, nelle scuole di questa nuova religione, pretesa scienza esatta, fioriscono i
catechismi più bizzarri, tipo “economia comportamentale”, “neurofinanza” ed altre
facezie del genere
Probabilmente non c’è concetto più mistificato del PIL, generalmente trattato
invece come una grandezza fisica. Naturalmente in questo ambito gli idioti sono
altamente perniciosi per l’interesse comune ma ossimoricamente intelligenti per il
proprio, anche e soprattutto quando, scomodando la teoria dei giochi, si sforzano
di spiegare che è nella natura delle strategie competitive trovare un punto di
equilibrio, con buona pace di tutti.
In medicina vi sono due irresistibili tendenze idiotiche. La prima ha per
protagonisti medici che, fin dall’inizio, o a un certo punto del loro iter
professionale, rendendosi conto di non aver mai veramente avuto intenzione di
esercitare la professione, hanno cercato qualche via di fuga, che non li rendesse dei
reietti, ma che, almeno in parte, si armonizzasse con la loro situazione di fatto. La
più battuta di queste vie è rivelare al mondo i misteri medici sottostanti a tutte le
altre attività umane, in primis quelle artistiche o filosofiche.
E naturalmente, per lustrarsi con il lustro altrui, le indagini devono riguardare i
maestri riconosciuti della storia spirituale dell’umanità. Fioriscono in tal modo le
diagnosi a posteriori, le autopsie in assenza di cadavere, le anamnesi delineate su
indizi.
Dunque Dante ha scritto la commedia in trance ipnotica perché sofferente di
narcolessia.
�63
La scienza degli idioti
Michelangelo era tormentato dall’osteoartrosi degenerativa
La filosofia di Leopardi deve molto alla spondilite.
L’afflato romantico di Schubert e Schumann era in qualche modo in relazione
con la sifilide, così come le note tenebrose dei Capricci di Goya e dei suoi Disastri
della guerra, il nichilismo di Nietzsche e il suicidio metafisico di Michelstaedter
La pennellata di Van Gogh testimonia l’epilessia del lobo temporale (patologia
di elezione anche per scrittori come Poe, Lewis Carrol e Dostoevskj) e la sua
notte stellata non è che la trasposizione pittorica degli effetti ottici causatigli dalla
digitale che prendeva per curarla
E così via.
La seconda tendenza porta avanti un progetto che è diventato egemone nel
paradigma terapeutico del terzo millennio: vale a dire la “medicalizzazione
permanente”. In questa prospettiva, dalla nascita alla morte l’individuo vivente
deve restare costantemente sotto controllo, in una sorta di bolla diagnostica. Tutte
le manifestazioni perturbate o sgradevoli dell’organismo vivente sono monitorate
in tempo reale e tempestivamente curate, quando non preferibilmente anticipate.
Questa seconda tendenza, connessa ad enormi interessi economici, regna
pressoché incontrastata negli istituti di ricerca di tutto il mondo, attraendo le
energie fresche degli aspiranti idioti, fortemente incoraggiati ad avviarsi in questa
direzione. Naturalmente non sono solo le malattie classiche ad essere bersaglio
della sollecitudine, ma ogni genere di disagio, sia fisico che psichico. Che poi
quello psichico è fondamentalmente fisico e quindi curabilissimo con ormoni e
chirurgia, se dovuto a motivi estetici, o disforia di genere, o con la farmacopea in
tutti i casi di sofferenza mentale o emotiva. Non solo ansia o depressione, ma anche
elaborazioni del lutto, nostalgia, spleen, noia o dipendenza.
Un giovane genio inglese ha, ad esempio, recentemente trovato il rimedio
chimico infallibile contro il mal d’amore.
Un paio di pillole e l’immagine dell’amato/a non ti tormenta più. Non ha avuto
un grande successo commerciale perché, come effetto collaterale, distrugge la
libido nei confronti di chicchessia.
I resoconti dei lavori sperimentali riempiono le miriadi di riviste “scientifiche”
specializzate, la cui principale funzione è quella di dispensare credibilità a
carriere in fase di decollo. In genere si tratta di esperimenti condotti, nell’arco di
pochi mesi o qualche anno, su una popolazione di poche centinaia di soggetti. I
risultati vengono, poi, elaborati statisticamente in risibile spregio alla legge dei
grandi numeri . In tal modo, anche riconoscendo l’onestà dello sperimentatore che,
come rivelato più volte da frequenti scandali, è tutt’altro che garantita, si può
“dimostrare” qualunque cosa e il suo contrario. E quanto più eclatante è la tesi
emersa, tanto più spazio trova nei rotocalchi di costume e sul web, diventando
verità conclamata.
L’ultimo campo nel quale gli idioti prosperano, certamente il più insidioso per
possibili sviluppi futuri, è quello della genetica. Ormai quasi tutto trova
�64
FRANCO FERRANT
spiegazione nei geni. Non solo le malattie di cui si conosce già da tempo l’origine
genetica, non solo la predisposizione a contrarre nel corso della vita certe
patologie, ma anche alterazioni le cui cause restano a tutt’oggi sconosciute.
Per cui la schizofrenia, l’autismo, la depressione, l’ansia, hanno, in quest’ottica,
una spiegazione genetica.
Ma il genetista idiota non si trattiene e non si ferma qui. Anche i tratti morali
sono scritti nei geni. Ho sentito uno dire che il razzismo avrebbe un’origine
genetica con il candore di chi non riesce neppure a rendersi conto di quanto razzista
sia questa affermazione. Ho letto un genetista di buona reputazione collocare nel
corredo genetico il segreto della felicità. Il che è a suo modo rassicurante, perché
se tu quel gene lì ce l’hai, qualsiasi disgrazia ti possa capitare non perderai mai il
tuo buon umore. E lo stesso, per dimostrare l’innegabile tendenza al suicidio dei
temperamenti artistici, insita nei loro geni, rispetto alla più equilibrata dotazione
genica degli scienziati, non mancava di citare Virginia Woolf o Sylvia Plath o
Pavese o Van Gogh. A cui di rimando si potrebbero citare Boltzmann o Turing,
o le ricorrenti pulsioni suicide di Wittgenstein, se prestarsi a un confronto del
genere non fosse mettersi sullo stesso umiliante piano di idiozia.
Ecco, o la scienza, esatta o meno che sia, riconquista la propria integrità e la
chiarezza dei propri obiettivi, senza tracimare in territori che non le competono,
prendendo atto che vita, storia e civiltà sono qualcosa di molto più complesso delle
semplificazioni dello spazio protetto di un laboratorio o rischia di deragliare
rovinosamente, non essendo in grado di esaurire compiti che competono ad altre
logiche e ad altre più ampie prospettive.
�65
Endoxa – Prospettive sul presente, 5, 25, Maggio 2020, pp. 65-71
“IN IRA E MALEVOLENZA”: DI
QUALCHE IDIOSINCRASIA COMICA
GENNARO CARILLO
Il comico, talvolta, picchia duro. Per farlo, deve alimentarsi di idiosincrasie
profonde, di cui Aristofane teorizza la legittimità morale, oltre che la produttività
politica: «Insultare (loidoresai) gli abietti (ponerous) non è una colpa ma, a
ragionarci bene (eu logizetai), un rendere onore (time) ai buoni (toisi chrestoisi)»
(Aristofane, Cavalieri, 1274-1275). Tutto molto schematico. Il comico presuppone
la polarità buoni-cattivi e, su questa base, colpisce con la loidoria, spingendosi
fino ad auspicare o addirittura a ‘suggerire’ la morte di qualcuno come misura
benefica per la polis. È il caso di Cleone nei Cavalieri: «Sarà dolcissima (hediston)
la luce del giorno per i cittadini e i visitatori, se Cleone morirà (en Kleon apoletai)»
(973-976). Tutto questo alla presenza, in teatro, del demagogo odiato e
pericolosissimo, al quale la polis democratica riconosce il privilegio della
proedria, un posto riservato in prima fila. Ed è il caso di Cleofonte nelle Rane: «la
rondine di Tracia […] intona un canto (nomon) funebre, perché lui [Cleofonte]
muore (apoleitai), anche se il processo finisce in parità (isai)» (681-685).
�66
GENNARO CARILLO
Quantunque trasfigurata in chiave comica, la morte violenta aleggia sulla scena
aristofanesca, prefigurando un destino tragico per la comunità politica.
Su Aristofane tornerò alla fine. Ora vorrei fornire qualche altro esempio
dell’idiosincrasia come materia prima del comico.
Eros e Priapo di Gadda non è solo un’invettiva feroce contro Mussolini. È
anche un tentativo – ilare e tragico – di ricercare la causa del consenso tributato al
fascismo in una malattia peculiare dell’ethos nazionale: il menadismo,
l’invasamento, l’enthousiasmos, la «ninfomania politica» di una nazione femmina
(e per troppi secoli «malchiavata») nei confronti dell’espressione massima di un
virilismo retorico e istrionico, il Duce, appunto. Nessuna motivazione logicorazionale, in questo consenso della moltitudine, ma solo un eros tirannico, un
rovesciamento della gerarchia platonica dell’apparato psichico sano, con gli
«impulsi animali a non dire animaleschi […] topicizzati nello epithymetikon, cioè
nel pacco dello addome, […] il gran vaso di tutte le trippe» (E. Gadda, Eros e
Priapo (Da furore a cenere) [1967], in Saggi Giornali Favole e altri scritti, II,
Milano, Garzanti 1992, p. 231), che s’insediano nell’acropoli dell’anima e da qui
comandano indisturbati.
Due idiosincrasie operano dunque in Gadda: quella verso Mussolini e il
fascismo, a un primo livello; la misoginia, a un livello meno superficiale. Ecco un
ritratto idiosincrasico del Duce:
“Questo qui, Madonna bona!, non avea manco finito di imparucchiare quattro
sue scolaresche certezze, che sono qua mè son qua mè, a fò tutt mè a fò tutt mè.
Venuto dalla più sciapita semplicità, parolaio da raduno communitosi del più
misero bagaglio di frasi fatte, tolse ecco a discendere secondo fiume dietro al
numero: a sbraitare, a minacciare i fochi ne’ pagliai, a concitare ed esagitare le
genti; e pervenne infine, dopo le sovvenzioni del capitale e dopo una carriera da
spergiuro, a depositare in càtedra il suo deretano di Pirgopolinice smargiasso,
addoppiato da pallore giacomo-giacomo, cioè sulla cadrèga di Presidente del
Consiglio in bombetta e guanti giallo canarino.
Pervenne, pervenne.
Pervenne a far correre trafelati bidelli a un suo premere di bottone su tastiera,
sogno massimo dell’ex agitatore massimalista. Pervenne alle ghette color tortora,
che portava con la disinvoltura d’un orango, ai pantaloni a righe, al tight, al tubino
già detto, ai guanti bianchi del commendatore e dell’agente di cambio uricemico,
dell’odiato ma lividamente invidiato borghese. […] Sui morti, sui mummificati e
risecchi dalle orbite nere contro il cielo, […] sui morti e dentro il fetore della morte
lui ci aveva già lesto il caval bianco, il pennacchio, la spada dell’Islam, fattagli da’
Maomettani di Via Durini a Milano. Per la pompa e la priapata alessandrina. E la
differenza la sapete bene qual è, la differenza che passa tra Lissandro Magno e
codesto brav’uomo: che l’Alessandro Magno l’è arrivato (sic) ad Alessandria col
�67
“In ira e malevolenza”: di qualche idiosincrasia comica
cocchio: e lui c’è arrivato col cacchio. Riscappò via co’ sua cochi e marmellate
dell’ulcera. Scipione Affricano del due di coppe (ivi, pp. 227s.).”
È un’immagine miracolosa, fecondante, quella del Duce, per le moltitudini di
Bassaridi che pendono dalle sue labbra perennemente estrovertite e in lui ravvisano
«il solo genitale eretto disponibile sulla piazza»:
“E talvolta, bastava il sogno, la imago. Le più pazze, le più prese dalla imago,
non bisognavano marito, né ganzo, né drudo. Checché. Gli bastava la Idea, la Idea
sola della Patria, e del kuce. Gli bastava imaginare il kuce nell’atto di salvar la
Patria per sentirsi salvate e pregne anche loro in compagnia della Patria. Una di
codeste pazze riuscì a fare un figlio: col ritratto del kuce. Ed ebbe il pupo, al
nascere, le quadrate mascelle del Mascellone, tanto che lo ricoverarono al
Cottolengo. Dove il mostriciattolo pisciò, cioccolattò, crebbe e proferì apoftegmi
in tutto simili a quelli del Padre.”
Qui l’idiosincrasia si sposa a un «atto di conoscenza», sia pure «tardivo»: non
ci sono solo Aristofane, Platone o Machiavelli, tra le fonti di Gadda; c’è anche
la psicologia delle folle. Certo, l’iperbole deforma e la misoginia deborda; eppure,
se la tentazione del mutato nomine de te fabula narratur è così forte, vuol dire che
Gadda coglie, per via idiosincrasica, un universale, l’essenza erotica dei
meccanismi sui quali si fonda un consenso altrimenti inspiegabile. Il paradosso di
Eros e Priapo è che fa dimenticare il Mussolini storico o comunque lo disincarna,
facendolo regredire a carattere, ad allegoria. Proprio nel senso dell’aliquid stat
pro aliquo: Mussolini sta per qualcos’altro e qualcun altro. E questo qualcun
altro è chiunque, dopo di lui, ne indossi più o meno consapevolmente la maschera,
personificandolo. Non a caso, chi abbia messo in scena Eros e Priapo (Fabrizio
Gifuni, Massimo Verdastro, Sandro Lombardi) si è visto costretto a esplicitare
di non aver manipolato il testo gaddiano, di non avervi aggiunto nulla di
‘contemporaneo’: il pubblico credeva di riconoscere in Mussolini il principe,
appena dissimulato, del momento e accusava il teatrante di faziosità.
Cambiamo scena, restando tuttavia in Italia. Ha già fatto epoca, tra le
idiosincrasie recenti, quella di Franco Cordero verso Silvio Berlusconi,
ribattezzato il «Caimano», il «nomofobo», il «re delle lanterne magiche», rubricato
come «caso clinico», esecrato come causa prima o almeno sintomo più evidente
del «morbo italico». Ma, per Cordero, Berlusconi è soprattutto la figura eminente
di una «convulsa pittura espressionista». Convulsa perché popolosissima. Cordero
cita Werner Tübke, ma forse nobilita troppo il quadro politico. Che piuttosto fa
pensare a Benito Jacovitti. Se Berlusconi, sulla scena, campeggia, chi gli orbita
intorno appare altrettanto a proprio agio. Fausto Bertinotti, per esempio. Eccolo
brillare nel teatrino delle stelle fisse: «[…] i rifondatori comunisti hanno un pilota
primesautier, innamorato della scena, facile parlatore in erre moscia nei salotti
televisivi». Una pietra tombale, più che il ritratto di un narcisista: quei «birignao
nel salotto televisivo» gli e ci costeranno cari.
�68
GENNARO CARILLO
Ma è nel ritratto di D’Alema che Cordero si supera. L’idiosincrasia partorisce
grande letteratura:
“Le style c’est l’homme: eccolo, Mercurio onnipresente […]. L’insonne
conversa, predica, disserta, detta, recita, scrive, sfila, allude, sogghigna,
ammonisce, gioca d’occhi e sopracciglia, sta al timone: s’espone ai fornelli col
grembiule, intento al risotto; modula sintagmi eleganti; tiene banco su temi
planetari commiserando i poveri diavoli il cui orizzonte sta nel cortile; voce e gesto
taglienti, dispensa mille interviste dove la minima battuta è testo marmoreo da
scolpire; frequenta anche i santi o almeno, san José Maria Escrivá, fondatore
dell’Opus Dei, incline a due dittatori poco raccomandabili quali Franco e Pinochet.
Oltre che «uomo di mare», lo sappiamo «appassionato d’archivi»: vive «nelle
antiche carte»; ha letto tutto l’erede d’Eugène Sue; in letteratura contemporanea
«sono uno dei conoscitori più importanti d’Italia» […]. Insomma, non soffre
d’autodisistima, né passa giorno senza un’epifania, premurosamente ripercossa dai
media: il coro dei finti indipendenti l’acclama riformista par excellence; il sire
d’Arcore se lo augura papa d’oppositori dialoganti. Che ispiri poca simpatia,
l’ammettono anche i caudatari, ma qui non interessano appeal, look, portamento.
La questione è se l’uomo, visto quale somma d’atti compiuti o pronosticabili,
venga utile ai vertici della partita. Nella mia sommessa opinione, no. Lo vedo
piuttosto cinico, egocrate autocontemplatore, cannibale, perfido, garrulo-fatuo; e
se qualcuno crede d’avere letto un rosario d’ingiurie querelabili, sbaglia; è lessico
tecnico, nomenclatura d’antropologia politica. Cominciamo dall’ultimo predicato:
solo un gaffeur poteva allestire la commedia bicamerale, convinto d’avere
catturato B.; andava a scuola dall’ex piduista veteroberlusconiano M. Costanzo.
Sopraffino però nelle guerre intestine e quanto sia cannibale, lo dicono i teschi. In
amor sui vale B. Se vede un palco, vi monta: la politica militante non è filantropia
ascetica ma lui straripa dal consueto habitus […]. Nessuno l’ha visto al naturale,
se ne ha uno. S’è sciolto in vorticosi manierismi vocali, mimici, gestuali. […] Non
accorda mai risposte congrue, però batte le frasi sull’incudine: plana au-dessus de
la mêlée; agli avversari concede mezzi sorrisi-smorfia, almeno fossero della sua
taglia.
B. è attore da music-hall, con varie cadute nell’avanspettacolo sbracato. Lui
filodrammatico contegnoso, tra Niccodemi e Beautiful […].”
Teniamo presente quell’«egocrate autocontemplatore» di Cordero. Diventa la
chiave per comprendere un altro affondo anti-dalemiano. È un D’Alema decaduto,
però, quello su cui infierisce Claudio Giunta. Un D’Alema costretto a ripetersi. A
interpretare il ruolo che lo ha reso famoso. Più che dalle parti di King Lear, siamo
da quelle di Gigi Baggini (Ugo Tognazzi), in Io la conoscevo bene di Pietrangeli:
“[…] presentando il movimento ConSenso davanti alla fronda PD, D’Alema
non ha resistito. Ha fatto il classico, mica l’alberghiero, e poi quattro anni di Scuola
Normale, è un capitale simbolico che bisogna spendere. Così ha detto: «…come
�69
“In ira e malevolenza”: di qualche idiosincrasia comica
avrebbe scritto un grande poeta, Quandoquidem dòrmitat Homerus. Mi sfogo qui,
perché nel Partito Democratico non si può più parlare in latino». Ilarità, applausi.”
Il problema non è che sono tre parole e due errori, dato che il verso di Orazio (il
«grande poeta») dice quandoque, ‘e quando, anche quando’, non quandoquidem,
e in dormitat la i è lunga, quindi si pronuncia dormìtat, con l’accento sulla i, non
sulla o. Il problema è proprio il latino, l’impiego minatorio del latino, l’idea della
cultura non come silenzioso possesso ma come distinzione, da far valere nel
confronto con chi quella distinzione non ce l’ha, perché non ha fatto le scuole
giuste o ha colpevolmente liquidato l’umanesimo perché occupato a inseguire idoli
più effimeri (il mercato, internet, il pop). Il fatto che D’Alema ignori il latino
aggiunge solo un tratto patetico a questo snobismo: come lamentarsi, ruttando, del
dilagare della maleducazione (C. Giunta, E se non fosse la buona battaglia?,
Bologna, il Mulino 2017, p. 280).
Non serve scomodare la Verneinung freudiana per capire che, invece, il
problema sono proprio gli errori di latino (ed è inutile aggiungere che «Non serve
scomodare la Verneinung freudiana» è, a sua volta, un esempio classico di
Verneinung). Altrimenti non si spiegherebbe perché Giunta li corregga con
implacabilità professorale e la deplorazione sacrosanta dell’uso intimidatorio del
latino passi in secondo piano, data l’albagia che l’errante conserva anche nella sua
fase di declino. Questo D’Alema prigioniero del personaggio gli offre
un’occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. E il censore lo morde,
inscenando un contrappasso che sta tutto in quella sentenza senz’appello:
«D’Alema ignor(a) il latino». Una ferita mortale, per un egocrate, la cui
supponenza intellettuale arma letteralmente il critico, innescando il pedagogo
spietato che è in lui. Il pedagogo, non il pedagogista, per carità: ché verso il
pedagogismo – e in particolare verso Franco Frabboni: un’autorità –
l’idiosincrasia di Giunta tocca vertici sublimi e liberatorii (per chi è costretto a fare
i conti con la neolingua della vittima). Al confronto, quella a D’Alema è una
carezza. Il paragone col rutto, infine, è una trovata degna di quel moralista classico
che fu Paolo Villaggio, ascritto da Giunta a un pantheon del comico di cui fanno
parte anche Rocco Tanica e lo Sgargabonzi.
Torniamo ad Aristofane, per concludere. Ci riportano a lui i caratteristi che
hanno da tempo saturato i luoghi di produzione del discorso pubblico, la
compagnia di giro saltabeccante di studio in studio, i pensosi, i pensanti, le seriose
autorità intellettuali di una nazione poco seria. Ci riportano a lui le maîtresses che
li orchestrano, che se li disputano e li giocano con sapienza combinatoria,
titillandone la corda narcissica. Ci vorrebbe un Aristofane, oppure, non dico un
Proust, ma almeno un Parini o un Alan Bennett, «un perfido talento mimetico»
(A. Arbasino, Ritratti e immagini, Milano, Adelphi 2016, p. 54) che sappia
restituircela, questa guitteria, debitamente deformata ma credibile.
L’irrisione dell’autorità intellettuale è un motivo ricorrente nelle commedie
dell’archaia e in particolare nel corpus di Aristofane. Come ha notato Alan H.
�70
GENNARO CARILLO
Sommerstein, c’è un solo modo per fugare il rischio di diventare
komo(i)doumenos (= oggetto di deprecazione comica) sulla scena: condurre una
vita la più oscura possibile, astenersi dallo spiccare sui molti, dissimulare le
deroghe eventuali al senso comune. C’è dunque un fondo retrivo, se non
reazionario, che incattivisce la commedia, più censoria che censurata. Non è
un caso che il catalogo dei komo(i)doumenoi aristofaneschi stilato da Sommerstein
comprenda, tra gli altri, filosofi/sofisti (il Socrate di Aristofane è un sophistes,
financo con tic gorgiani, l’opposto di quel che sarà il Socrate platonico), i
novissimi della tragedia (Euripide in testa, bollato come troppo effettistico,
fumista, compiaciuto del proprio immoralismo estremo), i demagoghi tanto
violenti quanto persuasivi (Cleone, che intenterà un processo contro il comico), le
drag queen più in vista (Clistene, solo omonimo del grande riformatore
democratico).
Tuttavia, davanti all’autorità, specie quella politica, il poeta comico fa sfoggio
di parrhesia estrema: rivendica una franchezza di parola, un discorso-che-dicetutto, senza autocensure (questo il senso etimologico di parrhesia) e incurante dei
pericoli che ne derivano. Il presupposto di questa libertà (che secondo Bachtin
intrattiene non pochi rapporti con le licenze del carnevale) riposa su un assunto
preciso: «anche la commedia (la trygo(i)idia, il canto del vino nuovo: si noti la
polarità per opposizione con la tragedia) conosce (oide) il giusto (to…dikaion)»
(Acarnesi, 500). Sono parole che Diceopoli, eroe comico degli Acarnesi, indirizza
direttamente al pubblico, con una di quelle rotture dell’illusione drammatica che
costituiscono una peculiarità esclusiva del comico. Nel quale è evidente l’istanza
paideutica: il comico sa e non ha remore a esporre in pubblico argomenti deina
(tremendi) ma al tempo stesso dikaia (giusti): Acarnesi, 501.
L’arma con cui il comico disinnesca il potere, mettendolo di fronte al
proprio nulla o almeno alla propria miseria, resta l’irrisione. Un’irrisione
fondata sul disconoscimento radicale dell’autorità. L’esempio più perspicuo è
offerto ancora una volta dagli Acarnesi, con l’agone comico tra l’eroe ‘pacifista’,
Diceopoli (nomen omen: colui che rende giusta la polis), e l’antagonistes, il
bellicista Lamaco. Agone linguistico, prima ancora che retorico: all’alto
tonitruante e borioso del registro di Lamaco si contrappone il basso corporeo di
Diceopoli, il cui odio verso il conflitto con i Lacedemoni non ha alcuna matrice
ideologica ma si fonda sulla constatazione amara dello scadimento della qualità
della vita materiale in tempo di guerra. Mangiare poco, mangiare male, sognarsi le
anguille (a causa dell’embargo voluto da Pericle contro Megara), bere poco e male
(vino spezzato con troppa acqua), scopare pochissimo: la consapevolezza di queste
perdite gravi, non altre considerazioni, rende sommamente indesiderabile la guerra
e insopportabile la retorica bellicistica.
L’agone tra Diceopoli e Lamaco è talmente efficace, sotto il profilo comico,
da diventare un modello per tutte le irrisioni a venire. Addirittura Diceopoli usa
una penna del cimiero di Lamaco per indursi a vomitare. Qualcosa di altrettanto
�71
“In ira e malevolenza”: di qualche idiosincrasia comica
improprio e spiazzante fa Antonio Scannagatti (Totò) con il fazzoletto
imprestatogli dall’onorevole Cosimo Trombetta (Mario Castellani)
nell’immortale episodio del vagone-letto in Totò a colori di Steno, con Isa
Barzizza nel ruolo di improbabile eppure sensuosa dark lady. Sono gesti che
scoronano e scornano il nemico comico, detronizzandolo, svuotandone
dall’interno la pienezza di sé, anzi rovesciandogli contro la sua stessa boria e la
propensione al ‘tragicismo’ (lemma caro a Petrolini: versione iperbolica e
contraffatta del tragico, assai pertinente connotazione del genus italicum).
Diceopoli vs Lamaco e Scannagatti vs Trombetta si corrispondono a distanza con
una puntualità che appare evidente. Il che farebbe pensare a una ‘funzione’
Aristofane da cui dipenda tutto il comico politico a venire.
O il comico sic et simpliciter. Basti riandare al Fortunello di Petrolini, il quale,
in Racconto idiota, inanella cinque epiteti con suffisso –ico che riproducono la
congeries di epiteti in –ikos (addirittura otto) con cui Aristofane sfotteva la
neolingua sofistica (Cavalieri, 1378-1381):
“Sono: Omerico,
Isterico
Generico
Chimerico
Clisterico.”
Chioserei che Petrolini fu amico di Ettore Romagnoli, il quale peraltro ne dettò
la lapide commemorativa per il Teatro Quirino. Romagnoli pubblicò nel 1909 per
l’editore Bocca (non il cognato dell’onorevole Trombetta…) la traduzione delle
Commedie di Aristofane.
�72
�73
Endoxa – Prospettive sul presente, 5, 25, Maggio 2020, pp. 73-76
IL VIRUS E LA CARPA A SPECCHIO
SAVERIO FATTORI
Padania sud-est, Ottobre 2004
Da dodici giorni non ho alcun contatto con M.O. Computer infestato da virus.
Allegati alle mail in Word pad che si aprono sempre più lentamente, poi via via
sempre più inaccessibili. Sono ai ferri corti con il negozio di assistenza tecnica. Ho
minacciato azioni legali. Hanno sradicato le metastasi virulente e sostituito il
sistema operativo, ma si sono permessi di svuotare tutto, tutti i file, le interiora del
disco rigido. E comunque non riescono a capire dove si annidi il problema. I due
tecnici si guardano in faccia, le loro ipotesi sembrano ragionevoli ma io sono
sempre più nervoso. Li seguo gravido di aspettative, neanche avessi un parente al
primo ciclo di chemio. Pensano abbia una tresca amorosa che viaggia via mail,
pensano che sia una piccola testa di cazzo dedita alle chat line. Interpretano così la
�74
SAVERIO FATTORI
mia ansia probabilmente. Sto al gioco. Non ho voglia di raccontare nel nostro
carteggio infinito, della follia della nostra falsa biografia autorizzata, di come tutto
il materiale sia scivolato in qualche buco di culo di antimateria di questo imbroglio
tecnologico.
Nemmeno M.O. riesce a leggere i documenti, così almeno mi giura al telefono,
ma alterna le versioni, si contraddice, a volte dice che addirittura non ha ricevuto
nulla (sto dunque definitivamente impazzendo? O è questo che vorrebbe farmi
credere?). Gli chiedo di mandarmi una mail di prova.
Il ragazzo con barba e forfora ha modi pacati e scandisce bene le parole. Non
ho dimestichezza con i termini tecnici in generale, ho molte difficoltà nel gestire
problemi e a compiere azioni risolutrici, e ora che sono in panico non riesco a
concentrarmi, mi limito a biascicare bestemmie. Il ragazzo con la forfora anche
nella barba mi deve scrivere STRUMENTI, ACCOUNT, PROPRIETA’, POP 3,
SMPT, APPLICA, OK, su un post it giallo e mi suggerisce di mandare una mail a
me stesso. Così, per prova. Devastante, ma a lui sembra assolutamente normale.
È entrato in negozio un tipo sulla trentina completamente glabro e di una
bruttezza rara. Sgradevoli macchie scendono lungo il collo. Tiene in mano una
videocassetta sulla pesca alla carpa dal titolo It’s my life, credo voglia riversarla su
dvd o su una chiavetta usb. Trovo tutto questo molto irritante. Il tecnico non può
distrarsi per questa cosa orrenda, il mio problema è vitale. Io vengo prima di tutto.
Anche la carpa in copertina è glabra. È una carpa a specchio di minimo venti chili.
È un animale repellente che ci ciba di mais e nei casi più rari anche di larve di
mosca carnaria. Non mi viene in mente nulla di più ripugnante. Il pescatore
maculato deve uscire entro trenta secondi o sfascio tutto.
Il mio pc non riesce più ad aprire il documento nominato Chi ha ucciso i Talk
Talk? Devo prendere atto di questa evidenza, mentre l’ordigno scricchiola una
clessidra appare al centro dello schermo aumentando il mio sconforto. Sono
rimasto seduto immobile a fissare le prevedibili evoluzioni di questa piccola inutile
clessidra credo per ore, molte ore. Come ipnotizzato. Non saprei dire per quante
ore, giorni, mesi, anni. Ho pianto.
Quasi il pianto per una volta avesse funzionato come una preghiera laica, il
documento mi è apparso, quasi un sogno, ma scorrendo le pagine mi rendo conto
che molte parti risultano illeggibili. File interminabili di lettere e numeri in ordine
casuale si alternano a frasi superstiti. Il disco rigido emette scricchiolii strozzati
sempre più sofferti. E la clessidra è sempre lì, al centro. Sto appiccicato al telefono,
sudo acido, le mie frasi escono sconnesse, imprecise, il tono a volte è violento, poi
supplichevole, il tecnico all’altro capo del filo dice che ci sono stati problemi con
la rete Telecom nella nostra zona, perfino un idiota come me può capire che mente,
prende tempo, ho la voce acutizzata dall’isteria, in chiusura di chiamata sbatto giù
il telefono fino a crepare la plastica lungo tutta la lunghezza della cornetta.
�75
Il virus e la carpa allo specchio
Sono le 11.19 di sabato 20 ottobre quando devo rassegnarmi al fatto che il
documento in word pad è pressoché distrutto, le frasi superstiti galleggiano
misteriose tra
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa££££££££££££££££££££££££££££££££QQ
QQQQQQQQParti
male
ragazzo????????????????????555555555555555555pppppppppppppppppp
pppppppppppppppppppppppppppppppppIl
gioco
delle
facili
seduzioni&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&I ricordi comuni di una
generazione mi mettono lo schifo addossoMMMMMi ricordo di Atlas Ufo
RobotMi ricordo i nomi Actarus e Goldrake Mi ricordo la casetta di Barbie
che avevo costruito per mia sorella Mi ricordo Carosello Mi ricordo It’s my
life dei Talk TalkùùùùùùùùùùChe ci faccio con minimi comuni multipli del
genere Misere cazzate rielaborate da cervelli in decomposizione
senileççççççççççççççççççççççç$$$$$$$$$$$Che fine hanno fatto i Talk Talk?
Perché non hanno combinato più un cazzo dopo Such a
shame0000================================================
=====================Le solite storie di eccessi&drogheLe solite
disarmonie post successo)))))))))))))(((((((((((((((Fragili ali spezzate LA
CONFERMA DELLA FRAGILITA’ è LA NON SOPRAVVIVENZA O NE
CONOSCETE
UNA
PIU?
NETTA?òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòtONDELLI,
ANCORA LUI, sempre così ingombranteeeeeeeeeeeeNella sua grandezza la
sua padanità cosmica da Correggio mi mette sempre di cattivo
umore^^^^^^^^^Non ho intenzione di incontrare M.O. in
futuro///////////////////Per me tornare sul luogo del delitto Piano ammezzato
Errore666L’errore più geniale Afterhours)))))))) Io non ho mai trovato
collocazione&Fuori tempo&Fuori posto Ovunque Disallineato Disarmonico
Scaleno33333333£££££££££££££££££££ììììììììììì+++++++++++è la mia forza
la mia malattia è la mia stessa forza ma sono carne in un reticolo di nervi e un
mare
di
sangueeeeeeeeeeeeM.O.
arrivi
a
Bologna
nel
197777777777777777777777????????????????Dov’eri il 12 marzo 1977
Confessa ne avevi i coglioni pieni di molotov e radicalismi
politici___________________________________________________________
___________________________________________________________Il resto è sparito.
Riconosco che il virus ha lavorato seguendo una sua idea di performance legata
alla scrittura, una forma d’arte visiva. Dai sintomi è come se non riconoscesse il
formato del carattere del documento. Adesso uscirò da questa casa, mi chiuderò la
porta alle spalle, scenderò le scale, avvierò l’auto lungo il vialetto e arriverò al
negozio in tre minuti secchi. Quei coglioni dovranno spiegarmi cosa cazzo sta
succedendo. Non attendo il mio turno, mi sono fatto una lista delle cose che non
vanno e devono capire quanto possa essere pericoloso e non pagherò nulla per i
�76
SAVERIO FATTORI
programmi che mi hanno installato, il virus non è stato estirpato, si riproduce,
riproduce sé stesso. Il tecnico pare dimagrito dall’ultima volta, il rimorso forse
l’ammorba, ma è convincente, dice che non c’è bisogno che paghi subito per il loro
lavoro, dice che il mio pc è solo un po’ lento e che verrà a fare un salto a casa mia
per alcune verifiche. Appena troverà tempo. Il negozio è affollatissimo. I virus di
ultima generazione sono subdoli e devastanti, ma gli ultimi aggiornamenti di
antivirus che mi hanno installato avrebbero dovuto tutelarmi. Il tipo blocca lo
sguardo gelido nella mia direzione poi fa la domanda che tiene tra la lingua e i
denti da alcuni giorni:
“Ma in quali siti vai a curiosare? È pericoloso navigare a vista.”
Un paio di avventori alle mie spalle si fanno scappare due sottili risolini. Dovrei
davvero squartarvi, dovrei rendervi simili a enormi, schifose, lucide, carpe a
specchio.
“No, niente di particolare, niente siti strani, senti non fa di fare il cittadini
indignato, ma col computer ci lavoro, ok, non ci mangio, voglio dire, non è proprio
un lavoro, non ci campo, vabbè, lasciamo perdere, ma scrivo cose poi mando
aggiornamenti quotidiani a una persona, cose che la riguardano, insomma ci
rimpalliamo i file modificati e ora dice che non riesce ad aprire i miei allegati, il
suo antivirus lo avverte che sono potenzialmente pericolosi e in effetti nemmeno
io riesco a ritrovarli integri. È un grosso problema, c’è il lavoro di mesi dietro.”
Il ragazzo con la barba e la forfora anche nella barba si gratta la testa, nel suo
cervello pigro sta comunque nascendo una larva di pensiero.
“E gli altri documenti? E con altri indirizzi di posta ha problemi?”
“Ho problemi solo su questi documenti e la posta elettronica funziona.”
“E non ha salvato nulla…”
“No. Ottanta fottute cartelle. Stavo dando un senso ad appunti che non avevano
nessun senso logico.”
“Noi crediamo che il tuo pc sia a posto.”
“A posto un cazzo.”
“E se fosse la persona cui mandi questi documenti ad avere infettato il file?”
I due alle mie spalle emettono uno strano rumore all’unisono. È il risucchio della
carpa a specchio quando nei mesi estivi di caldo torrido boccheggia in superficie
elemosinando ossigeno.
Estrapolazione da Saverio Fattori, Chi ha ucciso i Talk Talk?, Alberto Gaffi
Editore, Roma, 2006.
Photo by Edwin Hooper on Unsplash
�77
Endoxa – Prospettive sul presente, 5, 25, Maggio 2020, pp. 77-83
CUCKOLD LOCKDOWN
PEE GEE DANIEL
Era una domenica.
Alda mi fa: «Vado al concerto dei Diaframma.»
«Ok» rispondo io. Tanto ci ero abituato. C’era sempre qualche misterioso
concerto a cui andare o cose del genere.
La novità è che, per una volta, dopo che ho messo a letto la bambina, decido di
controllare sul motore di ricerca, così per sfizio. Risultato: non c'è alcun concerto
dei Diaframma in giro.
�78
PEE GEE DANIEL
Glielo scrivo per conferma: “Sei al concerto dei Diaframma?”.
Lei: “Sì sì.”
E io, con la massima nonchalance: “Guarda che non c'è alcun concerto dei
Diaframma stasera, ho controllato.”
Silenzio imbarazzato.
Alla fine una risposta arriva: “Eh no, ma non sono i Diaframma, è solo il
cantante, Fiumani.”
Controllo. Nessun concerto di Fiumani in giro.
Glielo scrivo. Risposta: “Non so cosa dirti, se non lo hanno scritto non è colpa
mia.”
Chiedo: “Ma dove sei?”.
Silenzio imbarazzato.
“Domanda difficile?” la incalzo, dopo un po’.
Passa ancora qualche minuto prima che risponda: “Monza.”
Controllo: non c'è alcun concerto a Monza, quella sera. Manco di una tribute
band degli Inti-Illimani, tanto per dire.
Glielo comunico. Risposta: “Non so cosa dirti, se non c'è scritto.”
Domando: “In che locale sei?”.
Silenzio imbarazzato.
Dopo varie sollecitazioni: “Al Noir qualche cosa, ma ora sto tornando.”
Ma come? Non eri al concerto tre domande fa? Comunque controllo. In zona
c'è un solo locale con quel nome, che tra l'altro è un ristorante. Strano. Controllo.
Non annunciano alcun concerto per la domenica. Non fanno concerti, in generale.
È più un posto per coppiette in cerca di intimità, a giudicare dalle foto...
Glielo faccio presente. Stessa risposta di prima.
Scrivo al locale, chiedendo se ci fosse stato un concerto di Fiumani o dei
Diaframma. Mi rispondono di no. Glielo faccio presente. Risponde: “Non so cosa
dirti. Ero con degli amici di Asti, era un concerto a inviti. Un evento riservato.”
“Così riservato che quelli del locale manco lo sapevano?!”.
Va beh. Scrivo direttamente ai Diaframma, attraverso la pagina Facebook, e
chiedo se loro o Fiumani abbiano suonato in zona Monza domenica. Mi
rispondono di no.
Glielo faccio presente. Risposta piccata: “Oh, ma cosa stai dicendo?”.
Fu allora che finalmente capii cosa doveva ricordarsi, in realtà, quando ha scritto
sul calendario diaframma...
Va beh, poco male, me l’aspettavo. Era sempre andata così: di quando in quando
capitava che sparisse per serate con amici che si prolungavano anche sino alle
quattro di notte, viaggi al mare o in qualche parco acquatico in compagnia di
qualche persona particolarmente cara, e mai meglio precisata, concertini fuori
provincia, aperitivi o caffè consumati chissà con chi e chissà dove, e via dicendo.
Ci avevo fatto il callo. Non che rientri nella categoria “cornuti e contenti”: uno di
quei pervertiti che se sospettano che la partner vada con qualcun altro, anziché
�79
Cuckold lockdown
risentirsi si eccitano. Semplicemente, ci avevo messo una pietra sopra. Per me con
Alda era finita da anni, mi focalizzavo sulle esigenze di nostra figlia e sul trantran
quotidiano, nell’attesa dell’occasione in cui, prima o poi, la avrei presa in castagna,
che era prontamente arrivata.
Una sensazione di euforia mi percorse quando, con un paio di facili mosse,
riuscii finalmente a sgamarla in maniera inequivocabile, per quanto lei, a sua
difesa, non fosse capace di fare altro di negare l’evidenza. Era la scuola di sua
madre quella: gli uomini sono tutti stupidi, le aveva insegnato sin da piccina, e lei
lo aveva preso per oro colato.
Era un punto di non ritorno: ormai non potevo più abbozzare, avevo le prove,
per quanto indiziarie. Tanto bastava.
Mi rivolsi immediatamente a un legale, finché il pasticcio era ancora caldo.
Googlando, trovai un’avvocatessa della mia città, una scelta a caso o poco più. A
breve presi un appuntamento nel suo studio, quasi in centro. Concordammo le linee
principali per la separazione. Eravamo già sul piede di guerra quando… scatta la
quarantena!
Già si potevano cogliere i primi segnali del destino verso cui la nazione stava
precipitando dal fatto che quando porsi la mano all’avvocatessa lei mi fece la finta,
indicandomi con il pollice dove fosse l’uscita, inoltre, per l’intera durata del
colloquio mi aveva puntato nel centro del petto la punta di un ombrello che
assicurava della lunghezza di un metro abbondante. Non me ne curai più di tanto,
avevo altro a cui pensare.
Ci scambiammo una manciata di mail nei giorni a venire, per tenerci
reciprocamente aggiornati. Finché, a neanche una settimana da quell’iniziale
contatto, si entrò nel pieno dei provvedimenti contro il Coronavirus. Da cui
conseguiva che i tribunali sarebbero rimasti chiusi sine die, che quello che avevo
finalmente trovato il coraggio di fare era stato sospeso chissà per quanto tempo e
che non si poteva più mettere il naso fuori dalle proprie abitazioni. Tradotto: me
ne sarei dovuto rimanere intampato a casa mia in una promiscuità continuativa con
quella da cui avrei voluto invece distanziarmi il più possibile. Un tempismo
eccezionale, non c’è che dire.
Una delle ultime mail inoltratemi dalla leguleia, a mo’ di messaggio infilato
dentro una bottiglia gettata tra i flutti prima di lasciarmi solo al mio destino, mi
intimava: “Mi raccomando, non abbandoni il tetto coniugale prima della sentenza
di un giudice. Resista!”.
E così, giorno per giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese mi ci
ritrovo a convivere 24/7. La peggiore compagnia che mi potessi scegliere in una
contingenza come questa, considerando che, tra le altre cose, Alda è una cacasotto
a livelli olimpionici. Già normalmente, quando non c’è la minima emergenza, lei
vive costantemente sul chi-va-là. Ha sempre avuto una paura fregata di tutto ciò
che desse anche solo lontanamente qualche segno di vita: ladri, malattie,
extracomunitari, altre donne che intravedesse appena appena più carine di lei. Uno
�80
PEE GEE DANIEL
snervante ricettacolo di paranoie e ipocondrie irrazionali. Per la sicurezza
domestica ha preteso sbarre alle finestre (nonostante abitassimo all’ottavo piano),
porta-blindata, sistema antifurto, serratura antiscasso, catenaccio. Ricordo che,
mentre il fabbro era ancora al lavoro, le domandai se il prossimo passo sarebbe
stata una buca riempita d’acqua e piranha proprio davanti all’uscio.
Ho sempre impressa in mente quella volta che in autostrada si mise a strillare
per la mia guida, malgrado rispettassi con largo margine i limiti di velocità. Mi
rimproverava perché stavo superando come un pazzo una decina di autoveicoli
tutti insieme. Mi voltai a guardare e scoprii trattarsi di una bisarca carica di nuovi
modelli caricati per qualche autosalone.
L’aspetto peggiore è che non riconosce assolutamente questa sua inclinazione,
vanificando così ogni possibilità di guarigione.
Anzi, tende a offendersi, se glielo si fa presente, difendendo strenuamente la
propria obiettività di giudizio (con forza perlomeno equipollente a quella
impiegata per ribadire la propria specchiata fedeltà).
Potete immaginare come abbia preso la minaccia Covid-19: qualcosa di
potenzialmente letale e allo stesso tempo invisibile, dunque una fonte d’angoscia
ancora maggiore dei semplici rapinatori a mano armata o degli incidenti stradali.
Qualcosa di paragonabile a quei minuscoli microbi che furono capaci di vincere i
giganteschi alieni supertecnologici nel finale di La guerra dei mondi.
Finora non ha fatto che subissarmi di notizie sanitarie spesso contraddittorie
carpite qua e là, rapsodicamente, da siti, giornali, trasmissioni spesso tutt’altro che
attendibili, ma che hanno questo di buono dalla loro parte: riuscire a fomentare le
più intime paure dell’utente. Benzina a cento ottani gettata sul fuoco. In fondo non
è poi questo a cui, in segreto, aspirano i paranoidi? Farsela sotto sino a riempirsi le
brache? Ho sempre sospettato che sia una forma di masochismo sotto mentite
spoglie la loro. Ci godono nell’apprendere brutte notizie, in realtà. Altrimenti non
si spiegherebbe il perché, anche quando tutto sembra procedere per il verso giusto,
si vadano a cercare lo spauracchio ad hoc, rimestando tra le news e le dicerie più
improbabili, pur di sentirsi cullati da quel senso di impotenza di fronte
all’ineluttabile, che per loro sembra essere la fonte del massimo, quanto perverso,
piacere (seppure si guardino bene dal confessarlo apertamente).
Quanto a lei, è stata ligia all’ordinanza, restandosene diligentemente in casa,
notte e giorno. Per andare anche solo sul balcone mancava poco che si intabarrasse
dentro uno scafandro da apicultore. La sua tendenza a rendere tragico quel ch’è già
di per sé sufficientemente drammatico l’aveva portata a credere, supportata non si
capiva bene da quale indiscrezione ministeriale, che il virus viaggiasse liberamente
attraverso l’aria, come le particelle d’ossigeno, e fosse quindi continuamente
respirabile se non si fossero usate le debite accortezze, come quella di non respirare
a oltranza – suppongo -. A questo si aggiunga che anche l’acqua del rubinetto, a
detta sua, poteva essere satura di Coronavirus – ho preferito non indagare sui
meccanismi virologici che lo avrebbero consentito -. Ogni doccia, ogni risciacquo,
�81
Cuckold lockdown
ogni gargarismo avrebbero potuto rivelarsi letali. A sentire lei, il Covid19 è
diventata la componente aggiuntiva alla formula chimica classica dell’acqua
corrente: H2O-SARS-CoV-2. L’igiene personale sembra avere ormai assunto i
contorni di un’emozionante roulette russa. Ogni volta che ti lavi i denti potrebbe
essere l’ultima.
La gran strizza, che rappresenta di lei l’aspetto dominante, l’ha avuta vinta su
ogni altra sua peculiarità, tant’è vero che nel corso della Fase1, al posto delle sue
consuete sortite serali, si limitava tutt’al più a trincerarsi in camera da letto per ore
con la scusa di certe telefonate, anche in questo caso mai meglio specificate,
seguite da misteriosi bidè, a cui si apprestava non appena riemergesse da quelle
chiamate in solitaria.
Appena è scoccata la Fase2, invece, munita di una semplice mascherina da
elettrauto, pedibus calcantibus o inforcando il suo vecchio motorino, ha
ricominciato ad assentarsi delle ore per destinazione vaga, se non del tutto ignota.
Dopo settimane di deliranti psicosi, le è poi bastata una mezza rassicurazione
ministeriale perché le sue smanie extra-domestiche tornassero a briglia sciolte.
Meglio così, non importa, ovunque vada, sempre meglio che averla tra i piedi.
Io mi godo la mia piccola Adele, e tanto basta.
Infatti, se la convivenza sotto emergenza pandemica con un’ansiogena fifona
del genere non fosse già abbastanza stressante di per sé, a questo si accompagna
una crescente intolleranza da parte mia verso ogni suo tic comportamentale, anche
il più innocuo.
Quando segue le patetiche dirette Instagram di Vincenzo Menga, il suo cantante
preferito, con il volume sparato a palla, squittendo allegra a ogni battutina di quel
supremo coglione, quando pilucca il cibo a punta di forchetta come una scimmia
inappetente, quando commenta il film che sto guardando o il libro che sto leggendo
con aria di sufficienza. Mi infastidiscono il suo tono di voce, i suoi difetti di
pronuncia, la tinta dello smalto per unghie. Addirittura il modo in cui dice il mio
nome, “Giulio!”, facendo geminare tra le labbra la palatale iniziale e insistendo
sulla l, che pronuncia come il gruppo gl.
Spinto dal risentimento, ho iniziato a provare intolleranza per molti di quegli
aspetti che un tempo trovavo caratteristici. Del resto è così che funziona la trappola
dell’attrazione. La natura ti frega, doppiamente: da impareggiabile prestigiatrice
qual è, ti fa prendere per gradevolezze quelli che a lungo andare risulteranno essere
ai tuoi occhi difetti o incompatibilità, e tutto questo a meri fini riproduttivi, che a
loro volta ti imbonisce sotto la pomposa quanto evanescente dicitura di “amore”.
Quel che davvero le sficchia è l’imperitura preservazione della specie, in barba ai
sentimenti di un povero tapino, offuscato nelle proprie scelte da motivazioni
zoppicanti e precipitose. Quando l’amorosa ti incastra definitivamente, allora
Maya cala il velo.
Ricordo ancora, seppur vaghissimamente, come appartenente a una diversa e
remota temperie storica, quando, i primi tempi, la ammiravo incantato e non facevo
�82
PEE GEE DANIEL
che ripetermi: “Che fortunato che sono! Ma come fa una così a voler uscire con
uno come me?”. Ora le cose si sono nettamente ribaltate e quando la osservo non
faccio chiedermi: “Ma come cazzo ho fatto a uscire con questa?”.
Se un tempo rimanevo ammirato da quei boccoli che le ricadevano sulle spalle
e le circondavano la nuca come un cesto di molle, ora, che i suoi capelli me li
ritrovo ovunque per casa, anche dentro le mutande, la sua capigliatura appare ai
miei occhi più che altro come una pecora morta poggiatale sopra la testa, in stile
Davy Crockett. Quel suo sguardo languido, in cui allora rischiavo tutte le volte di
annegare, ora mi ricorda gli occhi spenti di un pesce bollito. Avevo ragione in quel
periodo o in questo? Non credo sia poi così rilevante. È lo stato d’animo a generare
le interpretazioni.
“La amo!” proclamiamo a viva voce, all’inizio della relazione. “Amo! Amo!
Amo!”. E infatti quello è: un amo. Una volta che ho abboccato, il resto è venuto
da sé: gravidanza, frutto dell’amore, responsabilità.
E anche nel momento in cui, grazie a una sfrontatezza tutta nuova, legittimata
dalla consapevolezza di avermi ormai legato a filo doppio, tale e quale a un salame,
ha scoperto le carte, mostrando di che pasta fosse fatta, quel che non sopportavo
di lei me lo sono fatto andare bene, o meglio, l’ho ignorato, tirando avanti, un po’
per il quieto vivere, un po’ in nome di esigenze superiori, o che ci raccontiamo
come tali.
Del resto lo sapete, no, qual è l’anagramma di “il peggiore dei mali”? “È di
pigliare moglie”.
Ma è stata questa convivenza forzosa, che ha visto crescere geometricamente le
ore da condividere gomito a gomito, spalla a spalla, fiato a fiato, parole su parole,
proprio quando avrei fatto carte false per separare le nostre strade, a portare la mia
insofferenza a livelli nevrastenici.
Fiumi di parole in tv, sui giornali, per radio per quanto concerne uomini
possessivi e violenti che non vogliono lasciare libere di andarsene le proprie
partner, ma di un disgraziato che invece pagherebbe per vederla smammare e non
ce la fa non si interessa mai nessuno?
Di tutte le cose che mi tocca sopportare, quella che mi dà poi particolarmente
sui nervi è come ami denigrare il mio lavoro. Anche se ci dovrei aver fatto il callo,
visto che si tratta di una vecchia consuetudine
“Scrivi solo cazzate” è la critica che esce più ricorrente da quella sua bocca
tumida, ogni volta che mi nego perché impegnato a finire un pezzo per qualche
rivista o a chiudere un capitolo che mi stia particolarmente a cuore.
Dice che butto via il mio tempo, proprio lei che nella vita ha fatto giusto un
tirocinio al fulmicotone e un impiego temporaneo di un paio di mesi al massimo,
entrambi coronati dalle continue lamentele dei rispettivi superiori per la sua scarsa
resa lavorativa.
C’è però una cosa che le devo riconoscere: da che siamo rinchiusi dentro casa
ha cominciato a darsi da fare con le pulizie. Vetri, fornelli, sanitari, pavimenti. È
�83
Cuckold lockdown
un continuo. Che, fino a poco tempo fa, se passava l’aspirapolvere alle feste
comandate era già una conquista.
Sarà per fare un po’ di movimento? Sarà per passare i lunghi tempi morti? Sarà
per sanificare l’abitazione, rispondendo alle solite fisime che sempre la
accompagnano? Mah, secondo me invece deve aver equivocato, quella volta che
presumo sua mamma le abbia suggerito: “Sai che devi fare perché non se la
squagli? Scopa!”.
�84
�85
Endoxa – Prospettive sul presente, 5, 25, Maggio 2020, pp. 85-88
PANDEMIA, DISTOPIA,
IDIOSINCRASIA
JURI CAMBARAU
Alle 18:30 la spiaggia era deserta. Il vento di maggio alzava debolmente i
granelli di sabbia superficiali. Era l’ora che lei preferiva. Prese il telo e lo adagiò
ad appena un metro dal bagnasciuga, poco prima che finisse la sabbia asciutta, così
da poterci infilare i piedi nudi fino alle caviglie. Distolse per un attimo lo sguardo
dall’orizzonte e si voltò indietro per guardare l’inclinazione della prima luce del
tramonto infrangersi addosso ai pochi recinti di plexiglass dello stabilimento
balneare ormai opacizzati e rimasti ancora in piedi, al centro dei quali un paio di
anni fa si ergevano ombrelloni a spicchi gialli e arancioni. Ricordò con tristezza,
dentro all’accenno di un sorriso, quel goffo e ostinato tentativo che l’uomo utilizzò
�86
JURI CAMBARAU
per illudersi di poter dare una parvenza di normalità durante la prima ondata della
pandemia.
Ogni volta che qualche raffica di vento rinforzava da est, la donna si tirava gli
occhiali da sole sulla testa per scrutare meglio l’orizzonte, poi, quando il vento
sembrava rabbonirsi, appoggiava di nuovo gli occhiali sul naso e tornava a
distendersi sul suo telo verde acqua.
Aveva con se due libri, uno era il suo preferito, Le memorie di Adriano e l’altro
era dentro la sua borsa, avvolto in una camicia da uomo bianca, forse un regalo per
qualcuno.
Amava quel libro particolarmente. Non era un libro da spiaggia, ma era un libro
da solitudine, come quella che provava in quel momento, lì.
Amava ancor di più i Taccuini di appunti che si trovavano in fondo a quel libro
e soprattutto il pensiero di Flaubert che catturò la Yourcenar, quel pensiero
rinchiuso in una frase che lesse nella sua mente, scandendone bene le parole per
darle l’intonazione che meritava.
«Quando gli dèi non c’erano più e Cristo non ancora, tra Cicerone e Marco
Aurelio, c’è stato un momento unico in cui è esistito l’uomo, solo».
La rilesse per l’ennesima volta e ci cadde dentro nuovamente. La rileggeva
ancora e ancora, di tanto in tanto si tirava su a sedere per tornare a guardare verso
l’orizzonte, dove il tramonto non sembrava ancora tramonto, dove il tramonto era
ancora una promessa.
Le piaceva quell’odore di sale, di quel che resta di morte, sesso e banchetti di
alghe e pesci, ma decise che lo avrebbe rovinato per un po’, abbandonando per un
attimo il libro e accendendosi una Chesterfield blu.
Nello stesso momento vide qualcosa, lontano lontano, a un passo dall’orizzonte.
«Strano…» pensò. Quel qualcosa sembrava avvicinarsi in modo lento ma
costante. «Eppure le imbarcazioni sono ancora proibite» pensò ancora la donna,
mentre la linea delle labbra le si scuciva in un sorriso come solo la felicità tanto
attesa riesce a fare. Allora prese la sigaretta, succhiò l’ultima boccata e la soffocò
spingendola fino a farla sparire sotto la sabbia.
Ora quel puntino che sembrava essere sgocciolato dall’orlo dell’orizzonte non
era più un puntino.
Era un uomo.
Un uomo che nuotava verso la riva.
Un uomo che nuotava per lei.
La donna guardava le bracciate lente dell’uomo, quasi a scandirle col battito
degli occhi. «Chissà da quanto è che nuota?» si domandò.
L’uomo a circa dieci metri dalla riva emerse dall’acqua fino alla vita e continuò
il suo avvicinamento camminando. Era nudo. Un sorriso che si può accennare solo
�87
Pandemia, distopia, idiosincrasia
a chi si ama prese il posto della smorfia della fatica. Arrivato di fronte a lei, che
era rimasta seduta col libro in mano, chiese: «Posso sedermi lì, accanto a te?».
Parlarono per un po’, ma questa è una storia secondaria. Forse lui le spiegò cosa
pensava ad ogni bracciata di quel viaggio lungo i 200 chilometri di distanza che li
avevano separati fino a quel momento. Forse lei gli confessò immodestamente che
non si sentiva quella meraviglia per cui vale la pena compiere il viaggio e
soprattutto che il mare di maggio era un segreto solo suo fatto di vento e silenzio.
Quel silenzio che raccolsero in un bacio infinito di sale, vento, fatica e nicotina.
Dopo un po’ l’uomo disse: «Prima o poi questa incompatibilità forzata, questa
idiosincrasia tra l’amore e il virus scomparirà. Nel frattempo proviamo a gestire il
dolore della lontananza. Smettila di dubitarti e custodisci gelosamente la tua
meraviglia».
La donna annuì e poggiò la fronte contro quella dell’uomo. Stettero così a
guardarsi per il tempo sufficiente a far sì che ognuno di loro vedesse un solo occhio
dell’altro a causa dell’estrema vicinanza del contatto visivo.
Fecero l’amore per un paio d’ore.
Quando ebbero finito, respirarono quell’odore di sale, di quel che resta di morte,
sesso e banchetti di alghe e pesci, seduti sul bagnasciuga, in silenzio, un po’
infreddoliti. La donna, nuda, si alzò di scatto. L’uomo la guardò dal basso e le
sorrise.
Lei prese l’altro libro dentro alla sua borsa, avvolto in una camicia da uomo
bianca e glielo porse. Poi Prese il suo Le memorie di Adriano e gli porse pure quello
dicendo «abbine cura». L’uomo sorrise a sua volta.
«Adesso tocca a me, giusto?» chiese lei, cercando di mantenere il sorriso che
cercava di rimanere aggrappato nonostante la consapevolezza dell’addio. Allora le
sembrò di essere nel libro, come l’imperatore Adriano
«Piccola anima smarrita e soave, compagna e ospite del corpo, ora t'appresti a
scendere in luoghi incolori, ardui e spogli, ove non avrai più gli svaghi consueti.
Un istante ancora, guardiamo insieme le rive familiari, le cose che certamente non
vedremo mai più... Cerchiamo d'entrare nella morte a occhi aperti…».
Si concesse subito alla prima onda che la colpì all’altezza delle ginocchia e
piano si abbandonò al mare. Si girò soltanto un attimo verso l’uomo per accennare
un saluto.
Aveva occhi dello stesso colore che hanno il cielo e il mare quando si incontrano
all’orizzonte.
La prima lacrima di lei si perse nel mare alla prima bracciata.
La prima lacrima di lui cadde e finì assorbita dalla carta della pagina
dell’introduzione di Viaggio al termine della notte che la donna gli aveva porto
avvolto in una camicia bianca. La seconda lacrima cadde sulla V di Viaggiare
«Viaggiare, è proprio utile, fa lavorare l’immaginazione. Tutto il resto è
delusione e fatica. Il viaggio che ci è dato è interamente immaginario. Ecco la sua
�88
JURI CAMBARAU
forza.
Va dalla vita alla morte. Uomini, bestie, città e cose, è tutto inventato. È un
romanzo, nient’altro che una storia fittizia. Lo dice Littré, lui non sbaglia mai.
E poi in ogni caso tutti possono fare altrettanto. Basta chiudere gli occhi.
È dall’altra parte della vita».
L’uomo si infilò la camicia e continuò a piangere vedendola allontanare un poco
alla volta. La centotrentottesima lacrima cadde sull’ultima pagina del libro.
Precisamente sulla L di Lontano
«Lontano, il rimorchiatore ha fischiato; il suo richiamo ha passato il ponte,
ancora un'arcata, un'altra, la chiusa, un altro ponte, lontano, più lontano...
Chiamava a sé tutte le chiatte del fiume tutte, e la città intera, e il cielo e la
campagna, e noi, tutto si portava via, anche la Senna, tutto, che non se ne parli
più».
La donna ormai era solo un puntino che si adagiava sul tramonto.
L’uomo la osservò sparire all’orizzonte.
Prese il libro che la donna gli aveva affidato e lo avvolse nel telo verde acqua,
poi andò via.
La spiaggia di maggio tornò a essere un segreto fatto di vento e silenzio.
�89
Endoxa – Prospettive sul presente, 5, 25, Maggio 2020, pp. 89-96
L’IDIOSINCRASIA DELL’OCCIDENTE
DAVIDE ASSAEL
Non è facile definire l’idiosincrasia, tanta è l’ampiezza semantica di questo
concetto, che compare negli ambiti più svariati. Esistono idiosincrasie
psicologiche, di cui tanto si è occupata la letteratura psicoanalitica. Esistono
idiosincrasie sociologiche, con intere comunità che hanno sviluppato affetti
idiosincratici nei confronti di altri gruppi sociali. Non è certo difficile trovare nella
storia, anche recente, esempi di odio etnico. Esistono anche idiosincrasie politiche,
che sempre si fondano su tabù inavvicinabili. Dovendo trovare una definizione
generale, potremmo dire che l’idiosincrasia è l’immagine dell’alterità, sia essa
percepita con categorie psicologiche, sociologiche, oppure politiche. È, dunque,
una categoria identitaria, in quanto è quel limite che separa noi dagli altri,
confine consustanziale ad ogni identità. Per quanto varie siano le identità, tutte
riflettono una distinzione Io/Tu, che appare, appunto, come il loro fondamento
ontologico.
Nel corso della storia umana esiste solo una cultura che abbia tentato di
superare questo schema: la civiltà occidentale. Lo aveva ben capito il vecchio
Husserl, quando, lui ebreo in un’Europa in cui si era affermato il virus nazista, si
confronta con una crisi culturale di cui vede le radici assai più indietro. Parliamo
di quel grande libro, per alcuni il vertice della filosofia del ‘900, che risponde al
nome de La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, ultima
opera del filosofo a cui lavora ininterrottamente dal 1935 al 1937. Qui Husserl ha
�90
DAVIDE ASSAEL
il coraggio della domanda radicale: cos’è Europa? E cosa la distingue dalle altre
civiltà, come l’India o la Cina? Domande attualissime in un momento in cui queste
stesse realtà progettano il «sorpasso» sull’Occidente in termini economici e
geopolitici. La risposta husserliana è coraggiosa quanto la domanda: Europa non è
una civiltà fra le altre, ma l’unica che ha voluto sviluppare una cultura
universalistica, che ha forse trovato la sua massima espressione nella cultura
scientifica. Non è un caso che la globalizzzione con cui oggi facciamo i conti sia
stata in fondo un’occidentalizzazione. Un’adozione da parte degli altri del modello
occidentale. Non è la medicina tradizionale cinese ad essersi diffusa nel mondo,
ma la scienza medica occidentale. Andare in un ospedale a Pechino, non è così
diverso che andarci a Parigi o Londra. Così in un laboratorio di fisica, o di
qualunque altra scienza. Di matrice occidentale è la Carta universale dei diritti
dell’uomo, occidentale è l’idea stessa di istituzioni sovranazionali. Insomma,
utilizzando un ossimoro potremmo dire che la specificità dell’Occidente è la sua
universalità. Ma universale è, per definizione, ciò che non ha limiti, ciò che non
conosce idiosincrasie perché abolisce la distinzione dentro/fuori. Lo schema
identitario sopra richiamato sembra dissolversi.
Ma siamo sicuri che una società universalistica sia priva di idiosincrasie?
Oppure si fonda su una grande idiosincrasia rimossa perché inaccettabile alla sua
coscienza? Fra i tanti testi a fondamento della civiltà occidentale su cui potremmo
concentrarci, forse nessuno come la Bibbia, l’antica Torah ebraica, può aiutarci a
rispondere a questa domanda.
Tra Abramo e Giacobbe: la Torah e l’Occidente
La costruzione dell’identità occidentale, nella Torah, coincide con le
vicende dei tre patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe. Il punto di inizio lo
troviamo nel Cap. 12 della Genesi, in quel Lech Lechà, che significa
contemporaneamente «Vai via» e «Vai verso te stesso», che Dio rivolge ad Abramo
intimandogli (l’espressione è coerente con l’imperativo con cui è declinato il
verbo) di lasciare «la tua terra, la tua famiglia, la casa di tuo padre» per dirigersi
«verso il posto che ti mostrerò». Una simbolica di distacco dalle pulsioni di
possesso territoriale, familistiche e genealogiche, che basterebbe da sola a
riassumere un intero manuale psicoanalitico. Per questo gesto, invero ripetuto più
volte da altre figure bibliche, Abramo verrà definitivo ( עבריivrì, ebreo), dal verbo
ebraico ( לעבורlaavor), oltrepassare. Abramo è letteralmente «colui che
attraversa». Cosa attraversa il primo patriarca? Per riassumere, potremmo dire che
attraversa il limite etnico per fondare una società universalistica. Abbandona la
logica gerarchica dei due grandi imperi egizio e babilonese per fondare un modello
sociale e politico in cui venga riconosciuta la comune radice adamitica di tutti gli
individui. Il gesto che dà origine all’identità ebraica è, dunque, lo stesso che
stabilisce quell’orizzonte valoriale che nutrirà tutto l’Occidente. Ancor prima che
�91
L’idiosincrasia dell’Occidente
greca, l’identità occidentale è ebraica. Origine troppo spesso dimenticata, se non
esplicitamente rimossa.
Il percorso abramitico si concluderà ben oltre la sua morte, con la vicenda del
nipote Giacobbe, rinominato «Israele» proprio a conferma di un compimento
identitario. Siamo sempre nella Genesi, nel Capitolo 25. Come tutte le matriarche,
anche Rebecca, moglie di Isacco, non riesce a rimanere incinta. Così il figlio di
Abramo si rivolge a Dio affinché la aiuti a concepire. «L’Eterno accolse la
preghiera di Isacco e sua moglie Rebecca restò gravida» (Gen. 25, 21). La
gravidanza di Rebecca non fu semplice. La Torah racconta dei dolori che le
procurava, tanto che la matriarca si rivolgerà al Signore con un’espressione che
ancora oggi riassume i disagi esistenziali di ogni genitore, che sempre verifica la
distanza fra desiderio e realtà: «Se è così perché ho pregato tanto per questo?». E
«Andò a consultare il Signore» (Gen. 25, 22). La risposta alla domanda era già
stata in parte anticipata dal testo biblico, che aveva usato il plurale ( בניםbanìm),
figli per descrivere cosa stava accadendo nel suo ventre: «Nel tuo ventre ci sono
due nazioni, due popoli si dirameranno dalle tue viscere, una nazione sarà più
forte dell’altra, ma il più grande servirà il più piccolo» (Gen. 25, 23). La
profezia, parlando di popoli e nazioni, allarga di molto il significato di questa
gravidanza, aggiungendo una tonalità politica ancor più rimarcata dall’ultima
parte, che informa di un ribaltamento delle gerarchie tradizionali. A conferma,
come del resto già chiaro dai precedenti rapporti di fratellanza (Caino/Abele e
Isacco/Ismaele), di quanto l’etica biblica a fondamento dell’Occidente sia un’etica
dei figli minori.
Come noto, la lotta fra i fratelli per uscire per primi dalla pancia della mamma
sarà vinta da Esaù, che nacque per primo. Il primo nato, per la convenzione antica,
è considerato primogenito. Fin da subito è chiaro che fra i due fratelli sarà
Giacobbe ad ereditare quella propensione al superamento del limite che aveva
contraddistinto suo nonno Abramo. Nel descrivere la nascita, la Torah si concentra
su un passo apparentemente senza significato: è scritto che Giacobbe nasce con la
mano attaccata al calcagno di Esaù. Proprio da qui il nome Yaakov (Giacobbe),
che deriva da ( עקבekev), tallone. Perché un testo che parla di liberazione dei popoli
e grandi orizzonti etici si concentra su un particolare che definiremmo da
ostetricia? Il commento è chiaro in proposito: Giacobbe afferra il fratello per un
tallone perché vuole trascinarlo giù e superarlo, non rassegnato al ruolo di fratello
minore che la natura gli aveva imposto. Fin da subito i due gemelli manifestano
caratteristiche opposte. Riassumiamo quelle principali:
anzitutto i nomi. Esaù è fatto derivare dal verbo ( לעשותlaaśot), fare.
Significherebbe, quindi, «fatto» nel senso di già compiuto in se stesso. Di Yaakov,
invece, viene sottolineato come la prima lettera sia «la Yod, che corrisponde al
numero dieci, e sta per il Decalogo; la seconda la ‘Ayn, settanta, cioè i settanta
anziani alla guida del popolo; la terza è la Qof, che vale cento e indica il Tempio,
alto cento cubiti; l’ultima consonante è infine la Bet, il cui valore è due, come Le
�92
DAVIDE ASSAEL
Tavole della Legge» (tratto da, Louis Ginzberg, Le leggende degli ebrei. II. Da
Abramo a Giacobbe, Adelphi, Milano, 1997, p. 127).
Esaù era amato dal padre, Giacobbe dalla madre, che esprime un amore gratuito,
meno legato alle logiche genealogiche che definiscono la figura paterna.
Esaù è uomo di caccia e dei campi, Giacobbe invece era «uomo integro» e
risiedeva nelle tende. Il commento ci dice che si tratta delle tende di Shem ed Ever,
le prime yeshivòt, le case di studio dove ancora oggi si impartisce l’educazione
rabbinica.
Le differenze fra fratelli confermano le caratteristiche che la Torah assegna al
primogenito, sempre costretto a sacrificare la propria individualità alle aspettative
genitoriali. Il secondo, invece, gode di un amore più libero. È il primo ad essere il
ricettacolo di tutti quei meccanismi proiettivi che caratterizzano la maternità e la
paternità. Il secondo, invece, gode di un amore più libero.
Le consuetudini antiche erano, però, chiarissime: il primo uscito eredita il ruolo
di capofamiglia. Non rassegnato al proprio ruolo e descritto con la stessa
sfrontatezza che ritroveremo nel figlio Giuseppe, Giacobbe passerà l’intera
giovinezza a progettare il modo di sottrarre la primogenitura al fratello. Il momento
adatto arriva quando Esaù è di ritorno dalla caccia. Il Midrash ci dice che il gemello
maggiore fosse un grande cacciatore, che aveva addirittura sottratto a Nimrod, il
primo ribelle nei confronti del Signore, la veste che gli consentiva di attirare a sé
tutte le prede. Ma la caccia, soprattutto in epoca antica, è una pratica molto
rischiosa, in cui si può perdere la vita ad ogni istante. È, quindi, questo il momento
in cui l’orizzonte esistenziale di Esaù, già di per sé compromesso, è più chiuso.
Yaakov lo sa bene e fa scattare il proprio piano. Si farà trovare intento a mangiare
una zuppa, che la tradizione ha fatto coincidere con un piatto di lenticchie. Sempre
il commento ci mostra Giacobbe impegnato a far uscire l’odore della zuppa dalla
finestra della casa in modo da stuzzicare il fratello mentre tornava. Appena entrato
Esaù chiese a Giacobbe un po’ di ciò che stava mangiando. Il fratello gli rispose
che glielo avrebbe dato in cambio della primogenitura. Le parole con cui Esav
accetta sono una sintesi perfetta del suo stato d’animo: «Se devo morire, cosa me
ne faccio della primogenitura?». A confermare questo stato d’animo è proprio
l’immagine delle lenticchie, mai citate nel testo, che invece parla di una «zuppa
rossa» (alcuni interpreti fanno derivare da qui il nome Edom, da cui Edomiti, la
discendenza di Esaù). La lenticchia, per la tradizione biblico-ebraica, è il cibo del
lutto in quanto è circolare come la morte che circola inesorabilmente fra le persone
e anche perché è senza fori. Così come senza aperture verso l’esterno è colui che
deve rispettare il silenzio nei giorni di lutto. Tanti di più quanto è stretto il legame
di parentela. In questo clima ben studiato da Giacobbe avvenne lo scambio. Il
Midrash ci dice che il gemello minore aveva anche preparato un contratto scritto,
onde evitare future rivendicazioni.
Il passaggio della primogenitura, però, doveva essere sancito dalla benedizione
paterna. L’occasione non tardò ad arrivare. Ormai stanco e cieco, Isacco sentiva
�93
L’idiosincrasia dell’Occidente
che i suoi giorni erano alla fine. Percezione quanto mai sbagliata perché in realtà
vivrà ancora a lungo, ma quanto bastava per chiamare il primogenito e dirgli di
procurarsi della selvaggina per la benedizione della primogenitura. Rebecca, è
anche questa una scena notissima, udite le parole fra il marito e il figlio, chiamerà
Giacobbe per dirgli di camuffarsi da Esaù, mentre lei andava a prendergli uno dei
suoi capretti. È il primo momento in cui vediamo Yaakov vacillare perché ben
sapeva che una cosa è un accordo fra fratelli, un’altra è lo stesso accordo approvato
dai genitori. Per di più la tradizione ci informa quanto Esaù sia stato disposto ad
accettare le privazioni imposte dal suo ruolo solo per amore verso il padre, che
venerava. Come sappiamo, il piano della mamma ebbe buon fine e Giacobbe venne
benedetto al posto del fratello. La grande questione è qui se Isacco fosse
consapevole di impartire la benedizione al figlio più piccolo. Il commento è
unanime nel dire di sì. Molti gli indizi che ce lo fanno pensare. Anzitutto il passo
di Gen. 27, 22, in cui Isacco dice: «La voce è la voce di Giacobbe, ma le mani sono
le mani di Esaù». In secondo luogo vi è la questione dell’odore. Rashi di Troyes
(1040 - 1105), commentatore principe della Torah, dice che Isacco sentì l’odore
del gan Eden, il giardino dell’Eden dove risiedevano Adamo ed Eva. È il testo
stesso ad orientarci in quella direzione: «l’odore di mio figlio è come la fragranza
di un campo che l’Eterno ha benedetto» (Gen. 27, 27). Un odore che certo non può
essere attribuito ad Esaù per come la Torah ha descritto i due fratelli. In ultimo, la
forma della benedizione che Isacco impartisce al figlio. Sempre Rashi dice che si
tratta della benedizione che si attribuisce ai giusti, dove la maledizione profetizzata
a coloro che malediranno viene prima di quella a coloro che benediranno perché
«i giusti incontrano , all’inizio, delle sofferenze e poi, alla fine, godono della pace».
Insomma, Isacco conferma qui la qualità che la tradizione gli attribuisce: la גבורה
(ghevurah), il coraggio. Coraggio di scardinare antiche logiche identitarie, sociali
e politiche. Saputo di aver perso la benedizione, Esaù andrà alla ricerca del fratello
per ucciderlo. Ci si chiede perché Esaù si sia così risentito dal momento che aveva
già ceduto la primogenitura. Ma la risposta l’abbiamo già avuta: una cosa è la
relazione a due, un’altra quella a tre. La benedizione a Giacobbe fu vissuta da lui
come un tradimento insopportabile. Del resto solo un ingenuo poteva pensare di
ridurre la vita a rapporti giuridici. Sembra qui ripetersi lo stesso errore di Abele nei
confronti di Caino. Abele definito «il muto» dalla tradizione, in quanto nel
Capitolo 4 della Genesi, dove è narrata la storia dei primi fratelli, non si trova una
sola sua parola. Nulla ha fatto per lenire l’invidia del fratello nei suoi confronti. E
sarebbe finita allo stesso modo se non fosse stato per l’intervento della madre, la
quale, vista la reazione del figlio maggiore, intimò Giacobbe di riparare da suo
fratello Labano finché la rabbia di suo fratello non fosse scemata.
Nel percorso verso la terra dello zio, Giacobbe si «imbattè nel luogo» (Genesi
28, 11), da molti inteso come il Monte Moriah, per eccellenza luogo della
manifestazione divina. Qui si addormenta e farà il famoso sogno della scala, altra
immagine che si è sedimentata nel nostro immaginario. La scala, con gli angeli che
�94
DAVIDE ASSAEL
salgono e scendono, e con al vertice Dio stesso, è simbolo di comunicazione. È
anche proiezione delle angosce di Giacobbe, che per la prima volta sperimenta il
fallimento dei suoi progetti. Come per rassicurarlo, l’Eterno gli confermerà la
promessa fatta al nonno, aggiungendo, «Io sono con te e ti proteggerò ovunque
andrai» (Genesi 28, 13-15). Il Dio di Israele, pur mantenendo un rapporto
privilegiato con la terra d’origine che decifreremo fra breve, non è una divinità
locale. È un Dio universale, che, come dice la comunicazione stessa si estende a
Oriente come a Occidente.
Appena giunto nella terra dello zio, Giacobbe incontra sua figlia Rachele e se
ne innamora (Genesi 29). Incontrato Labano, la chiede in moglie. Lo zio
acconsentirà, ma pattuirono che, per sposarla, Giacobbe avrebbe dovuto lavorare
per lui sette anni. Così fece, ma al termine Labano, invece di Rachele, gli farà
trovare nel letto nuziale la figlia maggiore Lea. Di fronte allo stupore di Giacobbe,
la risposta dello zio sarà alquanto significativa. Alla domanda del nipote, «Perché
mi hai ingannato?», Labano ribatterà «Non si fa così nel nostro paese, di dar marito
alla minore prima che alla maggiore. Finisci la settimana di questa, e ti daremo
anche l’altra, per il servizio che mi presterai per altri sette anni.» (Genesi 29, 2728). Alla fine Giacobbe rimarrà da Labano 20 anni e per sposare Rachele dovrà
prima prendere in moglie, oltre a Lea, anche la sua serva e quella di Rachele stessa.
Lo zio non rispetterà nessuno dei patti stabiliti e la motivazione sarà sempre quella:
da noi si fa così. Sempre più il patriarca capirà che l’unico modo per realizzare la
profezia divina sarà tornare a casa propria. Del resto, con quale diritto imporre il
proprio modello ad altri? Così, una notte, Giacobbe «mise i figli e le mogli sui
cammelli, portò via il suo bestiame, tutti i beni che aveva acquistato, il bestiame
che aveva messo insieme in Paddan-Aram per tornare da suo padre Isacco in terra
di Canaan» (Genesi 31, 17-18). Quando, tre giorni dopo, Labano lo raggiungerà
per chiedergli conto della fuga notturna, Giacobbe risponderà con parole che
sintetizzano quanto scritto sopra: «In vent’anni che sono stato con te, le tue pecore
e le tue capre non hanno partorito feti morti, né ho mangiato i montoni del tuo
gregge. Non ti ho mai portato animali dilaniati da bestie feroci, rifondevo io il
danno, mi chiedevi conto dei furti commessi sia di giorno che di notte. Mi trovavo
in condizione che di giorno mi consumava il gran caldo, il gelo di notte, e il sonno
se ne andava dai miei occhi. Dei vent’anni che sono stato in casa tua, quattordici ti
ho servito per le tue figlie e sei per il tuo bestiame; tu hai cambiato la mia mercede
dieci volte.» (Genesi 31, 41-42).
La lotta con l’angelo e l’idiosincrasia dell’Occidente
Nella vicenda di Giacobbe ed Esaù, c’è un’altra immagine iconica: la lotta con
l’angelo. Quando si trovava con la sua carovana ormai sulla strada di casa,
Giacobbe si accorge di aver dimenticato qualcosa indietro e deciderà di
riattraversare il fiume Yabbok per prendere questi oggetti apparentemente
insignificanti. Un atto mancato degno del dott. Freud. Arrivato sull’altra riva il sole
era ormai calato, decise allora di pernottare lì. Nella notte arriva un malach, figura
�95
L’idiosincrasia dell’Occidente
di difficile definizione in ambito ebraico perché significa contemporaneamente
angelo e messaggero. Del resto, il pensiero ebraico non è di impronta metafisica,
ma esperienziale. Si può dire che quella angelica sia una funzione che si incarna
nelle vicende quotidiane. In ogni caso, il commento tende ad identificare questa
figura con l’angelo di Esaù perché è col fratello che Giacobbe deve combattere. Al
termine della lotta durata tutta la notte, Giacobbe ebbe la meglio e, proprio per
questo, il malach gli cambierà il nome in «Israele». Tanti i significati attribuiti al
nuovo nome, il più frequente è «Ish roeh El», «Uomo che guarda a Dio», ma è
certo che con questo passaggio si conclude il percorso inaugurato da Abramo.
L’identità biblica è compiuta, anche se si tratterà di saperla tradurre in tutti i suoi
aspetti. È un’identità caratterizzata da una zoppia, in quanto Giacobbe
rimarrà claudicante perché ferito al nervo sciatico. È questa zoppia, questa
imperfezione il grande rimosso dell’Occidente, che l’ha sostituita con
l’immagine dell’eroe greco, tanto tragica quanto esempio di forza e splendore.
Ormai cosciente del torto subito dal fratello, Giacobbe è pronto ad incontrarlo.
Quando Esaù gli correrà incontro per ucciderlo, il gemello minore si chinerà
davanti a lui prostrandosi sette volte, con tutto il valore simbolico che questo
numero assume nella narrazione biblica. I due fratelli si abbracceranno come segno
di riconciliazione. Divideranno la terra ed ognuno potrà badare alla propria
famiglia. La conciliazione fra Giacobbe ed Esaù è il modo in cui
l’universalismo occidentale, rappresentato dall’etica del fratello minore,
assume la consapevolezza del proprio limite: l’essere nato in luogo
particolare. La claudicanza di Giacobbe appare come il segno più tangibile
dell’assunzione di questa consapevolezza. La rimozione occidentale della propria
matrice ebraica significa esattamente la rimozione della Gerusalemme terrestre in
nome di quella celeste.
Ben presto, però, le differenze fra i fratelli riappariranno. Giacobbe, assai più
bravo negli affari rispetto al gemello, vedrà crescere il suo bestiame e le proprie
ricchezze, tanto da rendere difficile la convivenza con Esaù, che si ritirerà sul
monte Seir (Genesi 36, 6). E non è un caso, crediamo, che in ebraico capro
espiatorio si dica proprio Seir. Esaù, con le pulsioni genealogiche, familiari e di
possesso territoriale, che rappresenta in quanto fratello maggiore, è il grande
sacrificato all’universalismo occidentale. È lui la grande idiosincrasia che
l’Occidente non può ammettere perché considerata come un tradimento della sua
identità. Ed è da questa rimozione che nascono i problemi di relazione con l’Altro
che hanno definito il nostro mondo. Dalle crociate, alle battaglie napoleoniche,
fino alle recenti guerre di esportazione della democrazia. Perché trovare un punto
di conciliazione con Esaù significa sì una contraddizione rispetto ad ogni visione
universalistica, ma è anche riconoscere un’origine particolare, che è antidoto
contro ogni volontà di potenza imperialista. Più che rimuovere queste pulsioni
bisognerebbe sublimarle in un progetto pedagogico e politico, che, citando il
sociologo Michael Walzer, potremmo definire un «universalismo concreto»
�96
DAVIDE ASSAEL
(Michael Walzer, Geografia della morale. Democrazia, tradizioni e universalismo,
Edizioni Dedalo, Bari, 1994). Universalismo, come tale, sempre imperfetto,
sempre da ridefinire. Ma il Midrash aveva già detto tutto quando, commentando
l’abbraccio fra i due fratelli, descrive un Esaù intento a mordere l’orecchio di
Giacobbe. Se si parla di Occidente, si parla di una strada sempre aperta, che mai
può trovare una conclusione definitiva. Se non sublimate, queste pulsioni si
riaffacceranno nei momenti propizi, quando il progetto universalistico occidentale
mostrerà delle crepe, favorendo instabilità sociale. La Torah aggiunge un ultimo
particolare, che a noi appare come un monito: se si scorre la genealogia di Esaù
nel Cap. 36 della Genesi, si vede che ad un certo punto compare la figura di
Amalèk, la tribù senza volto che ha un solo compito: l’annientamento del popolo
ebraico. Si dice che sia comparsa solo tre volte nella storia ebraica: appena dopo
l’uscita dall’Egitto, quando i figli di Israele cominciano a mostrare dubbi nei
confronti delle parole di Mosè (Esodo 17, 8), durante la fallita strage raccontata
nella Meghillat Ester, il rotolo che si legge durante la festività di Purim. Infine con
il nazismo. Amalèk è il residuo della rabbia di Esaù e torna per riprendersi la
primogenitura sottratta dai fratelli minori. Torna per risvegliare dal «grande
inganno» ed imporre «la morale dei signori» con «la morale dei servi».
�97
Endoxa – Prospettive sul presente, 5, 25, Maggio 2020, pp. 97-100
I DISCORSI D’ODIO E LE STRATEGIE
ADOTTATE NEL NOSTRO PAESE PER
CONTRASTARLI
GIANPIERO COLETTA
1. Negli ultimi anni si è assistito ad un considerevole aumento dei crimini
d’odio e, di fronte a questa situazione, nell’ottobre del 2019 il Senato della
Repubblica ha approvato una mozione per l’istituzione di una Commissione
straordinaria diretta a contrastare l’intolleranza, il razzismo, l’antisemitismo e le
varie forme di istigazione all’odio e alla violenza.
Con l’approvazione di tale mozione, che ha avuto come prima firmataria la
senatrice Liliana Segre, si è inteso soprattutto arginare la diffusione di quella
particolare tipologia di crimini d’odio costituita dai discorsi d’odio, nella
consapevolezza che gli stessi, pur non essendo sempre perseguibili sul piano
penale, rappresentano in ogni caso un serio pericolo per la convivenza civile.
�98
GIANPIERO COLETTA
Come è noto, in ambito giuridico non esiste una descrizione generalmente
condivisa dei discorsi d’odio. Tuttavia, in base a quanto previso dal Comitato dei
ministri del Consiglio d’Europa nella raccomandazione n. 20 del 1997 ed a quanto
più volte evidenziato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, si può sostenere che
sono certamente discordi d’odio tutti quelli che diffondono, incitano,
promuovono o giustificano il razzismo, la xenofobia, l’antisemitismo e ogni
altra forma di forte avversione basata sull’intolleranza.
Per provare a contrastare in modo efficace la proliferazione dei discorsi in
parola, con la mozione approvata in Senato si è deciso di attribuire alla
Commissione straordinaria numerose ed importanti prerogative.
In particolare, nella mozione si è stabilito che i venticinque membri della
Commissione hanno il compito di studiare le varie manifestazioni d’odio che
hanno come destinatari singoli individui o intere comunità e devono anche
raccogliere, ordinare e rendere pubblici le normative vigenti sui diversi crimini
d’odio, i risultati delle rilevazioni statistiche su tali crimini e quelli delle ricerche
scientifiche effettuate sulle medesime condotte.
Occorre, poi, ricordare che il Senato ha attribuito ai commissari pure il
compito di controllare la corretta attuazione delle norme volte ad arginare la
diffusione delle manifestazioni d’odio ed ha riconosciuto loro la possibilità di
formulare proposte dirette a modificare la legislazione vigente, anche allo scopo di
renderla più coerente con la normativa dell’Unione europea e con le previsioni
contenute nelle Convenzioni internazionali in materia di prevenzione e lotta contro
ogni forma d’intolleranza, razzismo ed antisemitismo.
Non vi è dubbio, allora, che, con l’istituzione della Commissione
straordinaria, si è deciso di prendere sul serio il problema del considerevole
aumento dei discorsi d’odio e che, con l’attribuzione ai commissari di numerose
ed importanti prerogative, ci si è resi conto del fatto che, per cercare di risolvere il
problema in questione, bisogna studiarne in modo approfondito le caratteristiche,
comprenderne l’effettiva dimensione e sollecitare l’adozione di tutte le misure
idonee al raggiungimento dell’obiettivo.
2. È opinione diffusa che, nel prossimo futuro, la Commissione straordinaria
fortemente voluta da Liliana Segre avrà un ruolo centrale nel provare ad arginare
la proliferazione dei discorsi d’odio. Va, tuttavia, segnalato che, ben prima
dell’istituzione di tale Commissione, il nostro legislatore ha cercato di contrastare
il fenomeno in parola, facendo ricorso al diritto penale.
Come sappiamo, il principale intervento legislativo con il quale si è deciso di
sanzionare penalmente i diversi discorsi d’odio è individuabile nella legge n. 654
del 1975, che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione internazionale di
New York sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale. Non
sfugge, infatti, che l’articolo 3 di tale legge ha introdotto nell’ordinamento quattro
�99
I discorsi d’odio e le strategie adottate nel nostro paese per contrastarli
distinte figure di reato caratterizzate da condotte discriminatorie nei confronti di
soggetti appartenenti ad un gruppo diverso dal proprio e che, nella sua versione più
recente, ha considerato perseguibile penalmente anche chi propaganda odio
razziale, etnico, nazionale o religioso e chi motiva la sua forte avversione nei
confronti di singoli individui o di intere comunità con la negazione della Shoah,
dei crimini di guerra e di quelli contro l’umanità.
A ben guardare, la scelta di provare ad arginare la diffusione dei discorsi
d’odio ricorrendo allo strumento penale è stata compiuta anche da diversi altri
Paesi europei ed è sicuramente in linea con le numerose disposizioni di diritto
internazionale che limitano la libertà di manifestazione del pensiero per contrastare
ogni forma di discriminazione. Occorre, però, sottolineare che, con tale scelta, è
stata introdotta nell’ordinamento una previsione normativa che diversi studiosi
hanno considerato non rispettosa dell’articolo 21 della Costituzione.
Come è noto, la disposizione costituzionale in parola garantisce ad ogni
individuo la libertà di manifestazione del pensiero e prevede, come unico limite
all’esercizio di tale libertà, il rispetto del buon costume. Sembrerebbe, quindi, che
l’articolo 3 della legge n. 654 - i cui contenuti sono stati, peraltro, trasposti
all’interno del codice penale nel 2018 - non sia coerente con la Costituzione,
perché l’articolo del testo fondamentale che disciplina la manifestazione del
pensiero non giustifica in alcun modo il divieto di propagandare idee d’odio.
Bisogna, tuttavia, ricordare che, accanto a quello del buon costume, esistono
limiti ulteriori all’esercizio della libertà di espressione, che trovano fondamento in
altri interessi costituzionalmente protetti. È evidente, infatti, che il legislatore
ordinario può limitare la manifestazione del pensiero se, con un’operazione di
questo tipo, va a tutelare altri diritti costituzionali senza giungere alla totale
negazione della libertà in questione.
Si può, quindi, affermare che la disposizione che sanziona penalmente la
diffusione di discorsi d’odio potrebbe essere legittima se si rivelasse strumentale
alla ragionevole protezione di altri beni costituzionalmente rilevanti.
In realtà, la disposizione in esame non è mai stata oggetto di scrutinio da parte
della Corte Costituzionale, ma in più di un’occasione la Corte di Cassazione ha
fatto presente che la stessa limita la libertà di espressione in modo corretto perché,
sanzionando penalmente la propaganda dell’odio, va a tutelare il bene giuridico
costituzionale della dignità umana.
Occorre, però, considerare che nella legge n. 654 la dignità delle persone
offese da espressioni d’odio non è stata protetta con una limitazione della libertà
di manifestazione del pensiero, ma con il suo totale azzeramento. In altre parole, il
nostro legislatore non ha assicurato un equo contemperamento tra interessi di
rilievo costituzionale e ha determinato un vero e proprio “azzeramento” della
libertà di espressione.
�100
GIANPIERO COLETTA
Pertanto, la disposizione che impone ai giudici di punire quanti propagandano
odio risulta essere di dubbia legittimità, perché va a comprimere la libertà di
manifestazione del pensiero in misura eccessiva.
È auspicabile, allora, un intervento legislativo che modifichi la normativa in
vigore e non vieti più in modo assoluto l’esercizio della libertà di espressione a
coloro che diffondono idee d’odio, prevedendo, magari, di sanzionarli penalmente
solo se la pubblica manifestazione delle loro idee sia diretta a scatenare
comportamenti violenti o discriminatori. Non vi è dubbio, infatti, che, con un
intervento di questo tipo, la nostra legislazione diventerebbe rispettosa del dettato
costituzionale e l’autorità giudiziaria potrebbe legittimamente contrastare la
diffusione dei discorsi d’odio insieme alla Commissione straordinaria.
Photo by Markus Spiske on Unsplash
�101
Endoxa – Prospettive sul presente, 5, 25, Maggio 2020, pp. 101-105
QUESTA NON È UNA GUERRA
PAOLO CASCAVILLA
L’uso di metafore di guerra è frequente. In modo particolare lo si trova per
sintetizzare in modo efficace e comprensibile un percorso complesso: guerra al
cancro, alla criminalità, alla droga... Ma mai si era parlato in modo così intenso ed
esteso di guerra per descrivere una grave e globale emergenza sanitaria. Vi è chi
ritiene utile tale riferimento in questa pandemia, con un nemico invisibile e un
�102
PAOLO CASCAVILLA
pericolo che non si percepisce immediatamente. Il richiamo alla guerra sembra
necessario per far accettare al popolo scelte dolorose e sacrifici e per sviluppare
uno spirito di collaborazione e di obbedienza.
I popoli hanno identità nazionali che si rafforzano contro un nemico comune. È
possibile oggi far capire che è difficile e incerta una vittoria dei singoli stati sulla
pandemia, mentre va dedicato ogni sforzo per costruire una collaborazione e una
cooperazione internazionale? Metafore e parole di guerra possono aiutare in questa
direzione?
Bush nel 2005 e Obama nel 2014 intervengono al National Institutes of Health
sulle future pandemie. Esprimono preoccupazione per quelle nate da virus
provenienti dagli uccelli (già sperimentate), che si affacceranno di nuovo nel giro
di 5 o 10 anni. Di qui la necessità di elaborare strategie per prevenire e isolare i
focolai, accelerare la produzione di vaccini, stabilire forme di cooperazione
internazionale. Ma soprattutto, per fronteggiare una pandemia, ci vogliono
cittadini informati: sono essi che devono proteggere se stessi e gli altri, essi
possono interrompere la diffusione del virus.
Nessuno dei due ex presidenti parla di guerra. Entrambi esprimono in modo
articolato le azioni di contrasto alla pandemia, le strategie future, la partecipazione
dei cittadini. Non i tweet di Trump, che si è definito il presidente dei tempi di
guerra, e paragona la pandemia a Pearl Harbor o all’11 settembre. I giornali
statunitensi fanno i conti e dicono che alla fine i morti supereranno quelli di Corea,
Vietnam, Afghanistan.
Macron (16 marzo 2020) ripete più volte “siamo in guerra” con un “nemico
invisibile, inafferrabile, che avanza e richiede la mobilitazione generale”. Non così
Angela Merkel (18 marzo 2020). Oltre a non pronunciare mai la parola guerra,
parla di “una situazione dalla quale imparare continuamente”, di “consapevolezza
condivisa”, di capacità di agire “con il cuore e la ragione”.
In Italia è un coro diffuso, su giornali e televisione, con metafore belliche e
visioni collegate alla guerra (prima linea, trincea, eroi, armi, munizioni, economia
di guerra, chiamata alle armi…). Il riferimento inconscio è alla prima guerra
mondiale, lì troviamo le immagini ricorrenti: trincee, armi antiquate, logistica
carente, vulnerabilità (“Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie”), conquiste e
perdite, attesa e logoramento…
Tutto è cominciato con “Io resto a casa”. Solo stando a casa difendiamo gli eroi,
che combattono in prima linea.
Della guerra vi sono inizialmente le file ai mercati, gli scaffali vuoti ed anche le
prime rivolte per il pane. Guerra al nemico invisibile, eppure la sua immagine è
ovunque. È inafferrabile. Imprevedibile. Non si conoscono le sue mosse. Qualcosa
di analogo ci viene descritto nella guerra del Vietnam: i vietcong invisibili, nelle
foreste, nelle paludi, e gli americani per stanarli sono costretti a usare il napalm. In
Usa, dopo le prime comunicazioni presidenziali, molti corrono ad armarsi.
�103
Questa non è una guerra+
In Italia arriva il commissario Arcuri. Nella prima conferenza stampa delinea
la sua strategia. Siamo in guerra e non abbiamo armi e munizioni, il nostro esercito
rischia di non farcela. Stiamo perdendo anche la guerra diplomatica. Ci stanno
rubando in casa mascherine e attrezzature. E allora? Acquistare tutto quello che è
possibile, bloccare l’export della produzione italiana, riconvertire industrie per la
produzione di materiale utile a questa guerra. A Milano il coronavirus è peggio che
i bombardamenti dell’ultimo conflitto mondiale; in Lombardia i morti sono 5 volte
più di allora. Interviene l’esercito, che monta ospedali e offre personale. Si deve
vincere il virus. Il paese in guerra è sorretto da un rinnovato orgoglio patriottico:
si ripete spesso che siamo i primi (a chiudere i voli dalla Cina, a creare le zone
rosse), tutti ci imitano. C’è un modello Italia. I cittadini devono “stare dentro”.
L’Italia lo richiede e dice “grazie”. Tutta la pubblicità si adegua. Conte con un
tweet sintetizza: “60 milioni di cittadini lottano insieme per sconfiggere questo
nemico invisibile. Sventoliamo orgogliosi il nostro tricolore. Intoniamo fieri il
nostro inno nazionale. Uniti. Responsabili. Coraggiosi”.
Gli operatori sanitari in prima linea. Applausi dai balconi, davanti agli ospedali.
Nonostante dicano: “Non siamo eroi, dateci solo gli strumenti necessari”, eroi sono
definiti; e il termine deborda, non solo operatori sanitari, ma protezione civile,
forze armate, altri settori. Pure i funzionari della Pubblica amministrazione sono
sollecitati dalla Coldiretti a divenire essi stessi eroi per accelerare le pratiche
burocratiche.
Ogni sera il bollettino di guerra. Ci obbliga a essere obbedienti, silenziosi, senza
alternative. Abbiamo smarrito quel comportamento che ci porta a rispettare
l’autorità, ma anche a parlare, a dire… All’inizio muoiono gli anziani, tutti con
patologie pregresse, sottolineano i cronisti, poi con un gesto della mano fanno
intendere che sarebbero morti comunque. La lunga cronaca di morte è accettata
con fatalismo. Qualche lieve critica per le attrezzature mancanti.
Nessuno chiede come si “sta dentro”. I bambini, gli anziani, i sofferenti psichici,
gli autistici… Artisti e vip insegnano come stare dentro: leggere, scrivere, suonare,
mettere in ordine… “se proprio non sapete far niente prendete una pentola e
suonatela”. C’è chi canta, intrattiene il popolo, sulla falsariga dei divi di
Hollywood che vanno a rincuorare le truppe al fronte. Si coltivano, nei giardini e
sui balconi, verdure e piante aromatiche. Il governo nei tanti interventi non parla
mai dei corpi intermedi (associazioni, vicinato…) che occupano man mano un
posto importante ed aiutano, informano, incoraggiano…
La guerra diventa geopolitica e si riconoscono nemici e alleati: “Ci ricorderemo
di quelli che non ci aiutano”. Conte chiede i coronabond e apre un fronte contro
L’Europa: “Noi stiamo scrivendo la storia… e la storia ci darà ragione”. Il
linguaggio bellico deborda su un altro fronte: gli investimenti economici: “Per la
cura Italia una poderosa potenza di fuoco. Un bazooka”. Quasi tutti i giornali
raffigurano il bazooka.
�104
PAOLO CASCAVILLA
Intanto gli scienziati e i ricercatori fin dall’inizio occupano la scena. Discutono,
dicono di non sapere, se non sanno. E anche se la televisione chiede loro di fare gli
indovini, si defilano. Vediamo dall’interno come si muovono i ricercatori,
alternano certezze e dubbi, ascoltano, verificano, non nascondono di muoversi in
un territorio inesplorato. Litigano e collaborano. La scienza non ha la pretesa di
assolutezza, si mette in discussione, aperta a nuove ipotesi. Un laboratorio a cielo
aperto. Un apprendimento collettivo. Impariamo che contano le competenze,
l’esperienza passata, gli studi fatti, tenere la mente aperta… Osservare, riflettere,
sperimentare. È il metodo galileiano
22 giugno 1633. Galilei è per l’ultima volta davanti al Tribunale
dell’Inquisizione. Gli amici lo aspettano fiduciosi. Poi le campane annunciano
l’abiura. Galilei (nella versione di Brecht) entra nella stanza e un suo discepolo
disilluso e amareggiato: “Sventurata quella terra che non ha eroi”. Lo scienziato è
prostrato, stanco, contestato. Poi in tono sommesso: “No. Sventurata la terra che
ha bisogno di eroi”.
Come in guerra non tutto viene detto, poche le foto e clandestine. Il bisogno di
verità viene soddisfatto riempiendo tutta la tv di coronavirus. Le stesse notizie
ripetute dieci, venti volte. Una pandemia e un contagio di informazioni, senza
ampliamenti e approfondimenti. Tutta l’attenzione è concentrata sull’Italia e poco
su atri paesi. Affiora la stanchezza, l’angoscia, il panico. La paura degli altri, del
futuro non si trasforma in premura per gli altri, per il futuro. Si sta in silenzio e in
attesa. Il dolore è dentro, soffocato. Ma talvolta esce fuori (una chiacchierata con i
vicini sul balcone, una telefonata, una pagina letta, il sole primaverile…), e da esso
si riesce ad imparare qualcosa e si provano a definire le responsabilità proprie e di
altri, esprimere dubbi, fare domande…
E i malati? Sono chiamati a lottare. Le prime immagini di chi ce la fa, di quelli
che hanno sconfitto il virus, intorno applausi, pugni stretti, segni di vittoria, che
sugli altri non hanno effetto. Preferirebbero parole tenui, non essere considerati
soldati. Depressi, abbandonati, senza forze cercano volti familiari. Gli inviti a
lottare e a resistere aumentano la sofferenza. Lentamente escono le parole dei
necrologi, prima due pagine poi quattro, otto, infine decine. Sono vietati i funerali,
le bare sono portate fuori di notte.
Come sarà dopo? Progetti, impegni, doveri… usciremo e festeggeremo, verrà
la primavera, la festa degli abbracci…. Si ha paura della distanza. È la cosa più
difficile da imparare, l’uso di parole nuove, la cura dello sguardo e dei gesti. I
bambini si trovano meglio, non si danno la mano, né si abbracciano, né si
scambiano baci. Una bambina sorridendo saluta in modo discreto con la mano, la
nonna si intravede lontano, dietro una finestra.
E noi cosa impariamo? Qui la scena è tutta del Papa, quotidianamente da S.
Marta richiama la vicinanza creativa, la semplicità dei gesti, il rispetto del creato,
l’amore verso chi soffre… dice ai preti di non essere come don Abbondio.
�105
Questa non è una guerra+
Bisogno di verità e di parole esatte. Ci aiutano a capire meglio. Parole come
emergenza, tragedia collettiva, agenti patogeni, spillover, invasione del corpo
sociale… Le metafore aiutano a descrivere l’ignoto con il noto, una realtà diversa
con ciò che conosciamo. Ci riescono? O non creano piuttosto una nuova realtà?
Parlare di Stato di guerra, unione sacra tra governanti e governati, concordia
nazionale, eroismo non aiuta a ragionare di cura, inclusione, condivisione… Il
linguaggio bellico non è adeguato a descrivere quello che stiamo vivendo. È più
facile, più emotivo. Acuisce la separatezza, la solitudine, invece di creare
solidarietà ed empatia.
Le parole di guerra modificano gesti e azioni. In guerra niente è considerato
eccessivo. Nessuna parola o espressione è fuori posto. Nessun sacrificio è troppo
grande. È il linguaggio di guerra a spingere tanti a nascondersi e a morire a casa.
Nelle case di riposo si muore di Covid e di assistenza che non c’è. A Milano,
nel cimitero, vi è un’area con sepolture che nessuno piange. Altrove, nel mondo,
le fosse comuni.
Su “L’eco di Bergamo” i figli, i parenti scrivono piccole memorie: il distacco
momentaneo, l’attesa in quarantena, il rimpianto di non essere stati vicini, non
avere dato l’ultimo saluto. Qualcuno ha ricevuto i disegni dei nipoti appesi dagli
infermieri sulla sponda del letto.
Una madre positiva al virus non è andata in ospedale, è stata in casa vicino al
figlio con sindrome autistica. I vecchi sono morti soli. Se fossero stati colpiti i
bambini avremmo sopportato che le madri si fossero tenute lontano per paura del
contagio?
Corpi senza vestizione. La chiesa non ha reclamato quel momento per cercare
di dare un senso a qualcosa di inspiegabile. Un piccolo spazio in chiesa, pochi
momenti per raccogliere la nostra vulnerabilità, fraternità, comunanza dei destini.
Non si sa né come né quando l’inno nazionale ha lasciato il posto a Bella ciao.
Pare siano stati prima i vigili del fuoco inglesi. Non più inni nazionali, ma ovunque
un canto d’amore e di libertà. Alcuni speravano di celebrare la memoria della
Resistenza con la liberazione dal virus. Ma Bella Ciao, “inno europeo” di
solidarietà e coraggio, ha finito per adombrare l’unità nazionale e patriottica.
Photo by Daniel Tafjord on Unsplash
�106
�107
Endoxa – Prospettive sul presente, 5, 25, Maggio 2020, pp. 107-110
MA QUALE IDIOSINCRASIA: CHISSÀ
COME SI DIVERTIVANO!
MICHELANGELO DE BONIS
“Margie lo scrisse perfino nel suo diario, quella sera. Sulla pagina che
portava la data 17 maggio 2157, scrisse: ‘Oggi Tommy ha trovato un vero
libro!’”
La vita è imprevedibile. Mentre pensavo ad una idea per l’articolo mi è capitato
di rileggere un racconto che Asimov scrisse nel 1954, Chissà come si divertivano!
Un racconto schietto, immediato, tre pagine in cui si parla di didattica a distanza
�108
MICHELANGELO DE BONIS
e della didattica nel futuro, proprio in un periodo in cui la didattica a distanza si è
impadronita della vita di milioni di alunni, docenti e genitori.
È paradossale leggere un racconto in cui Margie e suo fratello Tommy trovano
un libro, addirittura un libro vero!, che parla di scuola in cui tutte le storie e i
racconti sono stampati su carta. C’era stato un periodo in cui su pagine gialle e
fruscianti le parole erano ferme, non si muovevano e se si ritornava indietro alla
pagina precedente si vedevano le stesse identiche di prima.
Una realtà che oggi come società siamo chiamati a realizzare. Nel racconto ci
sono degli spunti di come verremo visti nel futuro e di come ci giudicheranno per
come lasceremo questo periodo per scrivere il successivo.
“Questo è un tipo di scuola molto antico, come l’avevano centinaia e
centinaia di anni fa.”
Non passeranno centinaia di anni, sarà invece un processo molto più veloce
di quanto potessimo immaginare. La didattica a distanza è arrivata dal futuro
e si è palesata, improvvisamente, e noi tutti siamo stati travolti da questo uragano.
Un vento forte che ha scosso la vita degli attori principali: alunni, docenti e
genitori. Certo non è un caso dire che il futuro ci viene incontro (già altre volte ho
citato Ferdinando Menga con il suo monito nel suo volume Lo scandalo del
futuro. Per una giustizia intergenerazionale) e che oggi più che mai abbiamo
l’obbligo di ripensare il futuro.
“Certo che avevano un maestro, ma non era un maestro regolare. Era un
uomo.”
I due fratelli si meravigliano perché il docente era un essere umano, e non un
maestro digitale. Ma chi se lo sarebbe mai aspettato: un essere umano! Un uomo
non avrebbe avuto la possibilità di essere competente in tutti gli argomenti che la
scuola del futuro deve insegnare.
E come dare torto a Margie e Tommy. Ma allora, nella scuola di oggi, il ruolo
dei docenti così come lo conosciamo ha le ore contate?
Inutile dire che siamo una società in divenire. Il lavoro del futuro è una
incognita, non c’è modo di sapere quale sarà. Certo avremo modo di ipotizzare gli
ambiti di sviluppo: robotica, intelligenza artificiale, game theory, informatica
in generale, solo per restare in tema tecnologico. Ma, in questi ambiti, quale sarà
lo scopo e il lavoro vero e proprio? Nessuno con certezza può dirlo. Il trend che si
�109
Ma quale idiosincrasia: chissà come si divertivano!
segue per prevenire, e forse minimizzare, le incognite dal futuro è insegnare agli
studenti il learning to learn, l’imparare a imparare. Qualunque cosa gli uomini di
domani faranno avrà a che fare con nuove tecnologie, nuovi strumenti, nuove idee
e un mondo rinnovato rispetto all’attuale. Perché dovranno loro stessi essere in
grado di imparare a gestire le sfide per il futuro dell’umanità.
Quegli uomini avranno necessità di basi solide su cui poggiarsi e il nostro oggi,
il nostro presente, sarà le loro radici. Queste basi solide della cultura sono le
foundation delle singole discipline. Sono la base di qualsiasi trasformazione a cui
assisteremo nei prossimi anni. Un maestro umano difficilmente potrà essere al
passo nella sua carriera scolastica con le tecnologie emergenti e con le
trasformazioni reali del futuro. È plausibile, direi umano, che molti possano avere
delle idiosincrasie a riguardo. La tecnologia ha schiacciato e spazzato via le realtà
di moltissimi maestri che non erano pronti a scontrarsi con il futuro già oggi. Ma
questo non li ha spezzati, il loro ruolo resta vitale per i propri studenti. Moltissimi
hanno messo da parte la loro fobia tecnologica e hanno raccolto la sfida. Cosa
trasferiscono ai propri studenti? Le foundation. Le fondamenta, le basi e radici del
nostro futuro.
Margie e Tommy diranno: “Un uomo? Come faceva un uomo a fare il
maestro? Un uomo non può saperne quanto un maestro.” E noi nel passato
saremo in grado di fornire a loro delle risposte adeguate?
“E imparavano tutti la stessa cosa?”
Siamo tutti uguali? Ci insegnano le stesse cose? Tutti impariamo la stessa cosa?
Insegnare a studiare e cavarsela da soli, in modo indipendente. Ecco cosa
ognuno di noi deve imparare in modo personale. Gli alunni devono avere delle
caratteristiche nel loro DNA, un approccio alla didattica di tipo sprint. In poco
tempo devono essere in grado, sfruttando la tecnologia e non demonizzandola, di
acquisire nuovi metodi e nuovi punti di vista per un approccio ai problemi
pluridisciplinare e in modo da poter collegare in modo nuovo elementi di ambiti
diversi. Pensiamo alla macchina a guida autonoma, non ha solo problemi di tipo
tecnico (la programmazione del veicolo) ma anche problemi morali ed etici. Non
è quindi la personalizzazione delle attività didattiche. È l’approccio personale alla
risoluzione di problemi che mettono insieme aspetti diversi della vita, proprio
come la figura retorica dell’antitesi: accostare in un’unica soluzione elementi
opposti. Non è imparare la stessa cosa… è imparare!
�110
MICHELANGELO DE BONIS
“Io non ce lo vorrei un estraneo in casa mia, a insegnarmi.”
È la parte più sconvolgente, il capovolgimento culturale, forse la parte più
difficile da ripensare, non andare nello stesso edificio, nello stesso luogo fisico per
incontrare gli altri e apprendere con gli altri, dagli altri. Ma essere noi a casa a
ricevere il maestro e la relativa didattica. Culturalmente non siamo pronti, forse è
l’aspetto peggiore del momento che stiamo vivendo, non siamo in grado di ricevere
costantemente un’azione di questo tipo. Qui abbiamo una idiosincrasia vera.
Asimov conclude il suo racconto lasciando a noi uomini del futuro una lezione
di vita.
“Lo schermo era illuminato e stava dicendo – Oggi la lezione di aritmetica è
sull’addizione delle frazioni proprie. Prego inserire il compito di ieri nell’apposita
fessura.
Margie obbedì con un sospiro. Stava pensando alle vecchie scuole che c’erano
quando il nonno di suo nonno era bambino. Ci andavano i ragazzi di tutto il
vicinato, ridevano e vociavano nel cortile, sedevano insieme in classe, tornavano
a casa insieme alla fine della giornata. Imparavano le stesse cose, così potevano
darsi una mano a fare i compiti e parlare di quello che avevano da studiare. E i
maestri erano persone...
L’insegnante meccanico stava facendo lampeggiare sullo schermo: – Quando
addizioniamo le frazioni 1/2 + 1/4...
Margie stava pensando ai bambini di quei tempi, e a come dovevano amare la
scuola. Chissà come si divertivano!, pensò.”
Nel progettare il futuro ricordiamoci di Margie e Tommy, insegniamo ai nostri
figli, ai nostri alunni, a vivere la loro didattica e la loro scuola di oggi, come
dovrebbero amarla e non odiarla e come si dovrebbero divertire e non annoiare!
�111
Endoxa – Prospettive sul presente, 5, 25, Maggio 2020, pp. 111-116
RELAZIONI REPULSIVE: LEGGE,
NATURA E MUSICA IN UN’OPERA
BUFFA DI ROUSSEAU
PIER GIUSEPPE PUGGIONI
1. Il Rousseau compositore e le sue ‘idiosincrasie’ – Ogni tanto, quando ci
accostiamo alla storia della letteratura, potremmo chiederci quanta parte di ciò che
i grandi autori hanno consegnato ai posteri – o, meglio, di quello che i posteri
hanno raccolto da loro – corrisponda alle aspirazioni che tali autori avevano in vita.
Molto spesso, infatti, si celebrano importanti intellettuali, attribuendo ad alcune
loro opere un valore che essi, magari, avrebbero desiderato per altre.
La figura del grande Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), in effetti, corrisponde
in larga misura a questa descrizione, dal momento che, se quasi tutti ne conoscono
il genio filosofico e letterario, non tutti sanno della sua passione per la musica e
delle sue ambizioni di compositore. Non è un caso, d’altronde, che nelle
Confessioni il riferimento alla propria esperienza compositiva – e in particolare ad
un lavoro che vedremo qui – compaia con frequenza quasi maggiore rispetto alle
opere che lo hanno reso, dopo la sua morte, il filosofo della Rivoluzione francese.
�112
PIER GIUSEPPE PUGGIONI
La dedizione di Rousseau alla musica, in realtà, non sorprende più di tanto, in
quanto molti dei suoi contemporanei (intellettuali di spicco quali erano gli
enciclopedisti) lasciarono contributi e studi su teoria e pratica musicale pur senza
essere musicisti di professione. A suscitare un potenziale interesse è, piuttosto,
l’opportunità che abbiamo di leggere il fattore musicale all’interno del pensiero
rousseauiano, aiutandoci, in particolare, con un lavoro operistico che l’autore ebbe
molto a cuore. Nell’Indovino del villaggio (Le devin du village), di cui Rousseau
scrisse testo e musica, si possono osservare diversi aspetti della sua riflessione
filosofica, tradotti, da una parte, nella poesia del libretto e, dall’altra, in un
particolare approccio tecnico alla composizione.
Ora, prima di cominciare, è opportuno – come si suole dire – ‘mettere le mani
avanti’. Chi scrive non è, infatti, uno storico della musica, bensì uno studioso di
filosofia del diritto che, per qualche misteriosa e trascendente circostanza, si trova
a convivere con un viscerale attaccamento alla musica ed una modesta competenza
in materia. Non potrà avere luogo, dunque, una minuziosa analisi musicologica,
ma sarà importante fare riferimento, di volta in volta, ad alcuni temi e concetti
musicali di un certo rilievo, onde comprendere, da un lato, il modo in cui Rousseau
traduce il proprio pensiero nella partitura, scoprendo, dall’altro, che questo
esercizio musicale ci permette di rimarcare alcuni aspetti – forse un po’
sottovalutati – della riflessione politica dell’autore.
Attraverso il libretto e lo spartito del Devin, cercherò di osservare, in modo
particolare, il rapporto tra natura e civiltà, quello tra felicità e legge, nonché la
distinzione fra le relazioni umane proprie dello stato primitivo e quelle che, invece,
l’uomo instaura nella società civile. Sembra, infatti, che la famosa
caratterizzazione dell’uomo rousseauiano provocasse nei suoi lettori una sorta di
intima repulsione – o, addirittura, di ‘idiosincrasia’ – verso la società cetuale
d’Ancien Régime, tanto far dire a Voltaire che, a leggere i Discorsi, veniva voglia
«di camminare a quattro zampe» (Lettera del 30 agosto 1755). Il significato di una
simile repulsione, tuttavia, va indagato con una certa attenzione, per non
fraintendere il senso e – per certi versi – lo ‘scopo’ che potrebbe rivelarsi
adombrato in esso. Ai fini di questo discorso, il lavoro musicale di Rousseau ci dà
un grande aiuto, poiché sembra avallare una lettura per cui, nella sua raffigurazione
dello stato di natura, l’uomo non sarebbe in realtà completamente isolato, ma
farebbe esperienza di alcuni contesti relazionali, che a differenza delle relazioni
«civili» hanno qualcosa di ‘buono’.
2. L’indovino del villaggio: una pedagogia delle opposizioni – L’opera di cui
parliamo rappresenta il miglior prodotto dell’esperienza compositiva di Rousseau,
il quale in effetti se ne mostra assai orgoglioso. Tuttavia non si tratta, come
anticipato, del suo unico lavoro musicale. A precederlo sono infatti alcune
composizioni, sacre e profane, che sembrano dare del filosofo ginevrino
un’impressione di relativa mediocrità. Non a caso, egli racconta che, al momento
�113
Relazioni repulsive: legge, natura e musica in un’opera buffa di Rousseau
della presentazione dell’Indovino all’Opéra, nel 1752, era tutt’altro che ottimista
nei riguardi della propria musica, visto «l’insuccesso delle Muse galanti» (opera
composta circa una decina d’anni prima). D’altronde, trattandosi «di un genere del
tutto nuovo, al quale le orecchie non erano assuefatte» (Conf., VIII, 1), l’autore
non si stupì del disprezzo ricevuto da musicisti del calibro di Rameau. Pare,
tuttavia, che il pubblico nobiliare apprezzasse il lavoro, tanto che lo stesso re di
Francia, dopo averlo ascoltato, non smetteva di cantare, «con la voce più stonata
del suo regno», il tema e le parole della prima aria (VIII, 2).
Prima di analizzare vari aspetti interessanti di questo «intermezzo buffo»,
conviene fare una breve ricognizione della trama, a cui, peraltro, Mozart si ispirerà
per la scrittura di Bastien und Bastienne. Ambientata in un villaggio di campagna
nei pressi di una corte signorile, la vicenda si svolge in un unico atto e gravita
intorno a tre ruoli principali: la pastorella Colette, interpretata da un soprano;
l’indovino del villaggio, un simpatico basso particolarmente autorevole nella
piccola comunità; il pastore Colin, il quale, da bravo tenore, decide di divenire il
cicisbeo della Dama del Castello, spezzando il cuore dell’amante Colette.
Quest’ultima, in preda alla disperazione, viene aiutata dall’indovino a recuperare
le attenzioni dell’amato, il quale, forte del proprio sentimento nei riguardi della
pastorella, rinuncia allo sfarzo della vita di corte e decide di unirsi a Colette in un
«dolce matrimonio» (Devin, sc. VI, duetto).
All’interno di quest’impalcatura, si muovono diversi sentimenti e desideri, ai
quali l’autore associa differenti reazioni emotive. In un certo senso, proprio
l’accostamento delle reazioni ai desideri dei personaggi è il vero protagonista
dell’opera, in cui emergono, attraverso una serie di opposizioni, alcuni accenti
filosofico-politici tipicamente rousseauiani. Ciò si vede benissimo fin dal primo
verso del libretto, che apre l’aria di Colette: «J’ai perdu tout mon bonheur», che
sembra più plausibile tradurre come ‘perdita della felicità’, piuttosto che del mero
‘buonumore’. La giovane pastorella si trovava, dunque, in una condizione felice,
finché il suo amante – come suggerisce l’indovino – non ha sviluppato la ‘vanità’
(vanité) che l’ha condotto al tradimento. Questa vanità è dovuta, a sua volta, al
fatto che la Dama – personaggio di cui si parla, ma che rimane fuori scena – lo
costringe a vestirsi con sfarzo ed eleganza (il verbo è «se parer», che
evidentemente si lega alla parure: Devin, sc. II). Al sentimento della vanità,
l’indovino oppone l’«amore» che unisce i due protagonisti in modo spontaneo e,
pertanto, sincero, preservando in essi la felicità.
Dal lamento di Colette, traspare l’idea per cui un’altra possibile sorgente della
‘vanità’ risiederebbe nei «discorsi delle donne di città». Così, Rousseau riprende
un’altra celebre opposizione – quella tra campagna e città – che però egli articola
in modo parzialmente autonomo rispetto alla generalità delle opere di
ambientazione cortese. Per il filosofo ginevrino, infatti, questi contesti generano
non tanto «vizi» o «virtù», quanto sentimenti più o meno buoni a seconda della
loro maggiore o minore conformità a natura. Sappiamo, d’altra parte, che la
�114
PIER GIUSEPPE PUGGIONI
«felicità» ha un ruolo centrale nei due celebri Discorsi, nei quali il filosofo dice,
per un verso, che il progresso delle scienze e delle arti nulla apporta «alla nostra
vera felicità», andando semmai a detrimento dei costumi e del gusto (Discorso
sulle scienze e le arti, 1750, II), e sottolinea, per altro verso, come l’uscita dallo
stato primitivo, che nasce dall’istituzione arbitraria della proprietà privata, abbia
prodotto «composti funesti alla felicità e all’innocenza» (Discorso sull’origine
della disuguaglianza, 1754, II).
Lo stesso Colin si rende conto di aver perduto «dolci momenti» (Devin, sc. V,
air), non ascoltando i propri sentimenti per Colette e perseguendo piaceri vani ed
artificiali, come «castelli, grandezza e ricchezza», tutti ‘valori’ che presuppongono
la società civile ed un sistema di appartenenza ‘privata’ della ricchezza materiale e
della stima altrui. Egli saluta questi amori fittizi con un commosso «adieu»,
intonando in minore la prima parte della sua aria, con un tema cantabile che viene
poi ripreso dall’orchestra durante la ‘pantomima’ dell’ultima scena, all’ingresso
del signore del castello: forse, qui, l’autore vuole ricordare allo spettatore che le
asimmetriche relazioni di potere, tipiche della civiltà, non sono cosa di cui ci si
liberi facilmente. Ciò nondimeno, Rousseau insiste sul gioco di opposizioni,
sottolineando come neanche il ‘potere dei signori’ («de seigneurs d’importance /
… [la] puissance», ibid.) procuri all’uomo la felicità.
Nell’ottava scena, infine, l’indovino rende ancor più esplicito il divario fra il
contesto della città (ville), in cui prevale la ‘cortesia’ (amabilité), e quello del
villaggio, che ospita l’«amore», termine con cui si richiama ogni sentimento
innocente conforme alla «semplice natura» (sc. VIII, stanze I-II). Nella seconda
stanza del brano finale, ritorna il termine «parure» (gli ‘ornamenti’) – impiegato
in diverse parti del testo –, stavolta in evidente contrapposizione alla ‘natura’ («ici
de la simple nature / … en d’autres lieux, de la parure»). Tale sostantivo serve, in
generale, a richiamare i costumi corrotti dell’uomo ‘incivilito’ che, attraverso le
«raffinatezze della mollezza e del lusso» (Lettera ai signori della Repubblica di
Ginevra, premessa al Secondo discorso), diventano specchio della disuguaglianza
fra gli uomini.
3. Linguaggio musicale ed intimità naturale – Nel quadro tratteggiato da
Rousseau, il rapporto fra villaggio e città, fra la natura e la civiltà ‘iniqua’,
l’elemento musicale ricopre un importante ruolo comunicativo e, in un certo senso,
normativo. Da una parte, la concezione rousseauiana della musica deve leggersi
alla luce di quella querelle des bouffons nella quale, al tempo del filosofo, si
dibatteva se fosse meglio la musica italiana o quella francese. Ora, secondo
Rousseau, schierato a favore della tradizione italiana, esiste un legame profondo
tra la musica che si sviluppa in un dato Paese e l’evoluzione della sua lingua. In
particolare, nella Lettera sulla musica francese (1753) e nel postumo Saggio
sull’origine delle lingue, egli afferma che la tradizione francese non potrebbe
�115
Relazioni repulsive: legge, natura e musica in un’opera buffa di Rousseau
partorire buona musica, essendo il francese una lingua che poco si presta alla
musicalità.
La parentela fra linguaggio musicale e linguaggio verbale si articola, oltre che
nella ‘teoria’, anche nella ‘pratica’ compositiva del filosofo, per il quale la musica
dovrebbe esprimere la spontaneità dell’istinto naturale e non, invece, una serie di
convenzioni arbitrarie. In queste convinzioni, che deriverebbero dalla lezione di
Jean Baptiste Dubos, si nascondono implicazioni politiche non secondarie, che in
parte giustificano l’accostamento fra L’indovino del villaggio e La serva padrona
di Pergolesi, con cui l’intermezzo di Rousseau viene solitamente confrontato.
Senza dubbio, l’intento polemico dell’opera napoletana è ben più esplicito rispetto
alla critica dei rapporti di potere ravvisabile nel Devin, ma non deve dimenticarsi
che le due opere sottendono prospettive ‘politiche’, almeno in parte, differenti: se,
da una parte, l’intraprendente serva Serpina desidera esser rispettata e riverita
come «padrona, / arcipadrona, padronissima», dall’altra parte gli abitanti del
village non vogliono abbandonare lo stato felice in cui si trovano, poiché sono
l’incivilimento e l’assunzione delle convenzioni cortesi a causare l’infelicità.
Le due opere condividono, peraltro, alcune soluzioni tecniche – in cui l’abilità
di Pergolesi non è certamente eguagliata da Rousseau –, fra le quali una pare
estremamente significativa per il nostro discorso. Si tratta dell’impiego del
recitativo secondo uno stile ‘naturale’, che nell’Indovino è «accentato in maniera
del tutto nuova, e proced[e] in uno con la parola parlata» (Conf., VIII, 2). Fornendo
numerose indicazioni all’esecutore (cantante e strumentista), Rousseau cerca di
costruire una strettissima corrispondenza fra le dinamiche del suono ed il
significato del testo recitato, per trasmettere fedelmente la spontaneità del
linguaggio e l’atmosfera d’intimità che caratterizza la vita nel villaggio.
Questo stile musicale, che tutto sommato sembra abbastanza originale, funziona
come una ‘cassa di risonanza’ per le posizioni filosofico-giuridiche dell’autore.
L’intimità naturale, celebrata nel testo e rimarcata dalla musica, non è soltanto il
tema di una narrazione, ma è anche oggetto di una norma. Rousseau, infatti,
partendo dalla ‘descrizione’ d’uno stato primitivo e naturale, ricava la
‘prescrizione’ in relazione al giusto ed all’ingiusto, violando così – in buona
compagnia degli altri giusnaturalisti – la famosa ‘legge di Hume’ per cui non si
può ‘saltare’ arbitrariamente dall’essere al dover essere.
4. Relazioni nello stato di natura? – La vita del villaggio assume, come s’è
detto, un significato normativo, che riferisce gli attributi di ‘giustizia’ e ‘bontà’ alle
relazioni spontanee, nella misura in cui queste seguono l’istinto naturale – si badi,
è sempre Rousseau a stabilire il confine tra ‘naturale’ e ‘artificiale’ – e qualifica, al
contrario, come ingiusto e cattivo ciò che viene dalla civiltà e produce gelosia,
vanità ed invidia. Tale significato normativo è, in parte, accennato nel duetto dei
due amanti, che dichiarano di voler accettare l’amore come propria «legge» («que
l’amour soit notre loi», Devin, sc. VI, ensemble). Anche la figura dell’indovino –
�116
PIER GIUSEPPE PUGGIONI
che non esercita veramente poteri divinatori, ma è creduto ‘magico’ dagli abitanti
del villaggio – sembra una sorta di custode di queste ‘prescrizioni’, quasi per darci
un’avvisaglia di quella «religione civile» (Contratto sociale, 1762, IV, 8) i cui
articoli di fede sono funzionali al rispetto delle norme vigenti in un dato ordine
sociale, che nel Contrat è ‘civile’, mentre qui sarebbe ‘naturale’.
L’intimità descritta nel Devin, che si fonda sull’esigenza di conformarsi alla
legge di natura, potrebbe, tuttavia, essere intesa come un’aporia nella concezione
rousseauiana dello stato di natura, che da un lato sembra descrivere un uomo
primitivo isolato e autosufficiente, ma dall’altro assume che certe relazioni siano
comunque indotte dalla natura stessa. Ora, alcuni studi di storia della filosofia
(come quello di Annamaria Loche, Immagini dello stato di natura, Milano, 2003)
hanno rilevato come lo stato di natura in Rousseau assuma fattezze in parte diverse
nelle varie opere, ma questo non ci impedisce di ritenere che, per il filosofo
ginevrino, il bisogno fisico che guida l’istinto dell’uomo primitivo sia solo una
delle determinazioni che lo caratterizzano.
Senza dubbio, l’unione degli amanti è spontanea, informale, ed è sempre
possibile – come nota l’indovino – che i due un giorno si separino seguendo il
capriccio dei sentimenti («l’amore cresce … / s’assopisce …», Devin, sc. II, air),
ma ciò non esclude che, in generale, per realizzare la propria felicità (bonheur)
l’uomo debba passare da alcune relazioni che comportano la felicità altrui.
D’altronde, è un sentimento naturale a guidare la giovane coppia della Nuova
Eloisa (1761), che vuole unirsi in un modo libero dalle convenzioni civili. La stessa
pietà, descritta come «sentimento naturale», è una caratteristica umana che «ci
porta senza riflessione al soccorso di quelli che noi vediam soffrire» (Discorso
sull’origine della disuguaglianza, I) e, dunque, alla relazione con l’altro. Si può
sostenere, allora, che in questa composizione rousseauiana, dietro la quale si cela
uno sforzo pedagogico che prelude all’Emilio (1762), oltre ai rapporti nocivi e
corrotti della società civile iniqua, vi sia spazio anche per un altro insieme di
rapporti, che sono ‘naturali’ nella misura in cui assumono che l’individuo non basti
veramente a se stesso.
�117
Endoxa – Prospettive sul presente, 5, 25, Maggio 2020, pp. 117-126
TANTO PEGGIO PER I FATTI:
L'IDIOSINCRASIA DEL POSITIVISMO
GIURIDICO
ANDREA RACITI
1. Il diritto e il resto
Ai nostri giorni, a volte, si usa sentire ancora nei piccoli e grandi consessi della
scienza del diritto una frase latina – un brocardum – che suona così: “Ius causa
hominum est”. Il diritto esiste per gli uomini, è utile solo per loro. Ed
�118
ANDREA RACITI
effettivamente, presa nel suo palmare, quasi triviale, significato, non si può che
ammettere la correttezza di questa affermazione.
Proprio una volta che si sia preso per buono questo detto, non bisogna
nasconderselo, iniziano i problemi. Diciamolo subito: i problemi che sorgono
dall'interpretazione di questa (apparentemente) piana e ingenua formula non
vengono quasi mai considerati dalla scienza del diritto odierna, e le ragioni di
questa mancata interrogazione sono certamente molteplici. Diciamo fin d'ora
un'altra cosa: queste ragioni mi appaiono del tutto legittime, se considero il punto
di vista del giuspositivista. Anzi, qui avanzo l'ipotesi che queste ragioni rispondano
ad un fondo di “verità necessario” per il giuspositivista, nel senso che questo fondo
riguarda la stessa sopravvivenza della scienza giuridica. La scienza giuridica,
appunto, deve garantirsi la sopravvivenza, deve mantenersi in vita, preservarsi.
Ogni ente per preservarsi deve ritagliarsi uno spazio. Come? Negando ciò che lo
circonda.
Ora, la scienza giuridica, che non è solo un ente “spirituale”, ovvero un
complesso di conoscenze, dottrine disparate, indirizzi giurisprudenziali, è fatta di
uomini, di gente che ha come sua passione un oggetto particolare, particolarissimo,
quasi indefinibile, che chiamiamo “diritto”. La scienza di cui parliamo, pertanto,
deve isolare quel fenomeno di cui si occupa da tutto il resto. Questo resto,
appunto, non conta ai fini della scienza. Bisogna astrarre il diritto dal magma in
cui si trova originariamente e farne perdere il più possibile le tracce, perché il resto
è pericoloso per la sopravvivenza della scienza, rischia di macchiarla con un
mìasma, una lordura, una contaminazione. Serve garantire una certa purezza alla
scienza del diritto.
Adesso, certamente, delle orecchie mediamente informate sulle vicissitudini
storiche e dottrinali che hanno riguardato la teoria del diritto, penseranno subito
che il mio riferimento alla purezza della scienza giuridica riguardi la teoria
elaborata dal grande giurista austriaco Hans Kelsen. Queste orecchie, per così
dire, penserebbero correttamente. Tuttavia, non penserebbero ancora a sufficienza.
La dottrina formal-imperativista di Kelsen, che troviamo esposta nei suoi aspetti
essenziali in testi quali La Dottrina pura del diritto (1934) e nella Teoria generale
del diritto e dello Stato (1945), non è che una e, forse, neanche la più estrema delle
formulazioni contemporanee di un indirizzo filosofico incredibilmente pervasivo
e fondamentale per la storia del diritto: il positivismo giuridico.
Non si tenterà qui una ricostruzione storica della pur avvincente trama del
giuspositivismo, impresa realizzata da tanti studiosi più che degnamente.
In questo breve spazio, mi piacerebbe tracciare i caratteri essenziali di questo
indirizzo, che, come tutti gli “ismi” consiste in qualcosa di più che un mero “ismo”.
A mio modo di vedere, se – come ci insegna l’“archeologia del sapere” di
Foucault - provassimo a compiere un'interrogazione del presente che getti
un'ombra sul passato, ebbene, lo stato attuale della scienza del diritto ci si
staglierebbe dinanzi come un “destino” in un certo senso.
�119
Tanto peggio per i fatti: l’idiosincrasia del positivismo giuridico
La “positività” del diritto, che isola se stessa dal resto costantemente inascoltato,
si disvela come l'idiosincrasia della formula latina che si è citata più sopra.
L'idiosincrasia di una specifica, e cionondimeno storicamente vincente,
interpretazione del ius causa hominum est. La vittoria dell'interpretazione
giuspositivista della formula presenta una variegata sintomatologia, che ci
permette di individuare, con un grado di sufficiente certezza, i fautori del
positivismo giuridico anche in coloro che apertamente lo rinnegano – di fatto così
misconoscendolo - e si presentano quali alfieri dell'anti-formalismo, o di una
visione ispirata al Freirecht, oppure all' “istituzionalismo” che si vuol rifare ad ogni
costo al Santi Romano de L'ordinamento giuridico (1918) o a Maurice Hauriou,
e, a volte, addirittura a Il Nomos della Terra (1950) di Carl Schmitt.
In particolare, financo lo storico, il filosofo del diritto o il giurista teorico che
intendessero liberarsi del positivismo giuridico con un colpo di spugna, alla fine,
alla prova “dei fatti”, non potrebbero che cadere in una stridente contraddizione,
costretti ad argomentare sempre a favore di una pur minima “positività” del diritto.
Il carattere minimale della positività, stranamente, diventa quasi subito
magicamente capace di assorbire il resto che rimane sempre impensato dalla
scienza del diritto. Il presupposto dell'idiosincrasia che io denomino “positivismo
giuridico” nasce dall'interpretazione (quasi) letterale della formula latina: è diritto
solo ciò che è posto da un’autorità umana, quali siano poi i suoi criteri di
legittimazione si vedrà nei singoli ordinamenti e, in ogni caso, sarà tutt'al più un
problema dell'etica o della filosofia politica, giammai della scienza del diritto. Alla
domanda di Kant, che egli si pone nel contesto dei Principi metafisici della
dottrina del diritto (1797), che suona così: “Quid sit iuris?”, che cos'è del diritto,
cosa appartiene al diritto, la risposta non può essere che tautologica: è del diritto
ciò che appartiene al diritto, ovvero, è diritto tutto ciò che è prodotto
conformemente ad un'autorità umana preposta alla produzione del diritto. Se
ci chiediamo da chi o da che cosa quell'autorità venga preposta, nasce la filosofia
del diritto, che, secondo Kant, sarebbe un'interrogazione sulla giustizia del diritto
stesso: “Quid sit ius?”, che cos'è il diritto?
Tuttavia ci si potrebbe ulteriormente chiedere: siamo davvero approdati alla
filosofia del diritto se partiamo dal presupposto che il diritto sia un quid? In qualche
modo, anche la domanda della cosiddetta “filosofia del diritto” sembra mal posta,
perché ci stiamo già dando una risposta abbastanza chiara: qualunque cosa sia,
sappiamo già che il diritto è comunque una “cosa” o un “qualcosa” e che questa
cosa o qualcosa certamente “è”. Quindi, qualunque cosa sia, il diritto è già subito
identificato come un “che cosa”, un quid. E sì, questa cosa ha a che fare con
l'uomo, è posta dagli uomini, causa hominum est, esiste per loro. Il resto invece,
come sempre, deve rimanere silente, è ingombrante per una scienza del diritto
la quale, se è davvero “scienza”, deve avere ben chiaro il suo oggetto,
circoscriverlo, renderlo intelligibile dandogli un determinato “tono”, una voce
�120
ANDREA RACITI
(Stimme) che rimane fuori dal coro per possedere una sua propria determinazione
(Be-stimmung).
Attenzione, ciò non toglie che non esistano branche quali l'analisi economica
del diritto o la sociologia del diritto o fini analisi politiche del diritto da parte dei
politologi, ma anche, di recente, inedite collaborazioni tra filosofia del diritto e
ingegneria gestionale, diritto e informatica... Insomma, chi più ne ha più ne metta.
Come si potrebbe parlare di un'idiosincrasia, allora, vista tutta questa messe di
interdisciplinarità? In realtà, a mio avviso, l'idiosincrasia del positivismo giuridico
semplicemente si fa più estesa e pervasiva: tutte le analisi economiche,
sociologiche, informatiche o ingegneristiche devono dare per presupposto e
intelligibile il loro oggetto, il diritto: questa cosa posta da un'umana autorità
preposta (da chi?) alla sua produzione, emanazione o creazione... Il linguaggio
pseudo-teologico del positivismo giuridico ci offre un variegato bestiario
dogmatico di cui servirci ai fini della scienza.
2. Un fantasma tangibile
Allora, ci si pone un problema: ma non si stanno forse mettendo i puntini sulle
“i”, spaccando il capello in quattro per un ingiustificato e personale livore contro
una scienza del diritto che deve essere “positiva” per essere scienza? In fondo, il
messaggio della scienza “positiva”, anche quella giuridica, sembra essere del tutto
ragionevole: il diritto è qualcosa di tangibile, deve esserlo se si vuole farne scienza.
Questo è, nel suo nocciolo essenziale, il fulcro del positivismo giuridico, così duro
e infrangibile da mettere d'accordo anche coloro che si dicono anti-positivisti, antiformalisti, anti-legalisti, neo-contrattualisti, neo-giusnaturalisti. Insomma, gli
“anti” e i “neo” non possono che concordare con la buona novella del positivismo
giuridico. Il diritto è qualcosa, un “quid” tangibile, e anche quando è posto nella
fantasmatica “natura” o “ragione” umana, anche quando fosse posto in primis da
Dio stesso – si veda il De legibus ac Deo legislatore (1612) di Suarez per farsene
un'idea – che il diritto sia un qualcosa, un quid posto, in un'ultima istanza, da
un'autorità umana, rimane un presupposto irrinunciabile. Il resto, appunto, non
rileva. Difatti, cosa significa parlare di “natura” o di “ragione”, se non di un'autoautorità, di un comando interiorizzato che detta una determinata regola che guidi
l'uomo, che lo conduca per mano? Spinoza parla di un uomo che pensa e agisce
ex ductu rationis, che segue appunto il dictamen rationis. Ciò che può sembrare
giustificato sul piano ontologico, trasposto sul piano giuridico (ciò che Spinoza fa
soprattutto nel Tractatus politicus) si trasforma nell'asserzione incondizionata
della positività (qui presentata come statalità) del diritto, pur se teoreticamente
agganciato sempre a un diritto naturale che, come centro vuoto a cui sempre far
riferimento, possa ricordare allo Stato di garantire la tanto agognata libertas
philosophandi.
�121
Tanto peggio per i fatti: l’idiosincrasia del positivismo giuridico
Il fulcro dell'idiosincrasia giuspositivista lo riscontriamo proprio
nell’affermazione dell’esistenza di un centro vuoto a cui il pensiero si obbliga far
riferimento: “natura”, “ragione”, “volontà di Dio”, “volontà del legislatore”,
“Carta costituzionale”, “Grundnorm”, “Sovranità”.
Ciaramelli, nel suo Consenso sociale e legittimazione giuridica (2013), parla
di una eterogenesi dei fini del giusnaturalismo: la originaria affermazione di un
diritto meta-positivo e meta-fisico (a volte, come nella sua versione confessionale,
meta-umano) realizza un fine diverso da quello che si era originariamente
prefissato: la positivizzazione del diritto naturale da parte dell'autorità dello Stato,
il quale sancisce il suo monopolio della produzione giuridica a partire dalla
Rivoluzione francese, facendosi garante ed effettivo performer del diritto naturale
stesso.
Nonostante il risultato, da un punto di vista storico, sia consistito certamente
nella conversione per via autoritativa del diritto naturale in diritto positivo, non
credo che questo risultato possa definirsi altro rispetto al fine originariamente
prefissato. Non solo Spinoza, ma tutta la filosofia propugnatrice di una forma di
giusnaturalismo, da Grozio e Hobbes fino a Leibniz, Locke, Rousseau e Kant,
mai sganciò il diritto naturale dalla tensione verso una realizzazione storica in
forma statale: se il centro vuoto del diritto naturale nasceva come mera idea
filosofica, in statum potentiae, per passare in actu era necessario che questo centro
vuoto si realizzasse storicamente in forma autoritativa. Ma, sempre, attenzione,
di un centro vuoto trattavasi, e si tratta ancor oggi, quando si parla di positività del
diritto.
Con questo, naturalmente, non si vuole affatto dire che la filosofia politica e
giuridica moderna abbia in qualche modo preparato l'avvento del positivismo
giuridico nella sua forma avanzata o altre simili esagerazioni: la filosofia non
detiene un simile potere fondativo. Si vuol dire, piuttosto, che la filosofia dei
secoli XVII-XVIII è riuscita, come ogni vera filosofia, a esporre il destino
storico della sua epoca, essa davvero compì l'impresa di “cogliere in pensieri il
suo tempo”, come direbbe l'Hegel dei Lineamenti di filosofia del diritto (1821).
La filosofia moderna ha esposto il destino storico dell'Occidente, facendo emergere
la positività del diritto come la sua realtà effettiva. La ricchezza della filosofia sta
nel presentare gli innumerevoli aspetti dello Stesso in guise diversissime, quasi
sempre opposte l'una all'altra, in base alla visione particolare e spiccatamente
penetrante del singolo filosofo.
Non credo che la filosofia possa ridursi soltanto ad una battaglia dei caratteri
umani come vorrebbe Hans Jonas, o alla mera “invenzione di concetti”
propugnata da Deleuze e Guattari. Questi aspetti sono certamente importanti e
contribuiscono a delineare le infinite sfaccettature dell'avventura storica che la
filosofia è. Ma, senza quel potere espositivo, capace di mettere in luce lo Stesso,
il destino storico di un'epoca, attraverso opinioni, linguaggi e, a volte, “sistemi”
diversissimi tra loro, non si andrebbe oltre una, pur grande, letteratura.
�122
ANDREA RACITI
Ecco che, invece, qui si coglie quell'aspetto dello Stesso che ho denominato, in
senso lato, “positivismo giuridico”. Esso consiste nella credenza in un centro
vuoto di per sé sussistente, una vera e propria ipostasi, che, nelle sue varie
formulazioni, ci si presenta come una sorta di fantasma capace di produrre
legittimazione.
Legittimazione di che cosa? Di determinate azioni umane dirette ad
influenzarne altre. Ed è adesso che, se cerchiamo di guardare appena sotto il nostro
naso, ovvero attraverso la nostra esperienza, potremo provare a renderci conto del
fatto dell'intangibilità che fonda il positivismo giuridico, l'assoluta discrasia
rispetto all'umana esperienza che lo caratterizza. Anche in questi giorni, per
fare un esempio, si fa pedissequamente riferimento ai nostri diritti fondamentali
sanciti dalla “Costituzione”, o, a volte, in funzione sterilmente polemica, alla
“riserva di legge”, e, naturalmente, agli atti normativi del Governo, dai decreti
legge agli ormai celeberrimi decreti del Presidente del Consiglio, fino ad arrivare
alle sentenze dei tribunali o della stessa Corte costituzionale, ma anche gli atti
normativi di Regioni ed enti locali. Quanto qui è stato sbrigativamente elencato
costituisce l'armamentario basilare del giurista, alcune delle cosiddette “fonti del
diritto”, anche se, ma solo formalmente, le sentenze sarebbero da escludere in un
ordinamento di civil law, ma di fatto, come i giuristi sanno bene, vanno incluse
eccome (nella teoria kelseniana, su questo, a modo suo, più “realista”, le sentenze
sarebbero “norme individuali”). Ma il punto è il seguente: tutto ciò è davvero
qualcosa di tangibile e di vivo?
Come una volta scrisse Norberto Bobbio in uno dei suoi saggi kelseniani
contenuti adesso in Diritto e potere (2014), riferendosi però alla Grundnorm della
dottrina pura, anche nella situazione di cui parliamo qui il giurista positivo si trova
davanti al “capo delle tempeste” della sua scienza. Ciò che lo scienziato del
diritto afferma è: bisogna fare costante riferimento, ad esempio, ai “diritti
fondamentali” sanciti dalla Costituzione, bisogna tener presente gli indirizzi
giurisprudenziali della Corte Costituzionale in merito, e il resto... beh, considerare
questo resto, ciò che sta sotto il nostro naso, ma che sfugge sempre ai fantasmi che
il positivismo porta a spasso come vessilli strappati, questo resto è reputato
inutile.
Potremmo tentare di dare un nome al resto; per esempio, adottando il punto di
vista delle ipostasi giuridiche, potremmo chiamarlo ingiustizia. Dal punto di vista
della giustizia immancabilmente “posta”, propria del positivismo giuridico, la non
conformità di un fatto rispetto all'ipostasi della giustizia posta, che può chiamarsi
con il nome di “diritti fondamentali costituzionali” o di “sentenza additiva di
principio della Corte Costituzionale”, è certamente da considerarsi illegittimo,
incostituzionale, illegale, o che dir si voglia. Il resto, ossia ciò che è effettivamente
il vissuto reale del singolo, una volta considerato illegittimo rispetto ad una delle
ipostasi di turno, non ha una sua ragion d'essere oltre il giudizio – altrimenti detto
“qualificazione normativa” - che discende dalla bocca (?) del fantasma giuridico.
�123
Tanto peggio per i fatti: l’idiosincrasia del positivismo giuridico
Nel caso in cui, per fare un esempio non troppo di scuola, si venga selvaggiamente
manganellati da qualche poliziotto in un autobus o in un treno perché ci si trova
sul mezzo senza biglietto durante l'attuale quarantena, sarà più o meno di questo
genere la risposta del giurista positivo: che si inizi un procedimento penale e si
accertino le responsabilità. Tutto ciò è formalmente ineccepibile. Chiunque
farebbe lo stesso e si rivolgerebbe alla Procura, con ogni probabilità. Cosa succede
allora? Il rimedio all'ingiustizia si otterrebbe con l'inclusione del resto, così com'è,
in una dinamica in cui un'azione incondizionata, ma che si presume debba essere
vincolata all'osservanza della legge e al rispetto dei diritti fondamentali
costituzionali, viene giudicata in base alle medesime ipostasi alle quali quell'azione
si credeva dovesse essere vincolata. Il fantasma, in un certo senso, si rivolge su se
stesso e a se stesso ed emana un giudizio su qualcosa che crede di vincolare, ma
da cui si trova totalmente scisso, sganciato irrimediabilmente. Se noi
guardiamo al solo fantasma per cercare giustizia e legittimazione otterremo solo
un flatus vocis, formule normative o giudiziarie.
Nel caso dell’attuale situazione italiana, questa dinamica fantasmatica si traduce
nel disconoscimento dell'essenza storica della Costituzione stessa: questa non
è nata da un'operazione di “bilanciamento” di diritti, né da astratte formulazioni,
bensì da una lotta storica contro un nemico concreto, da una guerra di
Resistenza. L'intera struttura formale del testo approvato il 22 Dicembre del 1947
acquista un senso, un orientamento determinato solo e soltanto a partire dalla
Costituzione storica, nata dalla pura eccezionalità dell'evento fondatore che la
costituzione formale ci ricorda nella XII disposizione transitoria e finale, la quale
vieta la ricostituzione del disciolto Partito fascista. Secondo l'interpretazione
giuspositivista, con questa disposizione il legislatore costituente avrebbe previsto
una deroga rispetto alla libertà di associazione sancita dall'articolo 18 della stessa
costituzione formale. Ma, se guardiamo oltre la dogmatica ipostatica del
giuspositivismo, ci accorgiamo che proprio nella XII disposizione transitoria e
finale la costituzione formale riporta alla memoria dei cittadini il conflitto estremo
da cui è scaturito un novus ordo saeclorum, il quale più che causato, si dovrebbe
dire che si è occasionato da un evento eccezionale, strutturandosi in un
ordinamento che nega alla radice il suo nemico storico sul quale ha prevalso. La
Costituzione storica è l'unica davvero esistente, perché è l'unico evento davvero
accaduto, tale da dare un senso determinato ad espressioni contenute nella
costituzione formale che, altrimenti, ne sarebbero del tutto prive. Se si disconosce
l'evento eccezionale che la Costituzione è, riducendola a una mera “Carta”, come
il giuspositivismo deve fare per preservarsi, si giunge ben presto alla miopia etica
che fa tutt'uno con il positivismo giuridico stesso: pretendendo e credendo
fermamente di guardare ai “fatti”, il giuspositivismo si concentra su statuizioni
astratte, ovvero costruzioni evanescenti alla quali si presta fede, che si tengonoper- vere. Wahr-nehmung, la percezione, letteralmente vuol dire proprio questo:
è un tenere, un prendere-per-vero, ossia rappresentarsi una costruzione astratta
�124
ANDREA RACITI
a partire da una somma di tratti comuni riscontrabili nell'esperienza. Il positivismo
giuridico, in quanto scienza as-tratta, allontana e separa dall'esperienza alcuni tratti
per farne degli universali mentali (ad es. i “principi fondamentali della
Costituzione”). E fino a qui non ci sarebbe nulla di strano, trattandosi di un
procedimento del tutto naturale per l'essere umano il rappresentarsi gli oggetti
dell'esperienza in schemi astratti: la descrizione che, tra gli altri, Hegel fa della
Wahrnehmung, nella sua Fenomenologia dello Spirito (1807), ci descrive proprio
una simile dinamica. Tuttavia, se questo universale astratto viene scambiato per
oggetto di “scienza”, poiché si crede che l'azione degli uomini dipenda e sia
condizionata da questi universali (es. dalle norme giuridiche o dalle sentenze
giudiziarie) e, di conseguenza, si crede così di stare parlando della “concretezza”,
proprio qui si presenta l'idiosincrasia che il positivismo giuridico non può non
essere quando pensa “scientificamente”. Credere che le ipostasi giuridiche siano
effettivamente reali di per sé, significa non considerare l'ineliminabile scarto che
vi è tra un universale astratto (normativo) e la sua esecuzione. Se si giudicherà
quest'ultima sussumendola in schemi qualificativi a priori, si trasporrà un fatto
sotto la lente di una proposizione sciolta dal fatto medesimo, credendo che il fatto
possa esser stato o possa venire in futuro condizionato dalla proposizione. Il
fantasma, ancora una volta, si rivolge su se stesso e a se stesso.
3. L’idiosincrasia “scientifica”
Da questa credenza derivano tutte le formulazioni “scientifiche” del
giuspositivismo. Una molto in voga da sempre, ma ripetuta spessissimo in questi
giorni di quarantena, è quella del bilanciamento dei diritti fondamentali in
Costituzione: si crede, in poche parole, che “la Costituzione”, intesa solo come
“Carta” naturalmente, sia dotata di un suo buon senso, potremmo dire, e, tra le altre
sue qualità naturali, che essa “parli” e, stando a ciò che dice, utilizzi una bilancia
per stabilire se e quando dev'essere compresso un determinato diritto fondamentale
a favore di un altro. Tutto ciò, stando a sentire gli “interpreti”, veri e propri
aruspices della ornitologica, ma, attenzione, “immanente” volontà del
“costituente”, indicherebbe che i diritti vengono reciprocamente limitati in base
alle esigenze dettate dalle circostanze. Nulla prevale e tutto si equilibra nel magico
sistema ipostatico, verbale, che la Costituzione presenterebbe da sé, in forza di
valori tanto “pregnanti” quanto “tangibili”, sempre a parere della “Carta”…
Preso atto della ricostruzione divinatoria, uscendo soddisfatti dal pensatoio del
giuspositivismo, come Strepsiade dopo l'incontro con Socrate ne Le Nuvole di
Aristofane, torniamo a casa e ci guardiamo intorno, o, almeno, guardiamo sotto
il nostro naso.
Cosa vediamo? Il Parlamento non esercita più alcuna reale attività legislativa
autonoma durante lo stato d'eccezione che stiamo vivendo in questi mesi. Certo,
�125
Tanto peggio per i fatti: l’idiosincrasia del positivismo giuridico
neanche prima dello stato d'eccezione degli ultimi due mesi, anzi da più di due
decenni a questa parte, si può dire che l'organo centrale di una Repubblica che si
dichiara “parlamentare” abbia esercitato pienamente le sue alte funzioni. L'attività
di conversione dei decreti-legge governativi appare predominante da anni,
pochissimi sono ormai i progetti di legge di iniziativa parlamentare che vengono
approvati. La necessità e l'urgenza scandiscono l'attività legislativa della
Repubblica. Ma, per tornare agli ultimi due mesi, adesso si vede qualcosa di più:
l'annichilimento persino dell'attività di indirizzo del Parlamento sull'attività del
Governo. Questa situazione, tra l'altro, non può neppure essere imputata davvero
a questo o a qualunque altro Governo: è il Parlamento che sembra aver esaurito
la sua funzione storica, da decenni, e, negli ultimi anni, dall'emergenza
economica per giungere all'attuale emergenza sanitaria, l'organo in cui, più che in
ogni altra istituzione, si dovrebbe concentrare la cosiddetta “sovranità popolare”,
contempla la propria agonia politica. Anche qui, da buoni giuspositivisti,
dovremmo richiamare noi stessi alla calma, alla pacatezza, ad accogliere l'invito a
porgere lo sguardo alla limpidezza del dettato costituzionale al riguardo: poche e
scarne disposizioni (artt. 92-96 Cost.) sono dedicate dalla costituzione formale alla
disciplina dei poteri del Governo, i quali vengono descritti mediante formulazioni
generalissime e vaghe (“direzione della politica nazionale” attribuita al Presidente
del Consiglio, etc.), proprio perché si sono voluti limitare i poteri del Governo, dirà
il giurista positivo, dopo l'accentramento inverosimile nelle mani di esso durante
il fascismo. Certo, un positivista più accorto potrebbe avanzare l'ipotesi che più
indeterminati sono i poteri più si autorizza la prassi ad estenderli de facto, traendo
profitto dall'indeterminazione stessa. Ma questo, forse, è il massimo che potrà
essere affermato dal giuspositivista, azzardando magari dei riferimenti a concetti
solitamente presi in prestito dalla filosofia giuridica e dalla scienza politica come
la “crisi della democrazia parlamentare” o, addirittura, la “crisi dello Stato di
diritto”, formule che, se restano tali, ossia del tutto impensate, condividono con le
ipostasi giuridiche la medesima natura fantasmatica.
Ed ecco che, a questo punto, di fronte all'attuale situazione eccezionale, ciò che
il giurista positivo vede chiaramente come “un fatto concreto” è un problema di
bilanciamento. Davanti a noi, sotto il nostro naso, il resto rimasto impensato dal
positivismo giuridico ci mostra una situazione in cui, con alterni risultati, un
Governo, in nome della tutela prioritaria della salute, ha deciso che l'esercizio delle
altre libertà fondamentali previste dalla Costituzione doveva essere praticamente
annullato. Sarebbe del tutto inopportuno dare dei giudizi estemporanei su queste
misure, le quali dipendono dallo stato d'eccezione attuale (rimando al mio articolo
pubblicato su Endoxa nel mese di marzo: “Finzioni eccezionali”). A tal proposito
si è voluto parlare e si parla ancora, usando un evergreen dei mitologemi
giuridici, appunto, di bilanciamento. Bisognerebbe immaginare questa scena: se
chiunque di noi, fino alla data del 4 Maggio, fosse uscito in macchina soltanto per
“prendere un po' d'aria” come si suol dire, per poi tornare a casa, se fermato dalla
�126
ANDREA RACITI
polizia, sarebbe stato legittimamente multato. La libertà di circolazione è stata
trasmutata dall'interno dallo stato d'eccezione, in cui regola e vita giungono a
coincidere, in una sorta di soglia d'indeterminazione, come scrive Agamben in
Stato di eccezione (2003).
Ma non è necessario scomodare le raffinate analisi agambeniane. Poter
circolare solo al verificarsi di determinate condizioni previste da un atto normativo
del Governo (riassumibili nell'adempimento delle funzioni necessarie alla
sopravvivenza: salute, lavoro, approvvigionamento alimentare) non significa
poter circolare: una vera libertà di circolare non può essere necessariamente
vincolata all'assolvimento di attività volte al mantenimento del mio sostrato
biologico.
Parlare di bilanciamento può risultare un buon modo di parlare per metafora,
ma è lontano anni luce da una qualsiasi possibile concretezza.
Di fronte a una prassi incondizionata, il centro vuoto costituito dai dogmi
(perlopiù) normativi del giuspositivismo ci mostra la sua funzione storica: la
produzione di legittimazione di una prassi incondizionata, che non ha
effettivamente bisogno del centro vuoto, ovvero, non ha bisogno, ad esempio, dei
principi costituzionali per essere portato ad esecuzione. Le ipostasi giuridiche
serviranno, allora, solo a legittimare, per il tempo necessario, la prassi
incondizionata dell'autorità governativa, la quale si attua concretamente nell'azione
delle forze di pubblica sicurezza, come lo stato di eccezione che stiamo vivendo
paradigmaticamente ci insegna. Walter Benjamin, non a caso, in Per la critica
della violenza (1921), individua nella polizia, e nella sua “presenza spettrale”, la
vera forza motrice del diritto statale.
Ciò non toglie che, una volta tramontato lo stato di eccezione, le leggi di
conversione dei decreti legge del Governo potranno essere dichiarate
incostituzionali, determinati agenti o ufficiali delle forze dell'ordine potranno
essere processati per gli abusi, si faranno ricorsi amministrativi al Tar o al
Consiglio di Stato per invalidare atti amministrativi vari, etc. Il fantasma, di nuovo,
si rivolgerà a se stesso. Ma, per la durata dell'esecuzione, dell'attuazione della
prassi incondizionata, nulla potrà essere invalidato a partire dalla considerazione
di proposizioni normative scritte e solenni ragionamenti basati su mitologici
principi e bilance. L'unico limite reale, forse, sembrerebbe davvero costituito da
un misto di timore e di buon senso dei singoli “rappresentanti della legge”, ma,
come garanzia reale contro una prassi svincolata da universalità astratte, è davvero
troppo poco. Non si può pensare seriamente che dei meri fantasmi linguistici
costituiscano un reale limite ad una prassi di polizia che, nella sua concreta
esecuzione, per definizione, non conosce limiti a priori.
Ma, a questo punto, il buon senso del giurista (o del filosofo del diritto), che
magari si professa anti-formalista e anti-positivista tout court, potrebbe invitarci
alla moderazione, dicendo: “Sarà pur vero che ci sono stati degli abusi in questa
situazione, ma, se guardiamo alle statistiche, ai grandi numeri, si tratta pur sempre
�127
Tanto peggio per i fatti: l’idiosincrasia del positivismo giuridico
di casi sparuti, marginali, qualche migliaio, forse centinaia... Non è importante, il
punto è che le misure stanno funzionando, i cittadini sono perlopiù responsabili, i
principi costituzionali guidano costantemente la prassi, e, diciamocelo pure, lo
stato di eccezione non esiste!”.
Una volta giunti alla negazione radicale del fatto che, in questo momento, la
popolazione stia vivendo una vera sospensione dell’ordinamento costituzionale ossia, lo stato di eccezione - forse si realizza il vero compimento, il pleroma del
positivismo giuridico. Tanta è la repulsione idiosincratica per il nudo e schietto
fatto di verghiana memoria, da credere che l'esercizio delle libertà costituzionali
sia tutto sommato sempre posto sotto la guida saggia della “Carta costituzionale”,
tale che non si possa davvero parlare di uno stato di eccezione. Ma, sia detto solo
di passaggio, sarebbe giusto far presente al nostro ipotetico interlocutore che lo
stato di eccezione non è una situazione totalmente altra rispetto all’ordine
costituzionale concreto, bensì consiste in una una dinamica nomotetica inscritta
nella medesima struttura storica della Costituzione, ma certamente non
interna alla mera costituzione formale. Tuttavia, il giuspositivista tenderà,
perlopiù, a credere fermamente che le ipostasi giuridiche che tanto gli stanno a
cuore, ma che vengono travolte assai facilmente da un tratto di penna alla
Kirchmann o da una manganellata, sussistano comunque, anche quando non se
ne vede più l'ombra, e, se magari si verificano abusi e “violazioni dei diritti”, beh,
ci si rivolgerà, a tempo debito, magari “quando l'emergenza sarà finita”, ai patri
Tribunali... Le violazioni, certo, saranno qualche migliaia, forse centinaia, ma,
d'altronde, lo “scienziato” del diritto deve guardare ai grandi numeri, a ciò che è
rilevante in termini statistici, mentre il resto, appunto, ormai lo sappiamo, è inutile
ai fini di una “vera scienza”, i singoli casi sono davvero fuori legge, hors de la loi.
Insomma, la formula del giuspositivismo potrebbe così riassumersi: se i fatti
contraddicono la regola, tanto peggio per i fatti!
Quest'ultima formula (“Tanto peggio per i fatti!”) sembra attagliarsi davvero
bene al positivismo giuridico. Non si sa se realmente i personaggi a cui la frase è
stata attribuita l'abbiano mai pronunciata, probabilmente no. La si attribuì a Fichte,
a Hegel, e, più recentemente, a Emanuele Severino: pettegolezzi filosofici.
Ma questa impossibilità di attribuzione a una persona, a un chi determinato, ci
mostra la recondita sottigliezza di questa sorta di aforisma senza autore, la
performatività di questa frase: la sua stessa formulazione linguistica è
immediatamente efficace, non c'è davvero alcun fatto (chi l'ha detta?), ma l'assenza
di un fatto diventa l'unico fatto rilevante (positivismo giuridico).
La scissione, l'isolamento da qualsiasi tipo di fatto per rifugiarsi nella pura
ipostasi linguistica che la frase rappresenta, non ci permetterà mai di stabilire se,
da qualcuno di coloro a cui fu attribuita, fu davvero pronunciata.
Che ne è, alla fine, del resto?
�127
Endoxa – Prospettive sul presente, 5, 25, Maggio 2020, pp. 127-130
ORTEGA Y GASSET E LE MASSE:
UN’INTOLLERANZA LUNGIMIRANTE
MATTIA ZANCANARO
Sono trascorsi ormai novant’anni da quando José Ortega y Gasset, saggista,
filosofo e giornalista spagnolo di rara finezza, pubblicava La ribellione delle
masse, la sua opera più celebre e apprezzata. Con gli occhi rivolti a un’Europa
tormentata da conflitti identitari e crisi economiche, Ortega scrive un testo crudo e
disincantato, destinato a rimanere nei classici della storia della filosofia, e questo
perché, come ogni vero classico, oltre a non invecchiare mai veramente, sa
guardare così lontano da garantirsi l’immortalità. Non è certo compito mio fornire
qui un riassunto o un elogio di quest’opera (di cui del resto non avrebbe alcun
bisogno). Mi pare, però, che ripercorrerne alcuni passi possa renderci consapevoli
di come, al contrario di quanto spesso pensiamo, da uno screzio personale possa
nascere anche qualcosa buono. Sì, l’idiosincrasia può essere motore di idee e
riflessioni profondamente vere proprio perché mosse da un fastidio che non
intende concedere sconti o appiattirsi su analisi di convenienza. Vediamo allora,
�128
MATTIA ZANCANARO
brevemente, quale sorprendente risultato produce l’idiosincrasia di Ortega y
Gasset, che, da buon giornalista, è uno che non ama mandarle a dire. Può scegliere
tra una marea di problemi di cui occuparsi, dato che il periodo storico non è per
nulla avaro di stimoli per la penna di uno come lui, grande critico della
contemporaneità. La crescita repentina dei partiti nazi-fascisti, la crisi delle
democrazie occidentali, la fine dei grandi imperi tradizionali: tutti temi di
straordinario interesse, ma, a detta di Ortega, subordinati per importanza a
qualcosa di più rilevante. Ciò che più di tutto lo disturba – e non solo perché ha a
cuore il destino dell’Europa e del mondo, ma anche e soprattutto per una vera e
propria repulsione personale – è «l’avvento delle masse al pieno potere sociale».
Converrà, per meglio capire come Ortega la vede sull’argomento, continuare a
citare le sue stesse parole: «E poiché le masse, per definizione, non devono né
possono dirigere la propria esistenza, né tantomeno governare la società, questo
significa che l’Europa soffre attualmente la più grave crisi che popoli, nazioni,
culture possano patire». La massa è lo strato della popolazione – generalmente
opposto alla minoranza – i cui membri, proprio in quanto uomini-massa, non
distinguono se stessi dagli altri del loro gruppo, costituendo un tipo umano
incapace di definirsi: «massa è tutto ciò che non valuta se stesso». Quel che è
peggio, e con questo forse ci avviciniamo più evidentemente all’attualità, è che la
massa non può essere informata, nel duplice senso della parola: non può ricevere
informazioni rielaborandole criticamente e, in quanto massa informe, non può
ricevere una forma. Ortega, studioso della Madrid colta e pensatore d’élite, mette
in guardia i suoi contemporanei dagli uomini-massa, che, fa presente, sono sempre
esistiti, ma che solo dalla fine del XIX secolo hanno potuto alzare la voce,
ribellandosi a quelle minoranze colte – di cui lui stesso fa parte – che li hanno
sempre governati e guardati dall’alto. Sfruttando la magnanimità delle democrazie
liberali e il repentino sviluppo della tecnica, le masse reclamano ora – nel 1920
come nel 2020 – pieni poteri. Non c’è bisogno di essere docenti, professionisti
della politica o capitalisti; per ambire al potere basta, per usare un termine non
proprio privo di implicazioni, esserci: «Il fatto caratteristico del momento è che
l’anima volgare, riconoscendosi volgare, ha l’audacia di affermare il diritto della
volgarità e lo impone ovunque». Al lettore parrà di trovarsi davanti agli stralci
dell’articolo di punta di un qualche giornale uscito negli ultimi mesi, e invece legge
le acri parole di un pensatore del secolo scorso. Sembra un cliché fra gli altri, quello
dell’intellettuale di città che osserva con spocchia e fastidio il crescere del
potenziale di vita delle classi meno agiate. Il presunto cliché, però, è presto sfatato:
in prima istanza, sono molti i pensatori che nello scorso secolo guardano con
soddisfazione all’aumento della vita (celebre espressione orteghiana) delle masse
(basti pensare all’eterogeneo quanto vasto filone degli autori di impostazione
marxista); in secondo luogo, quello di massa è un concetto più psicologico che
collettivo, e ne fanno parte non soltanto gli umiliati e offesi, ma anche molti
scienziati della nuova tecnica. Quella patita da Ortega y Gasset è insomma
�129
Ortega y Gasset e le masse: un’intolleranza lungimirante
un’idiosincrasia tutt’altro che scontata, e ancor meno scontata è la sua sorprendente
lungimiranza. Se è vero che l’avvento dei movimenti di massa al governo e la vera
e propria presa da parte delle masse dei social network e dei mezzi di
comunicazione è accolta da alcune parti – di cui non è qui lecito fare il nome – con
una certa simpatia, è altrettanto vero che questo avvento e questa presa
rappresentano oggi un fatto incontestabile e decisivo per le dinamiche del nostro
corpo sociale. La libera e sconsiderata espressione dei propri impulsi e
l’ingratitudine verso chi ha reso possibile la sua condizione di totale agiatezza –
dopo lunghi secoli di lotte per portare il pane a tavola – sono i tratti distintivi
dell’uomo-massa degli anni ’20. Degli anni ’20 del secolo scorso, sì, ma anche di
questo. La psicologia del bimbo viziato che vive di illimitatezze di cui non conosce
i connotati, anziché suonarci come una lontana rimembranza del passato, bussa
alla nostra porta come la più inquietante delle questioni.
La caustica analisi di Ortega si fa ancora più interessante là dove, ricordando
una volta di più che tutti rischiamo di farci risucchiare dalla massa, passa a parlare
degli uomini-massa scienziati. Gli scienziati che lo circondano, figli
dell’avanzatissima tecnica occidentale, vengono spietatamente definiti nuovi
barbari. Specializzati fino all’esasperazione, sono come api chiuse nel proprio
favo: conoscono alla perfezione un ristrettissimo campo, ma perdono di vista la
scienza come movimento, e, come se non bastasse, in virtù del loro ben limitato
sapere, pensano di potersi esprimere con competenza su qualsiasi argomento. È
interessante ricordare, en passant, che simile a quella di Ortega è la critica mossa,
nell’Apologia, dal Socrate platonico agli artigiani, colpevoli proprio di una errata
presunzione di conoscenza dell’universale indotta dal loro padroneggiamento di
un ristretto campo del sapere. Anche – e forse soprattutto – quest’ultima sferzata
coglie nel segno anche ai nostri giorni, tratteggiando perfettamente la figura
dell’ingegnere medio, che come tale è uomo-massa, tecnico ultra-specializzato
del tutto incapace di riflettere sullo statuto e la natura delle scienze. Lo scienziatomedio, vero e proprio primitivo ben vestito, non tanto si accontenta del suo
limitatissimo àmbito di competenza dimenticandosi tutto il resto, ma ritiene
quest’ultimo, invece che una piccola parte, tutto ciò che in realtà serve sapere. La
palese antipatia di Ortega per lo scienziato del suo tempo, a sua detta vittima senza
speranza della barbarie dello specialismo, ci spinge inevitabilmente a guardarci
attorno e a interrogarci sulla formazione e sulle capacità dei tecnici dei nostri
giorni, fin troppo spesso avvolti da un’aura di santità che non aiuta a coglierne i
limiti radicali. L’inquietudine di Ortega, che sfocia in vera e propria avversione
categorica, è l’inquietudine di un pensatore che, nel difendere il suo diritto di
appartenere a una minoranza lesa, indica consapevolmente un problema destinato
ad angustiare per decenni l’intera società occidentale. Le accuse alle ingerenze
della scienza trovano terreno particolarmente fertile nella situazione di emergenza
da virus dell’ultimo periodo, un periodo in cui la tecnica – nella nobile veste della
medicina – sta visibilmente rosicchiando spazio alle decisioni della politica,
�130
MATTIA ZANCANARO
minacciando di non arretrare nemmeno a emergenza finita. Masse e scienza, in
apparenza agli antipodi, stringono un sodalizio potenzialmente deleterio, in grado
di abbinare a competenze tecniche sorprendenti una sempre rinnovata volontà di
potenza.
Quello della filosofia di Ortega, in grado di sviluppare temi e problemi oggi
sempre più inquietanti con diversi decenni di anticipo, è un esempio mirabile di
come da un risentimento certamente almeno in parte personale, da
un’idiosincrasia, da uno sfogo incontenibile, possa nascere la più lucida delle
analisi, in barba a ogni facile cerchiobottismo di convenienza. L’irritazione del
pensatore spagnolo, grazie al cielo, è vasta abbastanza da rivolgersi a buona parte
dei temi che angustiano il nostro presente di occidentali, e il minimo che possiamo
fare, a novant’anni dalla pubblicazione de La ribellione delle masse, è riproporre
questi temi nella loro urgente richiesta di essere affrontati con occhio lungimirante
almeno la metà di quello di Ortega.
�131
Endoxa – Prospettive sul presente, 5, 25, Maggio 2020, pp. 131-135
EMERGENZA E FILOSOFIA
DELL’ESTRANEO:
COSA PUÒ INSEGNARCI BERNHARD
WALDENFELS
GIULIANA VENDOLA
Per tentare di penetrare con sguardo critico le trame della sofferente e
idiosincratica situazione odierna qualche fecondo spunto lo possiamo trarre dal
pensiero di Bernhard Waldenfels, filosofo contemporaneo non molto noto al
pubblico dei lettori italiani, eppure autore di una produzione teorica a tratti
profetica, soprattutto se misurata sulla base di quanto l’attualità ci sta restituendo
negli ultimi tempi.
�132
GIULIANA VENDOLA
1. Lineamenti di una fenomenologia dell’estraneo
Avvicinarsi all’universo filosofico, antropologico, politico e sociologico
waldenfelsiano significa immergersi completamente sia in teoria che in pratica
nell’intreccio di proprio ed estraneo. Il proprio è appartenenza a qualcosa, a
qualcuno: è quella dimensione in cui il parlante, innanzitutto e per lo più, si sente
di stare e di esperire. Rappresenta quella sfera spaziale e temporale, circoscritta da
determinati confini, che ogni soggetto intende come soltanto – o, comunque,
preponderantemente – sua. Così configurata, si tratta, a ben vedere, di un dominio
percorso da una soglia in cui si è inclusi e da cui, immancabilmente, si producono
processi d’esclusione. Proprio per questo, però, Waldenfels ritiene che sia possibile
accorgersi e prendere consapevolezza di ciò che è proprio nel preciso istante in cui
quest’ultimo si distingue da qualcosa che gli si sottrae e si fa mancanza. Quel
qualcosa, quel qualcuno, quell’esperienza da cui la distinzione viene fatta e che si
sottrae all’ipseità (dal latino ipse = “proprio”) è appunto xénos (dal greco
“estraneo”), radicale inaccessibilità – in quanto irriducibile ad altro, inderivabile
da altro, originaria – che diviene accessibile, esperibile e per la prima volta
visibile nel perturbante ed eccedente sottrar-si, differenziar-si, allontanar-si.
Proprio ed estraneo si presuppongono e si scoprono guancia a guancia – in
quell’orizzontalità relazionale che non ha nulla a che fare con la tirannica
verticalità di vetuste istanze terze –, e al contempo conservano identità in
quell’allontanarsi tra inclusioni ed esclusioni. Ciò sta a significare che l’estraneità
nella sua apparente assenza è già, radicalmente in anticipo, presente in casa del
proprio (per dirla con Freud), lo abita ed è separata da esso per mezzo di una soglia
– così come la veglia è separata dal sonno, la salute dalla malattia, la vecchiaia
dalla gioventù. Rispetto a tale soglia nessuno si trova mai completamente su
entrambi i lati...
L’incontro/scontro tra estraneità e proprietà sembra si manifesti pienamente
“entre chien et loup” – per riprendere un’espressione dello stesso Waldenfels –
ovvero in quella zona di penombra creata dal crepuscolo in cui la sagoma del
cane si confonde con quella del lupo. Il fenomeno dell’estraneo si radica ed inizia
ad incubare qui, in questa dimensione interstiziale in cui tutto è apparentemente
sfumato, ma è in verità compenetrazione tra domini irriducibili. La soglia in cui
germoglia l’estraneità è inevitabilmente topos ombreggiato del proprio. Il che
implica, in fondo, che ogni esperienza del proprio debba essere intesa come ordine
non assoluto od ontologicamente saturo, ma inevitabilmente contingente, giacché
la contaminazione dell’estraneo impone che ogni ordine potrebbe essere in
qualsiasi momento altrimenti rispetto a come si presenta. Ogni ordine, infatti,
dispone di una molteplicità di elementi eterogenei sempre innestati al suo interno,
per quanto latenti e non sempre percepibili in modo esplicito. Waldenfels in
proposito preferisce declinare al plurale il concetto di ordine, sottolineando quanto
sia naturale pensare in realtà ad una varietà di ordini possibili che possiedono dei
�133
Emergenza e filosofia dell’estraneo: cosa può insegnarci Bernhard Waldenfels
loro limiti ed hanno anche la peculiarità di darne e porne. D’altronde l’umanità
ha sempre avuto a che fare con solchi di transito, si è continuamente confrontata
con barriere spaziali, temporali, concettuali, morali, sociali, sanitarie, politiche,
giuridiche. Questa stessa umanità ha avvertito ed avverte di volta in volta la
necessità di modellare la propria identità in base ai margini da cui viene circondata.
Ciascuna civiltà ha vissuto e vive entro determinate frontiere e ne costruisce di
ulteriori per sopravvivere. A tal proposito lo stesso Waldenfels asserisce – nel suo
saggio sui Limiti dell’ordine – che «il modo di rapportarsi ai confini rivela di quale
spirito è figlia un’epoca» (p. 349) … ed i confini a cui il filosofo si riferisce non
sono di certo solo geografici …
L’uomo abita negli ordini, è incluso in sistemi vestiti di quotidianità, esclude
ciò che non ritiene suo ed è a sua volta escluso da ulteriori forme del vivere. I
margini sono essenzialmente ineliminabili, in quanto senza di essi non potrebbe
esistere un qualcosa che si divide da altro, un proprio che si distingue da un
estraneo, ma allo stesso tempo sono soggetti a cambiamenti e spostamenti. Ogni
qualvolta vi sono irruzioni d’estraneità che tendono a stravolgere il sistema
vigente, a deviare la cosiddetta “normalità” culturale, politica, economica, sanitaria
e sociale a cui l’umano sente di appartenere in una data spazio-temporalità, si mette
in moto un processo di conflittualità da parte dell’ordine che patisce. Un attimo
dopo, spesso frettolosamente, sorge l’esigenza di un effettivo ri-modellamento dei
confini garantito dalla capacità di mobilità di quei confini. Difatti è naturale e
legittimo che l’elemento estraneo che travalica l’ordinarietà, spesso devastandola,
venga visto come quella minaccia, come il segno idiosincratico del caos che
sembra non dia alla realtà vigente nemmeno il tempo per reagire.
Waldenfels ci tiene a sottolineare quanto il pàthos di cui è imbevuta l’estraneità
ci sorprenda sempre in un tale insensato anticipo da non permetterci di rispondere
in tempo e di trovare in qualche modo una pseudo-soluzione che attutisca i duri
colpi inferti da quell’estraneo. Ma nulla toglie che tale straordinarietà – ovvero
incontenibile eccedenza che cresce intestina all’ordine e si fa fenomeno nel
travalicamento di quest’ultimo – sia destinata a restare elemento emergente,
irrompente. È facile che lo straordinario in un battito di ciglia si trasformi nel
nuovo ordine vigente, nel nuovo sistema regolamentato a cui il mondo un domani
potrebbe “abituarsi”, “dis-affezionarsi” e di cui potrebbe dimenticare la radicale
singolarità. Basti pensare alle grandi rivoluzioni, alle trasgressioni, alle violenze
che si sono avvicendate nella storia, alle malattie, alle grandi scoperte, alle grandi
partenze e ai grandi arrivi, a tutti gli eventi eccedenti che in ogni campo hanno
stravolto nel bene e nel male quella che era l’ordinarietà. Si tratta di estraneità
divenute proprietà e di cui – una volta nominate, riconosciute e fondate
convenzionalmente come nuovi ordini – si è perso probabilmente il carattere di
impensabilità.
Aver la memoria corta in merito alla paticità originaria dell’estraneo vuol dire
spesso rischiare di “banalizzare”, “archiviare”, voler a tutti costi confinare in un
�134
GIULIANA VENDOLA
“complesso di senso” quell’irruzione radicalmente insensata che incarna
l’estraneità. Oltretutto, far cadere nell’oblio la perturbante straordinarietà di ieri
dell’ordine vigente di oggi svuota di passione le risposte ritardate, singolari,
ineludibili, asimmetriche e creative che l’umanità si era naturalmente
preoccupata di mettere in atto. Waldenfels propone una visione della
straordinarietà che per questioni di fisiologica sopravvivenza si trasforma in
ordinarietà, ma allo stesso tempo lascia intendere quanto in verità quest’ultima non
abbia alcunché di scontato, programmato, immediatamente dato nella presenza.
L’ordinarietà attuale è l’estraneità del passato che corre sui margini intra-storici
ed inter-storici.
2. Pandemia, emergenza, vigenza: oscillazioni dell’estraneità
Il tema della soglia, protagonista indiscusso del pensiero waldenfelsiano, si offre
come illuminante metafora per poter comprendere i tempi (e)stran(e)i/straordinari
e di assoluta mancanza che ci stanno travolgendo. I sonni dell’umanità sono qui,
ora e altrove, sempre più leggeri, poiché turbati dal peso di sottraenti eccedenze,
di impetuose emergenze. Oggi si sta tentando di scavalcare il muro virulento eretto
da un inafferrabile estraneo che ferisce rendendoci tutti filosoficamente e
clinicamente pazienti, ma che nella sua irruente forza di sfondamento diviene
accessibile, afferrabile a tal punto da spingerci a dover fare responsivamente i
conti con ciò che fino a ieri aveva il sapore dell’ordinarietà. Siamo dinanzi
all’estraneità di una vicenda che appare vestita di Rna e proteine, ma viaggia
letteralmente sulle nostra gambe, tanto da rivelarsi sia in presenza che in latitanza
pienamente a suo agio nelle nostre case. Riflettendoci, sembra rispecchi, in modo
inquietante, l’idea waldenfelsiana di un’estraneità che abita e serpeggia in ciò che
è proprio. Ci scontriamo con un evento distopico, irripetibile nella sua
ripetibilità, che lascia attoniti, senza fiato e spesso senza neppure pensieri.
Abbiamo a che fare con un estraneo che ha minato morbosamente l’ordinarietà
molto prima che fossimo capaci di dargli un nome, un luogo di nascita, una data,
un dato, un’immagine, una rappresentazione. Quando i solitamente accecanti neon
degli uffici, delle fabbriche, dei negozi, delle città hanno cominciato
straordinariamente ad affievolirsi, con la stessa impietosa straordinarietà, i corpi si
sono allontanati e le relazioni sono mutate in scissioni. Perché, se su una sponda
della soglia – in cui la quotidianità si sta trascinando – i solchi frontalieri della
nostra normalità indietreggiano, tanto da consumare famelicamente gli spazi di
libertà, sull’altra sponda si gioca invece un continuo aumento di inscatolanti e
svilenti spazi omogenei tra persone.
La bestialità di questo dis-ordine solca esattamente in zona di penombra, traccia
sulla soglia un rovesciamento di inaccessibili relazioni/corporeità e accessibili
privazioni/scissioni. La realtà ci sta costringendo a sacrificare lo spazio
�135
Emergenza e filosofia dell’estraneo: cosa può insegnarci Bernhard Waldenfels
corporalmente vissuto, ad occultare il mondo-della-vita (Lebenswelt) di matrice
husserliana, ma è importante che domani non ci si dimentichi la contingente
singolarità e paticità di tali sacrifici. Probabilmente è proprio in questo darsi ampie
distanze fisiche, nel bardamento dei corpi mediante dispositivi di sicurezza, nella
serrata stretta che emacia le autonomie che si palesa paradossalmente
l’incomprensibile potenza patica dell’estraneo. D’altronde, non è forse
nell’incomparabilità, nella differenza, nelle inimmaginabili privazioni che
l’estraneità si svela, si fa esperibile?!
Alla luce della galassia waldenfelsiana, ritengo che il Covid-19 possa essere
inteso come quel beffardo estraneo, visibile nella sua invisibilità, che ci costringe
ad un ri-baltamento economico, politico, sociale, sanitario, culturale e per cui è
qui, ora e altrove necessario mettere in moto un rispondere creativo e responsabile.
Un rispondere che sappia plasmare i margini per permetterci una nuova
Resilienza. Stiamo scampando a tentoni ad una straordinaria vicenda di brutali
sottrazioni che domani apparirà, o meglio lo è già, sistema, ordine, normalità.
Quando l’estraneo, vento sinistro o primaverile che sia, si trasforma in ciò che è
familiare porta sempre con sé un ineludibile reinventarsi.
C’è solo da augurarsi che questa infetta, infettante ed incontenibile emergenza
– nonché buia vigenza che rientra in fin dei conti in una ciclicità storica – venga
in un futuro più che prossimo fratturata da un’ulteriore estraneità che ci stupisca e
tempesti di un indicibile, inimmaginabile, irrappresentabile, impensabile, nuovo
Rinascimento.
�137
Endoxa – Prospettive sul presente, 5, 25, Maggio 2020, pp. 137-142
UNA PARTICOLARE MESCOLANZA
MASSIMO FILIPPI
“Imbecilli, almeno mettetevi d’accordo prima di continuare a dire scemenze in
un linguaggio che neanche voi stessi capite. Perché dovete appiccicare etichette su
tutto?”
José Emilio Pacheco, Le battaglie nel deserto
Idiosincrasia, letteralmente, è una “particolare mescolanza” che, in medicina,
sta a indicare una ipersensibilità individuale extra-immunologica a determinate
sostanze e, per estensione, nel senso comune, un’incompatibilità altrettanto
personale verso qualcuno o qualcosa. In quest’ultima accezione, tutt* noi, che ci
piaccia o meno, siamo preda di una qualche forma di idiosincrasia. Pertanto la
questione non è affermare, per sostenere un tanto ridicolo quanto depoliticizzante
“volemossebene”, che si è immuni alle idiosincrasie quanto piuttosto, in un lavoro
di cura del sé e di soggettivazione resistente, esplicitare le proprie idiosincrasie per
creare anticorpi collettivi verso una serie di situazioni che vanno dall’irritante
�138
MASSIMO FILIPPI
all’abominevole. Ecco, allora, un assaggio, parziale, incompleto, idiosincratico,
della mia particolare mescolanza.
Apocalittici. Coloro che non riescono a vedere altro che la fine del mondo se
non come la nostra fine nel mondo o la fine del nostro mondo. Per gli apocalittici,
mondo-senza-noi è sinonimo di fine del mondo-per-tutt*. In tal modo, si
dimenticano (o rimuovono?, o forcludono?) quell* che vivono tra-le-due-morti
(tra la morte simbolica e quella materiale, la condizione de* oppress* di tutte le
specie) e quell* che hanno già esperito la fine del mondo ma che, malgrado tutto,
sono riuscit* a sviluppare strategie di sopravvivenza/resistenza. Guardando solo a
Occidente, gli apocalittici, con la loro totale incapacità di pensare la fine del mondo
sociale in cui siamo immers*, parlano di fine del mondo per perpetuare quello
esistente, per spegnere sul nascere ogni politica trasformativa. Loro parenti stretti
sono, pertanto, gli integrati, altrimenti noti come benpensanti.
Benpensanti. Coloro che pensano male per imporre la propria idea di bene,
un’idea che esclude sempre e comunque la bontà illogica (secondo Grossman, per
bontà illogica si deve intendere: «la bontà di tutti i giorni [...] senza testimoni, senza
grandi teorie [...] che si estende a tutto quanto è vivo, al topo o al ramo»). Le forze
dell’ordine, insomma, i tutori della norma, i guardiani dello status quo e della
restaurazione, , infatuati dal sogno di una sorveglianza continua, capillare, totale e
– perfino oltre Bentham – reciproca.
Capitale. Insieme di strutture e sovrastrutture volte alla massimizzazione dello
sfruttamento (di tutt*) e del profitto (per pochi), al cui mantenimento lavorano sia
apocalittici che benpensanti. Un tempo si pensava che la sovrastruttura fosse il
mero risultato delle strutture economiche. Oggi, dopo tante sconfitte, dovremmo
cominciare a pensare a come trasformare l’economia e l’ideologia del capitale,
visto che si alimentano a vicenda in un ininterrotto circolo ri/produttivo. Andrebbe
poi ricordata la lezione di Marx: sì, il capitale funziona grazie all’estrazione di
plusvalore dal lavoro salariato, ma anche e soprattutto grazie all’accumulazione
originaria – talmente originaria da essere sempre in funzione –, all’appropriazione
del lavoro non pagato di quant* ha marchiato come “donne”, “animali”, “natura”.
In breve, apocalittici e integrati sono ovunque, anche laddove meno te lo aspetti.
Dialettica. Una particolare forma di discorso molto amata da chi intende
mantenere lo stato di cose esistente. La dialettica produce il negativo per
partenogenesi per poi digerirlo nella sintesi. La dialettica annienta la potenza del
negativo, il suo potere di resistenza: I would prefer not to.
Esperti. Gli esperti sono reclutati tra gli apocalittici e gli integrati dotati di
capacità dialettiche ottimali. Costoro, infatti, devono innanzitutto mascherare il
fatto che si siano autoproclamati esperti – lo vediamo bene in questo momento in
cui pletore di esperti, siano essi scienziati o filosofi, non smettono un secondo di
parlare di un evento assolutamente inedito e di fronte al quale faremmo bene a
denunciare tutta la nostra ignoranza. Gli esperti, poi, con la loro tumescenza («la
situazione è apocalittica, quindi ci pensiamo noi») o la loro detumescenza («è tutto
�139
Una particolare mescolanza
come sempre, quindi ci pensiamo noi»), hanno la funzione di chiudere tra quattro
mura la politica trasformativa e l’impegno collettivo.
Fallo. Significante-padrone, punto di capitone, gran regolatore dell’ordine
simbolico, è ciò che, come barra disgiuntiva delle dicotomie che governano la
nostra società, viene fatto penetrare nella carne-del-mondo per classificarla
secondo la scala naturae, per produrre l’ideologia che, con le nozioni di razza,
sesso/genere e specie, naturalizza e normalizza privilegi e oppressioni, in tal modo
alimentando il capitale, la sua dialettica e i suoi funzionari.
Giardino dell’Eden. Sorta di esclusivo resort all inclusive che, dall’inizio dei
tempi, non cessa di produrre e distribuire Natura a buon mercato per rendere docili
i corpi, per fissarli in posture fisse e in comportamenti stereotipati. Il giardino
dell’Eden è una vera e propria eterotopia, se l’eterotopia, come insegna Foucault,
«ha il potere di giustapporre, in un unico luogo [...], numerosi spazi tra loro
incompatibili» e se eterotopia é, letteralmente, il luogo dell’altro, il posto a cui
le/gli altr* sono assegnat* e che, pertanto, devono occupare nella grande catena
dell’essere. Ovviamente, poiché esiste da ben prima che il capitale nascesse, il
villaggio vacanze Il giardino dell’Eden è la dimostrazione più lampante della
capacità degli ideologi dei circoli ri/creativi M-D-M e D-M-D di appropriarsi di
qualunque cosa possa (as)servire al profitto.
Habermassiani. Quelli che pensano che possano esistere relazioni
comunicative (sempre buone) in assenza di relazioni di potere (sempre cattive).
Ancora Foucault: «Mi sembra che l’idea che possa esistere uno stato di
comunicazione tale che i giochi di verità possano circolare senza ostacoli [...]
appartenga all’ordine dell’utopia». E le utopie, si sa, sono spesso letali.
Imbecilli. Vedi epigrafe.
Luce. È la figura retorica più abusata dai discorsi a favore dello status quo, dal
sol dell’avvenir alla luce in fondo al tunnel. Figura usata per indicare progresso,
redenzione, magnifiche sorti e progressive, per rinviare a un futuro non meglio
precisato quanto dovrebbe essere fatto qui e ora. È necessario un oscuro lavoro
politico per riappropriarsi della luce: la luce, a volte onda e a volte particella,
destabilizza materialmente ogni pretesa di identità; la luce fa vedere ma è
invisibile; la luce, se guardata negli “occhi”, acceca. La luce, quindi, è piena di
tenebre, è Lichtung. Ciò che va portato alla luce è il lavoro produttivo del negativo.
Massacri. La retorica dominante della luce serve a invisibilizzare l’ininterrotto
susseguirsi di massacri dell’Uomo a danno de* viventi mortali, indipendentemente
dalla specie di appartenenza: «Dove ci appare una catena di eventi, [c’è] una sola
catastrofe, che accumula senza tregua rovine su rovine [...]. Ciò che chiamiamo
progresso è questa tempesta», disse Benjamin. Sotto il sottile strato patinato della
democrazia, dei diritti, di una comunicazione senza vincoli, si estende, sconfinato,
un inimmaginabile inferno sulla terra. Le animali ne sanno qualcosa: ascoltate le
grida di sudore e sangue che si alzano dalle cantine dei grattacieli eretti contro il
cielo.
�140
MASSIMO FILIPPI
Natura. La più brillante invenzione del capitale. Qualcosa di assolutamente là
fuori utile, a seconda delle circostanze materiali, come riserva di risorse da
prelevare e/o come immensa discarica da riempire. E, a seconda delle circostanze
simboliche, paradigma indiscutibile da cui estrarre la retta forma-di-vita o
esemplare marchio di arretratezza da superare/eliminare. Ricordatevi: quando gli
amici del capitale vi parlano di Natura, vuol dire che la merce siete voi.
Opera. Ciò che chiude la comunità, in una stretta fusionale mortifera, dentro i
confini dell’archè e del telos. Contro quest’opera necro/bio/politica, bisogna
pensare a come rendere le nostre comunità inconfessabili e inoperose, oltre
l’origine e il compimento. Bisogna comprendere come abitare i confini, come
renderli soglie, passaggi, vie di fuga. Come sottrarre la vulnerabilità e la finitudine
de* viventi, la loro esposizione carnale, alla morsa dei segni e delle macchine
dell’imposizione e del dominio.
Palingenesi. È il rivolgimento totale e immediato di un individuo, di una società
o dell’intero cosmo. Generalmente effettuato, come per magia, da un qualche dio
o da una qualche avanguardia intellettuale. Come è il caso della retorica della luce,
anche quella della palingenesi rimanda sempre a un futuro indefinito, se non
addirittura all’altro mondo. La palingenesi, poi, prevede l’esistenza di una Natura
immodificabile e assolutamente buona schiacciata da una Cultura altrettanto
immodificabile ma assolutamente cattiva, una Natura che va riportata alla luce
dall’opera di liberazione. Al grande evento che cade dal Cielo o che si svilupperà
automaticamente dalle viscere della Storia – e che, in un caso come nell’altro,
annienta le micro-pratiche quotidiane di piacere e disobbedienza – si oppongono
le tecniche di riparazione del sé, della società e del cosmo. «Ricrescita di una
struttura e [...] recupero di una funzione», dentro il trouble di un mondo in
disfacimento, scrive Haraway. E prosegue ricordandoci che cosa fanno le
salamandre quando rispondono (rispondono, non reagiscono!) alla mutilazione di
un arto con la produzione di eterotopografie corporee: «L’arto ricresciuto può
essere mostruoso, doppio, potente». Meglio salamandre che Messia.
Quasi. «Il “normale”», sostiene Butler, è «un ideale che nessuno/a può
incarnare». Si è sempre quasi normali, quasi umani. Manca sempre un non so che,
un quasi nulla che produce carne addomesticabile o smembrabile. Il quasi
costituisce l’infinita riserva del plusvalore e dell’accumulazione originaria.
Robinson. Colui che gira in tondo sull’isola di cui si crede sovrano, cancellando
le sue tracce, per paura di essere sepolto vivo o mangiato dall’altro, cannibale o
bestia che sia – cannibali e bestie che, invece, è lui che non cessa mai di introiettare
e di sfruttare impunemente. Secondo Derrida, colui che opera come una ruota («la
ruota gira da sola»), come una macchina («la macchina è ciò che funziona da sola
girando su se stessa»). Come una macchina antropologica, che gira in circolo
arrestando la circolazione e ri/producendo il mondo attorno all’indetumescibile
significante-padrone. Da Marx a Derrida, le robinsonate sono passate da
un’economia ristretta a un’economia generale.
�141
Una particolare mescolanza
Sé. Il Sé è questo movimento continuo e circolare che esce da sé per tornare a
Sé. C’è un momento di follia perfino nel cogito cartesiano, c’è un momento di
esistenza perfino nel Sé hegeliano. Ma follia ed esistenza sono presto riassorbite
nel Sé che include/esclude le/gli altr* da Sé. Il Sé – Hegel lo ha detto chiaramente
– è gemello monozigote dello Stato. Sì, oggi più che mai, è necessario passare dalle
robinsonate del Sé all’impersonale e transpersonale si. Si arrossisce, si verdeggia,
si ama, si muore.
Totalitarismi. Non esiste il totalitarismo, esistono i totalitarismi, infiniti modi
di fossilizzare il dinamismo dei rapporti di potere in dominio istituzionalizzato, in
cancellazione della resistenza: ciò che è stato, è e sarà per sempre – i totalitarismi
più cupi sono quelli che investono direttamente i corpi (delle/degli) animali. Vista
l’estrema versatilità fenomenica dei totalitarismi, non bisogna mai abbassare la
guardia, anche quando sono percorsi da innegabili tratti comici, anche quando le
figure del comico e del politico entrano in uno stato di incandescente
sovrapposizione.
Uomo. Il prodotto tagliente di infinite sezioni e cesure, introiezioni ed
esclusioni, proprietà e privazioni, erezioni e smembramenti. Ciò che è legittimato
dalla macchina antropologica e che si legittima con la Natura. Colui che è cantato
da apocalittici e integrati, acclamato dai benpensanti, il capo di Stato, il Non-PiùAnimale. Colui che è Fallo, Luce, Volto.
Volto. Insieme a quella della luce e della palingenesi, la retorica del volto
contribuisce all’opera di occultamento mascherato eretto a sistema. Il volto apre –
chi ha volto (la vedova, l’orfano, lo straniero) mi chiama alla responsabilità – nel
momento stesso in cui chiude con inusitata violenza – chi non ha volto (l’informe,
l’invertebrato, il non/vivente,) non è respons/abile? Il volto include poch* con lo
stesso gesto con cui esclude moltitudini sterminate. Al volto vanno sostituiti gli
orifizi, le infinite beanze che attraversano – bucano, perforano – il reale, la materia,
i corpi. Che producono esistenza, che delirano i continenti, che mostrano le/gli
altr* dentro e fuori, davanti e dietro il Sé. Che lo circondano, che lo fanno circolare
nel comune, che lo restituiscono alla grammatologia della traccia. In fondo, non
riconosciamo Gregor Samsa dal volto, ma dalla cicatrice che porta sulla schiena.
Zecca. Quella di Stato, ovviamente, quella che stampa denaro. Nessuna
idiosincrasia per le zecche – anzi! – quelle animali filosofiche di superficie che
attendono anche per 18 anni e, poi – la parola a Deleuze – «tre affetti [...], un
mondo tripolare, e questo è tutto!». «Che potenza!». «Una vita sconosciuta, forte,
oscura, ostinata». Senza volto, senza altezza, senza profondità. Senza passioni
tristi.
Come detto, questa lista di idiosincrasie è incompleta, piena di vuoti, di linee di
faglia, di lacune. Ma questo vale per tutti i dizionari e tutte le enciclopedie: dietro
la loro pretesa “pienezza” universale si nascondono, infatti, idiosincrasie non
esplicitate. Con le parole di Wittig e Zeig, «l’assemblaggio delle parole, ciò che ha
�142
MASSIMO FILIPPI
dettato la loro scelta [...], tutto è costitutivo di queste lacune ed è pertanto operativo
per quanto riguarda il reale».
L’organizzazione di questa lista secondo lemmi disposti alfabeticamente è
pensata per facilitare un’elaborazione collettiva di un dizionario che, pur nella sua
necessaria interminabilità, «squadri da ogni lato» «ciò che non siamo, ciò che non
vogliamo». L’idiosincratico, insomma, proprio perché personale, è politico.
�143
Endoxa – Prospettive sul presente, 5, 24, Marzo, 2020
INFORMAZIONI SULLA RIVISTA
Endoxa – Prospettive sul presente è una rivista bimestrale di riflessione culturale a
carattere monografico. Lo scopo della rivista è sia disseminare conoscenze
riconducibili, direttamente o indirettamente, all’ambito umanistico sia di intervenire, in
una prospettiva di “terza missione”, nel dibattito contemporaneo, senza alcuna
preclusione culturale.
Tutti gli articoli sono tutelati da una licenza Creative Commons (CC BY-NC-SA 2.5
IT) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/
DIREZIONE/EDITOR:
PIERPAOLO MARRONE (Trieste) marrone@units.it
FERDINANDO MENGA (Caserta) ferdinandomenga@gmail.com
RICCARDO DAL FERRO (Schio) dalferro.ric@gmail.com
COMITATO SCIENTIFICO:
Elvio Baccarini, Cristina Benussi, Lucio Cristante, Renato Cristin, Roberto Festa,
Giovanni Giorgini, Edoardo Greblo, Macello Monaldi, Fabio Polidori
�
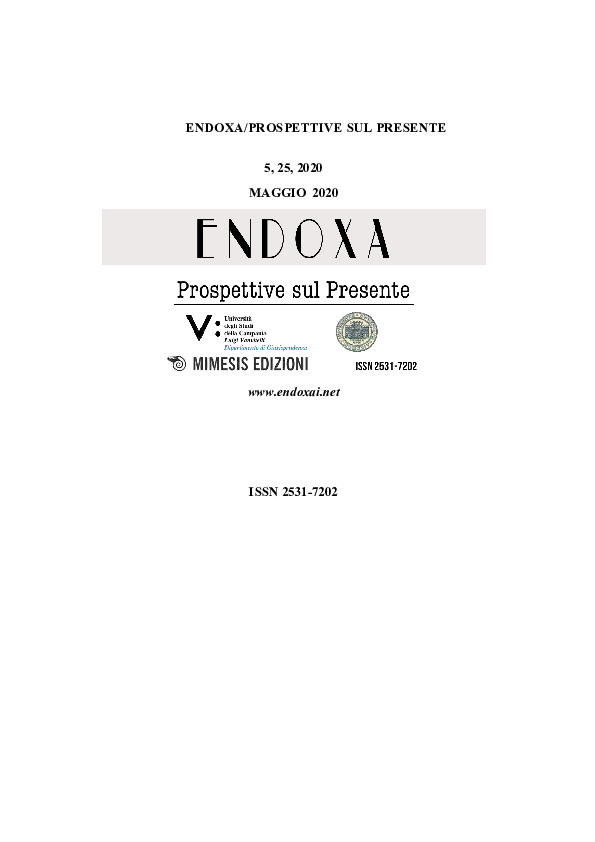
 Andrea Raciti
Andrea Raciti