Bollettino Filosofico
XXXIII (2018)
RIPENSARE LA FENOMENOLOGIA,
CON E OLTRE
�Bollettino Filosofico
XXXIII (2018)
RIPENSARE LA FENOMENOLOGIA,
CON E OLTRE
In copertina:
Paul Klee, Open Book (Offenes Buch), 1930 - Solomon R. Guggenheim Museum, New York, Estate of
Karl Nierendorf.
�Pubblicata da:
FedOAPress - Università di Napoli “Federico II” Piazza Bellini 59-60
80136 Napoli
Realizzato con Open Journal System
ISSN: 1593 - 7178
E-ISSN 2035 - 2670
Bollettino Filosofico è indicizzata in:
The Philosopher’s Index
Google Scholar
Google Libri
ROAD
Jurn
EZB – Elektronische Zeitschriftentbibliotek
ESCI- Clarivate Analytics
Web of Science
L’Anvur ha classificato la rivista Bollettino Filosofico come Rivista Scientifica nell’area 11
�BOLLETTINO FILOSOFICO
Editor in Chief
Pio COLONNELLO
Steering Committee
Pio COLONNELLO (Università della Calabria) Sergio GIVONE (Università di Firenze)
Eugenio MAZZARELLA (Università di Napoli - Federico II) Carlo SINI (Università
Statale di Milano)
Editors Committee
John ABBARNO (University of Buffalo - New York) Mauricio BEUCHOT PUENTE
(IIFL-UNAM - México) Franco BIASUTTI (Università di Padova) Horacio CERUTTI
GULBERG (CIALC-UNAM - México) Enrique DUSSEL (UNAM - México) Roberto
ESPOSITO (Scuola Normale Superiore di Pisa) Raùl FORNET BETANCOURT (Bremen
Universität) Carlo GENTILI (Università degli Studi di Bologna) Sergio GIVONE
(Università degli Studi di Firenze) Enrica LISCIANI PETRINI (Università di Salerno)
Eugenio MAZZARELLA (Università di Napoli “Federico II”) David ROBERTS
(University of Georgia - USA)
Consulting Editors
Roberto BONDÌ (Università della Calabria) · Romeo BUFALO (Università della
Calabria) · Fortunato M. CACCIATORE (Università della Calabria) · Felice CIMATTI
(Università della Calabria) · Ines CRISPINI (Università della Calabria) · Silvano
FACIONI (Università della Calabria) ·Fabrizio PALOMBI (Università della Calabria)
Editorial Team
Ingrid BASSO (Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano)
Vincenzo BOCHICCHIO (Università della Calabria)
Giuseppe BORNINO (Università della Calabria)
Deborah DE ROSA (Università della Calabria) - Secretary
Gualtiero LORINI (Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano)
Luca LUPO (Università della Calabria)
Maria Lida MOLLO (Università della Calabria)
Marco RISADELLI (Università della Calabria)
Ivan ROTELLA (Università della Calabria)
Emilio SERGIO (Università della Calabria)
�Indice
Focus
8 Illusione ed errore. Il dogma dell’intuizione e le avventure
fenomenologiche di Max Scheler
Stefano Besoli
52 Comme Dieu et comme Rien. Variations sur le nom de khôra
Danielle Cohen-Levinas
56 Percepire e comprendere
Vincenzo Costa
71 Tempo e arte: note per una fenomenologia
Ivo De Gennaro
85 Il paesaggio sociale: essenza e forme degli atti di empatia
Francesca De Vecchi
100 Elementi per una nuova fenomenologia dell’a priori culturale
Stefano Gonnella
114 Remarks on Appearing and Appearance in Husserl
Burt C. Hopkins
129 Plato is not Platonism: Musings on the Derivative De-eroticized
Nature of the Modern Subject
Marylou Sena
145 Husserl e la natura degli antichi Greci
Carlo Sini
�150 Due domande sulla natura dell’immaginazione
Paolo Spinicci
160 Il significato metafisico della teoria della conoscenza fenomenologica
Emiliano Trizio
Forum
176 Il valore teoretico della fenomenologia “classica” di Edmund Husserl
ed Edith Stein e il suo contributo alla fondazione delle scienze umane
Angela Ales Bello
185 Le conclusioni della filosofia del conoscere. Appunti sul programma
“razionalista” di Husserl e Bontadini
Daniele De Santis
208 Patočka y Henry. A-subjetividad y Fenomenología material: dos
modalidades de realismo fenomenológico
Eduardo Gonzáles Di Pierro
217 Come la fenomenologia diventò faneroscopia: il progetto di Peirce di
una “Filosofia Suprema”
Rossella Fabbrichesi
226 Per una nuova fenomenologia della natura. La filosofia delle
atmosfere di Gernot Böhme
Sandro Gorgone
239 La logica non-aristotelica da un punto di vista fenomenologico.
Gotthard Günther e Oskar Becker
Luca Guidetti
�255 Prova e Ragione. Struttura e demarcazione dell’epistemologia della
VI Ricerca logica attraverso alcuni casi di studio
Felice Masi
276 Corpo e Spazio: Husserl, Merleau-Ponty, Lacan
Bruno Moroncini
290 “L’effetto fantasma”: Jacques Derrida e l’“iperfenomenologia”
Fabrizio Palombi
304 “Occorre riflettervi ancora”. Considerazioni in margine a Fantasia e
immagine di Edmund Husserl
Giovanni Piana
308 Jacques Derrida e il non fenomenologico
Caterina Resta
322 Ritmo e durata fra Husserl e Bachelard
Carlo Serra
��STEFANO BESOLI
Illusione ed errore. Il dogma dell’intuizione e le avventure fenomenologiche di Max Scheler
Con lo stesso grado di certezza con cui siamo persuasi che qualcosa avviene
in noi, siamo anche persuasi che qualcosa avviene al di fuori di noi.
Comprendiamo benissimo le parole internamente e esternamente a noi. Non c’è,
e difficilmente ci sarà qualcuno che non sente questa differenza; questo è
sufficiente per la filosofia: non dovrebbe oltrepassare questo limite:
diversamente è fatica inutile e tempo perso. Poiché comunque siamo le cose è
ormai accertato che noi non possiamo saperne altro che quello che è nella nostra
rappresentazione. Per questo verso, che io credo esatto, la questione se le cose
siano veramente al di fuori di noi e siano proprio come noi le vediamo è senza
senso. […] Non m’importa davvero molto se questo lo si voglia chiamare
idealismo. Non dipende dai nomi. È almeno un idealismo che attraverso
l’idealismo riconosce che ci sono cose al di fuori di noi e che tutto deve avere
una causa; cosa si vuole di più? […] Al di fuori di noi. È molto difficile dire
come siamo giunti a questo concetto poiché noi veramente sentiamo solo in noi.
Sentire al di fuori di noi è una contraddizione: ciò che noi sentiamo è soltanto
una modificazione di noi, dunque è in noi. Poiché questi mutamenti non
dipendono da noi, noi li attribuiamo ad altre cose che sono fuori di noi e poi
diciamo che esistono cose al di fuori di noi. Si dovrebbe dire praeter nos ma a
praeter noi sostituiamo la proposizione extra che è tutt’altra cosa; vale a dire, noi
pensiamo queste cose nello spazio al di fuori di noi; questo evidentemente non è
una sensazione ma pare sia qualcosa che è intimamente connessa con la natura
della nostra facoltà di conoscenza sensibile; è la forma in cui ci è data la
rappresentazione del praeter nos, la forma della sensibilità.
G.Ch. Lichtenberg, Osservazioni e pensieri
1.
Nell’elaborazione peculiare di certi motivi fenomenologici, la riflessione concettuale di Scheler
assume una coloratura sempre più intensa man mano che si evolve il suo cammino di pensiero. Al
contempo, l’originalità, speso abusata, della filosofia di Scheler è consistita, fin dalle prime mosse,
nel tentativo di sottrarsi alle maglie della fenomenologia husserliana, ritenuta a torto colpevole di
aver preso congedo dall’orizzonte delle Logische Untersuchungen che, per un’intera generazione di
filosofi, aveva rappresentato il baluardo più affidabile nei confronti di ogni costruttivismo di stampo
idealistico-trascendentale e dell’empirismo psicologico di segno naturalistico, indicando come la
soluzione dei problemi filosofici – lungi dal poter essere rintracciata in astratti principi razionalistici
o nella faticosa individuazione di criteri di conoscenza indiretti – andasse senz’altro trovata a livello
di pura datità fenomenica e del suo coglimento intuitivo. Lungo questa via, che comportava un
graduale distacco dal programma di ricerca inerente alla «vita dello spirito» euckeniana e al
rispettivo metodo noologico, Scheler assume un impegno decostruttivo da attuare tramite una
filosofia riferita alle cose, una «Sachphilosophie»1 atteggiata allo studio degli aspetti contenutistici
e materiali dell’esperienza che eccedono il piano positivistico dei meri fatti, non essendo di
principio concepiti in modo atomistico proprio perché ammettono, sotto il profilo costitutivo, una
configurazione di senso che rende le «cose» passibili di una sistemazione teleologica. Non essendo
legata alla tradizione o a un sapere di scuola soggetto al culto dell’autorità, né identificandosi con
l’impianto dottrinario di un qualsiasi «filosofia del punto di vista», l’impeto di tale Sachphilosophie
– in parte già inaugurata dalle indagini neutrali condotte in seno all’«opera di rottura» husserliana
Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna
1
Scheler (2013), p. 32. Al riguardo, si veda anche Scheler (1973), p. 327, con riferimento ad aggiunte risalenti a
manoscritti del Nachlass del 1927, che Frings ha pubblicato in appendice a Die deutsche Philosophie der Gegenwart.
Bollettino Filosofico 33 (2018): 8-51
ISSN 1593 -7178 - 00030
E-ISSN 2035 -2670
DOI 10.6093/1593-7178/5901
�Illusione ed errore. Il dogma dell’intuizione e le avventure fenomenologiche di Max Scheler
che aveva dischiuso il percorso della fenomenologia pura – elegge a guida metodica il principio del
«primato dell’essere sul conoscere», che non smarrisce l’opportunità di offrire una soluzione più
stabile anche alle «questioni metafisiche delle visioni del mondo», fino quasi a congiungersi – in
maniera peraltro involontaria – con l’«idealismo obiettivo delle idee», al quale però si lega solo per
l’esigenza di approfondire la concretezza dei problemi filosofici2.
In verità, il tentativo scheleriano di oscurare, dai suoi trascorsi filosofici, la presenza di nuclei
dottrinari riconducibili a una varietà di scuole neokantiane e al programma della metafisica
neoidealistica di Eucken, così come il modo fantasioso o, per meglio dire, inventato ad arte, di
ricostruire l’incontro elettivo con la filosofia di Husserl trovano riscontro nel fatto che in uno scritto
celebrativo kantiano del 1904 non ci fosse ancora traccia di una propensione fenomenologica per la
«Wendung zu den Sachen», giacché Scheler continuava a quell’altezza a riservare i propri favori a
un funzionalismo costruttivistico di stampo trascendentale, rispetto alla risoluzione obiettivistica
offerta dalla concezione greca della conoscenza e della scienza3. Solo a partire dal 1907, dopo
essere cioè entrato in contatto, a München, con gli allievi di Lipps che, per sfuggire
all’impostazione psicologistica del maestro, avevano trovato riparo sui lidi più rassicuranti della
fenomenologia husserliana, Scheler avviò un primo riorientamento significativo della propria
filosofia, senza che questa si sia mai però allineata ai tratti realistici della «fenomenologia
dell’oggetto», ancorché gli stessi sviluppi del pensiero scheleriano si siano contraddistinti, in
negativo, per l’uso disinvolto di un intuizionismo sprovvisto di metodo. Malgrado le evidenti
assonanze con molti argomenti presenti nelle riflessioni di Reinach e Pfänder, così come il suo
uniformarsi all’«ethos di una dedizione» al mondo colto nei suoi tratti essenziali, dalla quale
scaturiva, nel segno di una «fenomenologia materiale», un contrasto ai caratteri razionalistici e
naturalistici tipici dello scientismo formalistico dell’epoca, Scheler non ebbe mai il desiderio
d’intestarsi un patrimonio d’idee provenienti dalle funzioni di «stimolo» esercitate da Husserl, al
quale non volle mai del resto riconoscere un effettivo ruolo di «guida»4. L’ambizione di Scheler non
poteva essere, infatti, quella di rivendicare la leadership di un movimento fenomenologico, del
quale disconosceva sia l’unità di scuola, sia quello spirito di sistema attraverso cui esso avrebbe
potuto banalmente tramandare un «contenuto di sapere obiettivo»5, ravvisando semmai in tale
formazione collettiva l’opera di una reale cooperazione retta dalla «comune convinzione che solo
attraverso il ritorno alle fonti originarie dell’intuizione e alle evidenze eidetiche ricavabili da essa si
possono utilizzare le grandi tradizioni della filosofia in base a concetti e problemi, e che solo per
questa via i concetti possono essere chiariti intuitivamente e i problemi essere posti di nuovo su
base intuitiva, e quindi anche essere per principio risolti»6.
Senz’affiancare la propria posizione a quella degli altri fautori di un rilancio dell’indagine
fenomenologica, che avrebbe dovuto estendere l’esplorazione delle essenze a campi fino a quel
momento inesplorati, Scheler sembrò piuttosto voler imprimere alla fenomenologia – con ben
maggiore radicalità – un indirizzo del tutto particolare, che ne mutava al tempo stesso la fisionomia,
scardinandone l’impianto. Il richiamo alla fenomenologia husserliana, che Scheler in maniera
sintomatica interpretò – in chiave storica – come una sorta di «rinnovamento del platonismo
intuizionistico», senza peraltro gravare tale filosofia delle «aggiunte mistiche» e della «reificazione
delle idee» che si è soliti attribuire a Platone7, diede luogo a un’indagine, «in senso ontologico e
2
Cfr. Scheler (1957), p. 261.
Cfr. Scheler (1957/19863a), in particolare pp. 356 ss. Si tratta di Kant und die moderne Kultur. Ein Gedenkblatt
(1904).
4
Cfr. Scheler (1973), p. 327.
5
Ivi, p. 309.
6
È un brano del manifesto editoriale dello Jahrbuch husserliano, in cui i curatori della rivista, tra i quali Scheler,
esprimono l’ufficiale condivisione di un determinato indirizzo metodico (Jahrbuch für Philosophie und
phänomenologische Forschung, Bd. I, 1913, p. V s.). Sul fatto che per Scheler non si potesse propriamente parlare di
una «Scuola fenomenologica», ma solo di una cerchia di studiosi animati da un atteggiamento d’indagine in larga parte
comune, cfr. Scheler (1957/19863b), p. 379.
7
Scheler (1973), p. 310.
3
�Stefano Besoli
realistico, delle componenti essenziali del mondo e dello spirito, che sono accessibili solo mediante
intuizione immediata ed evidente»8. L’esplicitazione di un programma così vasto, reminiscente di
certe aperture delineate da Reinach, conferma l’impressione che l’«etica materiale dei valori» fosse
qualcosa più di una semplice tappa dello sfruttamento strumentale del metodo fenomenologico,
poiché – a ben vedere – anche nella dichiarata autonomia, rispetto alla logica, della «fenomenologia
dei valori» e della «fenomenologia della vita emozionale», s’impone il senso di una ricomposizione
unitaria che ingloba lo stesso terreno del «pensiero emozionale», prefigurando la chiara
destinazione metafisica della riflessione scheleriana, poiché nell’«apriorismo dell’amore e
dell’odio» – quale espressione di una specifica concretezza materiale di natura assiologica – risiede
il «fondamento ultimo di ogni altro apriorismo», ovvero in esso non si appalesa il banale
stratagemma neokantiano che inverte il primato della ragion teoretica in quello della ragion pratica,
ma la «definitiva connessione e unità fenomenologica» riguardante le «sfere della teoria e della
prassi»9.
2.
È lo stesso Scheler a dichiararsi non simpatetico sia nei confronti di una fenomenologia ridotta ad
analisi psicologico-descrittiva, sia di quella fenomenologia realista che aveva fatto del motivo
ontologico la sua unica ragion d’essere, estromettendo dalle proprie indagini qualunque
coinvolgimento metafisico. Scheler non voleva proporsi, quindi, a punto di riferimento di un
indirizzo ingenuamente realistico, anche perché aveva visto prevalere in esso un’assoluta
frammentarietà delle ricerche, che spesso si attardavano a sviluppare una considerazione quasi
ossessiva delle singole essenze, degna di una «fenomenologia da libro illustrato»10. Sebbene il
pensiero di Scheler sia stato criticato spesso per il carattere contraddittorio di certe sue tensioni
difficilmente conciliabili, per l’eccessiva ampiezza della sua ricettività e la tendenziale
incompiutezza – nonché per il privilegio accordato al rispetto dei fenomeni a fronte di una volontà
di sistematizzare che si era non di rado tradotta in un’opera di semplificazione in cui, togliendo la
parola alle cose, si era giunti a subordinare alla coerenza teorica la pienezza che scaturisce dai
valori della vita – esso si consegna alla dimensione plurale della realtà e dei suoi valori, senza
necessariamente cedere alla dispersione. D’altronde, un’autentica impostazione filosofica non
poteva per lui abdicare dal perseguire un «carattere sistematico», tale da privilegiare le connessioni
essenziali in cui le «cose del mondo» appaiono strutturalmente inscritte11, al fine di esplicitare così
– nell’«apertura» cui tale sistematicità può tendere – il senso di un’opera di dedizione all’a priori
del mondo, come rimedio al presunto cedimento idealistico della fenomenologia husserliana.
Con gli esponenti dei primi Circoli fenomenologici di München e Göttingen, Scheler condivise
l’illusione di una convergenza prospettica tra le concezioni di Husserl e Kant, che si sarebbe
consumata con la comparsa del primo volume delle Ideen (1913), allorché sembrò concluso il
rientro nell’alveo del trascendentalismo kantiano che Husserl aveva iniziato a delineare con
l’approccio alla tematica costitutiva e alla problematica della riduzione fin dal 1907 (Die Idee der
Phänomenologie). Complice una visione semplificata e distorta della pratica riduttiva 12 e la
8
Scheler (2009), p. 7. Si tratta della presentazione alla seconda edizione del 1922 di Metodo fenomenologico e
metodo trascendentale (1900), coeva quindi a Die deutsche Philosophie der Gegenwart.
9
Scheler (2013), p. 147 e n. 17.
10
Ivi, p. 5.
11
Ivi, pp. 5 ss.
12
È noto come Husserl disapprovasse in toto la lettura scheleriana della sua conduzione fenomenologica, e che
anche in relazione al tema della riduzione non abbia mancato di sottolineare che si trattava di un «lettore così
superficiale al punto da confondere riduzione trascendentale e riduzione eidetica» (cfr. Cairns, 1976, p. 105). Il
sospetto, però, è che Scheler non abbia semplicemente confuso le due operazioni, che insieme costituiscono il plesso
solitamente definito come riduzione fenomenologica (vale a dire, la riduzione trascendentale e quella eidetica), ma che
le abbia per così dire annullate in un’indistinta opera di «derealizzazione del mondo», che – in qualità di unica tecnica –
funge da «condizione di essenzializzazione» di ogni essere ed esperienza contingente, denunciando così il vero
significato della metafisica scheleriana. Cfr. ad es. su ciò, Scheler (2018), pp. 89 ss. A supporto di ciò, come riferito da
Boyce Gibson (1971), p. 75, Husserl era dell’avviso che né Scheler, né Geiger e gli altri allievi monacensi avessero
10
�Illusione ed errore. Il dogma dell’intuizione e le avventure fenomenologiche di Max Scheler
pregiudiziale opposizione ad ogni processo costitutivo, che gli impedì tra l’altro di cogliere
l’eterogeneità tra il senso attribuito da Husserl alla teoria della costituzione – già presente, in
maniera embrionale, nelle analisi specificatamente soggettive avviate nelle stesse Ricerche logiche
– rispetto all’attività costruttiva e di messa in forma attribuibile alla pura spontaneità di un soggetto
di natura criticistico-trascendentale, Scheler assecondò con particolare vigore il rifiuto della
presunta svolta idealistica compiuta da Husserl, la quale avrebbe comportato l’affermazione di un
«idealismo gnoseologico» prossimo alle posizioni di Berkeley, Kant e Natorp, ma soprattutto si
sarebbe esaurita in uno studio eidetico delle strutture della coscienza, in una morfologia pura tale da
rendere assoluto il primato di un immanentismo coscienziale d’intonazione cartesiana, che aveva
acquisito ai suoi occhi l’ulteriore difetto di rappresentare il «principale ostacolo alla costruzione di
una metafisica basata su una teoria delle essenze»13, non ristretta a un dominio arbitrariamente
privilegiato sotto il profilo fondazionale.
È in questo modo che Scheler, tramite un’impostazione fenomenologica incentrata sul
riconoscimento della materialità dell’a priori e su un potenziamento della «visione» oltre i margini
che le erano solitamente consentiti, si risveglia dal «sonno idealistico» provocatogli dall’eccessiva
contiguità con la tradizione di pensiero neo-kantiana, piegando però il programma della
fenomenologia di Husserl a un disegno che rispecchia la sua piena vocazione antropologica, con la
quale tratteggia i contorni di una nuova scienza dell’uomo, dilatata dagli orizzonte di spiritualità
della persona, la cui «apertura al mondo» coniuga la partecipazione a ciò che di più essenziale vi è
in esso. Solo attraverso un atteggiamento che supera «ogni struttura d’esperienza vissuta dell’uomo
naturale», con le relative unilateralità, si ottiene consapevolezza circa la possibilità di «accedere ai
valori sussistenti oggettivi e di abbattere le pareti della prigione che ci isolano da essi e di lasciar
penetrare di nuovo, per così dire, la luce del giorno, la “visione del giorno” – come la definisce
opportunamente Fechner – nell’occhio spirituale con cui sentiamo i valori» 14. Di qui l’immane
portata che Scheler assegna all’atteggiamento (e non al metodo) fenomenologico, il cui compito è di
scandagliare le «strutture di essenze e d’idee a priori che intessono e dominano (nel senso della
validità), come logos obiettivo, l’intera realtà del mondo»15, eleggendo a portatore di luce e di
buona novella un discorso che emerge nell’atto di darsi a un’esperienza interamente permeata di
valori, la cui materialità è raffigurabile o, per meglio dire, intuibile nella sua pienezza, non essendo
il contrassegno a priori di una vuota legge formale.
Il distacco da una fenomenologia husserliana che sembrava aver imboccato con decisione la via
di Marburgo, e da un modello rappresentazionalistico dell’intenzionalità in cui ora inizia a stagliarsi
il momento emozionale come veicolo di una partecipazione ontologica alle cose, chiede a un
intuizionismo spinto al limite la prova che la vita emozionale non è mai una forma approssimata e
imperfetta del conoscere. Difatti, fissando un’equivalenza sostanziale tra «intuizionismo
emozionale» e «apriorismo materiale»16 si ha che, «in contrasto con ogni cosiddetto “fenomenismo”
e agnosticismo, una filosofia fondata sul procedimento della visione fenomenologica delle essenze
può asserire che in ogni sfera del mondo esterno e interno l’essere assoluto è conoscibile in maniera
evidente e adeguata. Ogni effettiva separazione e divorzio del nostro spirito da quest’essere non
poggia su una costituzione immutabile dello spirito conoscente, ma solo su debolezze e inclinazioni
davvero compreso il senso della riduzione trascendentale. Sui dubbi che Husserl nutriva circa l’uso del tema della
riduzione in Scheler, e in particolare sul fatto che questi potesse anche solo lontanamente convergere col senso della
riduzione fenomenologica da lui concepita, si veda Leonardy (1999), p. 38 s. Cfr. anche Husserl (2002), vol. 1, p. 419
(Postilla alle Idee), laddove si lamenta la diffusa incapacità d’intravedere la novità di principio costituita dalla riduzione
fenomenologica, ovvero l’ascesa dalla soggettività mondana a quella trascendentale, con il rischio – segnatamente nel
caso di Scheler e Heidegger – di dar luogo con ciò a un «antropologismo o psicologismo trascendentale». Per la
riduzione fenomenologica intesa come «tecnica di sospensione della resistenza e come atto che definisce in senso
proprio lo spirito umano, cfr. Scheler (2002/20084), pp. 135 ss. Sulle vicende teoriche della riduzione fenomenologica
in Scheler cfr., in particolare, Avé-Lallemant (1975) e Janssen (1994).
13
Scheler (1973), p. 311.
14
Scheler (2013), p. 531.
15
Scheler (1973), p. 310.
16
Scheler (2013), p. 13.
�Stefano Besoli
della natura umana di principio superabili. Ma se appunto la filosofia fenomenologica ritiene di
poter dimostrare questo principio che innalza di nuovo la metafisica ai suoi antichi diritti, e con essa
un vivere e un essere orientato verso datità assolute, le è prescritto allora un duplice compito:
indagare con profondità e precisione le molteplici forme d’isolamento dell’uomo dall’ente [...], e
parimenti le ragioni e i motivi di ogni possibile direzione illusoria riguardo a Dio, alle cose esterne
e a se stessi»17.
In questa caratterizzazione di una «filosofia fenomenologica»18, la cui identità si stempera in un
intuizionismo al servizio di un atteggiamento morale tendenzialmente ascetico, che funge da passepartout per l’accesso alla sfera dell’assoluto, sublimando una tecnica di riduzione – alquanto
controversa – in uno slancio d’amore indirizzato all’essere che ha sommo valore, prende corpo una
sedicente «fenomenologia d’orientamento realistico»19, in cui il fenomeno è sottratto ai vincoli della
coscienza e l’alterità dell’essenza guadagna i connotati assiologici esibiti dal conseguente
obiettivismo. Al riguardo, non vi è dubbio che Scheler pensasse di poter sancire – a partire sua
critica del formalismo kantiano – una secessione già in atto, rendendola ancor più palese per il fatto
di averla materialmente proclamata dalla tribuna dello Jahrbuch husserliano, ovvero sull’organo
ufficiale del cosiddetto movimento fenomenologico. Il primo grande strappo di tale movimento non
avviene dunque per effetto delle singole prese di posizione che si opponevano a un’esplicita
configurazione trascendentale della fenomenologia, ma si registra sul piano dell’essenzialismo
ontologico di cui Scheler traccia le coordinate, coltivando l’ambizione ermeneutica di aver
compreso Husserl meglio di quanto lui stesso fosse stato in grado di fare, non solo per aver
mantenuto la filosofia a un livello di rigore che prescindeva da ogni richiamo alla scientificità 20, ma
soprattutto per essere riuscito quasi paradossalmente a realizzare un percorso inverso rispetto a
quello per lui tracciato da Husserl in senso involutivo, ovvero emendandosi progressivamente dal
peculiare idealismo euckeniano e dalle persistenti attrazioni neokantiane, mentre la fenomenologia
husserliana – anche in ragione delle fraseologie di cui si era avvalsa – sembrava destinata a rifluire
nella ben nota tradizione di pensiero coscienzialistica e gnoseologica.
3.
L’impatto della fenomenologia sul pensiero di Scheler inizia ad avvertirsi negli scritti del decennio
successivo alla data del primo incontro (1902) con Husserl, al culmine della crescente
insoddisfazione per il tenore costruttivistico della logica trascendentale kantiana, in funzione del
riconoscimento del fatto che il «contenuto di ciò che è dato alla nostra intuizione è originariamente
assai più ricco di ciò che può esser rivestito in esso da componenti sensibili, dai loro derivati
genetici e dalle forme di unità logiche»21. La constatazione di un necessario ampliamento
categoriale dell’intuizione sanciva per Scheler «l’unione spirituale» con la fenomenologia
husserliana, che si era distinta per il rifiuto del «proton pseudos» kantiano, ascrivibile al ritenere
che «tutto ciò che nel dato non è sensibile, debba essere entrato nell’oggetto dell’esperienza solo
attraverso un’attività costruttiva e sintetica dell’intelletto o dell’intuire, ipoteticamente assunta» 22.
L’adesione a tale presupposto della fenomenologia, che elimina le ristrettezze del sensismo
dogmatico, cercando di portare il dato in prossimità dell’intuizione dopo averlo elevato, attraverso
un procedimento riduttivo di stampo ascetico, alla sua più pura e impregiudicata forma essenziale,
17
Scheler (1999), p. 49 s. (trad. modificata).
Scheler (1955), p. 7 s. (prefazione alla prima edizione del 1915), laddove l’autore continua ad affermare la sua
adesione all’atteggiamento fenomenologico di Husserl, rivelando al contempo che nell’opera sul formalismo sono stati
discussi in maniera approfondita i «principi metodici» di una filosofia che, a questo punto, solo per attribuzione
esornativa potrebbe però dirsi anche fenomenologica.
19
Scheler (1973), p. 299.
20
Cfr. Scheler (2009), pp. 251 ss., laddove Scheler contrasta la preferenza husserliana per la «fenomenologia
dell’atto» e per la «fenomenologia dello psichico» con la sua inclinazione per la «fenomenologia riferita alle cose» e
con le fenomenologie relative ad «altri ambiti d’essere materiali» (trad. modificata).
21
Scheler (1973), p. 308, ma si veda anche p. 296.
22
Ivi, p. 310.
18
12
�Illusione ed errore. Il dogma dell’intuizione e le avventure fenomenologiche di Max Scheler
implica un’estensione del concetto di esperienza al di là di ciò che è empirico in senso stretto,
evocando cioè il ricorso a un’esperienza fenomenologica che promette di essere più a contatto con
la vera natura delle cose, destinata altrimenti a rimanere estranea a un esperire di genere diverso. Al
riguardo, Kant aveva tendenzialmente soppresso l’alterità dell’estetica, assorbendo il senso
dell’oggettività nelle condizioni logiche della conoscenza, comprensive di quell’aspetto formale dei
fenomeni che appare rilevante per le finalità del trascendentalismo. L’errore di Kant era consistito
nel rifiutare ogni dato che non fosse al contempo sensibile, rinunciando a interrogarsi sulla sua
possibile estensione o, per dirla nel lessico della fenomenologia husserliana, su quello spettro di
modi di datità in cui si manifesta tutto ciò che, per pregiudizio dogmatico, consideriamo invece
conclusivamente dato. Di conseguenza, il limite di fondo della filosofia kantiana riguardava il fatto
di non aver a sufficienza esplorato «cos’è dato», ricorrendo a un metodo apagogico-regressivo che
puntava a definire – sul piano di una mera organizzazione categoriale – «cosa può essere dato»23,
avviando una mera risoluzione tautologica che non lega le «condizioni di possibilità» ad alcun
contenuto intuitivo, con il rischio di ricadere nello psicologismo, non importa se trascendentale. Le
carenze descrittive del metodo trascendentale provocano infatti un’inevitabile falsificazione
dell’esperienza, giacché considerare l’esclusiva datità di contenuti sensibili porta alla necessità di
presupporre un intervento della soggettività che provveda a plasmare, a mettere in forma, in
maniera proiettiva e quasi «empatica», un materiale di per sé amorfo 24.
Su questa base si delinea, secondo Scheler, il filo rosso che lega la concezione dell’esperienza
empirista a quella sostenuta da Kant, che l’ha per lo più introiettata in senso acritico, risultando
debitore di quel sensismo humeano, della cui problematicità egli pensava di poter essere invece la
soluzione. In consonanza con le tesi già espresse da Bergson, Scheler non accetta che il dato possa
essere inteso come un «“caos” d’impressioni» privo di un ordine e di una qualsiasi cornice
contestuale25, ovvero – per dirla con Kant – come un «ammasso di fenomeni» o una «rapsodia di
percezioni», che proprio per questa loro naturale impurità scatenano il ricorso a una funzione
sintetica che impone di necessità a tali contenuti la legalità di cui sono sprovvisti, definendo le
condizioni di un’unità trascendentale che dà forma a un’esperienza comme il faut. Calato
nell’atmosfera più congeniale per coltivare il suo modo di pensare intuitivo, con il quale avrebbe
cercato di «strappare l’eterno» ai decorsi di un’esperienza fuggevole, Scheler sembrò schierarsi
subito a favore di una fenomenologia intravista più come «nuovo atteggiamento filosofico» che
come una «scienza delimitata», più come una «nuova arte della coscienza intuitiva che un
determinato metodo del pensiero»26. Con tale forma d’intuizionismo, che incorporava accenni
provenienti sia dall’anti-intellettualismo proprio del «realismo intuitivo» bergsoniano 27, sia
dall’intellettualismo costruttivistico di Schelling, Scheler era esposto a rischi ancora maggiori di
quelli che gravavano costantemente sull’intuizione fenomenologica, e sull’intuizione in senso lato,
per il fatto stesso di considerare come realmente intuito ciò che invece, in assenza di un adeguato
riscontro metodico, poteva anche solo costituire una mera parvenza intuitiva.
Scheler consolida dunque quest’amalgama teorico attraverso un tipo di apprendistato
fenomenologico: in tale costrutto confluiscono anche l’eredità disseminata del «realismo
intuizionistico»28 di derivazione bergsoniana e alcuni spunti dell’unica tradizione di pensiero neokantiana che egli valorizza, e cioè della Neufriessche Schule inaugurata da Nelson, nella quale non
solo non prevalgono i tratti trascendentalistici dell’a priori che costituivano in particolare la cifra
della concezione marburghese, ma in cui – sulla base del presupposto dell’«esistenza di una ragione
23
Scheler (2013), p. 129.
Ibid.
25
Cfr. Scheler (2013), p. 151.
26
Scheler (1973), p. 309.
27
Cfr. ivi, p. 301. Scheler rimprovera però a Bergson l’assenza, nella sua esposizione filosofica, di un concetto
d’intuizione d’essenza e della corrispettiva forma d’esperienza, così come la grande oscurità del suo concetto
d’intuizione. Cfr. Scheler (1955), p. 327 e n. 1, p. 328 n. 1: si tratta dei Versuche einer Philosophie des Lebens.
Nietzsche – Dilthey – Bergson (1913).
28
Scheler (1973), p. 301.
24
�Stefano Besoli
direttamente intuitiva» – si avanza l’idea che le «somme cognizioni evidenti» non debbano essere
«prodotte», dedotte o costruite, ma unicamente «svelate» con un «metodo riduttivo» basato su
un’«auto-riflessione antropologica», che mostra come tale «possesso a priori del nostro spirito» sia
«scoperto e trovato in modo a posteriori»29.
L’esigenza di un ritorno all’intuizione e la conseguente adozione di un metodo intuitivo
esemplificano il tentativo scheleriano di non operare dall’alto con costruzioni estranee alle cose,
come se queste fossero già in partenza dichiarate inattingibili, ma di ricavare ogni conoscenza dalle
fonti intuitive ultime, colte nell’originale e penetrate per così dire con lo sguardo, afferrando il dato
in maniera diretta e non pregiudicata, al fine di renderne accessibile l’essenza. L’atteggiamento
anti-intellettualistico inerente all’«apriorismo dell’emozionale»30, che bandisce – assumendo i
valori come essenze raggiungibili tramite la figura intenzionale della pura emozionalità – la falsa
coincidenza tra apriorismo e razionalismo, contrasta con la «paura» kantiana di affermare la
funzione vincolante di un’«egoità» trascendentale, le cui mansioni copernicane vengono
erroneamente identificate, da Scheler, con la soggettività costituente della fenomenologia
husserliana, che proprio per le sue prerogative è invece al riparo dal potersi veder attribuire un ruolo
idealistico preminente. Da questo duplice antagonismo nei confronti di un’impostazione
trascendentalistica che si dileguerebbe al solo tentativo di «far saltare gli oggetti oltre il bastone
[…] delle nostre leggi d’esperienza»31, scaturisce un progressivo slittamento della filosofia
scheleriana da un utilizzo parziale della fenomenologia a un «ontologismo dell’essenza»32, e
finanche a un ontologismo della realtà, che presuppone l’approdo metafisico all’«essere assoluto»,
della cui rivelazione – come garante di un «ordine sempiterno delle cose»33 – si può essere
partecipi mediante una trasformazione spirituale guidata dall’umile contegno del rispetto, che
introduce a un regno di essenze ideali non più svalutabili, nella loro qualità di forme dell’«ens a
se», a mero fondamento teorico-scientifico34.
L’approdo che la riflessione scheleriana persegue fin dai suoi inizi contempla che l’essenza, pur
nel suo peculiare statuto fenomenico, non rientri nella sfera di controllo della soggettività, ma
definisca il principio che rende possibile la conoscenza metafisica di ciò che partecipa di una
compiuta inseità e di un’assoluta indipendenza dalla coscienza, con duplice riferimento alla sfera
dei valori e delle essenze e a quella della realtà propriamente intesa. Per quanto sia proprio la
distanza della fenomenologia dal fenomenismo a sancire il carattere ultimativo del fenomeno, e cioè
l’essere indicativo solo di se stesso e l’esser gratuito al massimo grado per il solo fatto di non
fungere da segno di una realtà posta al di là del dato, l’essenza non resta però del tutto ancorata alla
dimensione fenomenica, ma ha nei fenomeni la condizione che ne promuove un’occorrenza
propriamente metafisica, tanto più che le sorti della fenomenologia non si reggono, per Scheler,
sull’opposizione tra «essenza» (Wesen) e «fenomeno» (Erscheinung) o manifestazione, ma tra
«existentia» ed «essentia», tra Dasein e Wesen, per cui la destinazione naturale di tale
atteggiamento può essere solo quella di mostrare, in maniera direttamente intuitiva, le essenze
realizzatesi nel mondo35. In un contesto dai margini così dilatati trova linfa per svilupparsi sia la
concezione scheleriana secondo cui la realtà non può essere posta in termini conoscitivi, ma solo
provata o esperita, sotto un profilo volizionale, nella sua «resistenza»: in altri termini, come ciò
29
Cfr. ivi, p. 191 s.
Scheler (2013), p. 149.
31
Ivi, p. 733.
32
Dupuy (1959a), I vol., p. 264, ma si veda anche p. 291 s., dove si sottolinea la tendenziale unificazione della
filosofia con una «fenomenologia ontologica».
33
Metzger (1933), p. 249.
34
Scheler fornisce un’ulteriore precisazione in ordine alla natura ontologica dell’essenze, affermando – contro il
«falso platonismo» e la replica aristotelica – che le essenze non sono né «ante res» né «in rebus», ma vanno concepite
piuttosto come «cum rebus», essendo «co-originarie» al reale, poiché le stesse cose reali conseguono già dal principio
che pone l’essenza e che pone la realtà con il suo «accidentale essere-così». Cfr. Scheler (1975), p. 251 s. (si tratta dei
Zusätze a Idealismo.realismo, provenienti dal Nachlass.
35
Cfr. Scheler (1973), p. 307.
30
14
�Illusione ed errore. Il dogma dell’intuizione e le avventure fenomenologiche di Max Scheler
contro cui urta ogni comportamento che procede dalla spontaneità delle nostre tendenze vitali 36; sia
la convinzione fondamentalmente contraria alla gnoseologia kantiana, il cui ideale di oggettività è
arroccato in difesa di un pensiero simbolico, concettuale e discorsivo, quando invece lo stile
conoscitivo della fenomenologia consegue il proprio obiettivo laddove «non c’è più una
trascendenza e un simbolo», poiché in tal caso ciò che prima era ancora qualcosa di formale si
trasforma in «materia dell’intuizione»37. Essendo di principio asimbolica, in quanto qualificata da
una perfetta coincidenza tra ciò che è inteso e ciò che è dato, l’esperienza fenomenologica –
nell’immanenza di cui è portatrice – funge quindi per Scheler da paradigma di ogni verifica
intuitiva, costituendo il «pagamento di tutte le cambiali spiccate da ogni altra “esperienza”» 38,
poiché in essa non ha più luogo alcun riferimento oggettuale in forma allusiva o anche solo obliqua.
4.
Le speranze che Scheler indubbiamente nutriva nella fenomenologia, nell’unitarietà che questa
manifestava non in funzione di una ricerca legata a un ben definito ambito oggettuale, ma per
l’evidenza di una «datità nell’originale» (Selbstgegebenheit) capace di assicurare unità ad ogni
possibile dominio cosale39, vanno tuttavia valutate alla luce dell’investimento scheleriano, e cioè
della concezione in cui il pensiero di Husserl viene ad essere ospitato. Nel passaggio di consegne
dalla fenomenologia husserliana al realismo alquanto sui generis predicato da Scheler si ha
l’impressione, ben suffragata, di non trovarsi nel medesimo milieu, nell’avere cioè a che fare con
un’atmosfera culturale mutata di segno. Al riguardo, non si tratta tanto di rimarcare la tendenza
obiettivistica che Scheler rivendica per la propria impostazione, contrapposta – non senza enfasi –
alla svolta trascendentale in cui sarebbe incorsa la fenomenologia husserliana, quanto di considerare
la maggiore concretezza dei problemi da lui affrontati, la loro particolare rilevanza di ordine eticoreligioso e il progressivo ridimensionamento della prospettiva gnoseologica in cui essi trovano
riscontro. Il confronto critico che Scheler intende istituire con la fenomenologia husserliana non
mira a temperarne la natura, adattando il metodo fenomenologico ai temi eletti di volta in volta a
oggetto d’indagine, ma serve da fonte d’ispirazione per convertire la grammatica di pensiero
fenomenologica al perseguimento dei propri fini. Scheler non ambisce, infatti, ad essere un
fenomenologo e tanto meno un fenomenologo puro, giacché gli basta mettere al servizio di proprie
convinzioni già elaborate il linguaggio offerto della fenomenologia stessa, nel tentativo che anche le
posizioni da lui sostenute possano beneficiare della stessa evidenza che era solitamente accreditata
all’analisi fenomenologica.
La portata stabile dell’obiettivismo scheleriano si lega al riconoscimento del primato dell’essere
sulla coscienza, e cioè al principio della dedizione o del ritorno alle cose, che assume però un
significato diverso rispetto allo zu den Sachem selbst husserliano. Anche Husserl aveva
contrapposto la conduzione della propria filosofia dell’esperienza ai modi di procedere
dell’idealismo e del razionalismo in genere, giacché la fenomenologia – essendo una filosofia
basata sull’esperienza – doveva restare ben radicata in essa, in contrasto a ciò che avveniva in altre
filosofie in cui compare solo il richiamo a forme e funzioni della conoscenza, alle loro condizioni e,
36
Cfr. ivi, p. 307, laddove Scheler, rimarcando che la realtà è inaccessibile all’intelletto e alla rappresentazione,
accetta di essere inquadrato – soprattutto per ciò che attiene alla sua dottrina delle «cinque sfere» – nel cosiddetto
«realismo volizionale» (voluntativer Realismus) di matrice essenzialmente diltheyana, ma che tra i suoi precursori
annovera Maine de Biran, Bouterweek e Schopenhauer. Sul realismo della volontà cfr. Scheler (2009), p. 117 e Scheler
(2018), pp. 93 ss. cfr. anche Altmann (1931), p. 8 e Spiegelberg (1960/19823), p. 282 s.
37
Scheler M. (1957/19863b), p. 386. Cfr. anche Scheler (2009), pp. 129 ss. (trad. modificata), laddove si afferma che
il principio gnoseologico dell’evidenza non ha nulla a che fare con il sentimento di evidenza, ovvero con il carattere di
una «certezza soggettiva», ma consiste invece nel fatto che uno stato di cose o uno stato di valore oggettivo risplende, in
base al suo «esser-così», all’interno dello spirito stesso, per cui è presente «in sé» in esso, come correlato di un atto
intenzionale, nel momento in cui «ha luogo una perfetta unità di coincidenza tra i contenuti di tutti gli atti d’intuizione e
di pensiero possibili riguardo a quest’oggetto». Proprio «in» quest’unità di coincidenza come tale è «dato l’oggettuale
[…] stesso nel senso più rigoroso, e dunque in nessun modo una mera “immagine”, “raffigurazione” o “segno” di esso».
38
Scheler (2013), p. 121.
39
Cfr. Scheler (1957/19863b), p. 386.
�Stefano Besoli
quel che più conta, a conoscenze o principi ontologici non esperibili. Se in tale rivendicazione
dell’autonomia dell’analisi esperienziale va rintracciato, quindi, il significato dell’intuizionismo
husserliano che si oppone ad ogni metodo costruttivistico e deduttivo, nel ritorno all’oggetto e
nell’abbandono spirituale al mondo oggettivo c’è, per Scheler, la convinzione che lo spirito umano
sia in grado di cogliere intuitivamente l’evidenza prima inerente all’essere delle cose e
all’indipendenza delle loro determinazioni, in contrasto all’inquieto e febbrile attivismo dell’uomo
moderno, incapace di riconoscere che il pensiero deve solo regolarsi sul mondo, che già possiede
una sua configurazione prima di ogni intervento della soggettività.
Il tenore delle riflessioni di Scheler è espressione di un’incessante mobilità di pensiero, di un
incedere affidato all’eterno cominciamento d’idee improvvise che prevale sul bisogno di
conclusività e sullo stesso possesso di acquisizioni stabili o addirittura definitive. La curiosità
smisurata, unita a una notevole erudizione, rende incline Scheler a un eccesso di digressioni, nelle
quali prende corpo una fuga in avanti delle idee che, nel portato di una vocazione impressionistica e
rapsodica, legittima l’ideale di un «sistema aperto». Il rispetto dei fenomeni e la ricerca del contatto
immediato con le risultanze delle singole scienze non limita però l’esigenza scheleriana di operare
un continuo rimaneggiamento delle idee acquisite e di mettere in questione il livello di
sistematizzazione raggiunto, facendo trasparire il tratto costitutivo di una personalità filosofica
sempre in bilico nel dualismo d’impulso e spirito. In questo quadro disomogeneo, a rischio
d’incoerenza, l’obiettivismo di Scheler è frutto di una predisposizione che esce rafforzata dal
ricorso allo strumento della fenomenologia, tramite cui egli finisce per conferire all’oggetto
dell’intuizione una caratura ontologica di eccessivo spessore. Ciò si deve in particolare al fatto che
la ricerca fenomenologica di Scheler non ha mai goduto di una radicale autonomia, ma è sempre
stata ritenuta funzionale a promuovere la rinascita della metafisica, le cui aspirazioni potevano
essere soddisfatte tramite l’intuizione eidetica e le «conoscenze d’essenza» che rappresentano, per
dirla con Hegel, le autentiche «finestre sull’assoluto»40. In tal senso, la fecondità della
fenomenologia, come via d’accesso al reale assoluto e ad ogni fenomeno originario non ancora
contemplato, non può essere realizzata entro i margini descrittivi di una «fenomenologia
ricostruttiva» che resta inevitabilmente «relativista», ma ottiene la spinta decisiva attraverso una
«fenomenologia dell’essenza» che imprime una destinazione metafisica alla «conoscenza filosofica
fondamentale, [all’]eidetica ontologica di ogni datità del mondo (del mondo interno e di quello
esterno), [che] mette a nudo il logos eterno dinamicamente realizzato in questa realtà contingente
del mondo, come insieme di tutte le essenzialità e delle connessioni e strutture essenziali» 41.
5.
Sebbene l’interesse di Scheler sia stato di certo influenzato dalla «coscienza metodologica»
proveniente dai lavori husserliani e dal senso di unitarietà con cui «l’atteggiamento
fenomenologico» prometteva di non ignorare il «carattere di sistema» intrinseco alle «cose» stesse,
con l’intento di non incorrere in una «volontà di anarchia» del tutto priva di fondamento42, non si
può dire che gli sforzi da lui prodotti rientrino in una concezione rigorosa della fenomenologia. A
parte il crescente dissidio con la teoria husserliana della riduzione e il tendere a una filosofia
d’ispirazione antropologica che Husserl considerava il più esiziale fraintendimento della
fenomenologia autenticamente trascendentale, la tipica impronta scheleriana era già all’opera nel
periodo di gestazione del «Formalismusbuch», giacché – in ordine ai requisiti dell’Einstellung
fenomenologica – Scheler non si peritava di sottolineare che «per quanto riguarda il modo più
preciso di concepire, comprendere e realizzare quest’atteggiamento, e tanto più naturalmente
riguardo alla sua applicazione al gruppo di problemi qui discussi, l’autore rivendica, in ogni singolo
punto, la sua esclusiva responsabilità e paternità»43.
40
Scheler (1975), p. 80.
Scheler (2009), p. 733 (trad. modificata).
42
Cfr. Scheler (2013), p. 7.
43
Ibid. (trad. modificata).
41
16
�Illusione ed errore. Il dogma dell’intuizione e le avventure fenomenologiche di Max Scheler
Le riserve nei confronti della concezione fenomenologica di Husserl si erano peraltro già
manifestate anche negli scritti che precedono il grande progetto riguardante lo sviluppo di un’etica
materiale dei valori, di una logica della vita emozionale fondata sull’apriorità materiale del sistema
dei valori, con la quale si sarebbe potuto operare una critica radicale dell’impostazione kantiana,
scindendo il nesso apparentemente indissolubile tra apriorismo e razionalismo. Negli anni che
accompagnano non solo la realizzazione della prima parte della sua opera più monumentale, ma
anche la realizzazione di un volume (Zur Phänomenologie und Theorie der Sympathiegefühle von
Liebe und Hass, 1913) che, passando per un completo rifacimento, avrebbe poi dato luogo a Wesen
und Formen der Sympathie (1923), Scheler matura un coinvolgimento sempre più elevato per i
cosiddetti vissuti emozionali, stringendo un legame tematico con un territorio fenomenologico non
ancora compiutamente emerso, ma che si mostrava cruciale per l’obiettivo di attuare una
ridefinizione della psicologia e della psichiatria su basi fenomenologiche. In questa chiave, nello
stesso periodo Scheler aveva progettato un’opera (meglio, una quadrilogia) che avrebbe dovuto
nell’insieme intitolarsi Le leggi di senso della vita emotiva o Il senso etico della vita emotiva. Di
quest’opera, che non vide mai la luce, costituisce per certi versi il nucleo e fondamento teorico il
saggio sugli Idoli della conoscenza di sé (1915), già apparso in una veste più ridotta nel 1912, con il
titolo di Über Selbsttäuschungen (Sugli auto-inganni). In questi saggi lunghi, così come del resto
anche nei lavori più strutturalmente organizzati, Scheler mostrava la propria attitudine per il campo
delle discipline scientifiche in generale (tra le quali spiccava la biologia) e un talento non certo
comune per i temi della filosofia della cultura e di un’antropologia che, proprio per la radicalità del
suo esercizio, si sarebbe ben presto candidata a divenire filosofica. Nei lavori di questo breve torno
di tempo, caratterizzato da una produzione di grande intensità, Scheler fa già un uso estremamente
personale dei concetti e dei procedimenti della fenomenologia, rischiando di nuocere al rigore delle
analisi, anche per l’intervento di opzioni filosofiche appartenenti a un retrostante dominio di natura
pratico-morale.
A prescindere dalla rilevanza che Scheler attribuiva alla fenomenologia, nella misura in cui essa
era riuscita a legittimare un apriorismo di tipo nuovo che abilitava a fare riferimento a una pluralità
quasi indefinita di ontologie materiali e a coniugare, con ciò, le istanze del razionalismo e le
richieste del positivismo, respingendo l’opposizione vigente fin lì tra esperienza e pensiero 44, il
valore particolare che l’atteggiamento fenomenologico rivestiva ai suoi occhi consisteva nell’essere
il più efficace strumento per penetrare nel mondo dell’in sé, garantendo quel risveglio della
metafisica che sembrava poter scaturire da una direzione gnoseologica di segno spiccatamente
realistico. Nell’incipit del saggio sugli Idoli della conoscenza di sé, in cui risuona l’eco della logica
del cuore di Pascal, e in cui compaiono analisi assai fini sugli autoinganni che possono intervenire
nella conoscenza di se stessi e degli altri, con considerazioni che si alimentano oltre che della
cultura dei moralisti francesi anche della lezione del grande romanzo ottocentesco (Dostoevskij,
Stendhal e Balzac) e di uno scrittore-filosofo qual è Nietzsche, Scheler attua una dichiarazione
d’intenti sotto forma di citazione o richiamo. In un’opera del 1620 – il Novum Organum –
Francesco Bacone aveva premesso agli sviluppi di una metodologia positiva riguardante l’indagine
del mondo esterno (e dunque della natura) una sorta di trattato negativo circa gli idoli della
conoscenza: vale a dire, quelle inclinazioni naturali all’errore e all’illusione che offuscano lo
specchio del nostro intelletto e che vanno assolutamente cancellate affinché il metodo possa
dispiegarsi non trovando intralci davanti a sé. Gli idoli (o simulacra) non sono, per Bacone, degli
strumenti della conoscenza, ma ne rappresentano un ostacolo, costituendo dei pregiudizi o delle
false nozioni. Sfruttando tale indicazione, Scheler s’improvvisa continuatore dell’impresa
baconiana, di cui inverte però la rotta o il senso di marcia, concentrandosi, dal punto di vista
problematico, sull’affidabilità o assoluta adeguatezza riconosciuta alla percezione interna o
percezione di sé nell’ambito di una ben nota tradizione di pensiero. Scheler intende con ciò scalzare
l’indebito predominio assegnato a questo tipo di percezione, sostenendo che non vi sia ostacolo
maggiore per la conoscenza del mondo psichico dell’assunto che ha contraddistinto la riflessione
44
Cfr. Scheler (1973), p. 310.
�Stefano Besoli
cartesiana e la sua tipica scissione tra mente e corpo, secondo cui la percezione interna, nella misura
in cui essa è indirizzata ai nostri vissuti, sarebbe per così dire esente da inganno, mentre la
percezione esterna, che si rivolge a una realtà di altro genere, sarebbe assai più esposta al
fallimento.
Nel dualismo asimmetrico di tali forme di percezione Scheler coglie la spia del disconoscimento
del fatto che, nella sua individualità, la persona vive prima negli altri e nel mondo cosiddetto
comunitario che in se stessa, mentre si sono spesso sopravalutate le difficoltà che s’incontrano nella
conoscenza degli altri. Nell’impugnare l’assunto di ascendenza cartesiana secondo cui andrebbe
accordato un privilegio assoluto, di natura fondazionale, all’evidenza della percezione interna,
s’intende mostrare come essa sia esposta a illusione al pari della percezione esterna, e anzi per molti
versi lo sia ancora più di questa. Il problema su cui Scheler interviene ha peraltro radici prossime a
lui, poiché lo stesso Brentano – fautore della psicologia descrittiva e maestro di Husserl per ciò che
attiene al suo apprendistato filosofico – aveva asserito, in sostanziale continuità con Descartes,
l’auto-evidenza della percezione interna (innere Wahrnehmung). La percezione interna è, per
Brentano, la chiave che motiva la compagine stessa della psicologia descrittiva, poiché è essa a
dischiudere l’accesso ai processi psichici e alle rispettive componenti, mentre i fenomeni fisici,
pertinenza delle scienze naturali, sono per lo più frutto solo di osservazione. Al rifiuto del carattere
soggettivo e fallibile dell’introspezione od osservazione interna (Selbstbeobachtung) si
contrapponeva, dunque, l’evidenza incontrovertibile che spetta alla percezione interna, che si limita
però al possesso dei propri vissuti senza potersi estendere, se non in maniera indiretta, alle
percezioni interne dell’altro. Il carattere distorsivo dell’introspezione, incapace di lasciare inalterato
l’oggetto su cui è veicolata la nostra attenzione, porta in primo piano, dunque, la conclusività del
tutto affidabile che promanerebbe dalla percezione interna, funzionale a dischiudere l’accesso
conoscitivo ai nostri stati psichici. Reminiscente di una lunga tradizione aristotelica e scolastica, che
Brentano fa però rivivere in un’ottica differente, si fa largo la tesi secondo cui ciò che caratterizza i
fenomeni psichici è che essi contengono qualcosa a titolo di oggetto, anche se ciascuno lo contiene
a proprio modo. In tal senso l’oggetto è contenuto nei fenomeni psichici a titolo di oggetto
immanente, essendogli cioè immanente e godendo perciò di un’«in-esistenza intenzionale»,
qualificabile al tempo stesso come mentale traducendosi in un’esistenza nella mente, in un’esistenza
dell’oggetto in quanto presente alla mente.
Conseguenza di tale impostazione brentaniana è una sorta di sdoppiamento o di distinzione tra
un’esistenza intenzionale e un’esistenza effettiva, che paiono tuttavia andare di pari passo, anche se
quando si ha a che fare con un semplice fenomeno, ovvero con un oggetto immanente cui non
corrisponde una realtà effettiva, si parla di un’esistenza fenomenica o, per l’appunto, solo
intenzionale. Al riguardo, è indicativo considerare come si rapporti, in Brentano, la nozione di
esistenza intenzionale con la dottrina della percezione esterna, dalla quale traspare un fenomenismo
di fondo non dissimile da quello sostenuto da Mach e Comte. Per Brentano, infatti, le qualità
sensibili come i colori, i suoni, il calore ecc. sono meri fenomeni. Ciò non significa, tuttavia, che
egli neghi l’esistenza del mondo esterno, che è la causa di tali sensazioni, ma solo che tale esistenza
è inizialmente solo un’ipotesi dotata di alta probabilità, per cui ai fenomeni fisici – definiti dalle
qualità sensibili che sono oggetto della percezione esterna – non può che essere attribuita, per
difetto, un’esistenza fenomenica o puramente intenzionale, riaffermando con ciò che l’oggetto del
fenomeno psichico è sempre un contenuto immanente. Per questo, nella misura in cui le qualità
sensibili, i cosiddetti sensibili propri, non corrispondono strutturalmente agli oggetti esterni, si è
inevitabilmente soggetti a una serie di gravi illusioni per ciò che concerne la dimensione dei
sensibili comuni (moto, grandezza, figura ecc.) e la realtà di ciò cui essi ineriscono.
Al netto di certe modifiche intervenute nella sua evoluzione di pensiero, e segnatamente al rifiuto
di ascrivere ai fenomeni psichici un’esistenza più riparata e perciò stesso mentale, la dottrina
brentaniana si regge però sul principio secondo cui ogni fenomeno psichico si rapporta a un oggetto,
poiché l’essenza stessa di un intelletto capace di conoscere è rapportarsi a qualcosa. In termini
aristotelici, nel pensare a un oggetto l’intelletto è per così dire attualizzato, ma in tale condizione
18
�Illusione ed errore. Il dogma dell’intuizione e le avventure fenomenologiche di Max Scheler
esso percepisce accidentalmente anche se stesso o, per meglio dire, le proprie attività, per cui qui
sorge, in certo modo, il mito dell’assoluta trasparenza o coscienza di sé, legato alla peculiare
evidenza della percezione interna – una tesi peraltro non dimostrabile anche perché, secondo
Brentano, essa non necessita di esserlo. Avendo escluso la possibilità di procedere in termini
introspettivi, Brentano ritiene però che sia ugualmente possibile avere conoscenza diretta dei nostri
stati mentali, cogliendoli per così dire riflessivamente, nel senso che se ogni atto o fenomeno
psichico è coscienza di un oggetto, riferendosi cioè ad esso, è vero che un fenomeno siffatto è
sempre anche oggetto di una coscienza, ovvero di una coscienza concomitante o di
accompagnamento che coglie incidentalmente o en parergo le caratteristiche essenziali dei
fenomeni psichici, che in tal senso non potranno più in alcun modo risultare inconsci. La condizione
per cui ad ogni fenomeno psichico si aggiunge una rappresentazione concomitante, una coscienza
propriamente secondaria, non apre infatti a una complicazione infinita degli atti psichici, che
darebbe luogo a regresso incontrollabile di riscontri appercettivi. Per sottrarsi a questo rischio,
Brentano sostituisce all’idea di una serie infinita di riscontri appercettivi l’immagine di un cerchio
che si chiude immediatamente su di sé, nella misura in cui il fenomeno psichico e il suo riferimento
oggettuale non costituirebbero che un medesimo fenomeno all’interno del quale il suono, ad
esempio, e cioè il fenomeno fisico, rappresenta l’oggetto primario, mentre il fenomeno psichico del
sentire ha se stesso come oggetto secondario. Senza un oggetto primario in qualità di contenuto
immanente dell’atto psichico non potrebbe esservi né un atto psichico, né l’oggetto della coscienza
secondaria. Come già indicato da Aristotele, ogni pensiero verte su un oggetto differente da sé, ma
si rapporta a se stesso in maniera accessoria. In tal senso, l’oggetto primario manifesta un’effettiva
anteriorità rispetto all’oggetto della coscienza secondaria, essendo questa la condizione
indispensabile affinché vi sia un fenomeno psichico e, di conseguenza, il rapporto per così dire
aggiuntivo rispetto ad esso. Nel suo complesso, il fenomeno psichico comporta dunque una
duplicità di riferimento che non avviene solo in termini di simultaneità, ma realizza una vera e
propria fusione – una reale unità – tra l’atto psichico e la sua relazione coscienziale secondaria,
ovvero tra il fenomeno psichico e la coscienza interna di cui è oggetto. È per questo che si può
parlare, al riguardo, di un solo atto psichico con un duplice oggetto, circostanza che bandisce per
Brentano l’inconscio dalla sfera dello psichico, giacché la serie delle rappresentazioni o atti psichici
si chiude sempre con il secondo termine, costituendo una sorta di atto unico.
Per Brentano, la percezione interna è un atto che ha una direzione ma non uno svolgimento
temporale. Esso non si rivolge primariamente a se medesimo, ma è indirizzato a una coscienza
primaria. Tuttavia, non dipanandosi in un processo di ordine temporale, tale percezione è per così
dire sempre presente a se stessa, restituendoci la conoscenza di ciò che è attualmente dato, ovvero
del “che” dell’atto psichico, senza darci invece ulteriori informazioni sul “come” di tale dato, sulle
particolarità e differenze che lo concernono. Questa condizione, che determina il carattere di
confusione, indistinzione e incompletezza della percezione interna, può portare a fraintendimenti e
finanche a possibili errori45, ma non può metterne in discussione la caratteristica peculiarità,
rappresentata da un’evidenza immediata che esclude alla fonte ogni tipo d’illusione ed è
rigorosamente limitata al presente, senza che però l’identità ravvisabile nel paradigma della
coscienzialità brentaniana trasformi di fatto il cogito cartesiano in un ben più neutro es denkt.
45
Al di là del carattere fallace della percezione esterna, anche la percezione interna presenta però, per Brentano,
possibili fonti di errore, riguardanti la sua limitatezza e il non avere conoscenza precisa dei singoli momenti dell’atto
psichico, il fatto di non notare e dunque la convinzione di aver notato-che-non, il passaggio dalla percezione interna alla
memoria e, da ultimo, l’espressione linguistica del contenuto memorativo. Nell’ultima fase del suo pensiero, e cioè
dopo il 1900, Brentano opera però una distinzione tra una concezione ristretta e una più ampia di percezione interna,
rilevando come tramite la percezione interna non si ottenga solo una conoscenza confusa e indistinta di una totalità, ma
si possano cogliere in maniera chiara anche le singole determinatezze o relazioni psichiche di cui si compone ciò che è
esistenzialmente dato dal punto di vista psichico.
�Stefano Besoli
6.
Nel suo tentativo di vestire i panni di Bacone riguardo alla percezione interna, mostrando le
illusioni cui si va incontro nella conoscenza di sé, Scheler elenca un ampio spettro d’illusioni che
racchiude quelle dovute alla tendenza psicologistica a imitare la scienza fisica; le illusioni
comparabili a proiezioni attraverso cui attribuiamo processi interni al mondo esterno o, viceversa,
processi esterni a noi stessi; illusioni derivanti da meccanismi inconsci, com’è il caso della
rimozione in Freud, di cui Scheler tenta tra l’altro di offrire un’interpretazione fenomenologica;
quelle che provengono dall’assenza o dalla presenza di una terminologia congrua ai fenomeni
considerati e, da ultimo, per restare solo ai casi principali, le illusioni dovute alla nostra tendenza a
trattare l’auto-osservazione come mera imitazione di altri tipi di osservazione.
Il senso che accompagna l’indagine di Scheler sulla natura delle illusioni, candidata a essere un
contributo decisivo alla teoria delle illusioni in generale, ma anche l’esigenza di svalutare la
presunta evidenza della percezione interna, lo conduce a farci vedere come in molti stati della
percezione di sé il fisico non sia realmente separato e diviso dallo psichico, giacché ci possono
essere ad es. dati di fatto fisici che comportano caratteristiche intensive e qualitative, e non solo
quantitative ed estensive. D’altra parte, anche la sensazione della nostra corporeità vivente non è un
dato psichico, pur essendo priva di estensione. Ad esempio, nel senso di oppressione o di sforzo,
come quando siamo ostacolati da una forza o da una tensione, si ha la sensazione di un toccarsi e di
un congiungersi di psichico e fisico. Inoltre, ci sono stati psichici e processi interiori che sono
oggetto della percezione interna, senza che ciò comporti un riferimento cosciente all’io (come nelle
rappresentazioni coatte o nei processi di carattere autistico). In definitiva, il fisico e lo psichico,
l’esteriorità e l’interiorità sono, nell’uomo, solo due aspetti diversi o direzioni distinte
dell’autocoscienza della persona, che divergono quanto al loro modo essenziale di manifestarsi, ma
che non sono indipendenti o irrelate tra loro. Di conseguenza, la percezione di sé si mostra in
conflitto, sotto questo profilo, più con la percezione dell’altro che con la percezione esterna
propriamente intesa.
Nel trattare questi temi, Scheler dà prova di una capacità di penetrazione davvero non comune,
ma resta anche vittima del suo stesso pensiero, non riuscendo a fermare l’impeto che lo trascina
verso sempre nuovi confini od orizzonti problematici, con il rischio di ritrarre o anche solo mettere
in discussione ciò su cui sembrava essersi assestata la sua riflessione. Nondimeno, la valenza
obiettivistica delle sue considerazioni si nutre di evidenze materiali che, pur essendo acquisite
tramite una certa disposizione metodologica, non conseguono dalla tendenza – già ampiamente
lamentata da Lotze – di consacrare ogni sforzo ad affilare il coltello senza mai tagliare alcunché.
Infatti, Scheler non intende esaltare il carattere puramente metodologico della filosofia, che ne
avrebbe ridotto l’ambito di autonomia rispetto alle scienze, ma chiede al metodo fenomenologico di
assicurare alla filosofia un punto di partenza da cui procedere in maniera inattaccabile, rimettendola
in contatto con il proprio oggetto per conferirle una fecondità di natura non solo teoretica. Il
principale risultato che Scheler ottiene nella sua disamina delle Selbsttäuschungen riguarda
senz’altro il fatto che le fonti d’illusione della percezione interna sono legate al mancato
riconoscimento della realtà psichica, della sua stratificata profondità che la fa eccedere di molto i
confini dell’io. Dissipare il fenomeno dell’illusione può essere compito, secondo Scheler, solo di
una «fenomenologia della percezione» che si applichi intuitivamente a isolare il contenuto
percettivo46, dando luogo a una «fenomenologia dello psichico» che sappia palesarne la
«costituzione» e le «connessioni essenziali» 47, ben al di là dei meri dati sensibili o delle semplici
forme logico-concettuali.
In linea con ciò che era stato affermato da Reinach, la vera figura di riferimento dei
fenomenologi di Göttingen, la fenomenologia non rappresenta per Scheler un sistema di
proposizioni o di verità, ma è – più modestamente – un metodo di filosofare richiesto dai problemi
stessi della filosofia. Riconosciuto da Nicolai Hartmann come il prototipo del Problemdenker,
46
47
Cfr. Scheler (1999), p. 113.
Cfr. ivi, p. 146.
20
�Illusione ed errore. Il dogma dell’intuizione e le avventure fenomenologiche di Max Scheler
Scheler si cala nella parte di chi esercita lo sguardo fenomenologico per rapportarsi ad ogni tipo di
oggetto con intuitività e concreta pienezza. La distanza naturale dagli oggetti non è stata infatti
eliminata dalle scienze, che spesso si sono accontentate di procedere in modo definitorio e
deduttivo: tra queste va annoverata anche la psicologia che, pur dipendendo da un coglimento
diretto dell’essenza, si era fin lì in larga parte sottratta, per Scheler, a questo compito ineludibile. In
tal senso, confidando sulla componente metodica dell’intuizione d’essenza la stessa fenomenologia
«ha dovuto in primo luogo conquistare il suo diritto all’esistenza come fenomenologia dello
psichico»48, risalendo agli «ultimi fatti fondamentali intuitivi» che fungono da base di validità per
ogni scienza esplicativo-causale, ma anche per ogni scienza della natura, della cultura e delle stesse
scienze storiche.
Dietro all’obiettivo di evidenziare la matrice delle illusioni nelle loro forme più dispiegate,
combattendo l’atteggiamento ostinato con cui si era cercato di dominare il mondo restando
impermeabili alle evidenze delle datità che la fenomenologia aveva iniziato a far emergere, in una
pluralità di regioni eidetiche, attraverso il rispetto delle diverse modalità intenzionali e il correlativo
variare dei valori e delle essenze, Scheler mira a coinvolgere Husserl nella requisitoria condotta
contro il pregiudizio dell’evidenza apodittica assegnata alla percezione interna nel solco della
tradizione di pensiero cartesiana. Il presupposto di ogni psicologia doveva comportare, per Scheler,
un’ontologia eidetica dello psichico e un corretto approccio gnoseologico a quest’ambito peculiare,
mentre dal sostegno fornito al presunto primato della percezione interna e della sua evidenza
assoluta era scaturito il fondamento di «ogni idealismo soggettivo filosofico ed egocentrismo, e al
contempo una delle basi di quel falso tipo di certezza di sé che, nel corso del costruirsi della nostra
cultura, il protestantismo in particolare ha cercato di trasformare in un atteggiamento umano
giustificato, divenuto per molti il punto di appoggio per un negativismo e un criticismo smodato
contro ogni essere esterno all’io: Dio, natura e cultura oggettiva» 49. L’intervento che Scheler
compie per rimuovere tale «isolamento» dell’uomo dalle cose e, segnatamente, quello che ne ha
ostacolato la possibilità di guardare al fondo della propria anima, ha come principale bersaglio la
cancellazione di quel miserevole «stato di “buona coscienza”» in cui si è tradotta la «credenza nella
non illusorietà della percezione interna»50. L’atteggiamento negativo nei confronti delle cose
sarebbe dunque per Scheler tipico di gran parte della cultura moderna, che affonda le sue radici in
una mentalità intrisa dal risentimento e dal pessimismo che si diffonde rispetto alla natura51. Nelle
pieghe di quest’accentuazione problematica, si coglie l’impegno scheleriano a promuovere la
portata pratica delle proprie analisi fenomenologiche, dando già in questa fase la misura di voler
realizzare una fenomenologia engagé, in cui la coscienza umana, non più strettamente centrata
sull’io, ritrovi una visione più personale e responsabile, in cui non compaiano i pregiudizi che ne
hanno limitato la condotta. Il tema delle illusioni, che scandisce per molti aspetti l’incontro di
Scheler con la fenomenologia, rappresenta una costante del modo di pensare borghese in cui lo
spirito, separatosi dall’essere, cede alla spirale di un soggettivismo relativistico che oscilla tra il
desiderio di dominio e la passività rispetto a un ordine oggettivo. In questo contesto, l’illusione
appare anche perciò come una sorta d’inganno metafisico, che può essere vinto recuperando
l’umiltà e il rispetto spesso estromessi dalle forme di cultura più tradizionali, e che invece la
fenomenologia si propone di recuperare attraverso un metodo che implica l’abbandono al contenuto
intuitivo delle cose e il superamento di una generalizzata forma di sfiducia.
Nella versione della fenomenologia fornita da Scheler la percezione interna non gode dunque di
un’evidenza privilegiata rispetto a quella esterna. Anzi, l’esperienza fenomenologica, caratterizzata
dall’evidenza immediata, cioè dall’immanenza in senso gnoseologico, non ha nulla a che fare con la
percezione interna: solo l’immediatezza è il tratto che unifica, per così dire, l’esperienza
fenomenologica, mentre la condizione per cui qualcosa, per essere immediato, dev’essere dato nella
48
Scheler (1957/19863b), p. 476 s. (Zusätze a Lehre von den drei Tatsachen).
Scheler (1999), p. 49 (trad. modificata). Sull’evidenza della percezione interna cfr. Schäfer (1978), pp. 16 ss.
50
Ivi, p. 50.
51
Cfr. Scheler (2013), p. 153 n. 20.
49
�Stefano Besoli
(o alla) percezione interna, costituisce solo un pregiudizio psicologistico, poiché non si può far
coincidere il dominio dello psichico con quello di ciò è immediatamente e intuitivamente dato. La
realtà psichica, infatti, si caratterizza per il tipo di percezione con cui è colta e non per una
particolarità che le sia intrinseca: psichico, potremmo dire, è ciò che si manifesta attraverso la
percezione interna. Come dice Scheler nel saggio sugli idoli della conoscenza, non vi sarebbe alcun
diritto di parlare di una percezione esterna e di una percezione interna se la realtà psichica e quella
fisica rappresentassero delle differenze oggettuali, conformi a una certa specie e definibili come tali.
In tal senso, noi non parliamo, infatti, di una percezione tipica degli alberi e delle case 52. Del resto,
in entrambi i tipi di percezione il corpo vivo (Leib) svolge la funzione di analizzare e selezionare i
diversi stimoli attraverso i sensi esterni e il senso interno e, proprio per questo, anche la percezione
interna è soggetta a molteplici forme d’illusione, che Scheler esamina con acribia e che
testimonierebbero, a suo avviso, come anche la realtà psichica non sia sempre quale appare. E
inoltre, del fatto che l’io, espresso in prima persona, non possa ergersi a fondamento di ogni altra
conoscenza e di qualsiasi realtà è prova l’impossibilità di restituire ogni volta, in tale linguaggio, ciò
che il nostro animo prova e d’interpretare in maniera adeguata i nostri stati psichici, poiché
l’individualità dell’io si nasconde spesso dietro l’identità diffusa di un io sociale o comunitario.
Entro questa cornice, Scheler pone anzitutto il problema dell’esistenza di una percezione interna
– attraverso la quale si ha accesso al materiale degli atti del pensiero e a ciò che è propriamente
psichico, al fenomeno psichico in quanto tale – nella sua distinzione dalla percezione esterna,
ricercando con ciò anche il tipo di evidenza che spetterebbe a tale forma di percezione. In primo
luogo occorre cautelarsi nei confronti di alcune equivocazioni, che sono anche di carattere
terminologico-lessicale, ma che sottintendono delle autentiche distorsioni concettuali. Spesso si
trovano ad esempio accomunati nel significato termini come percezione interna, auto-percezione,
auto-coscienza, auto-esame, quasi che il riferimento al sé, all’io, fosse per tutti questi atti dirimente
e del tutto scontato. Viceversa, Scheler nota come vi siano sia dei processi psichici indifferenti
all’io – tali da poter essere cioè percepiti senza relazione a un io determinato – sia dei processi
estranei all’io che colgono infatti il vissuto individuale con una cogenza paragonabile a quella della
realtà esterna, come quando ad esempio si tratta d’impulsi coatti o di rappresentazioni imposte a
forza. A esemplificazione di questi processi psichici, che noi possiamo percepire ma che non
comportano un legame con l’io (con il sé), Scheler parla della possibilità di riferirsi a un pensiero
senza sapere se in verità sia nostro o se provenga da una lettura: in altri termini, possiamo avere un
sentimento senza sapere se si tratta di qualcosa di realmente provato da noi o, al contrario,
d’importato per contagio psichico.
Il ragionamento di Scheler porta dunque a concludere che non solo nel caso della percezione
esterna – poniamo, della percezione di un certo colore – essa avviene senza percezione di sé, ovvero
senza consapevolezza del fatto di essere io a compierla, ma anche nel caso della percezione interna
o percezione dello psichico non è necessario ricorrere a un tale presupposto. Allo stesso tempo,
Scheler contrasta l’idea che il proprio sé ci sia dato (e risulti accessibile) solo attraverso la
percezione interna, laddove invece anche nel guardare le proprie mani o le proprie gambe
percepiamo il nostro io allo stesso modo di quando cogliamo di stare vivendo determinate
esperienze vissute o sentimenti. Ciò significa che un’eventuale contrapposizione non è costituita
dalla coppia percezione di sé/percezione esterna, ma semmai alla prima forma di percezione si
oppone quella dell’estraneo, che non è per nulla coincidente con la percezione esterna. Anche nella
percezione esterna si può cogliere, infatti, ciò che ci è proprio, ma per converso la percezione
interna non si risolve sempre nella percezione di sé, giacché essa fornisce solo l’eco di ciò che la
vista di qualcosa che cogliamo nel volto di un’altra persona ha prodotto nella nostra interiorità, non
sapendo nemmeno se ciò che si percepisce in tal modo sia qualcosa di proprio o di estraneo, che
proviamo solo per una sorta di riproduzione affettiva. La distinzione tra proprio ed estraneo, per
nulla parallela a quella tra percezione interna e percezione esterna, porta Scheler a considerare che
anche ciò che appartiene a una psiche estranea possa essere fondamentalmente percepito, a
52
Cfr. Scheler (1999), p. 79.
22
�Illusione ed errore. Il dogma dell’intuizione e le avventure fenomenologiche di Max Scheler
differenza di quanto ritengono coloro per i quali i tratti della psiche altrui possono essere solo
dedotti da un comportamento corporeo (questo sì realmente percepito) o, altrimenti, ottenuti tramite
un meccanismo empatico, e cioè attraverso la proiezione nella corporeità altrui di qualcosa che
attinge al serbatoio dell’esperienza di sé53. Ne consegue che percezione interna e percezione esterna
costituiscono due differenti direzioni dell’intuizione percettiva della persona, ma tale
contrapposizione non equivale a quella tra percezione di sé e percezione dell’estraneo, poiché la
persona può percepire in entrambe le direzioni intuitive sia il proprio sé, sia qualcosa che esula da
tale sfera54.
Scheler s’interroga dunque, in maniera per nulla occasionale, sul modo in cui può dirsi
propriamente esistere una percezione interna, ovvero su quella particolare direzione d’atto o forma
dell’intuizione nella quale viene a manifestarsi ciò che è psichico. Il naturale svolgimento di tale
problematica conduce, in un crescendo metafisico, alla definizione di una psicologia della persona
che prende le mosse dall’essenza dello psichico e dal contenuto che si riscontra in tale evenienza
come dato55. Per definire lo psichico è necessario appellarsi all’idea di percezione interna, così
come Scheler la concepisce, ma se esso non può essere definito dai tratti caratteristici che lo
distinguerebbero dal fisico, allora l’unità dello psichico finisce per consistere in un’autentica
essenzialità: non trattandosi cioè di un contenuto di esistenza particolare, ma di una forma di
esistenza cui corrisponde un particolare modo d’intuizione. Il concetto di psichico non è quindi
ottenuto per astrazione da ciò che è comune ai singoli fatti psichici, per cui è possibile determinare
ciò che è psichico solo riferendoci al modo particolare in cui percepiamo tali fatti, cioè a dire
considerando l’atto della percezione interna, poiché psichico è un significato che si riempie
invariabilmente quando imbocchiamo questa specifica direzione d’atto56. Nel caso partissimo dal
presupposto sviante che si tratti solo di una differenza empiricamente oggettiva, per Scheler non
potrebbero darsi due forme di percezione radicalmente divaricate, i cui rispettivi dati sono però
ugualmente immediati57.
Lo scavo che Scheler compie nel dominio dello psichico lo conduce a distinguerlo da quello
dello spirito e dai suoi atti. L’analisi condotta sul piano individuale dell’io e sul riscontro della
differenza che sussiste tra fatti psichici e fatti fisici mostra come lo psichico possa divenire oggetto,
mentre ciò non possa darsi per la persona e gli atti che la connotano. In contrasto all’io, l’essere
della persona non ha una natura oggettuale, per cui essa stringe semmai una relazione con la
coscienza, essendo per così dire indifferente, al pari dei suoi atti, alla distinzione istituita tra
psichico e fisico. Sotto questo profilo, se con psicologia s’intende la scienza di tutti gli accadimenti
passibili di essere osservati, descritti o spiegati, ovvero di tutto ciò che è presente nella percezione
interna, l’attualità della persona – come forma concreta dello spirito – non è obiettivabile,
trascendendo perciò quest’ambito58. Il contrassegno spirituale della persona, come centro di atti, la
esclude quindi dalla sfera psichica, che è dal canto suo mondana e in cui rientrano l’io e i vissuti
egoici che possono divenire oggetto di un atto di percezione interna inerente alla persona. Tale
caratterizzazione della persona mira, nell’idea di Scheler, a incrinare il fondamento dell’alternativa
su cui era basata la metafisica cartesiana, dato che si mostra con ciò che la disgiuzione tra psichico e
fisico non è affatto esclusiva, non dando luogo infatti a una totalità. Non vi è un «io» che
«appartenga all’essenza dello spirito», così come non gli appartiene quella tra «io e mondo
esterno»59. Di conseguenza, anche il rapporta tra la persona e la sua capacità di agire non può essere
53
Cfr. ivi, p. 66.
Cfr. ivi, pp. 72 ss.; su ciò si veda Loscheid (1957), pp. 9 ss.
55
Cfr. Binswanger (1922/1965), pp. 16 ss. e 232 ss., in cui tra l’altro si contrappone la posizione di Häberlin a
quella di Scheler.
56
Cfr. Scheler (1999), pp. 78 ss.
57
Cfr. ivi, p. 81 s.
58
Cfr. Scheler (2013), pp. 745 ss.
59
Ivi, pp. 757 ss.
54
�Stefano Besoli
ricondotto, per Scheler, al problema dell’interazione tra anima e corpo, poiché «”persona” non
significa proprio nulla di psichico»60.
Con le sue analisi, Scheler ritiene dunque di aver mostrato che la sfera dello psichico è assai più
ampia di quella dei meri atti intenzionali61, abbracciando tutti i livelli e i momenti vitali, nella
misura in cui comprende anche le sensazioni e i sentimenti corrispondenti. Così, ad esempio, non si
può negare che il contenuto di una rappresentazione fantastica sia psichico, ma al contempo si deve
evitare di chiamare psichici gli atti della percezione interna nei quali lo psichico è per l’appunto
dato, perché ciò condurrebbe altrimenti a un regresso all’infinito. In tal senso, l’essenza dello
psichico è ciò che diviene visibile nella percezione interna, il cui oggetto – vale a dire ciò che è dato
in maniera evidente in questo genere di atto – è «l’essenza e l’individualità dell’io e di qualche sua
esperienza vissuta e determinatezza»62. Tale datità è immediata non essendo frutto di un’astrazione,
né potendo l’io scaturire nelle pieghe di un ragionamento come somma o sintesi di una pluralità di
aspetti coscienziali o come fondato sull’assunzione di un’idea di sostanza63. Con riguardo non solo
a Brentano ma anche a Stumpf, Scheler sottolinea come sia del tutto corretto affermare che «suoni e
colori non siano necessariamente dei fenomeni psichici, ma non è corretto dire che non possono
esserlo»64 In realtà essi lo sono «come contenuti parziali di una determinata coscienza dell’io; lo
sono in quanto vissuti in riferimento a un io», per cui anche il suono sentito da me è un fenomeno
psichico, come lo sono le «pseudo-allucinazioni di Kandisky», poiché merita di essere qualificato
così «tutto ciò che è dato in uno spazio rappresentazionale che diverge da quello reale» 65. Dallo
sfondo dell’io si stagliano così tutte le varie determinazioni psichiche, ovvero i fenomeni psichici
che sono tali perché in generale appaiono sempre «in un rapporto immediato all’io»66, senza che l’io
possa essere però oggetto di un’apprensione isolata, svincolandosi dalle sue esperienze. Il rapporto
tra l’io e le proprie esperienze vissute non è riconducibile ad alcun meccanismo di associazione, ma
è regolato dal fatto che un’esperienza del genere appartiene sempre a un «determinato io
individuale», collocandosi dal punto di vista ontologico nella «totalità di ogni possibile “mondo
interno”, inteso come intero accessibile tramite la percezione interna»67. Ciò comporta che
l’immagine dell’io non possa essere quella di un principio immutabile che dominerebbe dall’alto di
una postazione durevole lo scorrere sottostante di determinazioni che sembrano non toccarlo, né per
contrasto quella ugualmente ingannevole secondo cui l’io sarebbe da equiparare alla «connessione»
di quel flusso. Al contrario, l’io individuale è così poco portatore di tale forma di durata da
«cambiare» – senza pregiudicare la sua «egoità» – «in ognuna delle sue esperienze vissute», che
non sono però la «causa» del suo «divenire-altro» o «essere-altro nel divenire»68. Nella continuità
del passaggio dall’essere in un certo modo al divenire altrimenti, Scheler trova conferma che non
c’è alcuna separazione tra l’io e le sue esperienze vissute, che non restano quindi isolate «da
qualche parte», ma rintraccia in esso un percorso di maturazione in cui l’io assimila, con una nota di
originalità, tutto ciò che rientra nel variegato materiale esperienziale, impregnando ogni sua singola
determinazione dello stile individuale che s’imprime all’intero processo di cambiamento in cui è
trascinato, ma di cui al tempo stesso si appropria 69.
Con un ulteriore slancio esegetico, Scheler incrementa la portata realista nella propria
concezione della sfera psichica, mettendo in luce che, pur essendovi una differenza essenziale tra le
due direzioni percettive, c’è però una sorta di bilanciamento tra psichico e fisico dovuto al fatto di
riconoscere ai fenomeni fisici un’indipendenza, rispetto all’esercizio della percezione, del tutto
60
Ivi, p. 931 (trad. modificata).
Cfr. Scheler (1999), pp. 75 e 78 s. n. 6.
62
Scheler (2013), p. 801.
63
Scheler (1999), p. 86.
64
Ivi, p. 77 (trad. modificata).
65
Ibid. (trad. modificata).
66
Ivi, p. 81 (trad. modificata).
67
Scheler (2013), p. 823 (trad. modificata).
68
Cfr. ibid. e n. 57.
69
Cfr. ibid.
61
24
�Illusione ed errore. Il dogma dell’intuizione e le avventure fenomenologiche di Max Scheler
analoga a quella che si è soliti attribuire ai fenomeni fisici. Così come questi debordano
costantemente dal campo più ristretto di ciò che di volta in volta percepiamo, allo stesso modo
anche la vita psichica è assai più estesa di ciò che possiamo gradualmente coglierne, data la distanza
che intercorre tra «ciò che uno vive coscienzialmente e ciò che, vivendolo, conosce così da poter
dire cosa vive»70. Tale ritrovata simmetria corrobora appunto la convinzione scheleriana secondo
cui le illusioni possono annidarsi anche sul versante della percezione interna, non essendo cioè
appannaggio esclusivo dell’indirizzo percettivo ritenuto, per consuetudine, ampiamente fallibile. A
ricondurre sullo stesso piano le forme di percezione considerate è l’intervento di un «senso interno»
– ben diverso da quello evocato nell’estetica trascendentale kantiana 71 – che opera sul lato della
percezione interna in analogia al ruolo di «mediazione» svolto dalle «funzioni sensoriali» per ciò
che attiene alla percezione esterna. Se è vero, infatti, che tali funzioni si collocano «a metà» tra
l’atto della percezione esterna e il suo «possibile contenuto», avendo un carattere «analizzatore» che
non concorre in alcun modo a «produrre» il contenuto dell’«intuizione esterna», ma serve solo a
selezionare nell’Umwelt ciò che di essa può risultare più utile alle funzioni vitali del corpo, va
ugualmente riconosciuto che la stessa percezione interna «non si rivolge direttamente all’io e ai sui
vissuti», ma lo fa «attraverso un “senso interno”»72. Infatti, è raro poter avere coscienza
dell’inclusione reciproca dei vissuti nell’io e della molteplice fusione che in tal caso si
registrerebbe: questo tipo di coscienza è destinata a rimanere insoddisfatta e la percezione interna ci
pone sempre in presenza di stati psichici staccati e singoli, che occupano di volta in volta un posto
privilegiato rispetto alla nostra attenzione. Questi stati si manifestano dunque, nella loro
particolarità, a seguito di una dissociazione della totalità da cui derivano, e l’organo di tale
dissociazione è il senso interno che si frappone, per così dire, tra l’atto della percezione interna e la
vita psichica, allo stesso modo in cui la funzione sensoriale ha una posizione mediana tra la
percezione esterna e il mondo fisico. Del tutto erroneo è perciò ritenere che esista, dal punto di vista
psichico, solo ciò che di volta in volta troviamo già presente nella coscienza, e che ogni vissuto
psichico trascorso esisterebbe solo nelle disposizioni fisiologiche o in quelle di una sostanza
metafisica dell’anima, poiché in tal modo la realtà psichica si ridurrebbe solo a ciò che l’individuo
vive con la coscienza di essere lui stesso a viverlo in quel momento. Tale concezione è del tutto
assurda in rapporto alla realtà psichica, così come lo sarebbe ritenere reale solo quel frammento di
natura presente nella percezione sensoriale data, considerando tutto il resto alla stregua di mere
possibilità percettive73.
A fronte dell’idealismo berkeleyano, che aveva quasi annullato la distanza tra i due tipi di
percezione, facendo della percezione esterna una dimensione percettiva a stretto contatto con l’io (o
con lo spirito), per Scheler l’essere dello psichico (così come quello del fisico) è invece irriducibile
al suo percipi, poiché è indipendente dal senso interno e non si confonde con i fenomeni in cui certi
suoi contenuti si manifestano a tale strumento di mediazione. Per questo, è legittimo e perfino
70
Scheler (1999), p. 94 (trad. modificata).
Cfr. Ivi, p. 89 n. 21, nella quale Scheler afferma che la sua nozione di senso interno non ha nulla a che fare con
quella kantiana che si propone di accreditare ciò che egli invece rifiuta, e cioè l’equiparazione tra senso interno e
percezione interna. Il senso interno è, per Kant, ciò mediante cui l’animo intuisce se stesso o un suo stato interno. Della
concezione kantiana, Scheler critica anche il fatto che il tempo sia concepito come forma del senso interno, quando esso
è anche un momento essenziale del contenuto della intuizione esterna, nonché dissente sul fatto che la realtà dello
psichico sia da considerarsi trascendente come una cosa in sé, e se ne possa cogliere quindi solo un apparire
fenomenico. Il senso interno – che per Scheler rappresenta un dato di fatto, e non un’ipotesi di natura metafisica –
svolge a sua volta una funzione analizzatrice, in quanto isola dall’intero vissuto psichico (ovvero dall’intero contenuto
intuitivo fornito dalla percezione interna) ciò che è importante per la vita, ciò che ha un significato per la sfera di attività
e d’interesse del corpo proprio, illuminandolo per così dire di luce viva. La tesi sostenuta da Scheler è che se i vissuti
psichici non possono essere ricondotti a stati del proprio corpo, a complessi di sensazioni, ogni percezione di un vissuto
psichico è però legata a un caratteristico stato corporeo, a una determinata intenzione di movimento, senza la quale non
potrebbe oltrepassare la soglia del senso interno. Questo significa che ogni vissuto, nella misura in cui è percepito, è in
certo modo dipendente da stati del corpo proprio, senza che tale dipendenza possa però estendersi – come vorrebbe il
parallelismo psicofisiologico – al vissuto in sé e al puro contenuto intuitivo colto dalla percezione interna.
72
Ivi, p. 87 (trad. modificata). Su ciò cfr. Lorscheid (1957), pp. 26 ss.; Altmann (1931), p. 44.
73
Cfr. Scheler (1999), pp. 87 ss.
71
�Stefano Besoli
obbligatorio l’utilizzo, nel dominio della psicologia, di un concetto – come quello di «cosa – di cui
si vorrebbe limitare l’uso al mondo esterno. Tale concetto può essere liberato, infatti, dal legame
troppo esclusivo che intrattiene con l’idea di corpo, e che il linguaggio solitamente gli attribuisce,
rendendosi disponibile a illustrare molte fattezze dello stesso mondo interno 74. Nell’avanzare la
prospettiva del realismo su entrambi i fronti dell’indagine da lui condotta, Scheler intende delineare
come la presenza di un filtro selettivo tra la molteplicità dei vissuti e ciò che può diventare, in senso
proprio, oggetto della percezione interna dischiuda la possibilità che si verifichino illusioni anche in
riferimento a tale indirizzo della percezione, nel senso che anche nella vita interiore si mostra un
divario tra «parvenza» (Schein) e «realtà». I fenomeni del senso interno, infatti, non esauriscono la
realtà psichica, poiché esibiscono come un’«intera serie di strati dell’oggettualità psichica del
medesimo vissuto» dipendano dal senso interno, e come tali siano relativi in misura diversa, quanto
all’esistenza, all’individuo che li apprende75. Pertanto, il fatto che ogni percezione interna si compia
per mezzo di un senso interno fa sì che la «percezione effettiva dell’io e della sfera dei fatti
“puramente” psichici non sia una percezione immediata che darebbe quei fatti stessi, ma una
percezione mediata dalla sensibilità del corpo vivo [leiblich-sinnlich vermittelte], con il risultato di
risultare così esposta alle illusioni, come avviene del resto per «l’effettiva percezione esterna a
causa della “sensibilità” esterna»76. Come dire che non solo la percezione interna s’inganna
facilmente, ma che una percezione del tutto interna e del tutto psichica del proprio sé sia quanto mai
illusoria. Essendo l’io un «“membro” del noi», come peraltro lo stesso noi è «membro necessario
dell’io»77, l’evidenza dell’io rappresenta quindi un miraggio psichico, al pari di ogni
assolutizzazione della percezione interna come fonte autorevole della certezza dei propri vissuti.
7.
Se il saggio sugli Idoli della conoscenza di sé rappresenta una fonte quasi «inesauribile»78 di spunti
tematici e di approfondimenti critici in ordine al panorama della vita psichica e alle possibili
alterazioni che subentrano nei meandri di tale realtà, non vi è dubbio che in esso, così come in altri
scritti coevi, il bersaglio polemico di Scheler fosse la revisione idealistica della fenomenologia che
Husserl sembrava aver intrapreso avallando il primato della percezione interna, a conferma di una
rinnovata adesione al paradigma di pensiero cartesiano 79. Prima ancora di aggredire la
fenomenologia husserliana nei suoi risvolti idealistici, Scheler le aveva però già indirizzato almeno
un altro rimprovero, di segno curiosamente opposto. In Lehre von den drei Tatsachen – dopo aver
delineato una suddivisione riguardante i «fatti fenomenologici puri», attingendo ai quali la filosofia
fenomenologica meriterebbe di diritto il titolo di «empirismo e positivismo» più radicale»80 –
Scheler fa convergere sulla dottrima delle «qualità figurali», sulla concezione di Stumpf relativa a
«fenomeni e funzioni psichiche», ma soprattutto sul modo husserliano di determinare l’«intuizione
categoriale», la critica di una forte compromissione con un certo empirismo sensistico e con una
teoria della conoscenza ugualmente atteggiata. Nel suo spirito di contraddizione, Scheler coglie
bene che l’intuizione dell’eidos come invariante costituisce, per Husserl, la generalizzazione del
momento figurale nella sua piena portata logica, ma al tempo stesso snatura l’impianto della
fenomenologia husserliana, per la quale la Wesensschau – a differenza della Wahrnehmung, che è
un’autentica intuizione di una qualità ontica – è solo funzionalmente analoga all’estesi percettiva
74
Su ciò cfr. ivi, p. 93.
Cfr. ivi, p. 90.
76
Scheler (2013), p. 801 (trad. modificata). Nella n. 48 Scheler segnala di aver già mostrato nell’Appendice al
Sympathiebuch del 1913 come le difficoltà che s’incontrano nel riconoscere lo «psichico altrui» nascano proprio dal
trascurare che anche «l’effettiva percezione di sé psichica è mediata» dalla sensibilità e dal corpo vivo.
77
Scheler (2010), p. 219. Sul fatto che l’esistenza dell’altro non possa essere accertata partendo dal presupposto di
evidenza del proprio vissuto, per cui la «conoscenza di processi psichici in altri non presuppone che processi simili o
uguali siano stati osservati in noi stessi» cfr. Scheler (1999), p. 147.
78
Cfr. al riguardo Rothacker (1949), p. 3.
79
Cfr. Frère (2006).
80
Scheler (1957/19863b), p. 381.
75
26
�Illusione ed errore. Il dogma dell’intuizione e le avventure fenomenologiche di Max Scheler
radicata nel fondamento antepredicativo dell’esperienza, in assenza del quale l’ideazione non
potrebbe aver luogo. L’aspetto quasi-intuitivo dell’intuizione d’essenza non compromette per
Husserl il fatto che, anche nel suo caso, l’oggetto le sia dato in una presenza immediata, anche se
ciò che varia rispetto alla percezione sono appunto i caratteri che qualificano tale presenza. A fronte
dell’empirismo eidetico tipico della gnoseologia husserliana, Scheler lamenta invece che i
«contenuti sensibili» non possono avere un ruolo «fondante per tutti i restanti contenuti
dell’intuizione», poiché altrimenti si estinguerebbe l’autonomia che egli intende salvaguardare per
l’intuizione categoriale delle essenze, che solo così potrebbe continuare a fondare l’esperienza che
abbiamo dei dati sensibili81.
Con il piglio di chi ostenta di essere più in linea con Husserl di Husserl stesso, Scheler inizia a
scavare ulteriormente il solco con il pensiero husserliano, ibridando il metodo fenomenologico con
formule appartenenti ad altri indirizzi dottrinari. Sotto tale profilo, non si trattava per Scheler solo di
affermare il primato dell’intuizione rispetto a qualunque forma di costruttivismo, ma di sgombrare il
campo da una riduzione fenomenologica troppo connaturata alle funzioni di una coscienza o di una
soggettività trascendentale che, quale funtore di un’attività costituente, di donazioni di senso e di
sintesi d’identificazione oggettuale, sembrava allinearsi fin troppo ai requisiti del trascendentalismo
kantiano, senza nutrire più alcun rispetto per l’alterità della cosa. La riduzione come tale non viene
messa da Scheler in discussione, ma è concepita come una sorta di circoscrizione, di
«delimitazione» (das Eingrenzen) che mostri «ciò che l’essenzialità non è ancora», e cioè un
procedimento che non può «provare» o «dedurre» determinati contenuti a priori, ma solo farli
«vedere», separandoli da tutti gli altri82. L’intuizione d’essenza mostra quindi, nel contesto di
un’esperienza davvero fenomenologica, una «quidditas» ottenuta per esclusione degli altri
contenuti, adottando un criterio che consente di riconoscere la «natura eidetica» di ciò che dato,
ancor prima di averlo osservato, poiché nel tentativo di «osservare» (beobachten) un dato ci
avvediamo di averlo già «colto intuitivamente», a dimostrazione dell’«indipendenza del contenuto
d’essenza» rispetto a quello di «ogni possibile osservazione e induzione» 83. L’efficacia di tale
criterio non procede quindi per astrazione empirica o per accumulo di osservazioni, ma consegue da
una misteriosa rivelazione in grado di far apprendere un’essenza che, pur essendo inosservabile,
fonda la possibilità stessa dell’osservazione.
Il metodo riduttivo cui Scheler ricorre si avvale, quindi, di una «via negationis» che lo
approssima alla «teologia negativa», nella misura in cui cerca di appalesare il fenomeno
dell’essenza attraverso un cammino che elimina, in progressione, tutto ciò che non ha a che fare con
esso o che sembra essergli, per certi versi, addirittura opposto84. Tuttavia, l’esperienza
fenomenologica, nella sua pura immediatezza, restituisce un livello di datità esperienziali assai più
ricco di quello offerto dalla mera esperienza sensibile, poiché dischiude «l’assoluto contenuto
ontologico e assiologico del mondo, annullando la differenza tra “cosa in sé” e “fenomeno”, con
l’esito di portare alla luce la «legge fondamentale», di schietto tenore tolemaico, che regola il
rapporto tra «essenza e realtà effettiva»85. L’incipiente torsione ontologica della fenomenologia, che
prelude alla compiuta aspirazione metafisica della filosofia scheleriana, è veicolata – fin dagli
esordi – da una scienza eidetica dell’essere. In risposta all’eccessivo intellettualismo che promana
dall’elaborazione strettamente logico-conoscitiva della fenomenologia husserliana, Scheler
interrompe il disegno di ricondurre ogni dato alla sfera dell’immanenza coscienziale, nelle forme
cioè – trascendentalmente addomesticate – di una trascendenza nell’immanenza. In altri termini,
Scheler esclude dalla prospettiva fenomenologica il presupposto cartesiano di una coscienza
assoluta, per fare «dell’oggetto intenzionale non un semplice oggetto di pensiero, ma […] un
oggetto che sussiste […] indipendentemente dall’atto che l’apprende»86, attuando così un
81
Cfr. Scheler (1957/19863a), pp. 448 ss.
Cfr. Scheler (2013), p. 119.
83
Ibid.
84
Su ciò si veda Dupuy (1957a), vol. 1, p. 222 s.
85
Scheler (2013), p. 165 (trad. adattata).
86
Dupuy (1957a), p. 215, ma si veda anche p. 252 e 260; cfr. anche Dupuy M. (1959b), p. 248.
82
�Stefano Besoli
paralogismo della trascendenza che, pur nell’ambizione di permanere sul piano della
fenomenologia, converte l’essenza stessa in un ambiguo simulacro esistenziale.
Attraverso un modo sistematico di confondere la riduzione fenomenologico-trascendentale con il
genere di riduzione eidetica prefigurata, Scheler mantiene in vigore solo quest’ultima operazione
riduttiva che, prescindendo sia dal «reale compimento dell’atto», sia da «ogni posizione […] della
particolarità dei coefficienti di realtà»87 con cui è dato il rispettivo contenuto, conferisce un
significato ontologico alla correlazione spirito-mondo88, con il fine di stabilire non solo la sua
priorità rispetto ad ogni teoria della conoscenza, ma di adibire l’intuizione eidetica al coglimento di
quell’essere assoluto che necessita dell’emozionalità del sentimento non disgiunta da una certa
irrazionalità. Il tentativo di combattere Husserl sul suo stesso terreno non conduce, però, a risultati
apprezzabili, poiché una «tecnica» intuitiva – messa al servizio di un’ascesi morale che trasforma la
sospensione di ogni tesi naturale in una vera e propria «de realizzazione» – è predisposta solo a
colmare l’irriducibilità di quell’essere assoluto, che resta però irrimediabilmente relativo, nella
misura in cui la sua trascendenza non è ricondotta al campo di un’immanenza autenticamente
fenomenologica.
8.
Il confronto serrato con Husserl trova spazio anche nel saggio sugli Idoli della conoscenza di sé,
sebbene Scheler lo persegua un po’ sotto traccia. L’occasione è data dal prendere le distanze da una
dottrina divenuta in quel tempo à la page, secondo cui nel mondo psichico non avrebbe cittadinanza
la divaricazione tra parvenza e realtà, poiché in esso vige una sorta di chiaroscuro, per cui tutto c’è
o non c’è, e lo psichico sarebbe equiparabile per questo a una «vera e propria “cosa in sé”», dal
momento che esso «è come appare»89. In una lunga nota a corredo di questo passo, Scheler
approfondisce il suo antagonismo nei confronti di Husserl, attribuendogli sul tema delle posizioni
contraddittorie. Di più: in parallelo alla sua presunta evoluzione idealistica, anche su un piano più
ristretto Husserl sembrerebbe avere cambiato parere in maniera significativa. Mentre nelle Ricerche
logiche, infatti, egli aveva contrastato con decisione il privilegio accordato da Brentano (e
Descartes) all’evidenza della percezione interna, stabilendo che le due forme di percezione hanno
invece, dal punto di vista gnoseologico, il medesimo carattere, per cui quella distinzione non
corrisponde affatto a quella tra percezione evidente e non evidente, illusoria e non illusoria 90, in uno
scritto apparso qualche anno dopo (Philosophie als strenge Wissenschaft, 1910-1911), su una rivista
diretta dal neokantiano Rickert, la tesi sostenuta si sarebbe per così dire rovesciata. Al riguardo,
Husserl afferma, infatti, che «l’essere psichico, l’essere come “fenomeno”, non è di principio
un’unità che sarebbe esperibile come individualmente identica in più percezioni separate […] In
altri termini, non c’è nella sfera psichica alcuna differenza tra manifestazione [Erscheinung] ed
essere»91. Peraltro, che il fenomeno, nell’ambito della riflessione trascendentale che qualifica
costitutivamente la fenomenologia husserliana, definisca un campo di datità ultime rispondente al
detto di Herbart «Soviel Schein, soviel Sein», è cosa risaputa, di cui occorre solo prendere atto.
Scheler insinua, però, che dietro a tale ribadita coincidenza, Husserl volesse scambiare l’essenza del
87
Scheler (1957/19863b), p. 394.
Cfr. ivi, p. 396.
89
Scheler (1999), p. 90 s.
90
Cfr. Husserl (1968/2005), vol. 2, pp. 529 ss. È chiaro, per Husserl, che la maggior parte delle percezioni degli stati
psichici non possono essere evidenti, dal momento che vengono percepiti come localizzazioni nel corpo. Ad esempio
percepiamo che l’angoscia ci serra la gola, che il dente ci duole, che l’affanno ci tormenta il cuore, nello stesso senso in
cui percepiamo che il vento scuote gli alberi o che una scatola è quadrata e ha un colore scuro, per cui è ovvio che
possono essere percepiti come trascendenti anche dei fenomeni psichici, nel momento in cui la percezione di un mal di
denti (in cui cogliamo un vissuto effettivo) spesso risulta ingannevole, giacché potrebbe trattarsi del trigemino o di un
dolore causato altrimenti, dato che il dente che sembra tormentarci è invece sano. Di conseguenza, la distinzione –
fondamentale anche per la psicologia – tra percezione adeguata e non adeguata interseca quella tra percezione interna ed
esterna, inserendosi anche nella sfera apparentemente priva d’illusioni.
91
Husserl (1994/2005), p. 48 (trad. modificata).
88
28
�Illusione ed errore. Il dogma dell’intuizione e le avventure fenomenologiche di Max Scheler
«fenomeno» con quella dello «psichico»92, anche se in altro passo egli ha cura di distinguere,
correttamente, tra una «fenomenologia della coscienza» e una «scienza naturale della coscienza»
che rispondono, rispettivamente, a un atteggiamento fenomenologico e a un atteggiamento
empirico93. Da questa richiesta husserliana di sottrarre il campo della coscienza pura al controsenso
implicito in ogni naturalizzazione, Scheler fa però scaturire il rilievo che in tal modo la psicologia
in generale, con inclusione della psicologia descrittiva, resterebbe priva di un contesto fenomenico,
essendo invalsa in essa la pratica osservativa. Da un lato, è vero che la «fenomenologia dello
psichico», come «dottrina dei costituenti essenziali dello psichico e dei suoi modi di datità», va
distanziata dalla psicologia, cui è preordinata, ma al contempo per Scheler è possibile dare
significanza a determinati concetti (cosa, processo, causa) anche nella sfera psichica, a patto di
liberarli dalle modalità assunte nelle sfera della percezione esterna e dell’«essere naturale»94.
Eliminare le incrostazioni naturalistiche e impedire ogni metabasis eis allo genos non comporta
però, per Scheler, quel restringimento fenomenico che Husserl sembrerebbe aver attuato, giacché –
se «”fenomeno” significa solo ciò che è immediatamente dato nell’atto vivente», ovvero «ciò che
mi sta di fronte in una datità nell’originale [Selbstgegebenheit]» – questo modo di manifestarsi può
essere cercato in qualsiasi oggetto, non importa se psichico o non, e lo stesso dicasi per la «cosalità»
e la «realtà»95.
A prescindere dalle difficoltà che Husserl incontra nell’esplicitazione dello statuto trascendentale
della fenomenologia e nel graduare il passaggio dalla fenomenologia statica a quella dinamica, a
emendarsi da certe modalità espressive e dalle concezioni filosofiche cui esse nascevano
appoggiate, non si può però dire che tale offensiva scheleriana colpisca nel segno. Nel luogo
evocato, l’impossibilità di distinguere tra manifestazione ed essere non è finalizzata a individuare in
tale assolutezza fenomenica anche una prerogativa dello psichico, ma solo a rimarcare come il
fenomeno psichico sia per l’appunto «fenomeno e non natura»96, poiché come testimonia la
«riflessione» condotta sulla percezione di qualsiasi manifestazione psichica, questa non è a sua
volta un essere che si manifesti attraverso ulteriori manifestazioni, ma è un vissuto coscienziale che
fa tutt’uno con la riflessione che lo coglie, per cui si può parlare a ragione di fenomeno solo laddove
la riflessione faccia in qualche modo parte della manifestazione stessa 97. D’altronde,
l’identificazione tra apparire ed essere non sorge dall’esigenza di rilanciare l’evidenza della
percezione interna e dunque da una sorta di persistenza dogmatica che avvalorerebbe il carattere
introspezionistico di certe affermazioni husserliane, ma costituisce un tratto generalizzato della
fenomenologia che prende spunto dal rifiuto della «cosa in sé» e, quindi, dal sancire la correlazione
necessaria tra coscienza ed essere, tra la nozione fenomenica di datità e la fonte soggettiva
dell’esperienza, tra la plurivocità dell’essere e il modo trascendentale del suo darsi. Per Husserl,
solo così era possibile scongiurare l’idea che qualcosa si sottraesse per principio alla conoscenza e
che il realismo dovesse consegnarsi a una visione raffigurativa o segnica in cui si sarebbe
definitivamente fissato lo scarto – come si registra anche in Brentano – tra un oggetto fenomenico e
un oggetto reale che, non potendo essere esperito, può solo essere inferito dai vissuti coscienziali.
Da parte sua, Scheler non avverte l’assenza di ogni limite naturalistico nel procedimento della
riflessione trascendentale husserliana, ritenendo invece che Husserl – tematizzando la datità
assoluta del vissuto coscienziale – abbia confuso la riflessione con l’atto della percezione interna,
dando vigore così al primato che da più parti era stato rivendicato a questa98.
92
Scheler (1999), p. 91 n. 23.
Cfr. Husserl (1994/2005), p. 28.
94
Cfr. Scheler (1999), pp. 91 ss.
95
Ivi, p. 91 s. (trad. modificata).
96
Husserl (1994/2005), p. 48.
97
Cfr. ivi, pp. 48 ss.
98
Anche in considerazione di una specifica nozione di atto psichico, Scheler si oppone a far collassare la riflessione
sulla percezione interna. Infatti, quando nella percezione interna volgiamo lo sguardo verso di noi e verso ciò che ci
appartiene, compiamo un atto di percezione interna che comporta aspetti osservativi, di attenzione, e che è analogo
all’atto di percezione esterna attraverso il quale – ad esempio con l’utilizzo di uno strumento – osserviamo un fenomeno
93
�Stefano Besoli
Il dispiegarsi stesso del pensiero di Husserl non sembra però comprovare le accuse d’idealismo
rivoltegli tra gli altri da Scheler, né quella di aver ritrattato in corso d’opera la critica a un
coscienzialismo di stampo cartesiano, che si sarebbe addirittura accresciuto in senso trascendentale.
Come detto, a prescindere da una certa familiarità con l’impianto della psicologia descrittiva
brentaniana, Husserl già nelle Ricerche logiche contesta la distinzione tra il carattere fallibile della
percezione esterna e l’evidenza apodittica attribuita a quella interna. L’evidenza non si attaglia solo
a una ristretta cerchia di atti, ma riguarda ogni processo mentale, ogni vissuto, così com’è esperito e
come ci è dato. In questa chiave, Husserl mostra però come l’evidenza non possa ad esempio
spettare ad ogni «percezione dei propri vissuti effettivi», poiché – come nel caso di un mal di denti –
si potrebbe facilmente incorrere in una percezione ingannevole. «La possibilità d’ingannarsi è
chiara. L’oggetto percepito non è il dolore così come viene vissuto, ma il dolore interpretato in
modo trascendente, e quindi attribuito a un dente. Ma è proprio della percezione adeguata il fatto
che in essa viene vissuto il percepito così com’è percepito (così come la percezione lo intende, lo
apprende). In questo senso abbiamo ovviamente una percezione evidente solo dei nostri vissuti, ma
solo nella misura in cui li assumiamo nella loro purezza, in luogo di andare appercettivamente al di
là di essi»99.
Anche in questa congiuntura di pensiero, Husserl non si limita quindi ad adottare un motivo
cartesiano per assegnare all’interiorità la matrice di ogni conoscenza, ma delinea una distinzione tra
percezione adeguata e percezione non adeguata che, una volta approfondita nelle Ideen, gli
consentirà di superare, anche dal punto di vista terminologico, le ambiguità connesse alla cosiddetta
«percezione interna». La distinzione fondamentale, di cui Husserl affina i contorni, è quella tra
l’adeguatezza o no della percezione, considerando che «non si può dubitare della percezione
adeguata, puramente immanente, proprio perché in essa non vi è alcuna intenzione residuale che
aspiri al riempimento», poiché «ogni intenzione, ovvero l’intenzione in tutti i suoi momenti, è
riempita»100. Viceversa, la percezione può risultare ingannevole quando si travalica ciò che è dato in
maniera immanente, oltrepassando l’orizzonte della datità attuale.
Per evitare i fraintendimenti riguardo alla innere Wahrnehmung, e al tempo stesso quasi per
neutralizzare le obiezioni circa una possibile coincidenza tra riflessione e percezione interna, che
era stata vista dallo stesso Scheler come una preferenza accordata a tale indirizzo percettivo,
Husserl introduce nelle Ideen (1913) il termine «riflessione», la cui diversità dalla percezione
interna avrebbe potuto facilmente risaltare – come nota acutamente Edith Stein – proprio nel caso
degli inganni di tale percezione, dei quali tratta Scheler nella sua Idolenlehre101. Tuttavia, anche la
riflessione sembrò a un certo punto comportare un eccessivo coinvolgimento psicologico, per cui
era necessario accompagnarla a un sistema di riduzioni che ne sancisse la caratura trascendentale,
evitando cioè i rischi di una reificazione coscienziale. In ogni caso, Husserl modifica il proprio
armamentario concettuale, introducendo un «orientamento riflessivo» al posto di «una cosiddetta
di tale realtà. Il problema sta però nel fatto che l’atto, così concepito, non può mai diventare oggetto di qualsiasi
rivolgimento percettivo: esso non è un oggetto in generale, né tanto meno è un oggetto esistente, poiché l’essere
dell’atto consiste, in tale sua accezione, nel relativo compimento ed è quindi assolutamente distinto dal concetto di
oggetto. Il compimento dell’atto può essere però accompagnato da riflessione – e questo avviene quando la persona non
scompare del tutto da tale compimento: nondimeno, anche la riflessione non è un’oggettivazione dell’atto (non
trasforma cioè in oggetto l’atto), né costituisce un atto di percezione, neppure interna, ma è solo il «librarsi insieme»
della «coscienza di», del tutto priva di qualificazione, con «l’atto che si compie». A differenza di quanto avviene nel
caso della percezione interna, che non può mai avere come suo contenuto quella esteriore, per Scheler tramite la
riflessione può essere invece dato, nel suo compimento, anche un atto di percezione esterna. Cfr. Scheler (1999), p. 74
(trad. modificata).
99
Husserl (1968/2005), vol. 2, p. 543.
100
Ibidem.
101
Ne Il problema dell’empatia, Stein chiarisce, al riguardo, che ingannarsi circa i sentimenti nutriti per un’altra
persona non vuol dire cogliere nella riflessione un atto d’amore che in realtà non sussiste. Con la riflessione si coglie un
sentimento d’amore che, come dato assoluto, non può essere rigettato. L’inganno può viceversa riguardare l’oggetto di
tale amore, e cioè la persona che potrebbe essere diversa da quella che ci è sembrato di cogliere in quell’atto, e che
poteva anche avere una natura fantasmatica, benché l’atto fosse genuino.
30
�Illusione ed errore. Il dogma dell’intuizione e le avventure fenomenologiche di Max Scheler
“percezione interna”»102, delineando con radicalità i termini della questione. Come già fatto in parte
nelle Ricerche logiche, anche nel primo volume delle Idee si trattava di evitare l’uso, gravido
d’incertezze, dei termini “percezione interna e percezione esterna”, per servirsi solo della
distinzione tra «percezioni (o atti in generale) trascendenti e immanenti», dalla quale si poteva
evincere che i vissuti intenzionali con riferimento immanente sono «quelli alla cui essenza inerisce
che i loro oggetti intenzionali, qualora in generale esistano, appartengono alla stessa corrente di
vissuti cui appartengono gli atti stessi», mentre i vissuti intenzionali diretti in maniera trascendente
sono «tutti gli atti diretti su essenze o su vissuti intenzionali di altri soggetti con altre correnti di
vissuti; così come tutti quelli diretti su cose, su realtà in generale […]»103. Da questa partizione, che
potrebbe lasciar ancora intravedere un incedere cartesiano, emergono in realtà solo i limiti cui è
consegnata la percezione immanente, cioè il polo d’identità che regola la tenuta stessa
dell’evidenza. Fin dall’Idea della fenomenologia (1907), in cui compare la prima vera
tematizzazione della riduzione fenomenologico-trascendentale – l’evidenza si configura infatti
come datità nell’originale, che chiarisce il senso gnoseologico dell’ideale rappresentato da una
piena presenza della cosa alla coscienza. Quest’ideale è ciò in ragione del quale è possibile
comprendere il reale stesso. Essendo l’ideale di una presenza priva di sfrangiature, ecco che essa
appare come il vissuto di un’identità, la piena concordanza tra l’inteso e il dato, la perfetta
correlatività dei due momenti costitutivi dell’esperienza. L’evidenza non è perciò ristretta
cartesianamente, da Husserl, a una sorta di visione intellettuale, ma va compresa come il tipico
modo di essere in cui una cosa si manifesta alla coscienza, e che può risultare a sua volta più o
meno adeguato. L’ampliamento del concetto di evidenza operato da Husserl chiarisce come esso
non rappresenti la condizione di trasparenza assoluta che spetterebbe alla coscienza, ma solo un
modo di datità delle cose e non la caratterizzazione soggettiva della presenza al proprio sé.
L’evidenza non è, quindi, un mero contrassegno psicologico della verità, ma è l’idea di un
riempimento perfetto, il telos della datità assoluta di ciò che appare. Con chiaro intento polemico
nei confronti di un certo idealismo, Husserl rompe dunque con la concezione che aveva fatto
dell’evidenza un sentimento, inteso come «mistico index veri», giacché in tal caso si trattava di
«sentimenti teoreticamente inventati», frutto di costruzioni teoriche calate dall’alto 104.
Con il principio di evidenza si fa ritorno, invece, al campo delle datità intuitive, in cui
un’esperienza attuale del tutto priva di virtualità e un’evidenza perfettamente adeguata fungono solo
da idea-limite, teleologicamente destinata a non realizzarsi. Ancorché l’esperienza immanente
venga presentata da Husserl come esemplare di evidenza adeguata, non si deve però ritenere che
l’attualità esperienziale vada ristretta all’ambito regionale dell’immanenza, giacché è semmai
quest’ultima a doversi cogliere, in relazione all’attualità, come espressione compiuta di un tendere
all’esperienza del trascendentale. In tal senso anche l’ego – definito da Husserl come «polo
trascendente d’identificazione» – non si qualifica per un’evidenza davvero adeguata, se non
nell’aporetica apoditticità del cogito. In quanto radicalmente legato al terreno dell’esperienza, il
percorso della fenomenologia deve sempre attenersi, invece, al piano dell’assertorietà, cercando di
riportare l’io della riflessione all’adeguatezza che compete alla coscienza esperiente. In questa
chiave va letta la correzione di tiro appartata da Husserl in un’appendice alle Idee, nella quale si
precisa che «anche l’essere immanente è dato alla conoscenza solo come idea, poiché necessita di
un processo di “approssimazione”. La datità adeguata è un’idea che ha il carattere di un limite al
quale ci si può approssimare a piacere»105.
In definitiva, il tentativo scheleriano d’intravedere nella grammatica husserliana della riflessione
le prove di un arroccarsi della fenomenologia in un percorso d’indagine psicologico-introspettivo è
destinato a fallire, dato che l’ambizione coltivata da Husserl è di poter mettere in luce l’invarianza
102
Husserl (2002), vol. 1, p. 89.
Ivi, p. 90. Oltre al § 38, sul tema della riflessione in generale e sull’importanza che assume per Husserl lo studio
fenomenologico della riflessione sui vissuti, cfr. §§ 76 ss. (pp. 181 ss.).
104
Ivi, p. 48.
105
Ivi, p. 417. È l’appendice XXVIII al § 144, datata intorno al 1914. Nel Bd. III/2 della Husserliana, che contiene
gli Ergänzende Texte (1912-1929) a Ideen I, Karl Schumann indica che si tratta dell’appendice 73 (p. 624).
103
�Stefano Besoli
di determinate strutture esperienziali accessibili dal punto di vista interoggettivo, indagando non
solo tali strutture, ma anche gli oggetti d’esperienza e la correlazione tra questi e i loro differenti
modi di datità. Il potenziale critico che la riflessione husserlianamente sprigiona non si limita
dunque, nel suo impiego metodologico, a stilare un resoconto di ciò che attiene all’esperienza
interna, per cui scaturiscono ulteriori difficoltà nel volerla sempre ritenere veridica o degna di fede,
tanto più se si considera che la riflessione esercita un ruolo modificante sui vissuti ai quali si
rivolge, finendo dunque per alterarli106. Attraverso gli atti dell’esperienza riflessiva veniamo a
sapere qualcosa sulla corrente dei vissuti e sul suo necessario riferirsi all’io puro ma, posta la
possibilità che una percezione immanente si dia, sarebbe assurdo ritenere che «i vissuti siano
conoscitivamente accertati solo nella misura in cui sono dati nella coscienza riflessiva della
percezione immanente»107.
L’impegno di Husserl a riconoscere, sul piano coscienziale, la mancata distinzione tra apparire
ed essere non determina quindi un’assoluta chiusura di stampo idealistico, in cui il mondo sarebbe
dissolto in una sequenza di apparizioni mentali, né esclude che la fenomenicità della cosa
trascendente sia portatrice di una sua realtà. Per la fenomenologia, le cose non vanno considerate in
opposizione a ciò che sono per la coscienza, ma nell’aspetto sotto il quale si presentano nella
concretezza della vita coscienziale. Per il modo in cui le cose necessariamente si manifestano,
l’oggetto della percezione trascendente non può mai però risultare immanente alla coscienza,
aprendosi così la possibilità del dubbio e l’eventualità del fallimento percettivo. Viceversa,
all’«essere dell’immanente», all’«io stesso», al mio io puro e all’attualità della sua vita egologica è
riservata una realtà assoluta e una posizione incondizionata, a prova di cancellazione 108. Ma se
questa condizione certifica l’assolutezza della regione coscienziale nella dimensione puramente
riflessiva, il registro cambia quando si dischiude la riflessione sul «soggetto psichico reale» e sugli
«stati» di cui si compone la «vita psichica» nella sua «realtà sostanziale». In questo caso il soggetto
è, infatti, un «substrasto di proprietà», in analogia alla «cosa materiale». Al riguardo, anche per ciò
che attiene al soggetto psichico, non tutti i vissuti ne costituiscono delle «proprietà», ma più
esattamente si tratta di suoi «modi di comportamento» o, appunto, di suoi «stati psichici». Ne
consegue che le proprietà psichiche (proprietà personali, disposizioni intellettuali, carattere affettivo
e pratico, facoltà spirituali, abilità, sensi, disposizioni immaginative ecc.) «sono quindi “unità che si
annunciano”» in relazione a determinati gruppi omogenei di vissuti reali e possibili. Pertanto, le
modalità appercettive che trasformano in realtà l’essenza di vissuti psichici che, in quanto stati,
attestano l’unità reale della psiche non possono rivendicare una conoscenza di stampo assoluto, né
di appartenere al regno dell’infallibile, proprio perché tali modi di comportamento o gli stati
psichici in genere sono sempre riferiti, nell’apprensione costitutiva, a determinate «circostanze» 109.
Certo, si può operare in un contesto di riduzione fenomenologica ovviando a questo tipo di
trascendenza e concependo la psiche solo come «essenza eidetica», ma questo limite imposto
all’analisi non farebbe che riportare ciò che ha luogo in quest’esperire coscienziale nella «cornice di
una ricerca psicologico-razionale»110.
A fronte di un atteggiamento fenomenologico che nel complesso Husserl conduce in maniera
lineare, il tragitto della fenomenologia di Scheler sembra essere invece molto più tortuoso, e
soprattutto rischia di uscire costantemente dagli argini di un corretto esercizio di pensiero
fenomenologico. Nel tormentato sviluppo della sua filosofia, Scheler ha attuato, dal punto di vista
gnoseologico, una radicale rinuncia ad ogni forma di trascendentalismo, sensismo o psicologismo,
contrastando ogni tentativo di costruire il mondo a partire da funzione sintetiche di ordine
intellettuale o anche solo dagli elementi della sensazione. Per lui è data, infatti, non solo la realtà
delle cose, ma lo è anche il loro esser-così (Sosein), per cui l’oggetto della filosofia è rappresentato
106
Cfr. ivi, pp. 187 ss.
Ivi, p. 191, ma si veda anche p. 187.
108
Cfr. ivi, p. 113.
109
Cfr. ivi, vol. 2 (si può sempre ovviare questo tipo di trascendenza operando nella cornice della riduzione
fenomenologica), pp. 125 ss.
110
Cfr. ivi, vol. 3 (La fenomenologia e i fondamenti delle scienze), p. 414 s.
107
32
�Illusione ed errore. Il dogma dell’intuizione e le avventure fenomenologiche di Max Scheler
dalla datità trascendente di ciò che immediatamente si qualifica come possessore di un’esistenza
metafisica. L’orientamento della filosofia scheleriana è di partecipare all’ente assoluto, compiendo
un «balzo» in un essere che funge da ipostasi di un’essenzialità materiale, al cui reperimento
provvede un intuizionismo spinto al limite. Se Scheler imputa a Husserl di aver annullato il divario
tra fenomeno ed essere, individuando in ciò il rischio di un arretramento idealistico-psicologico, la
sua dichiarata fenomenicità dell’essenza schiude la prospettiva di un ontologismo eidetico che si
dilata fino a comprendere la realtà, con l’obiettivo di approntare una conoscenza metafisica di ciò
che è in sé ideale111. Lungi dal sottrarre all’essenza ogni rilievo metafisico, nell’assimilarla al
fenomeno Scheler determina non solo le condizioni “trascendentali” della propria ontologia, ma
fornisce il trampolino per la sua ulteriore promozione metafisica, nella quale ciò che si svela per
com’è, sembra in effetti sussistere indipendentemente dalla propria manifestazione, con l’esito ben
più problematico – rispetto alla riconduzione husserliana dell’essere al fenomeno – di spianare la
strada a un inveramento dei fenomeni a cose, da cogliersi però intuitivamente nella loro speciale
irrealtà.
Per Scheler è l’essere, e non la sua conoscenza, a costituire l’oggetto della filosofia. I molteplici
rivolgimenti cui il pensiero di Scheler va incontro hanno come filo conduttore l’espandersi di certe
tesi ontologiche in direzione di un approdo apertamente metafisico, in cui l’essere deborda
l’oggettualità dell’ente e occorre puntare direttamente all’essere assoluto. Il superamento della
fenomenologia si consuma, in Scheler, con un’investitura metafisica dell’ontologia che fa
beneficiare il Dasein stesso di un’evidenza intuitiva. Come correlato della visione d’essenza, il
fenomeno dismette il ruolo dissimulatorio di manifestare ciò che non si vede, per assumere, nella
coincidenza col Sein, le sembianze di una datità cui si dev’essere in qualche modo riconoscenti.
L’impronta del sacro, che colora gli sviluppi della problematica scheleriana, ha la sua genesi nella
maniera in cui il fenomeno tende a confondersi con l’essere per tradursi, sganciato da ogni
immanenza coscienziale e in modo fenomenologicamente del tutto ambiguo, nell’annuncio di ciò
che non si mostra in quel che peraltro è manifesto, attestando l’alterità e indipendenza del proprio
modo di essere rispetto a quello del pensiero stesso112.
9.
La controversia di Scheler con la fenomenologia husserliana è presente fin dall’esordio del saggio
in stile baconiano, nel quale ci si occupa a spettro ampio del tema delle illusioni. Al riguardo,
Scheler intende dare un contributo alla definizione di una teoria generale delle illusioni,
distinguendo con nettezza l’illusione dall’errore. L’approccio che egli adotta è, genericamente,
quello della fenomenologia, secondo cui noi incontriamo il mondo come realmente è dato e nel
modo in cui è dato, per cui la nostra analisi si svolge sempre a partire da ciò che si presenta nella
sua immediatezza. Come corollario di quest’assunto fenomenologico – che ha per risultante una
sorta di realismo diretto – si ha che nella percezione cogliamo le cose stesse, percependole appunto
“in carne ed ossa”, “nell’originale”, e non come mere apparenze o per mezzo di raffigurazioni,
anche se la manifestazione della cosa (e cioè il vissuto) non va confuso con la cosa che si manifesta,
poiché le manifestazioni vissute appartengono al nesso coscienziale, mentre le cose che ci si
manifestano appartengono al mondo fenomenico113. Pur non essendo, dunque, una forma di
rispecchiamento, la percezione necessita sempre di una mediazione fenomenica che non serve però
a rilanciare le istanze del fenomenismo, nel senso che con tale posizione non s’intende sostenere
che le cose – senza potersi manifestare da sé –si dissolvono in una «baraonda» di fenomeni, ma che
tale piano fenomenico ha il compito di manifestare la cosa, di rendere cioè possibile che la
trascendenza degli oggetti s’imponga nell’immanenza degli atti percettivi. L’ancoraggio al mondo e
l’esigenza di far presa sulle cose costituiscono lo sfondo dell’attività percettiva, ma al contempo
occorre tener conto che le cose non possono esserci totalmente restituite nel loro immediato
111
Cfr. su ciò Dupuy (1957a), p. 263 s.
Al riguardo si veda Dupuy (1957b), pp. 36 ss. e 245 ss.
113
Cfr. Husserl (1968/2005), vol. 2, p. 142, ma si veda anche pp. 164 e 171 ss.
112
�Stefano Besoli
apparire, richiedendo infatti un decorso di scene percettive all’interno del quale s’istituisce l’unità
del riferimento in base a una certa struttura dei rapporti fenomenici. Anche in ragione di tale
impostazione, che investe sulla passività dei processi di costituzione percettiva, Husserl rifiuta la
concezione rappresentazionalistica della percezione, poiché il dato descrittivo da cui si parte è la
percezione di cose e non la presenza d’immagini racchiuse nello spazio della soggettività, come
cioè se il processo percettivo si giocasse solo all’interno della coscienza e dovesse accontentarsi di
cogliere dei contenuti mentali. L’immediatezza della percezione non può consistere, infatti, nel farsi
immagini delle cose, anche perché occorre prender atto che l’immagine, nella sua peculiarità, non è
un surrogato dell’oggetto percepito, ma è l’oggetto di una determinata modalità intenzionale
(l’immaginazione), per cui solo nell’ambito della coscienza costitutiva dell’immagine si stabilisce il
fenomeno della somiglianza114. Dal punto di vista del realismo fenomenologico, la percezione non
ha che fare, quindi, con repliche mentali di una realtà non data che si sottrae alla vista, ma è il modo
diretto di accertare cose contraddistinte da proprietà di natura sensibile e aperte a un riscontro
intersoggettivo. Su queste basi, sorge la convinzione scheleriana che non sia possibile affrontare il
problema conoscitivo dell’errore senza passare attraverso una definizione della tematica
dell’illusione.
Dall’alto della sua inclinazione realistica, Scheler voleva in primo luogo mostrare come la
percezione interna fosse esposta a illusione al pari della percezione esterna, e anzi lo fosse ancor più
di questa. Sulla questione della conoscenza di sé, la posizione di Scheler critica la tesi che i fatti
della coscienza (i vissuti psichici) siano a) non soggetti ad errore; b) conosciuti senza mediazione
alcuna; c) addirittura più originari dei fatti esterni. In via preliminare, Scheler distingue tra illusioni
ed errori, poiché questi concernono i giudizi e le deduzioni, vale a dire i procedimenti logicodiscorsivi, mentre le illusioni sono proprie di tutti gli atti intenzionali (come il percepire o il
“sentire”) che non hanno per principio nulla a che fare con il vero e con il falso, ma con ciò che
esiste o no. Contro lo svolgimento dell’intera tradizione della filosofia razionalistica, che aveva
cercato di ricondurre le illusioni a errori (confondendo le rispettive essenze e annullandone dunque
la specificità), Scheler tenta di sostenere, avvalendosi di un certo intuizionismo filosofico, che «tutti
gli errori sono fondati su illusioni», e che anzi l’errore va concepito – per sua essenza – come «un
caso limite d’illusione di un certo tipo, ovvero di «un’illusione della riflessione che si presenta nel
volgere lo sguardo ai risultati dei nostri atti di pensiero»115. Tuttavia, non solo il razionalismo
filosofico, ma anche «l’empirismo sensistico» non è stato in grado di afferrare l’essenza
dell’illusione, dal momento che in nessuna sua forma essa è immediatamente riconducibile al
materiale sensoriale su cui si costruisce l’oggetto tipico dell’illusione, e cioè il fantasma
(Phantom)116.
L’intero campo delle illusioni percettive – riguardanti sia la percezione esterna, sia quella interna
– si situa per Scheler tra il regno del «pensiero» propriamente inteso (ossia lo spazio logico del
giudizio, della conclusione, del ragionamento inferenziale) e quello delle «pure sensazioni», che
possono esserci o non esserci, potendo anche risultare l’occasione o la causa scatenante del
verificarsi di un’illusione, ma che non possono configurarsi come ciò in cui consiste l’illusione
stessa e il fantasma che essa produce. Rispetto a ciò, Scheler introduce un riferimento ad Aristotele
che potrebbe anche apparire poco chiaro, e per certi versi inesatto, per la brevità del rimando.
Scheler osserva, infatti, che se la celebre tesi aristotelica, secondo cui non ci sarebbero «illusioni dei
sensi», significasse quanto da lui sostenuto, o di fronte alla tesi equivalente che i sensi come tali non
possono né ingannare né indurre in errore, ecco che si potrebbe convenire con Aristotele. Ma
114
Cfr. ivi, pp. 206 ss. Contro la teoria indiretta della percezione Husserl mostra, in maniera definitiva, che ogni
riferimento per immagine richiede che l’oggetto, interpretato appercettivamente come rappresentazione o immagine, sia
già primariamente apparso in modo percettivo. Di conseguenza, la rappresentazione (o immagine) presuppone già dal
punto di vista intenzionale la percezione, non potendo quindi spiegarla, poiché altrimenti s’innescherebbe un regresso
all’infinito. In altri termini, le esperienze percettive presentano le cose secondo determinate caratteristiche, e cioè
registrano il modo in cui queste si manifestano, ma non possono mai caricarsi di una funzione rappresentazionale.
115
Scheler (1999), p. 50.
116
Cfr. ivi, p. 50 s.
34
�Illusione ed errore. Il dogma dell’intuizione e le avventure fenomenologiche di Max Scheler
Aristotele – secondo Scheler – parte da qui per sostenere che, proprio per questo, tutte le illusioni
equivalgono a dei giudizi erronei che si differenziano dagli errori veri e propri – quelli cioè che
conseguono sul piano della dimostrazione e della conclusione – solo per il loro carattere immediato.
In sostanza, Scheler ritiene che se Aristotele non ha inteso piegare l’essenza delle illusioni ai
parametri dell’empirismo sensistico, ha finito però per dare loro una risoluzione razionalistica,
facendone un caso particolare dei giudizi che incorrono in errore117.
La tesi di Aristotele non sarebbe dunque per Scheler corretta, poiché interpreta l’illusione in
chiave razionalistica, rendendola alla stregua di giudizio pur dichiarando al contempo che essa
avviene a livello di mera sensazione. L’essenza dell’illusione consiste invece per Scheler in
tutt’altro, e precisamente nel fatto che in essa è dato intuitivamente qualcosa che «di per sé non
c’è». Pertanto, l’illusione non ha nulla a che fare con il vero e con il falso, poiché questo genere di
alternativa si lega per intero alla dimensione apofantica del giudizio e alla sfera proposizionale.
L’illusione percettiva dev’essere in primo luogo distinta dall’ambito giudicativo, in cui vige
l’alternativa vero/falso, e ciò comporta che mentre l’illusione resta legata al terreno dell’intuizione,
l’errore rientra a pieno titolo nel campo del giudizio. In secondo luogo, l’illusione va tenuta distinta
dal criterio dell’adeguatezza della percezione, anche perché si possono ad esempio pronunciare
giudizi giusti o sbagliati su un oggetto che è frutto di allucinazione o d’illusione, ma anche
formulare proposizioni vere o false in ragione della loro eventuale adeguatezza al fantasma
dell’illusione. Tra l’altro, la distinzione tra illusione percettiva e percezione evidente riguarda il
valore di conoscenza del sapere, ma non ha a che fare con la distinzione tra vero e falso, giacché un
essere che non abbia mai avuto illusioni percettive potrebbe comunque incorrere in giudizi errati,
mentre chi è incorso già in illusioni potrebbe formulare dei giudizi veri sui fantasmi immaginati (dal
momento che la verità di un giudizio o di una proposizione riguarda sempre l’adeguatezza tra ciò
che essi enunciano e l’enunciato su cui vertono). Scheler esclude, quindi, che la differenza tra valori
di verità possa essere ricondotta, alla maniera di Spinoza, ai «gradi di adeguatezza di una
conoscenza intuitiva», e la stessa cosa può dirsi per l’illusione e per il suo opposto, la «datità
nell’originale» (Selbstgegebenheit), tanto più se si è attenti a distinguere la «pienezza di ciò che di
un oggetto ci è dato in un atto di percezione» dalla «completezza» conoscitiva ottenuta tramite il
dispiegarsi della percezione stessa118.
L’illusione non rappresenta quindi un concetto difettivo rispetto a una percezione che colga
interamente una cosa in tutti i suoi lati e le sue prospettive. L’illusione non è un atto percettivo
riempito meno adeguatamente rispetto a una percezione completa della medesima cosa. Chi
117
La dottrina aristotelica, cui Scheler fa riferimento, è sviluppata nel De anima (cfr. in particolare III, 3, 428 a 10
ss.), e si può riassumere in questo modo. I sensibili si dividono in tre specie: i sensibili per sé, percepibili in se stessi
direttamente e immediatamente, e suddivisi a loro volta in propri e comuni, e i sensibili per accidente che sono percepiti
in concomitanza con i sensibili per sé. I sensibili propri sono sensibili in senso stretto, perché è alla loro percezione che
i cinque sensi speciali sono essenzialmente finalizzati (colore, odore, suono ecc.). Si chiamano propri perché non
possono essere colti da sensi diversi da quelli corrispondenti. Per questa ragione, la loro percezione è infallibile (ma
Aristotele non parla d’illusioni), poiché ciascun senso è capace di discriminare e di giudicare il proprio sensibile, e cioè
non può confonderlo con l’oggetto di un altro senso. Da questo riconoscimento dei sensi come facoltà di giudizio
emerge dunque anche il loro potere attivo (e non solo ricettivo) nel processo della conoscenza. Ci sono poi i sensibili
comuni (movimento, numero, figura ecc.) che sono appunto comuni a tutti i sensi, poiché tutti i sensi – in misura
diversa – contribuiscono alla loro percezione. Infine, ci sono i sensibili per accidente, che sono gli enti materiali
sensibili (come le cose e persone). Rispetto al valore di verità della percezione dei tre tipi di sensibili, Aristotele dice
che la sensazione dei sensibili propri è sempre vera, in quanto ciascun senso non può scambiare i propri oggetti per
quelli di un altro senso (ad es. la vista non può scambiare un colore col suono, ma può scambiare un colore per un
altro). Soggetta propriamente all’errore è invece la percezione dei sensibili per accidente, laddove non ci s’inganna ad
esempio nella percezione del bianco, ma piuttosto nell’identificazione del bianco con un dato oggetto (e cioè
nell’inferenza con cui operiamo una determinata attribuzione accidentale). Da ultimo, però, l’occasione più frequente di
errore è procurata dalla percezione dei sensibili comuni, i quali non sono l’oggetto proprio di alcun senso speciale, ma
vengono semmai colti attraverso il funzionamento sinestetico dei vari sensi o, per dirla alla maniera di Aristotele, dalla
sensazione comune.
118
Cfr. Scheler (1999), p. 52 (trad. in parte modificata).
�Stefano Besoli
scambia ad esempio una «figura di cera» per una «signora»119, può benissimo averne colto tutte le
caratteristiche che crede di avere di fronte, a dimostrazione che l’illusione è indipendente dal livello
di adeguazione, insorgendo sempre all’improvviso (senza che in ciò entri in gioco un incremento o
una diminuzione nel grado di adeguatezza). In definitiva, l’illusione – potremmo dire – ha sempre
cittadinanza nella sfera dell’apprensione immediata, mentre l’errore avviene sempre in una forma di
conoscenza mediata. Inoltre, al contrario che nell’errore, nell’illusione è sempre implicito un
problema di riferimento all’essere. A ciò potremmo aggiungere che l’illusione riguarda sempre un
fatto, mentre l’errore può affermare anche l’esistenza di qualcosa che non c’è, come nel caso in cui
si afferma il sussistere di un animale fantastico – il che sembra comportare che la genesi degli errori
sia molto più soggettiva di quella delle illusioni. Infine, l’illusione percettiva – che è stata delimitata
verso l’alto nei confronti della sfera del pensiero – va anche tenuta distinta, verso il basso, dalle
varie illusioni sensoriali (visive, acustiche ecc.), sulle quali può anche essere fondata, ma con le
quali non coincide. Occorre dunque separare con precisione le autentiche illusioni percettive dalle
mere illusioni dei sensi. E al riguardo, Scheler chiarisce il suo punto di vista attraverso un esempio
– ripreso da una lunga tradizione scettica e presente anche in Descartes – in base al quale si può dire
che un bastone (Stab) immerso nell’acqua, e che per questo sembra spezzato, non rappresenta
un’autentica percezione illusoria, ma una normale illusione sensibile, dovuta a un fenomeno fisico
riguardante le leggi di rifrazione della luce120.
Un’illusione autentica si ha invece, per Scheler, quando differenti funzioni sensoriali danno, in
maniera contemporanea o successiva, quei contenuti sensoriali che sono richiesti (e in qualche
misura attesi) dall’oggetto dell’illusione, e cioè dal fantasma e dalle sue determinazioni o
costituzione strutturale. Un caso d’illusione effettiva si ha ad esempio quando alluciniamo un
oggetto come una sedia e, nel prenderla per un bracciolo o per una gamba, essa ci trasmette
l’impressione della forma o della presa stessa di un bracciolo o della gamba di una sedia. Qualcosa
di analogo potremmo dire avviene se, risvegliandoci di notte, abbiamo l’allucinazione di vedere un
essere umano nella stanza e, toccando l’oggetto che è causa originaria di tale allucinazione, ne
traiamo un’impressione sia tattile sia per ciò che riguarda la forma, analoga a quella che abbiamo
quando tocchiamo realmente un uomo. In questo caso, cioè, noi non esperiamo qualcosa che
oggettivamente non esiste, giacché in primis abbiamo per l’appunto un’illusione sensoriale sul
piano ottico o su quello tattile, ma al contrario sperimentiamo questo tipo d’illusione sensoriale
proprio perché crediamo che di fronte a noi vi sia – nel campo percettivo – un “non esistente” che
ha le fattezze di una sedia. Scheler insiste al riguardo, con particolare enfasi, sul fatto che le normali
illusioni sensoriali, le sensazioni abnormi o anomale, non hanno diritto di essere chiamate illusioni
percettive, anche se possono diventare materia d’illusioni, soprattutto quando travalicano la sfera
della cosiddetta normalità. Qui Scheler dà prova dunque di ritenere che l’illusione non sia solo
quell’alterazione percettiva in base a cui la percezione non si conforma alle caratteristiche dello
stimolo, determinando una sorta di discrepanza tra realtà fisica e mondo percepito. Né l’illusione
andrebbe distinta dall’allucinazione per il semplice fatto che questa si configura come una
percezione senza oggetto, vale a dire una percezione falsa in assenza di stimoli sensoriali adeguati,
che si rivelerà come tale nel corso dell’esperienza. D’altro canto, per Scheler anche nelle
allucinazioni più autentiche vi è una qualche materia di sensazione, al pari di quanto accade nelle
illusioni vere e proprie. Non c’è quindi un’allucinazione che sia esclusivamente causata a livello
centrale, senza che vi sia – come concausa – un «processo di stimolazione centrifuga della sfera
sensoriale esterna»121.
119
L’esempio del manichino o della figura di cera scambiata per una donna ritorna in molte opere di Husserl
(Ricerche logiche, Lezioni sulla sintesi passiva, Esperienza e giudizio), in cui tale problematica percettiva trova una
trattazione all’altezza del compito di volta richiesto dallo sviluppo dell’indagine fenomenologica.
120
Cfr. Scheler (1999), p. 53.
121
Cfr. ivi, p. 54 s. Su tali temi si veda in particolare Leyendecker (1913), che ha messo in mostra come ad ogni
illusione appartenga essenzialmente un tipo di disinganno percettivo, rafforzando così l’idea che non ci può essere
illusione senza che vi sia una percezione veridica.
36
�Illusione ed errore. Il dogma dell’intuizione e le avventure fenomenologiche di Max Scheler
Se nell’insieme la trattazione scheleriana sulle illusioni è maggiormente coinvolta in interessi di
carattere psicologico e psicopatologico, il livello primario su cui egli interviene è di natura
fenomenologica e teorico-conoscitiva, al fine di dare risposta a cosa sia un’illusione e a ciò che la
differenzia essenzialmente dall’errore. Nell’economia del discorso scheleriano occorre partire dalla
constatazione che quando si fa riferimento a una proposizione falsa riguardante un oggetto reale,
tale falsità può avere una doppia origine, che lo stesso linguaggio comune situa sul versante
dell’illusione o su quello dell’errore in senso proprio. Come detto, l’illusione inerisce alla sfera
dell’immediatezza, mentre l’errore ricade in quella del «conoscere mediato» o della conclusione in
senso stretto. Per sostenere ciò, Scheler porta il seguente esempio. Usciamo da casa e troviamo una
pozzanghera sulla strada, e da ciò giudichiamo che sia piovuto. Proseguendo nel nostro cammino,
verifichiamo però che la strada non è bagnata e scopriamo che invece è passato un carro che getta
acqua sulla strada (Spritwagen), al fine probabilmente di evitare che si sollevi la polvere in strade
tendenzialmente non asfaltate. Il giudizio che avevamo formulato in origine e in maniera del tutto
frettolosa, si dimostra dunque sbagliato: si tratta di un vero e proprio errore, poiché la presenza di
una pozzanghera non implicava logicamente l’idea della pioggia in relazione alla pozzanghera
stessa, con l’esito che aver precipitato questo ragionamento ha comportato un’inferenza senz’altro
indebita. Del tutto diverso è il caso in cui vedo un bastone immerso per metà nell’acqua e che mi
appare spezzato, o se vedo ergersi davanti a me nella nebbia una quercia a mo’ di gigante
torreggiante. In questi casi, si tratta propriamente di un’illusione122.
In altre parole, Scheler ci sta dicendo che l’illusione ha sempre inizio con un «contenuto ben
determinato», che crediamo appunto di vedere, di sentire, di toccare. Al riguardo, non fa differenza
quale tipo di giudizio formuliamo su di esso. Il nostro giudizio potrebbe infatti risultare falso se
riferito alla realtà, ma può invece essere vero se riferito al fantasma dell’illusione, ovvero a ciò che
in essa ci appare in maniera determinata. Nell’illusione non c’è però solo tale contenuto, ma vi è
qualcosa d’altro. Anzi – aggiunge Scheler – la mera apparizione del bastone spezzato non
costituisce ancora un’illusione, poiché questa consiste nel ritenere che «lo stato di cose dell’esserspezzato» – che ci è dato immediatamente come contenuto sensoriale – appartenga come «proprietà
reale» al bastone reale che, nella sua qualità o costituzione effettiva, non ci è dato intuitivamente
(non lo cogliamo cioè sul piano sensoriale), poiché altrimenti non vi sarebbe illusione. E tuttavia, è
come se a un primo sguardo ci fosse già «presente la sfera d’essere delle “cose stabili”» e il
manifestarsi del bastone spezzato ci consentisse di guardare all’interno di quella sfera, trasferendovi
quello «stato di cose fenomenico 123. L’illusione è quindi, come tale, indipendente dal giudicare, dal
credere, dall’asserire, situandosi nella sfera «pre-logica» dei dati di fatto, ovvero in una dimensione
che potremmo definire antepredicativa124.
Nello stesso tempo, per continuare a smarcare la nozione d’illusione da quella di errore, Scheler
afferma che l’illusione non ha nulla a che fare con il senso dell’attesa, e dunque con un’aspettativa
delusa125. Nel caso in questione, non è che ci siano infatti due bastoni: un fenomeno relativo al
senso della vista e uno relativo al senso del tatto, per cui l’illusione deriverebbe dal fatto che ci si
aspetta che il bastone sia rotto anche per il tatto – aspettativa che viene invece delusa quando
122
Cfr. ivi, p. 59.
Cfr. ivi, p. 59 s. (trad. modificata).
124
Cfr. Schilpp (1927), p. 628.
125
Più in generale, Scheler giudica erronee le teorie secondo cui la «normale percezione delle cose» si baserebbe su
una «connessione d’attesa», quando invece la situazione è per lui esattamente inversa. Scardinando il programma della
teoria della percezione fenomenologica di stampo husserliano, Scheler ritiene che in una percezione normale ci
attendiamo di vedere l’altro lato di una cosa «perché crediamo di vedere una “cosa reale”», e cioè l’attesa si baserebbe
sul fatto che nel «contenuto dell’intuizione immediata» sia già incluso che tale cosa ha «un altro lato, un interno»:
Scheler (1999), p. 112. In questo modo, Scheler dà tuttavia per scontato il sussistere in sé degli oggetti percettivi e delle
qualità che essi per così dire emanano, senza impegnarsi a descrivere il modo in cui gli oggetti sensibili si costituiscono
in decorso strutturato di rapporti, in cui il fenomeno dell’attesa – stante che la percezione racchiude una promessa che
non può essere del tutto mantenuta – è il naturale prolungamento della percezione, in grado di prolungare, dall’interno
della trama percettiva, la «credenza» o «certezza originaria» fino a realizzarne una conferma, o è passibile risultare per
contro «delusa», schiudendo le porte alla negazione, al dubbio e a tutte le moralizzazioni della «coscienza d’essere».
123
�Stefano Besoli
tocchiamo il bastone. Non si tratta di preferire, infatti, i dati del tatto quali indicatori o segni di ciò
chiamiamo reale. Se le cose stessero in questi termini – dice Scheler – dovremmo concludere che
anche prendendo in mano il bastone, esso risulterà spezzato – aspettativa che, come sappiamo, sarà
invece delusa. A ben vedere, però, le percezioni illusorie non sembrano essere accompagnate dal
fenomeno della “credenza”, che è invece un ingrediente consueto delle percezioni veridiche. Di
fronte a un bastone nell’acqua che ci appare spezzato è possibile optare tra le due alternative,
sapendo bene però che il bastone tornerà a mostrarsi integro non appena lo estrarremo dall’acqua e
che anche in questo caso, quindi, la percezione consente di decidere a quali apparenze dare ascolto,
poiché è la peculiarità stessa del fenomeno osservato a dare ragione per così dire al tatto. Senza
abbandonare il terreno dell’esperienza e dover necessariamente sostenere che sia il tatto a smentire
la vista, è possibile avere contezza di come si è generata l’illusione, sapendo perché le cose ci
appaiono così, anche se siamo sempre al cospetto di un’esperienza che ci mostra un bastone
spezzato, facendoci vedere un bastone per come esso realmente non è. L’obiezione di Scheler al
riguardo è che, traendo questo tipo di conclusione, è come se riducessimo di nuovo l’illusione ad
errore. Viceversa, l’illusione «permane», malgrado questo tentativo di riduzione. Dire, infatti, che
esistono due bastoni relativi ai due sensi coinvolti, ammettendo la presenza di due oggetti differenti,
non sgombrerebbe il campo dall’illusione, ma ci porrebbe solo nelle condizioni di avanzare che a un
oggetto reale se ne aggiunge un altro solo mentale, che non è come la percezione ce lo mostra. Tale
ipotesi concettuale non riuscirebbe però a farci cogliere perché riusciamo a vedere solo ciò che di
fatto vediamo, dato che la convinzione guidata dalla conoscenza delle leggi della rifrazione non può
estinguere la configurazione fenomenica che sta al fondo della percezione illusoria, in quanto questa
non ha come oggetti dei puri contenuti mentali. La duplicazione oggettuale, resasi apparentemente
indispensabile per non dover attribuire dei predicati contraddittori a un medesimo oggetto, non
rende conto però del fatto che le percezioni illusorie sono solo parzialmente ingannevoli, poiché
fanno comunque riferimento a un oggetto mondano e hanno lo stesso materiale sensoriale e la
medesima struttura della percezione che ci consegna ciò che ha effettivamente luogo nella realtà.
Per Scheler, dunque, l’illusione non scompare, non si dissolve quando – toccando il bastone – ci
accorgiamo che esso non è spezzato: tale circostanza ci permette solo di rifiutare la proposizione
falsa basata sull’illusione. Infatti, l’apparizione illusoria continua a esserci – il suo contenuto per
così dire permane – nel senso che «crediamo» sempre di vedere nell’acqua un bastone spezzato. Ciò
significa che l’illusione non può «consistere» in un’«attesa insoddisfatta» o delusa, giacché
l’illusione sussiste anche quando – dopo aver toccato il bastone – tale aspettativa viene meno126.
Ammettere di percepire nelle due apparenze fenomeniche il «medesimo reale» consente di
riconoscere la contraddittorietà delle due proposizioni costruite su di esse. L’inverso però non vale,
giacché è sbagliata la concezione secondo cui noi costruiremmo percettivamente le cose a partire
dai loro singoli aspetti visivi o tattili, come se esse fossero concepibili come una sorta di mosaico o
d’incastro determinato da tessere o elementi in qualche modo presupposti a una totalità che si
compone di essi. Il quadro teorico presupposto da Scheler è viceversa capovolto: noi percepiamo le
cose stesse in quanto cose, nella loro unitarietà per così dire gestaltica (e cioè come un tutto
strutturato), anche se tale percezione avviene sempre per gradi, in maniera unilaterale, dato che
percepiamo le cose sempre per adombramenti (Abschattungen), sotto determinate angolature o
scorci prospettici. In questo, Scheler sceglie il rigore fenomenologico, poiché anche Husserl ritiene
che l’esperienza sia sempre oggettualmente strutturata, per cui anche la sfera della passività è in
qualche modo astratta, divenendo tematica solo tramite un regredire dall’oggetto ai suoi presupposti
genetico-strutturali. È in tal senso che Husserl critica infatti l’atomismo sensistico della psicologia,
che dava precedenza ai dati sensoriali e non alla relazione intenzionale che la coscienza intrattiene
con l’oggetto nei suoi modi di datità. Anche quando cogliamo un bastone che ci appare
illusoriamente spezzato (dal punto di vista del fenomeno visivo), il nostro sguardo è in realtà rivolto
al bastone nella sua interezza. Solo attraverso «atti successivi di riflessione» si giunge a isolare i
diversi contenuti parziali di un dato fenomenico complessivo, attribuendoli alle varie funzioni
126
Cfr. Scheler (1999), p. 60 s.
38
�Illusione ed errore. Il dogma dell’intuizione e le avventure fenomenologiche di Max Scheler
sensoriali (al vedere, al toccare ecc.). Ma l’illusione – come si è detto – riguarda altro, e consiste nel
cogliere immediatamente «lo stato di cose dell’esser-spezzato, presente nel fenomeno visivo, come
una «proprietà reale» del bastone in quanto cosa. Ciò significa che tale stato di cose – inconfutabile
come contenuto del vedere, ma che necessita di una spiegazione di ordine fisico – viene trasferito in
uno «strato dell’essere» al quale non appartiene, e precisamente a quello dell’«esistenza reale della
cosa»127.
La tesi avanzata da Scheler comporta quindi che in ogni illusione vi siano sempre più stati di
cose e strati dell’essere coinvolti (ad es. la sfera dell’essere reale e quella dell’apparenza sensoriale).
In ogni caso, l’illusione non consiste in un atto di natura giudicativa (di semplice credenza o
affermazione), ma rientra nella sfera pre-logica, giacché esprime un «rapporto inadeguato tra
almeno due stati cose e gli strati dell’essere appartenenti a essi» 128. Nel caso dell’errore, le cose
stanno invece in maniera diversa, poiché non si richiede che un giudizio sia formulato con
riferimento a un qualche strato dell’essere. Un giudizio può essere formulato, infatti, riguardo alla
non-esistenza, così come in positivo riguardo all’esistenza di qualcosa (di uno stato di cose), e un
giudizio così strutturato può essere vero o falso. Il riferimento a un qualche strato dell’essere non è
dunque una caratteristica necessaria del giudizio, e poiché l’errore è sempre la proprietà di un
giudizio, un simile riferimento non è nemmeno una caratteristica necessaria dell’errore. L’errore
consiste sempre, infatti, nel rapporto tra due stati di cose: quello che intendiamo nel giudizio e
quello che ci è dato nell’intuizione. Per meglio dire, l’errore consiste, per Scheler, nella
discordanza, nella mancata conformità che si verifica tra i due stati di cose: «quello inteso» (che si
regge su connessioni di significato) e «quello dato nell’intuizione», vale a dire quello meramente
pensato e quello dato sotto il profilo intuitivo. Scheler rileva che qui non sono però in causa degli
strati dell’essere, poiché a differenza dell’illusione – che ricade interamente nella sfera
dell’intuizione – l’errore sta invece nel rapporto tra «pensato e intuito»129.
Proprio ciò costituisce un’ulteriore significativa differenza tra illusione ed errore, visto che
mentre la prima aderisce interamente alla sfera dell’intuizione (o, se si vuole, della sensazione),
l’errore ha una struttura per così dire relazionale, inerente al rapporto tra pensiero ed essere. Ciò si
evince considerando ad esempio un caso di allucinazione, in cui chi ha un’allucinazione può anche
enunciare delle proposizioni false sulla realtà che lo circonda, e tuttavia non si tratta al riguardo di
errori, né è necessario che lo siano. Questa persona può certamente descrivere un determinato
oggetto – frutto di allucinazione – nella maniera più accurata, in modo che questa sua descrizione a
parole (e cioè nello stato di cose inteso nel giudizio) sia del tutto conforme agli stati di cose che gli
sono dati intuitivamente. Ovviamente, non si può dire in questo caso che egli incorra in un errore,
poiché tale condizione si realizzerebbe, eventualmente, se egli asserisse degli stati di cose di cui non
ha riscontro diretto nell’intuizione o che gli sono dati in maniera diversa 130.
Tutto questo comporta per Scheler una differenza ancor più accentuata tra illusione ed errore, dal
momento che il fenomeno complesso (la manifestazione) che ci è dato nell’illusione è sempre un
fatto, e come tale è incontestabile e inconfutabile. Questo significa che l’illusione non può
consistere nel suo contenuto e che un tale fatto complesso non è necessario che esista laddove
invece si dà errore, giacché in questo possiamo anche affermare l’esistenza di un oggetto (o di uno
stato di cose) che viceversa non esiste per nessuno dei sensi, come quando poniamo un contenuto
complesso (ad esempio un centauro) che contrasta con la sfera intuitiva dei dati di fatto. L’inganno
proprio dell’illusione non consiste dunque in ciò che ci è dato intuitivamente (e che i sensi per così
dire ci veicolano), ma ha che fare con un aspetto formale riguardante il fatto che attribuiamo quel
contenuto intuitivo complesso a una sfera dell’essere cui non appartiene o sulla quale per così dire
non poggia. Mentre nell’errore capita di riferirsi a qualcosa che propriamente non esiste, e che
quindi non è oggetto d’intuizione, nel caso dell’illusione questa evenienza è invece esclusa, nel
127
Ivi, p. 61 s. (trad. modificata).
Ivi, p. 62 (trad. modificata).
129
Cfr. ibid.
130
Cfr. ivi, p. 62 s.
128
�Stefano Besoli
senso che il contenuto dell’illusione è sempre qualcosa di effettivamente intuito, non è un puro
nulla. Per questo, imparare a vedere il contenuto di un’illusione nella sua reale sfera dell’essere –
non trasferendolo cioè a una sfera cui non appartiene – comporta il venir meno o la sparizione
dell’illusione stessa, senza però che il contenuto dell’illusione sparisca o venga anche solo
modificato in quella sfera che gli compete realmente e in cui lo intuiamo essere. Il contenuto
sensoriale intuito rimane cioè lo stesso. Per tornare all’esempio del bastone spezzato, l’illusione
cessa di essere nel momento in cui attribuiamo il dato di fatto del bastone rotto alla sola cosa visiva.
Ciò che fa di un’esperienza normale un’illusione è il fatto di vedere come spezzata la cosa reale
“bastone”; così come rappresenta una forma d’illusione quell’ostilità o quell’odio che indirizziamo
indiscriminatamente a tutte le cose, avendo rimosso l’oggetto cui l’odio era in origine rivolto, e
ritornando viceversa al quale viene meno anche quello stadio d’illusorietà. In altre parole,
nell’illusione ciò che è inteso in qualche modo esiste sempre, per cui essa concerne «solo il “come”
dell’esistere e non l’esistere in sé» (il contenuto intuitivo in sé)131.
Scheler conclude la sua trattazione riferendosi, in maniera particolare, a «una differenza
fenomenologica tra illusione ed errore, relativa al fatto che la prima è assai meno individuale e
soggettiva del secondo, poiché sotto l’aspetto genetico il meccanismo dell’illusione è indipendente
dall’io che – nel verificarsi dell’errore – si comporta invece in maniera consapevolmente attiva,
attraverso forme di riflessione e di giudizio che contemplano l’uso deliberato dell’attenzione. Al
contrario di quello che a tutta prima saremmo portati a ritenere, Scheler sostiene che,
«nell’esperienza dell’illusione», ciò che porta a una proposizione falsa non proviene «da me» (dal
soggetto), poiché nell’illusione tutto parte invece da una manifestazione che «si spaccia per
qualcosa che non è», ma non per qualcosa che non c’è. Per contro, nell’errore è sempre il soggetto a
determinarne il verificarsi, attraverso le sue interpretazioni e il suo giudicare, tanto che l’errore è il
«risultato» di attività inferenziali del tutto coscienti, che prendono le mosse dall’io. Nell’illusione si
ha, invece, che una manifestazione pretende di essere qualcosa che non è, quasi si trattasse di un
«mentire» che ha il suo centro e il suo punto di partenza non nel soggetto ma nell’oggetto, che
conserva quindi il suo status di fatto assolutamente incontestabile. Di qui il carattere assai «meno
individuale» e «soggettivo» dell’illusione che, a differenza dell’errore, presenta un «meccanismo
genetico» del tutto staccato dalla soggettività132.
10.
Anche in quest’esercizio critico, nel quale Scheler dichiara di servirsi del metodo fenomenologico,
non manca la prova della sua naturale predisposizione a saltare i passaggi e a procedere tramite
rovesciamenti prospettici, che spesso si accontentano di dar luogo a esiti paradossali. Non mancano
inoltre, nella sua analisi, incongruenze e semplificazioni che rischiano di comprometterne la
riuscita, gettando più di un sospetto sul tenore obiettivistico che egli intende conferire alla propria
fenomenologia. In maniera ripetuta, Scheler insiste sull’esigenza di distanziare la dottrina
dell’illusione dalla teoria dell’errore, poiché qui deve insediarsi il contrasto nei confronti di ogni
tendenza idealistica. Tuttavia, sono molte le indecisioni o le vere e proprie contraddizioni che
mettono a repentaglio le sue affermazioni. Da un lato, ad esempio, Scheler distingue tra illusioni
percettive e mere illusioni sensoriali, ma al tempo stesso sostiene che l’illusione permane nella sfera
del materiale sensibile direttamente intuito, proprio per preservarla dal contatto con l’ambito
giudicativo in senso proprio. Ciò rende però più difficile mantenere in vigore il primo tipo di
distinzione, anche se il baricentro dell’indagine è tutto spostato sul versante di natura gnoseologica.
Tale incertezza si riverbera poi su un’assunzione per così dire topografica, che per un verso colloca
l’illusione interamente a livello d’intuizione sensibile, mentre per un altro le assegna una postazione
mediana tra la sfera del giudizio e quella delle pure sensazioni, che si limitano a testimoniare il loro
esserci o no. Quest’oscillazione determina, naturalmente, più di un crampo mentale, rendendo
ambigua la posizione occupata dall’illusione, che non si sa se sia invariabilmente consegnata al
131
132
Cfr. ivi, p. 63 s.
Cfr. ivi, p. 64.
40
�Illusione ed errore. Il dogma dell’intuizione e le avventure fenomenologiche di Max Scheler
livello intuitivo o se invece non sconti un qualche tipo di legame con il “piano nobile” del giudizio.
D’altronde, l’intero sviluppo del discorso scheleriano sembra andare in questa direzione, nella
misura in cui il Leitmotiv ribadisce, senza tregua, che l’illusione deriva dall’attribuire uno stato di
cose, immediatamente colto nell’intuizione, a una sfera dell’essere cui esso di fatto non appartiene –
attribuzione che avverrebbe all’improvviso e senza che nient’altro intervenga. Al riguardo, è
difficile però togliersi dalla testa che tale riferimento erroneo non preveda il concorso di una
qualche forma di giudizio e che tale trasferimento inappropriato non sottenda un richiamo di tipo
inferenziale. Ma su questo punto Scheler è inflessibile, operando una chiusura totale. Per lui,
l’illusione avviene in un’assoluta immediatezza, all’interno di cui si nasconde però l’atto di
attribuzione che la connota, dando l’impressione che – non potendoci essere una totale coincidenza
tra i due momenti di tale rivendicata immediatezza – l’illusione comporti un’eccedenza di pensiero
o un’istanza riflessiva che mal si coniuga con un’apprensione quanto mai diretta. A prescindere
dalla stravaganza di ritenere che l’errore non faccia riferimento all’essere, rendendo con ciò
problematico interrogarsi sullo statuto dei giudizi di forma esistenziale, sembra che Scheler voglia
far convivere il permanere dell’illusione con il perpetrarsi di un atteggiamento naturale che, in
funzione anti-copernicana, certifica la genesi oggettiva dell’illusione nella sua radicale
indipendenza dal soggetto. Dietro al fatto che la stessa attribuzione su cui l’illusione si regge sia per
così dire occasionata dall’oggetto che, pretendendo di qualificarsi per ciò che non è, trae in inganno
l’io con una spontanea e disinteressata dissimulazione naturalistica, sembra però di scorgere qui la
presenza di un atto d’accettazione apparentato al giudizio. Se, infatti, è un erroneo riferimento a
costituire il nucleo dell’illusione, e se esso – dal punto di vista strutturale – appare materia di
giudizio, è chiaro che l’intento di stabilire con nettezza un divario tra l’errore giudicativo e
l’illusione percettiva risulta quantomeno traballante. Per quanto l’illusione percettiva possa
dipendere da cause fisiche o da disposizioni fisiologiche e mentali, il falso riferimento attuato
dall’illusione introduce l’errore già sul suo stesso terreno, rendendo palese in essa la presenza di un
«giudizio in stato nascente»133, ovvero di un giudizio in forma per così dire embrionale. In tal senso,
diventa arduo separare con nettezza illusione ed errore, anche se non è difficile individuare qualche
differenza specifica. In ogni caso, i confini tra illusione ed errore sono assai più fluidi di quanto
Scheler non fosse disposto a riconoscere, con il risultato che è addirittura l’illusione a fondarsi
sull’errore – e non viceversa come preteso a forza da Scheler – poiché l’attribuzione sbagliata di cui
essa è responsabile ha tutte le sembianze di un giudizio erroneo.
Già da queste premesse era facile intuire come il pensiero di Scheler fosse destinato a
distanziarsi sempre più dall’orientamento della fenomenologia husserliana. La sensibilità filosofica
di Scheler non avrebbe potuto intercettare il livello di approfondimento costituito dalla
fenomenologia genetica husserliana, condizionata com’era da una concezione statica
dell’intuizione, incapace di riconoscere il carattere operativo del Wesen, come complesso dinamico
di relazioni. Interrogarsi sul fatto che la percezione talvolta c’inganni e, conseguentemente,
sull’effettiva natura dell’illusione, non significa certo minare la percezione alle fondamenta, ma
nell’impostazione scheleriana c’è qualcosa che riporta comunque a vecchi strumenti di pensiero.
Scheler non rispolvera, nel contesto percettivo, la nozione d’immagine, né pensa alla conoscenza in
termini di raffigurazione, ma la sua concezione dell’illusione sembra riproporre inconsapevolmente
le condizioni per riaffermare una dottrina rappresentazionalistica della percezione, non disgiunta
dalle inevitabili conseguenze scettiche. Se l’illusione e il dubbio sembrano richiamarsi
indirettamente all’affidabilità dei sensi, rivendicando come l’oggetto percettivo sia, di norma, una
datità immediata e indubitabile, l’argomento di Scheler scommette al tempo stesso sull’idea che il
contenuto intuito nell’illusione sia un’immagine provocata dall’oggetto in maniera gratuita, alla cui
fissità non è lecito però sottrarsi, poiché anche tale contenuto si manifesta con una fisionomia ben
definita, che imbarazza e complica l’andamento della conoscenza stessa. Vale a dire, se la verità
risiede nei caratteri intrinseci di ciò che è dato e nell’esser-così di un contenuto che si manifesta
intuitivamente, senza far ricorso cioè a una relazione estrinseca che soddisfi la concordanza con
133
Schilpp (1927), p. 632.
�Stefano Besoli
l’oggetto, nel caso dell’illusione è l’immagine che si frappone all’effettivo modo di essere del
contenuto intuito a risultare falsa, oltre che ingannevole, per il fatto di attribuirgli un Sosein che non
gli corrisponde intimamente134.
Scheler prende in esame il fenomeno dell’illusione sullo sfondo di una fenomenologia della
percezione esterna, che non trova però un compimento soddisfacente. Egli ritiene, in maniera
condivisibile, che i fenomeni fisici non costituiscono un contenuto coscienziale che deve trovare
fondazione nello psichico, riportando l’intero campo fenomenico nel recinto della mente. Anche la
dipendenza dei fenomeni della percezione esterna dal corpo del soggetto percipiente non ne fa,
infatti, un contenuto psichico, ma solo un «oggetto più o meno relativo all’esistenza», in ordine al
tipo di dipendenza che esso sconta135. Scheler contrasta, quindi, sia il percorso cartesiano, che aveva
portato a dare una «spiegazione fisica» di «tutti i fenomeni esterni», sia il tentativo ugualmente
maldestro di voler considerare dapprima i fenomeni come senz’altro psichici, per poi introdurli
nell’ambito del fisico tramite «conclusione» o «interpretazione» 136. A questo tipo d’impostazioni
Scheler oppone che «in ogni atto della percezione esterna diviene evidente l’esistenza del fisico, di
una natura tout court», e solo in relazione ai modi d’essere, più o meno dubbi, di tale oggetto può
scaturire un’ulteriore questione, spesso sommariamente rubricata col titolo di «realtà del mondo
esterno». Naturalmente, rispondere a tale questione non significa confidare su una “realtà”
(Realität) assunta come «al di là della coscienza», ma basarsi «sull’esistenza data come evidente del
mondo esterno già come fenomeno [Phänomen]»137. Pertanto, ne discende che, così come i
fenomeni psichici e i fenomeni fisici sono dati per Scheler in maniera ugualmente immediata, anche
gli strati dell’essere reale e i fantasmi dell’illusione sembrano essere accolti in una sorta di
assolutezza, che rende per così dire simmetrico il realismo ontologico scheleriano. «Anche laddove
ad esempio c’inganniamo assumendo che vi sia qualcosa di vivente, lì nel contenuto dell’illusione
dev’esserci data l’essenza [Wesen] intuitiva del “vivere”. Chiamiamo “fenomeno” [Phänomen] il
contenuto di tale intuizione», che non ha nulla a che fare con il manifestarsi di qualcosa di reale, né
con la parvenza, ma è il correlato di un’intuizione fenomenologica che traccia i contorni di
un’esperienza ugualmente atteggiata138. Attenendosi al presupposto di un’accessibilità pressoché
immediata del mondo reale fisico, Scheler sembra piegarsi al riconoscimento che le illusioni
costituiscono solo una forma di debolezza della natura umana, che si può semplicemente superare
inibendosi dall’attribuire un determinato contenuto a una sfera d’essere che non gli compete 139. In
questo modo, Scheler imposta però una strana genealogia della logica che, invece di analizzare
come il fenomeno dell’illusione si determini, dal punto di vista della sua essenza, nelle
problematiche della modalizzazione inerenti alla processualità del decorso esperienziale, preferisce
ricorrere a un iper-realismo che ribalta l’onere della prova, sostenendo che sia una fantomatica
illusione a trarre il giudizio in errore e a collocarlo in un ruolo derivato, al fine di dettargli le
condizioni per essere dissolta.
Dal canto suo, la riflessione husserliana segue un indirizzo assai diverso. La grande novità della
fenomenologia è consistita, infatti, nell’operare un’analisi genetico-strutturale dell’esperienza,
discendendo nel sottosuolo in cui – in forma stratificata – ha luogo, nella più anonima passività, un
autonomo processo di costituzione oggettuale. Ciò ha consentito di affrontare, in termini risolutivi,
il tema dell’origine antepredicativa delle forme del giudizio, e con ciò d’illustrare come anche la
genesi dell’errore sia ben radicata sul terreno della passività. Di qui la matrice del rinvio husserliano
alla percezione come esperienza più originaria. Nella sua immediatezza, la «percezione è il modo
originario dell’intuitività (intesa sempre nel senso della posizionalità dossica)»140: essa è in qualche
modo il paradigma dell’evidenza e la fonte che nutre la «tesi generale del mondo» nell’ambito
134
Su ciò cfr. Stegmüller (1989), p. 105.
Cfr. Scheler (1999), p. 81 s.
136
Cfr. ivi, p. 84 s.
137
Ivi, p. 85 (trad. in parte modificata).
138
Scheler (2013), p. 117 (trad. modificata).
139
Cfr. Schäfer (1978), p. 26.
140
Husserl (2016), p. 15.
135
42
�Illusione ed errore. Il dogma dell’intuizione e le avventure fenomenologiche di Max Scheler
dell’atteggiamento naturale. Nella sua assoluta semplicità, la percezione non presenta aspetti
inferenziali o un’articolazione di tipo discorsivo, ma è caratterizzata semmai da un tipo primitivo di
certezza che sottostà alle forme superiori del giudizio, nella sua veste di credenza o doxa
contrassegnata da uno stato di passiva ricettività 141. La radicalità della via battuta da Husserl porta
quindi a operare una chiarificazione delle categorie logiche e delle modalità stesse del giudizio al di
fuori dell’orizzonte linguistico-grammaticale, realizzando che «il luogo originario per
chiarificazioni realmente radicali è […] la percezione e, per motivi che diventeranno in seguito
evidenti, soprattutto la percezione trascendente»142.
È in questo quadro che Husserl traccia un’analisi dinamica della struttura percettiva, colta alla
stregua di una grammatica implicita della sensibilità che precede ogni forma di espressione
linguistica. In tal modo si avvia un’indagine archeologica del giudizio che porta a mostrare come il
logos sia già presente prima di ogni esplicita formalizzazione verbale delle regole logiche, il cui
valore si concretizza in anticipo rispetto alla loro tematizzazione, a dimostrazione che l’aspetto
meramente sintattico deborda da quello del linguaggio espressivo. Il carattere di omologia formale
registrabile tra il dominio della sensibilità e la dimensione categoriale diviene ancor più esplicito
allorché Husserl esamina non la strutturazione interna delle connessioni logiche, ma le
modalizzazioni del giudizio, in un legame che riporta alla coscienza percettiva come coscienza
originariamente non modalizzata, che costituisce il mondo tramite sintesi concordanti che hanno per
riferimento cose date in carne ed ossa, in una sorta di certezza o credenza percettiva corredata da
una qualche ingenuità. Lo spostamento della problematica logico-linguistica sul piano percettivo
non comporta un arretramento a livello dei vissuti di stampo psicologistico, ma impone di riflettere
su un metodo di chiarificazione che mette in rilievo come molte proposizioni enuncino stati di cose
accertati in maniera percettiva. L’originarietà della percezione rispetto alla logica dell’esperienza è
di natura puramente fenomenologica è va intesa con l’obbligo di dover «già parlare di giudizio in
senso ampio in ogni rivolgimento antepredicativo e obiettivante a un ente», come nel caso di una
«coscienza percettiva in cui un oggetto sta di fronte a noi come esistente» 143.
L’estensione della logica in direzione della sfera della passività si giustifica in funzione
dell’operatività antepredicativa della percezione e del riconoscimento di elementi logici in questa
stessa base esperienziale. Ciò non significa, tuttavia, che la strutturazione proposizionale
dell’enunciato categoriale possa corrispondere a quella sintetica del dato percettivo, ma solo che in
tale rapporto c’è il riscontro di una precedenza che non può essere aggirata. Le strutture della
percezione vengono infatti prese in considerazione, da Husserl, per la necessità d’intendere «come
sull’esperienza percettiva sensibile si costruiscano le operazioni logiche con il loro risultato di
formazioni logiche e come sul fondamento della percezione siano prodotti, tramite spontaneità
logica, oggetti categoriali, oggettualità generali e di stati di cose»144. Da qui si evince come la
percezione categoriale husserliana – a differenza del modo in cui Scheler considera l’intuizione
d’essenza – non sia un atto di natura intellettuale che coglie, nell’immediatezza, ciò che altrimenti è
consegnato a una forma discorsiva, ma sia deputata a cogliere – partendo dall’articolazione dei
processi percettivi – le strutture della base estetica e del genuino momento intuitivo da cui si
stagliano le forme rinvenibili sul terreno proposizionale. In questa congiuntura di pensiero, Husserl
radicalizza alcuni aspetti delle «sintesi estetiche» o sensoriali, cercando di chiarire il significato
della logica trascendentale nella sua operatività originaria e fondativa, e cioè non solo come scienza
di una coscienza «conoscitiva», impegnata sul fronte teoretico-scientifico, ma come scienza
«predonatrice», rivolta non solo alle operazioni logiche, ma alla definizione in termini costitutivi
delle condizioni di possibilità di queste stesse operazioni, il cui senso non può essere kantianamente
orientato alla pura forma. La percezione occupa quindi un luogo di congiunzione tra la semplicità
dell’affezione e i tratti sintetici del concetto, ma ciò che le conferisce valore in questo contesto è il
141
Cfr. ivi, p. 146.
Ivi, p. 104.
143
Husserl (2007), p.135 (trad. modificata).
144
Ivi, p. 153 (trad. modificata).
142
�Stefano Besoli
depositarsi in essa dell’evidenza originaria di un’impressione data nel presente, sulla quale può
erigersi l’evidenza di ordine superiore del giudizio costituito in maniera categoriale. Il presupposto
costante della genealogia della logica muove, dunque, dalla centralità del carattere posizionale della
percezione, rilevante per cogliere la logicità della stessa processualità dell’esperienza. L’attività
della percezione parte sempre dal riconoscimento di qualcosa di dato, che funge da momento di un
decorso percettivo in cui la cosa tende a confermarsi di continuo nel senso oggettuale che manifesta.
Affinché un oggetto non sia una mera sequenza di manifestazioni, queste devono integrarsi e
trovare una conferma reciproca, unificandosi in un sistema coerente. Il decorso percettivo produce
una coscienza unitaria solo se tra le diverse manifestazioni si registra un «nesso di affinità» e se la
loro fusione dipende da una congruenza contenutistica 145. Come «sintesi continua del
riempimento»146, la percezione si configura come un processo in cui le anticipazioni di ogni fase si
riempiono nell’impressione originaria della fase successiva. Tuttavia, non è detto che le cose
continuino a procedere con questa linearità, giacché l’attualizzazione dei rimandi può deludere le
attese. Di conseguenza, il decorso può subire un arresto e l’attesa determinata in termini
contenutistici, che di continuo si ripropone nella certezza cosiddetta originaria, può andare delusa.
Di qui l’emergere di una questione percettiva appartenente al “non”, preliminare rispetto al modo in
cui la negazione si consolida come proprietà autenticamente proposizionale. Di norma, la struttura
della percezione è un processo che non conosce ostacoli, accompagnato da una certezza d’essere
indiscutibile e da una credenza che ne riassume il senso. Nella struttura standard dell’atto percettivo
è già inclusa la certezza di ciò che immediatamente percepiamo, dato che anche le attese
protenzionali non sembrano mettere in dubbio o revocare l’andamento di tale esperienza, trattandosi
di attese volte alla sua conferma. Su questa situazione soggetta alla processualità, che si traduce,
anche sotto il profilo conoscitivo, in una sorta di «abitudine»147, incombe il pericolo di
un’interruzione che complica la struttura originaria del decorso percettivo, imponendole una
modificazione derivante dalla presenza di un ostacolo che frena il previsto prosieguo della
percezione stessa. Il problema della negazione può di principio scaturire, quindi, solo in presenza di
un processo percettivo di natura posizionale, e cioè ancora essenzialmente non modalizzato. Le cose
però cambiano quando un oggetto, nel suo costituirsi percettivo, si manifesta nella forma
dell’«altrimenti», dando sfoggio di aspetti inattesi. Al riguardo, infatti, si smarriscono le
concordanze interne al processo percettivo che avevano accompagnato, per lunghi tratti,
l’acquisizione di un determinato senso oggettuale, e al loro posto subentra una delusione – una
situazione conflittuale e di vero e proprio contrasto – che colpisce «solo una parte dell’intenzione
predelineante»148, generando una soppressione dell’attesa che impone all’indietro una
modificazione delle direzioni intenzionali passate e del modo in cui certe attese possono essere
riattualizzate, ma soprattutto determina una riconfigurazione profonda della struttura della vita
coscienziale. Con tale cancellazione retroattiva, «l’intero senso della percezione si modifica, e non
solo quello che appartiene al tratto percettivo attuale»149, per cui il precedente corso dell’esperienza
viene per così dire «reinterpretato», conservando però al suo interno traccia dell’esperienza
soppressa nelle forme di un’esperienza per l’appunto cancellata. L’elemento soppresso assume
perciò il «carattere modale del “non valido”» e anche la rispettiva coscienza subisce la stessa
alterazione modale, pur in presenza della mantenuta identità del «senso oggettuale» 150, che non è
conferito dall’esterno ma è immanente alla struttura della datità percettiva, e in quanto tale funge da
regola che presiede al decorso percettivo, contrassegnando lo stile della percezione stessa. Il fine
della trasposizione problematica compiuta da Husserl diviene qui del tutto perspicuo, nella misura
in cui la negazione – come fenomeno d’interruzione e caso esemplare di modalizzazione della
struttura percettiva – mostra come la percezione possa riprendere il suo corso e come il ripristino di
145
Cfr. Husserl (2016), pp. 245 ss.
Ivi, p. 178, ma cfr. anche p. 150.
147
Husserl (2016), p. 81.
148
Ivi, p. 106.
149
Ivi, p. 103.
150
Cfr. ivi, p. 109.
146
44
�Illusione ed errore. Il dogma dell’intuizione e le avventure fenomenologiche di Max Scheler
una certezza sempre meno ingenua qualifichi il «destino della coscienza», per la quale «tutti i
cambiamenti e le modificazioni, di cui fa esperienza, rimangono, dopo la modificazione,
sedimentati in essa come sua “storia”»151.
Anche nel caso del bastone spezzato – che per lo stesso Scheler non rappresenta una schietta
illusione percettiva – non è possibile sostenere di vedere qualcosa che non corrisponde a ciò che
realmente si percepisce, per cui non c’è rischio di dover adibire tale contenuto a puro arredo
mentale. C’è però un altro esempio, riproposto in varie fasi da Husserl, che consente di risalire, in
maniera più puntuale, al meccanismo che genera l’errore e alla stessa problematica del dubbio
attraverso una disamina delle strutture della passività, conseguente al passaggio da una grammatica
concettuale inerente alla sensazione a una che dà esclusivo rilievo al tema dell’affezione.
L’emergere del significato della negazione dal terreno dell’esperienza percettiva ha evidenziato la
possibilità che a una determinata apprensione originaria, in cui sono presupposte delle attese che
anticipano un certo sviluppo della percezione, se ne sostituisca un’altra basata sulla delusione di tali
attese, nella quale si nega il precedente senso apprensionale, che conferiva un preciso orientamento
appercettivo al decorso in questione. In questo mutamento direzionale, generato da un cambio di
apprensione, viene mantenuta però l’unità del riferimento oggettuale, poiché il fenomeno della
negazione avviene nel contesto di un’intenzione più vasta destinata a trovare riempimento, mentre
all’interno di essa trova spazio l’intenzione elusa nella modalità del contrasto. La forma logica della
negazione si trova perciò già approntata a livello antepredicativo, laddove la delusione convive con
un riempimento parziale che garantisce una certa continuità e concordanza alle esperienze
percettive, consentendo loro di riferirsi a un unico oggetto.
Tra le diverse strutturazioni che il processo percettivo può assumere, la modalità delusiva che
porta a negare l’apprensione originaria non è però la sola, dato che un ulteriore aspetto problematico
si dischiude con il «modo della transizione verso la negazione», ovvero col fenomeno del dubbio
che può presentarsi come «stato duraturo» oppure risolversi sia nella forma dell’affermazione, sia in
quella della negazione152. Nella trattazione di tale tema ha una notevole pregnanza il caso del
manichino o, come si potrebbe anche dire, dello scambio di persona, che Husserl non si stanca di
riproporre a partire dalle Ricerche logiche, passando per i corsi sulla logica trascendentale e la
sintesi passiva tenuti agli inizi degli anni Venti del secolo scorso, fino a farlo definitivamente
confluire in Esperienza e giudizio. Questo caso d’illusione percettiva s’inscrive, all’interno della
Quinta ricerca logica, nel confronto critico che Husserl istituisce con la nozione brentaniana di
rappresentazione, che richiedeva di essere profondamente riformulata. Per Brentano la
rappresentazione, oltre a essere preordinata al giudizio e qualitativamente diversa da esso, era vista
come base di ogni ulteriore atto costruito su di essa – non importa se conoscitivo o emozionale. La
tesi di Brentano, per nulla evidente dal punto di vista fenomenologico, è che ogni atto intenzionale
sia una rappresentazione o sia basata su una rappresentazione, Sostenendo ciò, Brentano sembrava
voler affermare che una rappresentazione possa semplicemente essere sussunta – senza in alcun
modo modificare la propria fisionomia – all’interno di un atto di giudizio che la incista, facendone il
proprio punto di partenza. Per Husserl, una rappresentazione, come del resto ogni altro atto, deve
sempre ritenersi composta di qualità e materia, per cui pare ovvio ritenere che tale qualità
rappresentazionale non possa sussistere come tale, e cioè del tutto inalterata, in un atto complesso
che assuma come propria una diversa qualità. Se si prende ad esempio il caso di un desiderio, è
chiaro che dobbiamo supporre di rappresentarci ciò che è oggetto di desiderio, ma la
rappresentazione – nell’ambito dell’atto desiderativo – non può mai essere allineata alla
rappresentazione dell’oggetto che si dà quando esso non è desiderato. Un desiderio non si compone
per giustapposizione di una specifica qualità d’atto a una rappresentazione concepita come insieme
di qualità e materia, ma è il frutto di una relazione che interviene tra la materia di una
rappresentazione e la qualità d’atto del desiderio, dando luogo così a un’essenza intenzionale di
altro genere rispetto a quella della rappresentazione.
151
152
Ivi, p. 116 (trad. modificata).
Ivi, p. 111.
�Stefano Besoli
In questa direttrice teorica si può analizzare anche l’illusione percettiva rappresentata dalla
visione di una figura “umana” presente in una vetrina, oppure di un manichino incrociato vagando
in un museo di figure di cera, e che per un istante scambiamo per una bella sconosciuta per di più
ammiccante153. Dietro a un esempio di questo tipo è sotteso il problema dell’ambiguità percettiva, il
tema del carattere figurale della percezione, ma vi è anche quello di definire la valenza
epistemologica della percezione stessa o, per converso, quella di avvicinare la formazione di un
costrutto scientifico a una visione carica di teoria. Il fenomeno del dubbio percettivo si deve per
Husserl al fatto che nella dinamica di un processo di tal genere si dà l’alternativa di poter prendere
un manichino per una persona o, più modestamente, di poter percepire il manichino stesso. Ma nei
due casi, non è comunque la stessa rappresentazione a fungere da base. Se così fosse, infatti, si
dovrebbe dire che solo il manichino è rappresentato e che, nell’altro caso, vi si aggiunge una
credenza di natura percettiva, determinando una sorta d’illusione assai deprecabile. In tal caso si
tratterebbe di un effetto di dissociazione che si attesta sul piano della percezione corretta e
dell’illusione, ma che al tempo stesso contempla il permanere di un atto di base identico. Peraltro,
sembra chiaro che si potrebbe parlare di una dissociazione – quasi si trattasse di un’opzione in
nostro possesso – solo se la rappresentazione del manichino potesse considerarsi come realmente
contenuta o preservata nell’illusione che da essa ha origine – come in fondo anche Scheler sembra
ritenere. Ma nel caso dell’illusione si può escludere che la rappresentazione originaria del
manichino si conservi, dato che essa viene per così dire soppressa per contrasto. L’insorgere
dell’illusione fa in qualche modo venir meno la presenza del manichino rappresentata, anche se il
senso apprensionale originario non viene totalmente cancellato nelle sue motivazioni, ma
ridimensionato nelle pretese di validità che indeboliscono la certezza dell’appercezione attuale.
Come modo di passaggio verso un’eliminazione che nega 154, il dubbio non porta a compimento
l’azione del negare, non mette del tutto fuori gioco un’anticipazione percettiva vuota: anche nel
caso del dubbio s’interrompe, infatti, il processo di conferme che sembra prolungare
indefinitamente il decorso percettivo, ma senza che si operi una frattura nelle forme di una
delusione dell’attesa in senso proprio. Ciò che viceversa qui si verifica, è un impedimento dato
internamente al succedersi delle scene percettive, che determina uno stallo o un’indecisione
percettiva tale da non poter però decretare la sospensione del processo, che infatti è già
dinamicamente proiettato al di là di tale impasse. Mentre dubitiamo se si tratti di un uomo reale o di
un manichino, le rispettive «apprensioni percettive scivolano manifestamente una sull’altra» 155, con
lo slittamento di un senso intenzionale sull’altro che provoca lo stato di «sovrapposizione»
caratteristico di una condizione di strutturale indecidibilità – spesso solo provvisoria – del dubbio
percettivo. Come nel caso della delusione parziale delle attese, anche qui si afferma una sostanziale
unitarietà della situazione percettiva, poiché le differenti apprensioni che entrano in gioco
riguardano sempre un medesimo momento oggettuale, un aspetto nucleico della cosa percepita e
non la cosa in quanto tale, poiché la condizione stessa del contrasto, e l’oscillare tra ragioni
contrapposte graduate da un maggiore o minor peso, richiede il «mantenersi di una certa unità del
senso oggettuale attraverso il deflusso delle manifestazioni mutevoli» 156. Al fondo delle apprensioni
che si sovrappongono «c’è un’identica compagine di dati iletici», di un medesimo materiale
sensoriale che rende più stabile la scena del «conflitto» determinatosi157. Anche in questo frangente,
le forze della «doppiezza» percettiva, che si biforca fino a raggiungere un punto di effettiva
indecisione, operano in senso retroattivo sull’esperienza trascorsa, estendendo così il «divenire
discordante con la sua sovrapposizione appercettiva […] alla coscienza ritenzionale» 158.
153
Cfr. Husserl (1968/2005), vol. 2, pp. 229 ss.; Husserl (2007), pp. 209 ss.; Husserl (2016), pp. 111 ss.
Cfr. Husserl (2007), p. 209.
155
Husserl (2016), p. 111.
156
Husserl (2007), p. 201 (trad. modificata).
157
Husserl (2016), p. 112.
158
Ivi, p. 113.
154
46
�Illusione ed errore. Il dogma dell’intuizione e le avventure fenomenologiche di Max Scheler
Se il tema dell’illusione percettiva e quella della modalizzazione 159 è ben radicato sul terreno
delle datità antepredicative, in cui vige il primato genetico della passività, la questione delle
percezioni ambigue può anche avere implicazioni teoretiche superiori. Mentre nella «possibilità
aperta», come ulteriore aspetto della modalità, non vi sono per così dire «alternative» nello
scambiare un manichino per una persona o nel caso di qualsiasi percezione fugace (e come tale non
ripetuta), al grado zero della rappresentazione l’opposizione tra manichino e persona si palesa
invece come un’alternativa esclusiva Altrimenti, sospenderemmo il giudizio, decidendo di non
essere in grado di decidere su ciò che abbiamo percepito. L’alternativa sembra presentarsi, infatti,
solo a livello di giudizio percettivo, consentendo una scelta che parrebbe comportare una
sospensione del principio d’identità degli indiscernibili, quantomeno nel caso delle percezioni
ambigue in cui a uno stesso stato di cose non ulteriormente discernibile possono corrispondere due
giudizi opposti e quindi due oggetti distinti. Questo caso di discernibilità degli identici non resta
però confinato alla percezione, ma può estendersi a situazioni di portata teoretica (ad esempio alle
diverse interpretazioni di una stessa teoria), per cui non è marginale ma generalizzabile come
principio. Il principio dell’identità degli indiscernibili potrebbe essere salvato indebolendolo,
includendo cioè tra le differenze discernibili anche il momento soggettivo che caratterizza il
giudizio. Potremmo dire, cioè, che non è vero che la stessa figura la giudichiamo ora in un modo
ora in un altro, ma si danno proprio due figure distinte, con molti tratti in comune tranne uno. Un
principio dell’identità degli indiscernibili così indebolito risulterebbe però tautologico e dunque
inservibile. E del resto questa non è la soluzione praticata da Husserl, che lega tra l’altro le proprie
indagini a un diverso indirizzo problematico.
La vicenda legata al tema dell’illusione percettiva è inizialmente affrontata da Husserl all’interno
del suo tentativo di riformare il concetto brentaniano di rappresentazione, cercando di non smarrirne
il senso unitario, ma restituendo coerenza e validità al principio che prende spunto da esso. In tal
senso, occorre lasciar cadere la pretesa che la rappresentazione circoscriva l’intera materia dell’atto
di cui è a fondamento e che possa trattarsi di un atto per così dire separabile e in sé completo. Lungi
dal costituire un atto del tutto neutrale che soggiace, ad esempio, ad ogni atto di tipo giudicativo, la
rappresentazione – come atto che ha qualcosa per oggetto, che ci pone di fronte qualcosa – è un
momento non-dipendente e astratto rintracciabile in ogni atto. Per questo, Husserl dice che le
rappresentazioni svolgono il ruolo di «vissuti non-indipendenti che appartengono necessariamente
a tutti gli atti, poiché appartengono come momenti astratti alla loro essenza intenzionale»160. In
questa chiave, la rappresentazione è un atto che ha come paradigma la percezione monoradiale,
ovvero quella che si appropria dell’oggettualità in un unico raggio d’intenzione posizionale.
Rappresentazione è, dunque, l’atto in cui qualcosa diventa per noi oggetto in senso stretto, in cui ci
è presente qualcosa che diviene oggettuale in un determinato modo. Il senso della
“rappresentazione” va colto quindi nei termini di un atto oggettivante, e cioè di quel genere di atto
che consenti agli atti non-oggettivanti (desideri, sentimenti, volizioni) di riferirsi all’oggettualità
attraverso la materia d’atto. Ogni atto, in quanto intenzionale, dev’essere rivolto a un oggetto, per
cui la rappresentazione è il termine più generico per descrivere l’atto oggettivante che, in quanto
tale, è una rappresentazione o è sempre fondato su un almeno una rappresentazione così concepita.
Gli atti oggettivanti possono essere predicativi e antepredicativi, nominali e percettivi, giudicativi e
proposizionali, ma soprattutto si distinguono in atti posizionali e non posizionali, a seconda che in
essi l’oggetto sia posto come esistente (come nel caso della percezione) o sia invece solo
rappresentato (come avviene negli atti immaginativi o nelle supposizioni). La rilevanza che Husserl
attribuisce all’analisi descrittiva degli atti oggettivanti rimonta al fatto che la nozione di significato
è intimamente connessa a un possibile riferimento oggettuale, per cui tali atti sono visti come i
principali portatori di significato.
Nell’annoverarla tra gli atti oggettivanti, Husserl rileva che la percezione, oltre a presentarci gli
oggetti, è in qualche modo garante dell’esistenza con cui li pone, ma al contempo rende esplicito
159
160
Sul tema della modalizzazione cfr. Husserl (2007), p. 227 e Husserl (2016), p. 123.
Husserl (1968/2005), vol. 2, p. 240.
�Stefano Besoli
che essa può assumere la stessa articolazione che caratterizza, nella sua complessità, le unità
proposizionali di significato. Calandosi poi nel progetto di una genealogia della logica, Husserl
evita di caratterizzare come psicologica, o anche solo psicologico-descrittiva, tale problematica
genetica, attuando un ritorno alle evidenze più originarie dell’esperienza che contempla anche il
programma di una fenomenologia genetica del giudizio. Attraverso un’attenta decostruzione di ogni
idealizzazione conoscitiva e l’analisi della struttura antepredicativa dell’esperienza, Husserl punta a
legittimare il ruolo fondante della doxa, mettendo in luce come tutto ciò che conferisce al mondo
attuale il proprio senso sia già contenuto, nei suoi tratti essenziali, nei sedimenti deposti in tale
fondo inesplorato. Il passaggio dall’esperienza antepredicativa alla configurazione predicativa della
proposizione e del giudizio scandisce la transizione dal dominio della passività a quello dell’attività,
dalla doxa passiva alla spontaneità logica, senza che sia ravvisabile però in ciò una separazione di
ordine gerarchico o un’effettiva disposizione cronologica. Nel contesto di tali indagini assume
rilievo la ricognizione genetica delle modalizzazioni giudicative e coscienziali e, ancor più, l’analisi
stratigrafica dell’esperienza percettiva, il cui senso è implicito nell’orizzonte, poiché il senso
percettivo non è il risultato che assembla i sensi delle singole fasi del decorso, ma è qualcosa che si
estende e si determina in essi, rappresentando così il fondamento e l’esito della sintesi percettiva.
Anche nella considerazione del dubbio percettivo e della tipica modalizzazione che gli corrisponde,
Husserl s’immerge nelle pieghe della percezione per cogliere in esso l’aspetto nodale delle
complicazioni in cui il suo decorso può imbattersi. Il fluire della coscienza getta di continuo davanti
a sé un orizzonte protenzionale, ma tra i momenti essenziali dell’attesa vi è la possibilità della
delusione. Il ruolo cruciale della percezione deriva dal fatto che solo grazie ad essa è possibile dare
riempimento alle attese, potendo però a sua volta rimanere delusa. L’essenza della percezione è di
portare «qualcosa di nuovo», predelineando ciò che può giungere «in conformità con qualcosa di
già noto, di già costituito per me come passato»161. In tale processo, la decisione spetta sempre alla
percezione, dato che l’attesa veicola solo la «necessità di un essere anticipato», che però può
manifestarsi diverso da come avrebbe dovuto essere162. Quando s’incorre in una percezione illusoria
non basta convincersi della sua illusorietà per sopprimere ciò che non possiamo fare a meno di
vedere, e cioè la configurazione fenomenica cui siamo al cospetto, anche perché vi è un «comune
nucleo contenutistico» in virtù del quale due percezioni si compenetrano 163. La soluzione di un
conflitto di percezioni – che riguarda il modo in cui la percezione al suo interno esita a ritrovare
l’assetto consueto – non può essere delegata ai lampi di un’intuizione improvvisa o all’impegno
finalizzato a imparare a guardare meglio, ma richiede di affrontare il lato passivo dei processi di
costituzione percettiva. Il caso non può risolversi pensando all’errore percettivo come se fosse un
problema di rapporto tra l’immagine illusoria e la cosa che ce la restituisce, per cui occorrerebbe
solo ripristinare una corretta forma di adeguazione, immortalando il vero originale – come Scheler
ci suggerisce di fare – a dispetto di un’immagine di cui non riusciamo a sbarazzarci. Tra una ricerca
archeologica sospinta nel profondo e un intuizionismo pseudo-fenomenologico che si libra in
superficie, la chiarificazione intuitiva dell’illusione percettiva chiede d’imboccare la via delle
sintesi associative, disponendosi a riconoscere che «un essere accertabile, in sé vero, si trova alla
base di tutto; ogni errore, ogni illusione ha la sua norma in una verità nascosta da raggiungere»164.
Bibliografia
Altmann, A. (1931), Die Grundlagen der Wertethik: Wesen/Wert/Person. Max Schelers Erkenntnisund Seinslehre in kritischer Analyse, Reuther & Reichard, Berlin.
Amori, M. (2010), Forme dell’esperienza e persona. La filosofia di Max Scheler dai primi scritti al
Formalismus, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ).
161
Husserl (2016), p. 315.
Ivi, p. 316.
163
Ivi, p. 112.
164
Ivi, p. 318.
162
48
�Illusione ed errore. Il dogma dell’intuizione e le avventure fenomenologiche di Max Scheler
Avé-Lallemant, E. (1975), Die phänomenologische Reduktion in der Philosophie Max Schelers, in
P. Good (ed.), Max Scheler im Gegenwartsgeschehen der Philosophie, Francke, Bern, pp. 159178.
Binswanger, L. (1922/1965), Einführung in die Probleme der allgemeinen Psychologie, Springer,
Berlin, Nachdruck Bonset, Amsterdam.
Boyce Gibson, W. R. (1971), “From Husserl to Heidegger. Excerpts from a 1928 Freiburg Diary”,
Journal of the British Society for Phenomenology, vol. 2, 1971, pp. 58-83.
Cairns, D. (1976), Conversations with Husserl and Fink, ed. by the Husserl-Archives in Louvain
with a Foreword by R.M. Zaner, Nijhoff, The Hague.
Dupuy, M. (1959a), La philosophie de Max Scheler. Son évolution et son unité, P.U.F., Paris, 2 voll.
Dupuy, M. (1959b), La philosophie de la religion chez Max Scheler, P.U.F., Paris.
François, A. (2011), “Scheler et la question du monde de la vie: entre pragmatisme et
phénoménologie”, Philosophie, vol. 108, n. 1, pp. 55-65.
Frère, B. (2004), “Phénoménologie et personnalisme”, Archives de Philosophie, vol. 67, n. 3, pp.
445-464.
Frère, B. (2006), “Scheler critique de Husserl. Esquisse d’une perspective non transcendantale au
cœur du projet phénoménologique”, Philosophie, vol. 91, n. 4, pp. 63-88.
Frère, B. (2007), “Max Scheler et la phénoménologie française”, Revue philosophique, vol. 132, n.
2, pp. 177-199.
Gabel, M. (1991), Intentionalität des Geistes. Der phänomenologische Denkansatz bei Max Scheler,
Benno, Leipzig.
Gandillac de, M. (1957), “L’usage schelerien du langage phénoménologique dans le
«Formalisme»”, in Archivio di Filosofia, pp. 217-228.
Good, P. (ed.) (1975), Max Scheler im Gegenwartsgeschehen der Philosophie, Francke, BernMünchen.
Guccinelli R. (2016), Fenomenologia del vivente. Corpi, ambienti, mondi: una prospettiva
scheleriana, Aracne, Roma.
Gurvitch, G. (1930/1949), Les Tendances actuelles de la Philosophie allemande, Vrin, Paris.
Husserl, E. (1968/2005), Ricerche logiche, 2 voll., trad. it. a cura di G. Piana, il Saggiatore, Milano.
Husserl, E. (1994/2005), La filosofia come scienza rigorosa, trad. it. di C. Sinigaglia, Laterza,
Roma-Bari.
Husserl, E. (2002), Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, 2 voll.,
trad. it. a cura di V. Costa, Einaudi, Torino.
Husserl, E. (2007), Esperienza e giudizio, trad. it. a cura di F. Costa e L. Samonà, Bompiani,
Milano.
Husserl, E. (2016), Lezioni sulla sintesi passiva, trad. it. a cura di V. Costa, La Scuola, Brescia.
Jaspers, K. (1963), “Zur Analyse der Trugwahrnehmungen (Leibhaftigkeit und Realitätsurteil)”
(1911), in Id., Gesammelte Schriften zur Psychopathologie, Springer, Berlin, pp. 291-251.
Lenoci, M. (1992), Autocoscienza, valori, storicità. Studi su Meinong, Scheler, Heidegger, Angeli,
Milano.
Hartmann, N. (1928), “Max Scheler †”, Kant-Studien, vol. 33, pp. IX-XVI.
Heinemann, F. (1929), Neue Wege der Philosophie. Eine Einführung in die Philosophie der
Gegenwart, Quelle&Meyer, Leipzig.
Henckmann, W. (1998), Max Scheler, Beck, München.
Janssen, P. (1987), Schelers Wesens- und Wertphänomenologie, in Ströker E.-Janssen P. (hrsg.),
Phänomenologische Philosophie, Alber, Freiburg/Münche, pp. 161-202.
Janssen, P. (1994), “Die Verwandlung der phänomenologischen Reduktion im Werke Max Schelers
und das Realitätsproblem”, Phänomenologische Forschungen, vol. 28/29, pp. 240-270.
Kelly, E. (1997), Structure and Diversity. Studies in the Phenomenological Philosophy of Max
Scheler, Kluwer, Dordrecht.
�Stefano Besoli
Kidd, C. (2015), “The idols of inner-sense”, Philosophical Studies, vol. 172, n. 7, pp. 1759-1782.
Kraenzlin, G. (1934), Max Schelers phänomenologische Systematik, Hirzel, Leipzig.
Leonardy, H. (1991) (éd. par), “Les annotations de Husserl dans le Formalisme de Max Scheler.
Husserls Randbemerkungen zu Schelers Formalismus”, in Ètudes phénoménologiques, vol. 1314, pp. 3-57.
Leyendecker, H. (1913), Zur Phänomenologie der Täuschungen, I. Teil, Niemeyer, Halle a.d.S.
Lorscheid, B. (1957), Max Schelers Phänomenologie des Psychischen, Bouvier, Bonn.
Lützeler, H. (1947), Der Philosoph Max Scheler. Eine Einführung, Bouvier, Bonn.
Metzger, A. (1933), Phänomenologie und Metaphysik. Das Problem des Relativismus und seine
Überwindung, Niemeyer, Halle a. d. Saale.
Melandri, E. (1960), Logica e esperienza in Husserl, il Mulino, Bologna.
Meyer, H. H. (1987), “Max Scheler’s Understanding of the phenomenological Method”,
International Studies in Philosophy, vol. 19, n. 1, pp. 21-31.
Mohr, E. J. (2012), “Phenomenological Intuition and the Problem of the Philosophy as Method and
Science: Scheler and Husserl”, Symposium. Canadian Journal for Continental Philosophy, vol.
16, n. 2, pp. 218-234.
Passweg, S. (1939), Phänomenologie und Ontologie: Husserl, Scheler, Heidegger, Heitz,
Strassburg.
Piana, G. (1979), Elementi di una dottrina dell’esperienza, il Saggiatore, Milano.
Pöll, W. (1936), Wesen und Wesenserkenntnis. Untersuchungen mit besonderer Berücksichtigung
der Phänomenologie Husserls und Schelers, Reinhardt, München.
Rothacker, E. (1949), Schelers Durchbruch in die Wirklichkeit, Bouvier, Bonn.
Sander, Max Scheler zur Einführung, Junius, Hamburg 2001.
Schäfer, M. (1978), Zur Kritik von Schelers Idolenlehre. Ansätze einer Phänomenologie der
Wahrnehmungstäuschungen, Bouvier, Bonn.
Scheler, M. (1955), Vom Umsturz der Werte. Abhandlungen und Aufsätze (1915), hrsg. von Maria
Scheler, Francke, Bern.
Scheler, M. (1957/19863a), “Lehre von den drei Tatsachen“ (1911-1912), ora in Id., Gesammelte
Werke, Bd. X, Schriften aus dem Nachlass, vol. I, Zur Ethik und Erkenntnislehre, hrsg. von
Maria Scheler, Francke, Bern-München, pp. 431-502.
Scheler, M. (1957/19863b), “Phänomenologie und Erkenntnistheorie“ (1913-1914), ora in Id.,
Gesammelte Werke, Bd. X, cit., pp. 377-430.
Scheler, M. (1973), “Die deutsche Philosophie der Gegenwart” (1922), ora in Id., Gesammelte
Werke, Bd. VII, M.S. Frings (hrsg.), Francke, Bern-München.
Scheler, M. (1975), “Philosophische Weltanschauung” (1929), in Id., Gesammelte Werke, Bd. IX,
M. S. Frings (hrsg.). Francke, Bern-München.
Scheler, M. (1999), “Gli idoli della conoscenza di sé”, in Id., Il valore della vita emotiva, trad. it. a
cura di L. Boella, Guerini, Milano, pp. 47-154.
Scheler, M. (2002/20084), La posizione dell’uomo nel cosmo, trad. it. dall’edizione originale del
1928 a cura di G. Cusinato, ed. riveduta e ampliata, Angeli, Milano.
Scheler, M. (2009), Metodo trascendentale e metodo psicologico, trad. a cura di S. Besoli e M.
Manotta, Quodlibet, Macerata.
Scheler, M. (2009), L’eterno nell’uomo, trad. it. di P. Premoli De Marchi, Bompiani, Milano.
Scheler, M. (2010), Essenza e forme della simpatia, trad. it. a cura di L. Boella, Angeli, Milano.
Scheler, M. (2013), Il formalismo nell’etica e l’etica materiale dei valori, trad. it. a cura di R.
Guccinelli, Bompiani, Milano.
Scheler, M. (2018), Idealismo-realismo, trad. it. a cura di G. Mancuso, La Scuola, Brescia.
Schilpp, P.A. (1927), “The doctrine of ‘illusion’ and ‘error’ in Scheler’s phenomenology”, Journal
of Philosophy, vol. 24, pp. 624-633.
50
�Illusione ed errore. Il dogma dell’intuizione e le avventure fenomenologiche di Max Scheler
Spiegelberg, H. (1960/19823), The phenomenological Movement. A Historical Introduction,
Nijhoff, The Hague.
Stegmüller, W. (1989), Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie, Kroner, Stuttgart.
Willer, J. (1981), “Der Bezug auf Husserl im Frühwerk Schelers”, Kant-Studien, vol. 72, n. 2, pp.
175-185.
Abstract
This essay examines some of the main aspects of Max Scheler’s conception of phenomenology,
starting from some of the early writings previous to the Formalismusbuch in which he analyzes the
theme of self-deception and the idols of Self-Knowledge. Scheler, to whom Husserl’s
transcendental phenomenology had no meaning, attacked the self-evidence of inner perception on a
much larger scale. For him, inner perception, or more specifically self-perception, was as
susceptible to illusion as external knowledge; in fact, Scheler thought it to be even more exposed to
such risk. In an attempt to demonstrate this, Scheler went back to Bacon’s general doctrine of the
idols with an investigation of the sources of illusions in the field of self-knowledge. In this essay I
move from an analysis of the peculiar version of Scheler’s phenomenology and of its attitude –
through which we enter into an immediate intuitive relationship with things, so that
phenomenological facts or “whatness” are always fully given and are now beyond the range of all
possible illusions, in order to contrast it with the Husserlian doctrine of perceptual illusion,
developed in the context of the genealogy of logic and with reference to the theme of transcendent
perception and of antepredicative experience.
Keywords: Error, Illusion, Intuition, Phenomenology, Scheler
�DANIELLE COHEN-LEVINAS*
Comme Dieu et comme Rien. Variations sur le nom de khôra
A «L’homme qui marche» d’Alberto Giacometti...
«Plus d’un, je vous demande pardon, il faut toujours être plus
qu’un pour parler, il y faut plusieurs voix…»
(Jacques Derrida, Sauf le nom)
Je serais brève, non pas parce que la question ne mérite pas d’argumentation déployée, mais
parce qu’elle touche à un point névralgique de l’histoire de la philosophie: que faire de Dieu?
En termes phénoménologiques, Dieu n’est pas plus un constitué de notre conscience, qu’un
argument de réfutation. Je commencerai donc par vous vous demander pardon des soulever le
voile d’un irréductible au cœur de tout ce qui aura été déconstruit et disséminé par Derrida
lui-même: cette précaution toute derridienne n’est pas étrangère à ce qu’elle annonce, et ce
qu’elle annonce n’est rien de moins qu’une méditation sur le nom, sauf le nom, à même le
nom. On aimerait en savoir davantage. Pourquoi Jacques Derrida se sera-t-il aventuré dans
l’apophase d’un discours dont la pointe ultime se nomme Dieu? Question improbable, si
lointaine que Derrida lui-même consent à y séjourner, le temps d’un livre, Sauf le nom; plus
encore que le temps d’un livre, le temps d’une trilogie: Passions, Sauf le nom, Khôra1. Trois
chapitres, trois temps, trois fictions que Derrida aura voulu d’un seul tenant, comme si le
nom, l’indéconstructible, avait besoin de se frayer un passage crypté à l’intérieur de ces trois
espaces distincts. Dans un Prière d’insérer que Derrida a pris soin de glisser à l’intérieur de
chacun de ces trois essais, on peut lire:
À suivre les signes qu’en silence les personnages de telles fictions s’adressent l’un à l’autre, on peut
entendre résonner la question du nom, là où elle hésite au bord de l’appel, de la demande ou de la
promesse, avant ou après la réponse2.
La question qui est au centre de ces trois espaces d’écriture est donc celle du nom. On peut
éprouver un certain vertige quant à la possibilité même de déployer une pensée philosophique
sur ce face à face incommensurable entre l’appel et la réponse, là où vient précisément se
glisser un nom qui «dit aussitôt plus que le nom, l’autre du nom et l’autre tout court, dont il
annonce justement l’irruption»3. L’altérité qui habite l’expérience du nom, l’habite en tant
qu’elle désigne déjà, non plus le nom lui-même, mais l’autre – ce que dans une autre langue,
que Derrida investit pleinement, Levinas appelle le tiers. Il y aurait toujours l’autre du nom
dans le nom qui parle et qui se tient dans la loi éthique de l’altérité, celle que Levinas
*
Archives Husserl-Paris/ENS-CNRS
1
Derrida (1993abc).
Ivi, p. 1.
3
Derrida (1993b), p. 15.
2
Bollettino Filosofico 33 (2018): 52-55
ISSN 1593 -7178 - 00030
E-ISSN 2035 -2670
DOI 10.6093/1593-7178/5941
�Comme Dieu et comme Rien. Variations sur le nom de khôra
commentait dans Totalité et infini (1961), en citant l’epekeina tês ousias (le bien est au-delà
de l’être) de Platon. Nous y voici. Derrida reprend le motif platonicien magistralement
interprété par Levinas et le conduit jusqu’au bord de l’appel, là où la multiplicité des voix se
transforme, en guise de réponse, en une immense polyphonie interrogative. Une voix peutêtre, un peu plus puissante que les autres, clame dans ce désert de noms? Ce n’est pas
exactement de clameur qu’il s’agit, mais d’un déploiement non dialectique, non
métaphysique, non théologique, non ontologique, qu’aucune relève ne peut sauver. Derrida
précise:
Cette voix se démultiplie en elle-même : elle dit une chose et son contraire, Dieu qui est sans être ou
Dieu qui (est) au-delà de l’être4.
On reconnaît ici l’attachement, non seulement à Levinas, mais à la tradition platonicienne, à
cette figure solaire de khôra dont on peut se demander si elle n’est pas entendue par Derrida
comme métaphore du Bien au-delà de l’être. «Il y a khôra mais la khôra n’existe pas»5. Ce à
quoi nous pourrions rétorquer: il y a Dieu mais Dieu n’existe pas. Pourtant, et le mot khôra et
le mot Dieu présentent les caractéristiques du nom propre – khôra en tant que khôra et Dieu
en tant que Dieu. Autrement dit, deux figures eschatologiques qui se jouent dans l’affection
d’un nom par un autre nom. Il y a khôra pourrait signifier l’impensable d’epekein tês ousias.
khôra n’existe pas, pourrait renvoyer à une donation dans le retrait qui ne peut se dire que
dans la langue du nom, mais ce nom
n’est pas un mot juste. Il est promis à l’ineffaçable même si ce qu’il nomme khôra ne se réduit pas,
surtout pas, à son nom6.
De quelle donation s’agit-il, de quel retrait? Dans le monde platonicien, l’idée de retrait
désigne une forme d’espacement des logoi commençant là où le retrait s’annonce. Aucun
homme ne peut soutenir l’éclat de la vision du soleil sans courir le risque d’être frappé de
cécité. Socrate lui-même fait le récit dans la République du prisonnier philosophe contraint de
faire face au soleil dans sa khôra, comme si la posture du philosophe était celle qui pouvait se
tenir devant le Bien. Ce n’est donc pas la khôra en tant que telle que peut soutenir le regard du
philosophe, mais la khôra en tant que ce qui se retire, à savoir l’image d’or de la khôra ellemême, la brillance de l’être qui ne peut se dire que dans la langue des logoi. Il y va de la
signification même du don dans le retrait comme condition de la donation. Lors d’une
discussion avec Jean-Luc Marion7, Jacques Derrida revenait sur cette question si complexe,
précisant néanmoins qu’il se disait prêt à abandonner le mot «Don»:
Je voudrais simplement comprendre ce qu’est l’événement de don et l’événement en général.
J’essaie dans Donner le temps et dans d’autres textes de rendre compte, d’interpréter la
réappropriation anthropo-théologique de la signification du don comme la signification de
l’événement sur le fond sans fond de ce que j’appelle khôra, le fond sans fond d’un ‘il y a’, d’un ‘ça
a lieu’, du lieu de cet ‘avoir lieu’ qui précède et se trouve totalement indifférent à cette anthropothéologisation, à cette histoire des religions et des révélations.8
Ce retour à la question du don n’est pas fortuit. Il permit à Derrida de préciser la place
névralgique qu’occupe la khôra, à la fois structure non donatrice, lieu, désir et peut-être même
Derrida (1993a), p. 15.
Derrida (1993b), p. 32.
6
Ivi, p. 25.
7
Cette discussion eut lieu à la Villanova University, le 27 septembre 1997. Le modérateur était Richard
Kearnay. Elle a été publiée une première fois en américain in J. D. Caputo, M. J. Scanlon (1999). Elle a été
reprise en annexe dans un ouvrage de J.-L. Marion (2012).
8
Derrida (2012), p. 203.
4
5
53
�Danielle Cohen-Levinas
événement: «l’Ereignis comme événement et appropriation» 9 . Comme si l’ouverture
originelle du sens de khôra n’était pas mondain, mais l’avoir lieu d’un non-lieu. Cela conduit
à maintenir un espacement irréductible, un écart qui semble expulser le lieu de lui-même.
Reste la parole qui dit cet événement, «dans et sur le langage»10. On peut se demander si
Derrida ne cherche pas ici une pensée de la révélation qui excède toute phénoménalité et toute
référence religieuse, car comment interpréter un lieu «où l’événement comme processus de
réappropriation d’un impossible don devient possible»11 sans solliciter la question du nom:
Dieu? Nous sommes en pleine équivoque. Derrida l’admet. Khôra ne désigne ni ceci ni cela,
c’est pourquoi elle peut donner lieu à un nom propre, parce que précisément elle ne possède
rien en propre, pas même ce que Socrate désigne lorsqu’il parle du «soleil lui-même en luimême dans sa khôra »12. Ni eidos ni image, khôra n’est pas, ou alors elle est cette apostrophe
dont parle Derrida, ce nom qui ne nomme rien, juste l’événement qui reste, «qui en appelle à
Dieu»13 et, le faisant, qui parle, qui s’achemine vers une autre apostrophe, en direction d’un
autre nom. Là serait la passion du nom, ou son secret, ou l’avoir lieu du non-lieu du secret. Ce
qui reste n’est même pas Dieu, pas même khôra. Disons le autrement: khôra donne son nom
mais ne se donne pas elle-même. Faisant référence à une chose qui n’en est pas une, Derrida
précise que dans le Timée de Platon khôra
[…] ne doit pas recevoir pour elle , elle ne doit donc pas recevoir, seulement se laisser prêter les
propriétés (de ce) qu’elle reçoit14.
Remettons à nouveau le mot Dieu sur le métier, en reprenant encore une fois l’argument de
Jacques Derrida sur la possibilité de penser ce nom dans la trace d’un effondrement sans fond
de ce qui donne. Il faut à ce Dieu, sauf son nom, cet effondrement, pour que s’annonce le
désir de Dieu ou le désir de donner, et que par conséquent le nom, «promis à l’ineffaçable»15
s’ouvre à ce que Derrida nomme l’anachronie de l’être.
Bibliographie
Caputo, J.D.-Scanlon M.J. (eds.) (1999), God the Gift, and Post modernism, Indiana
University Press, Bloomington.
Derrida, J. (1993a), Sauf le nom, Galilée, Paris.
Derrida, J. (1993b), Khôra, Galilée, Paris.
Derrida, J. (1993c), Passions, Galilèe, Paris.
Marion, J.-L. (2012), Sur le Don: une discussion entre Jacques Derrida et Jean-Luc Marion,
in Id., Figures de phénoménologie: Husserl, Heidegger, Levinas, Henry, Derrida, trad. fr.
par S.-J. Arrien, Vrin, Paris, pp. 189-214.
Platon, La République.
Abstract
Why Jacques Derrida measures himself against the apophasis of a discourse whose last arrival
point is called God? Deconstruction of the undeconstructible name, Derrida devotes
9
Ibidem.
Derrida (1993a), p. 60.
11
Derrida (2012), p. 203.
12
Platon, 516b (ma propre traduction).
13
Derrida (1993a), p. 21.
14
Derrrida (1993b), p. 34.
15
Ivi, p. 25.
10
54
�Comme Dieu et comme Rien. Variations sur le nom de khôra
to khôra several reflections, and in particular he devotes to the theme a book. The alterity that
inhabits the experience of the name, does it because it designates not the name itself but the
other, that Lévinas calls the “third”. Derrida examines the tropic and the anachronism of the
name khôra and he puts it “beyond its name” as anachrony of being, because it precedes the
actuality itself of being by going beyond the distinction between intelligible and sensible.
Keywords: Alterity, Derrida, God, Khôra, Name, Third
55
�VINCENZO COSTA*
Percepire e comprendere
1. Un’ambiguità: lo statuto dell’atteggiamento naturale tra datità originaria e teoria divenuta
seconda natura
L’accesso alla fenomenologia è stato da sempre pensato da Husserl come una trasformazione del
nostro atteggiamento. Si tratta di passare, infatti, da un atteggiamento naturale, diretto sul mondo e
che ha gli oggetti del mondo come tema, alla soggettività nella quale questi si costituiscono. Quindi,
si tratta di passare dalla percezione esterna, che ha come tema oggetti esterni, alla percezione
interna, che ovviamente non ha come tema oggetti interni, ma la correlazione tra soggettività e
mondo. E tuttavia, questo modello si lascia guidare dall’idea di primato della percezione, intesa
come accesso originario alle cose stesse, siano esse le cose esterne o la vita soggettiva stessa. Si
comprende allora in fretta come proprio su questo punto si possa assumere una prospettiva diversa,
che fa leva sul primato della comprensione piuttosto che della percezione. Così, Heidegger ha
insistito sul fatto che le cose ci sono originariamente date nella comprensione, poiché non
percepiamo mere cose che poi rivestiamo di un significato, ma ci rapportiamo direttamente a
qualcosa di cui sappiamo che cosa serve a fare, qual è il suo senso, la sua direzione all’interno di un
sistema di rimandi. Di conseguenza, se prendiamo le mosse da questa prospettiva, l’atteggiamento
fenomenologico non sarà inteso come passaggio dalla percezione esterna a quella interna, ma come
un lasciar apparire l’essere dell’ente, poiché nella vita quotidiana siamo così presso gli enti da non
scorgere ciò che li rende tali, cioè che li rende comprensibili nel loro essere. In termini più semplici,
afferriamo il senso di un ente (di una bottiglia, di una matita, di una chiesa, dell’amore, della
preghiera o della sessualità) come se fosse ovvio e naturale, e dimentichiamo che quel senso
d’essere si radica in un orizzonte di rimandi di senso, cioè in un’apertura del senso dell’essere e
nella storia dell’essere, che è dunque il vero trascendentale, cioè la vera condizione di possibilità
dell’apparire dell’essere dell’ente. Si capisce dunque la posta in gioco nella questione circa il
primato della percezione o della comprensione.
Prima di affrontare queste questioni conviene tuttavia precisare un poco meglio natura e portata
(estensione) del campo dell’esperienza, e quindi definire una questione importante circa lo statuto
dell’atteggiamento naturale. Infatti, rispetto al senso di questa problematica vi è una relativa
ambiguità, ed essa può disturbarci parecchio e metterci su una cattiva strada proprio nella
determinazione del concetto di esperienza. La questione è: l’atteggiamento naturale caratterizza
ogni umanità possibile? Indica un modo originario e astorico di essere al mondo o è, invece, il
risultato e il contraccolpo dell’epoca della scienza? In termini più vicini a noi: l’atteggiamento
naturale è un atteggiamento originario, che precede gli schemi concettuali, o è una teoria diventata
seconda natura? Cioè una spontaneità concettuale che si è compenetrata con la ricettività e che ora
siamo portati a considerare esperienza, mentre è solo la sedimentazione sull’esperienza di un dato
ordine concettuale?
Su questo punto credo che Husserl sia molto ambiguo, e spesso usa come sinonimi “concetto
naturale di mondo” e “atteggiamento naturale”. Proporrò, andando un poco contro Husserl ma non
senza Husserl, di differenziare questi due concetti: mentre il concetto naturale di mondo è uno stile
invariabile del mondo, l’atteggiamento naturale, con le caratteristiche che ho prima indicato, è un
misto di datità di esperienza e di retroazione dell’epoca della scienza. Questo ci indicherà la
________________________
*
Università del Molise
Bollettino Filosofico 33 (2018): 56-70
ISSN 1593 -7178 - 00030
E-ISSN 2035 -2670
DOI 10.6093/1593-7178/5905
�Percepire e comprendere
necessità di sviluppare, nello stesso movimento, una fenomenologia trascendentale ed
un’ermeneutica fenomenologica. Cerchiamo di chiarire meglio che cosa possiamo intendere con
ciò.
In primo luogo, Husserl dice che il mondo dell’atteggiamento naturale è un mondo di pura
esperienza, poiché qui l’esperienza non viene oltrepassata con l’uso di concetti:
L’atteggiamento naturale è l’atteggiamento dell’esperienza. L’io esperisce se stesso e fa esperienza delle
cose, dei corpi e degli ego estranei. Questo atteggiamento dell’esperienza è quello naturale, nella misura in
cui esso è, esclusivamente, quello degli animali e dell’uomo prescientifico.1
E tuttavia, siamo sicuri di potere attribuire tutte le caratteristiche ascritte all’atteggiamento naturale
agli animali e all’umanità prescientifica? Per esempio, un animale si avverte come inserito in un
sistema di vincoli causali? Un uomo appartenente ad una civiltà che precede l’apparire della
scrittura esperisce il mondo come un sistema causale dotato di una chiusura causale? Un animale
avverte forse che qualcosa, colpendolo, gli farà male, una mentalità pre-logica esperisce che una
pietra cadendo lo schiaccerà, dunque esperisce un rapporto causale. Ma di qui non possiamo
giungere a dire che abbia l’idea o l’esperienza di un sistema di causazione universale. Tuttavia, ha
un’esperienza di un sistema di dipendenze funzionali di tipo causale: una scimmia, per raggiungere
delle banane, mette insieme dei bastoni e poi colpisce le banane in modo che queste cadano, e un
uomo primitivo evita un luogo dove rotolano i sassi, anche se spiega tutto ciò come frutto della
presenza degli dei.
Emerge così che l’esperienza non è un insieme di stimoli isolati e disorganizzati che possono
essere collegati solo da ragioni, dunque in virtù del linguaggio o da uno schema concettuale
incorporato nel linguaggio. L’esperienza è una struttura sintetica, associativa, in cui si
costituiscono corpi (si produce una forma di entificazione che precede il linguaggio), si costituisce
la causalità esperita, l’induzione esperita, cioè una serie di attese che non sono riconducili, neanche
negli animali, a un condizionamento pavloviano, ma derivano da una regolarità dell’apparire. In
questo senso, vi è un concetto naturale di mondo, ed in questo senso l’atteggiamento naturale
precede la scienza e non è una retroazione delle concezioni scientifiche.
E tuttavia, questo non può significare che le idee di tempo obiettivo, di chiusura causale, di
universo governato da leggi e della psiche come interno in cui si riflette un esterno appartengano al
concetto naturale di mondo, al mondo che precede la teoria. Una cosa è parlare di causalità
percepita, un’altra di chiusura causale. La prima appartiene all’esperienza, la seconda alla teoria, la
quale agisce retroattivamente sull’esperienza, divenendo seconda natura, abitudine appercettiva.
Del resto, lo stesso Husserl lo nota quando cerca di spiegare l’origine della psicologia moderna.
L’idea di psiche, come interno e come parte dell’universo causale, non si fonda su motivazioni
derivanti dall’esperienza prescientifica del mondo ma, al contrario, su una loro rimozione, derivante
dall’influsso sulla nostra esperienza degli schemi concettuali derivanti dalla rivoluzione scientifica.
L’origine di questa metafisica e di questa decisione fondamentale, che pensa la soggettività come
un oggetto tra gli altri all’interno di un sistema causale, è infatti una ricaduta del procedimento
astrattivo delle scienze della natura. Queste, per ottenere il puro elemento fisico, fecero inizialmente
astrazione di ogni elemento soggettivo, separando qualità primarie quali la spazialità (appartenenti
ai corpi) dalle qualità secondarie (che sarebbero, invece, soggettive), e dimenticarono che quanto da
esse definito “realtà oggettiva” e qualità primarie è pur sempre qualcosa che si costituisce in una
esperienza, e dunque in relazione al soggetto. Obliarono che le determinazioni oggettive delle cose
sono il risultato di operazioni soggettive (dato che gli enunciati e i concetti scientifici sono
formulati da soggetti psichici).
Dimenticando che ogni oggetto è un oggetto per un soggetto si costruì un mondo di pure cose
(senza soggetti) e si operò un’introiezione delle sensazioni2 che, da manifestazioni di cose,
1
2
Husserl (2008), p. 13.
Cfr. Avenarius (19273), pp. 77 e ss.
57
�Vincenzo Costa
iniziarono ad essere intese come dati di sensazioni, cioè immagini interne di cose esterne. Infatti,
una cosa è dire ho un dato di sensazione rosso, un’altra è dire “quella cosa mi sembra rossa” 3. Solo
nel primo caso emerge l’idea di soggettività come scatola in cui sono contenute immagini di cose
esterne, e dunque sorgono quei problemi caratteristici della filosofia moderna, che affronta il
problema della giustificazione come ricerca di una adeguazione tra immagini interne e cose esterne.
Da un punto di vista fenomenologico, nel darsi concreto e originario dell’esperienza preteoretica,
l’apparire non è un dato di sensazione, né un’immagine o copia di un originale, ma la cosa vista in
uno dei suoi modi di datità. Quando in seguito, a partire da questo orizzonte di senso, nel frattempo
diventato “ovvietà”, cioè seconda natura, si volle por mano ad una scienza delle menti, si adoperò
un concetto di natura sorto attraverso un’astrazione, quindi uno schema concettuale, una teoria
come sistema di interanimazione di enunciati4, e si giunse a pensare, come se fosse ovvio, che
questa natura “esterna” è ovvia ed è data in un’intuizione concreta. Si dimenticò che ciò che si
chiama “natura” è un costrutto teorico sorto attraverso un’astrazione, attraverso una
matematizzazione dei plena, e dunque un’idealizzazione della nostra esperienza della natura.
È all’interno di questa generale apertura di senso che diventano comprensibili gli errori della
psicologia e l’interpretazione dualistica, cioè l’interpretazione dello «spirito come mera appendice
[Annex] del corpo vivo materiale o come una serie causale parallela a quella della materialità
fisica»5. La psiche venne a essere determinata a partire dagli oggetti, come un oggetto di natura
particolare. Poi, lentamente, come notava giustamente James, questo oggetto divenne sempre più
evanescente, sinché non si seppe più dove collocarlo, e coloro che ancora si richiamano alla nozione
di psiche si attaccano «al tenue mormorio che l’anima nel suo scomparire lascia nell’aria della
filosofia»6.
Abbiamo voluto indugiare su questo punto perché da queste considerazioni credo emerga un
punto: che alcune strutture dell’atteggiamento naturale non appartengono al concetto naturale di
mondo, cioè al mondo dato prima di ogni pensiero scientifico e al modo di darsi delle sintesi di
esperienza prima delle sintesi intellettuali. Pertanto, prima di ogni altro passo bisogna sapere
distinguere ciò che appartiene all’esperienza da ciò che viene aggiunto dagli schemi concettuali, e
quindi, come vedremo tra poco, tra una fenomenologia dell’esperienza e un’ermeneutica
fenomenologica. Vorremmo dire: una fenomenologia dell’esperienza non può ridursi ad una
fenomenologia della percezione.
2. Lo spazio: intuizione, schema concettuale e interpretazione
Per chiarire meglio che cosa intendiamo prendiamo rapidamente in esame la questione dello spazio.
Thomas Kuhn ha notato che «tra le poche cose che conosciamo con certezza [...] vi sono queste:
che stimoli molto differenti possono produrre le stesse sensazioni; che lo stesso stimolo può
produrre sensazioni molto differenti; e, infine, che il percorso dallo stimolo alla sensazione è in gran
parte condizionato dall’educazione», per cui – può concludere Kuhn – «due gruppi, i cui membri
hanno sistematicamente sensazioni differenti quando ricevono gli stessi stimoli, di fatto in un certo
senso vivono in mondi differenti»7.
In questa prospettiva, il mutamento di una teoria scientifica sembra addirittura implicare un
mutamento dello stesso nostro mondo percettivo. Civiltà diverse vivranno allora in «mondi
diversi», i loro paradigmi saranno incommensurabili con i nostri, come incommensurabili sono
teorie tra loro diverse, perché non vi è un mondo comune, quello che appunto Husserl chiama
concetto naturale di mondo. Di conseguenza, in mancanza di vincoli esterni, «qualsiasi cosa può
andar bene», cioè bisogna abbandonare l’idea stessa di giustificazione.
3
Sellars (2004), pp. 13 e ss.
Quine (1996), p. 3.
5
Husserl (1962), pp. 55-56.
6
James (2009), p. 4.
7
Kuhn (1978), p. 232.
4
58
�Percepire e comprendere
Al contrario, Husserl insiste sul fatto che la scienza cambia il modo in cui pensiamo il mondo,
ma non il modo in cui lo esperiamo. Per esempio, la rivoluzione copernicana fa sì che noi non
pensiamo più che il Sole giri attorno alla terra ma che sia la Terra a ruotare attorno al Sole. E
tuttavia, per la nostra esperienza la terra non si muove8, sicché vi è uno strato dell’esperienza che
non viene modificato dal cambiamento dei nostri schemi concettuali. Secondo Husserl, «è
necessario osservare che il concetto naturale di mondo non è quello che gli uomini si sono formati
prima della scienza, bensì il concetto di mondo che costituisce il senso dell’atteggiamento naturale
prima e dopo la scienza»9.
Potremmo riprendere questa idea appunto nel senso che all’interno dell’atteggiamento naturale
vi è uno strato che non si modifica con il modificarsi delle nostre interpretazioni, e prendere anche
le distanze dall’idea, presente in Patocka, secondo cui il mondo naturale è il mondo preistorico. E
questo significa: l’esperienza deve avere proprie regole di autoorganizzazione che precedono e
fondano gli stessi schemi concettuali, per cui il pensiero va ricondotto all’esperienza sensibile che,
dunque, non sarà l’esperienza soggettiva, interna, ma il manifestarsi dell’essere stesso.
E tuttavia, se contro Kuhn ribadiamo che vi è una esperienza dello spazio che non dipende dagli
schemi concettuali, dobbiamo essere cauti nel dire che lo spazio omogeneo e isotropo è già presente
nell’atteggiamento prescientifico, per esempio nel mondo mitico. Di fatto, Husserl sembra offrirci
questa indicazione quando scrive che, parlando di ritorno al mondo della vita, non bisogna
sottovalutare il fatto che
il modo in cui noi moderni usiamo (senza farle scivolare sotto una costruzione scientifica) la parola
“mondo”, è già un’idealizzazione di primo grado, derivante dalla tradizione storica con una forma di senso
[Sinnesform] che oltrepassa [überspringt] la struttura del mondo degli originari modi di datità, poiché
mediante essa è sorto un nuovo senso di mondo intuitivo, che per noi poi vale senz’altro come il mondo che
si trova prima delle nostre scienze.10
Bisogna dunque stare molto attenti quando si parla di spazio intuitivo, perché questo può alludere a
due gradi molto diversi dell’esperienza dello spazio, e se non sorvegliamo questa duplicità
possiamo determinare in maniera erronea l’esperienza dello spazio e considerare originaria quella
che è una retroazione di schemi concettuali successivi. Bisogna dunque stare attenti a come si
intreccino strutture invariabili dell’esperienza e aperture di mondo, cioè come si intrecciano
percezione e comprensione.
Riguardo allo spazio, nota Husserl – ma qui il tema ci interessa solo per fare emergere un
problema generale – originariamente la nozione di péras allude a ciò che ha una forma conclusa e
delimitata, alle «cose in senso consueto», a tutto ciò che può essere visto da tutti lati, che ha una
«forma conclusa [geschlossenen Gestalt]»11. Qui le strutture percettive sono invariabili. In
contrapposizione a queste cose dotate di limiti sta tuttavia «il senza forma [das Gestaltlose]: la terra
come suolo terrestre che, per principio, non può essere esperito come una “cosa” (Gaia), il cielo, il
mare infinito, l’aria, la notte, lo spazio (concretamente riempito) che abbraccia ogni cosa» 12. Qui
non si tratta di percezione, bensì di comprensione di un intero universo di senso. In questa prima
considerazione della natura, che si mantiene all’interno di una determinazione “mitica”, lo spazio
viene determinato come ciò «da cui le cose hanno la loro “origine”» 13. Teatro eterno dell’apparire,
lo spazio viene esperito come ciò da cui tutto sgorga e in cui tutto ritorna.
8
Husserl (1991).
Husserl (2008), p. 28.
10
Husserl (1993), pp. 140-141.
11
Ivi, p. 141.
12
Ibidem.
13
Ibidem.
9
59
�Vincenzo Costa
3. Fenomenologia dell’esperienza ed ermeneutica fenomenologica
Emerge così la necessità di un’ermeneutica fenomenologica che affianchi una ricerca
fenomenologico-trascendentale delle strutture dell’esperienza. Questo deriva dalla struttura della
vita trascendentale, poiché
ogni presente vivente di vita racchiude “in sé”, nella sua intenzionalità concreta, la vita intera e,
unitariamente all’oggettualità percettivamente cosciente in questo presente, porta in sé, come orizzonte,
l’universo di tutte le oggettualità che abbiano mai avuto validità per me e, in un certo modo, addirittura
quelle che varranno per me in futuro.14
Qui emerge un concetto fondamentale della fenomenologia: quello di orizzonte: tutto ciò che viene
esperito si inserire ed emerge da un orizzonte. La vita trascendentale, quella vita nella quale le cose
vengono esperite nel loro senso, infatti, è «già una continuazione della vita [Fortleben] che ha
dietro altra vita, ma non nel modo di una esteriorità puramente naturale, bensì in quello
dell’interiorità di una tradizione intenzionale»15. Per questo, comprendere chi siamo, comprendere
noi stessi, i nostri pensieri, il modo in cui guardiamo il mondo, gli altri e il futuro, significa
comprendere una tradizione che giunge sino a noi e che ci ha plasmato prima che noi potessimo
dire qualcosa, poiché è solo a partire da questo essere plasmati dalla tradizione che noi possiamo
parlare e pensare. Comprendere noi stessi significa dunque prendere coscienza della nostra
intrinseca storicità, e questo significa, in termini fenomenologici, che
il presente effettivo [reelle] deve essere esplicitato [ausgelegt], deve essere interpretato [interpretiert], in un
senso amplissimo, “storicamente”, cioè, ciò che si trova intenzionalmente in esso, ma non come dato
effettivamente analitico, deve essere disvelato, indicato [induziert], dischiuso intenzionalmente16.
Per questo Husserl parla di una «ermeneutica della vita di coscienza»17. Il suo sviluppo ci deve
impedire di assumere come originario (dunque come fonte di giustificazione) ciò che è già il
risultato di schemi concettuali e interpretazioni divenute seconda natura. Essa dovrebbe indagare
come intuizione e interpretazione (o comprensione) si intreccino, come dunque entrino in contatto il
concetto naturale di mondo come struttura percettiva e il concetto naturale di mondo come
orizzonte di significati.
Vorrei dire, accennando un punto che va oltre gli scopi che ci siamo prefissi in queste pagine: vi
è una costituzione percettiva, ma nel passaggio allo schema concettuale e alla scienza (e al
linguaggio) vi è uno strato intermedio, quello dei significati come possibilità d’azione, e solo dove
si apre un mondo di questo tipo può esservi linguaggio e schema concettuale. Quello che qui ci
interessa è che emerge già, attraverso la tematica degli orizzonti, che una fenomenologia in senso
pieno dovrà esplicitare come questi livelli si intreccino nella nostra esperienza concreta.
Il rapporto tra ermeneutica fenomenologica e fenomenologia dell’esperienza è un tema ancora
interamente da sviluppare, dato che sinora la questione si è giocata come contrapposizione tra
ermeneutica e fenomenologia. In queste pagine ci limitiamo a indicare i problemi, dato che il nostro
scopo è qui muoversi all’interno dei testi husserliani, presentare la filosofia fenomenologica,
facendo emergere le possibili vie di sviluppo ma anche i rischi che forse è necessario evitare.
4. Schema concettuale e concetto naturale di mondo: un breve confronto con la tradizione analitica
La necessità di distinguere all’interno dell’atteggiamento naturale tra ciò che è seconda natura e ciò
che è invece esperienza invariabile e dunque mondo naturale può divenire più chiara se avviamo un
rapido confronto con alcune posizioni della tradizione analitica.
14
Husserl (2007), p. 208.
Husserl (2001), p. 147.
16
Ivi, p. 148.
17
Husserl (1987), p. 177.
15
60
�Percepire e comprendere
Come abbiamo visto, a proposito dell’animale non diremmo che vi è pensiero causale, e tuttavia
vi è esperienza causale. Cioè, l’animale non ha semplicemente un insieme di impressioni organiche:
ha una esperienza fenomenica al cui interno vi sono nessi e sintesi sensibili. E questo testimonia
una prima cosa: che vi sono sintesi sensibili che precedono quelle intellettuali e sono indipendenti
da esse. Questo indica che vi è un concetto naturale di mondo e che l’organizzazione della vita
trascendentale non emerge soltanto con lo spazio logico delle ragioni, con gli schemi concettuali, e
che la ricettività non necessariamente è compenetrata di attività, cioè che non sempre la spontaneità
dei concetti è all’opera nella ricettività, come pensa McDowell quando scrive che possiamo asserire
che abbiamo «ciò che hanno i semplici animali, una sensibilità percettiva a certe caratteristiche del
nostro ambiente, ma di averlo in una forma particolare. La nostra sensibilità percettiva all’ambiente
è assorbita nell’ambito della facoltà della spontaneità, e questo è ciò che ci distingue da loro»18.
Naturalmente, nell’uomo emerge la spontaneità, ma questa non consiste nello strutturare la
recettività, ma nella capacità di esplicitare e idealizzare i nessi passivamente presenti
nell’esperienza, sia essa quella percettiva sia essa quella dell’ordine dei significati entro cui
l’esistenza è gettata.
Nel caso del comportamento della scimmia, è difficile spiegare quanto avviene dicendo che qui è
all’opera una teoria, cioè «un tessuto di enunciati variamente associati l’uno all’altro e a stimoli
non-verbali dal meccanismo della risposta condizionata»19. Infatti, nel caso dell’animale non vi è
linguaggio e non vi teoria in quanto tessuti di enunciati. Non so se vi sia o meno pensiero, ma
certamente non vi è teoria come interanimazione di enunciati. L’animale non applica, attraverso uno
schematismo trascendentale, il concetto di causa. Vi è, invece, una mera passività dell’esperienza,
che possiamo caratterizzare così: l’esperienza mostra proprie articolazioni, indicazioni, produce
attese, che sono interne ai decorsi delle manifestazioni. L’essere ha la capacità di mostrarsi da se
stesso.
Nel caso dell’animale vi è esperienza, ma è difficile parlare di una kantiana messa in forma o di
un modellamento da parte del linguaggio e del pensiero linguistico. Gli animali, anche se non
sappiamo se hanno un pensiero prelinguistico, è certo che non hanno un linguaggio inteso come
sistema teorico che incorpora una teoria sul mondo. E tuttavia, pur non avendo appreso alcuna
lingua, pur non vivendo in alcun gioco linguistico, colgono strutture dell’esperienza, cioè
articolazioni d’essere.
A differenza di quanto pone alla base del suo intero programma Quine, qui non abbiamo
linguaggio, ma non per questo abbiamo un caos di stimoli disorganizzati. Potremmo allora indicare
il senso della differenza tra concetto naturale di mondo e atteggiamento naturale proprio ragionando
su un’affermazione di Quine, quando questi scrive che «sottraendo i suoi indizi dalla sua visione del
mondo, otteniamo, come differenza, il contributo netto dell’uomo» 20. Cioè, poiché l’esperienza è
costituita da stimoli disorganizzati, se togliamo questi, vediamo che le forme di collegamento in
virtù di cui si manifesta un mondo dotato di una coerenza, ordinato e sensato derivano
dall’interanimazione tra gli enunciati. Dunque, l’atteggiamento naturale sarebbe in realtà una teoria
divenuta seconda natura, poiché a collegare gli stimoli sarebbe una teoria, e cioè la nostra teoria,
quella della nostra epoca della scienza. In questo senso, non vi è concetto naturale di mondo.
E tuttavia, proprio l’esempio dell’animale mostra che le cose non stanno così, che il concetto
naturale di mondo non è una teoria divenuta seconda natura. E inizia a emergere una nozione di
esperienza completamente diversa. Infatti, se rovesciando l’argomento di Quine ci chiediamo che
cosa resti una volta sottratto quanto il linguaggio aggiunge alla nostra esperienza del mondo, come
risultato non troviamo dati sensoriali, stimoli privi di forma e di struttura: ma un universo articolato
in maniera antepredicativa, pre-categoriale, uno stile invariabile del mondo, un suo modo di
apparire: suo perché le sintesi non vengono prodotte da ciò che l’intelletto proietta sulla sensibilità,
18
McDowell (1999), p. 11.
Quine (1996), p. 20.
20
Ivi, p. 13.
19
61
�Vincenzo Costa
ma dalla maniera in cui le manifestazione si collegano tra loro nella sensibilità attraverso sintesi
contenutistiche.
Parlare di esperienza non significa dunque parlare di stimolazioni che ci fanno passare
dall’ambito delle giustificazioni a quello delle cause e alla ricerca psicologica o fisiologica, perché
nell’esperienza si dispiegano motivazioni, la vita in essa prende forma, prima (sempre prima,
sempre più avanti) che il concetto espliciti queste forme categorialmente.
È questo aspetto ad essere interamente rimosso da Quine, il quale assume che la nostra intera
esperienza sia costituita da solo due componenti: stimoli e linguaggio. Se con Quine potremmo
essere vagamente d’accordo sul fatto che «la concettualizzazione su qualunque scala considerevole
è inseparabile dal linguaggio»21, questo non significa che l’intera tematica della giustificazione
debba essere spostata all’interno del linguaggio e delle sue forme di organizzazione, dunque che
l’intera problematica filosofica si debba spostare sul versante dell’analisi del linguaggio e
dell’analisi logica. E questo proprio perché le giustificazioni avvengono sul terreno dell’esperienza.
Abbiamo così indicato un orizzonte di problemi e le caratteristiche della percezione, conviene
riassumere prima di procedere verso un nuovo ordine di problemi interni al rapporto tra percezione
e comprensione:
1) All’interno dell’atteggiamento naturale abbiamo distinto tra concetto naturale di mondo e
teoria divenuta seconda natura. Dunque, abbiamo caratterizzato l’atteggiamento naturale come un
misto di esperienza effettiva (di concetto naturale di mondo) e di interpretazione, poiché la vita
concreta del soggetto si svolge tra questi due momenti, che dunque vengono a sostituire la vecchia
distinzione tra sensibilità e intelletto intesa come rapporto tra forme concettuali e dati sensoriali.
2) Pertanto, prima di giungere alla soggettività trascendentale è necessario mettere in luce la
struttura dei livelli di giustificazione, e questo implica come primo passo la riduzione del mondo
della teoria e della stessa logica al mondo dell’esperienza (concetto naturale di mondo o mondo
della vita), per vedere che cosa è mera teoria divenuta seconda natura (e dunque storicamente
determinato) e che cosa è invece autentica datità, e quindi in che cosa consiste l’intrascendibilità
dell’esperienza.
3) Già ora nessuno di noi intenderà il termine datità come un ricorso al mito del dato, dato che
qui non si danno dati sensoriali, ma strutture sintetiche della passività.
4) Solo dopo questa riconduzione del mondo del concetto (degli schemi concettuali) al mondo
dell’esperienza potremo interrogarci, nella nostra decostruzione, intorno alla legittimità dello stesso
mondo dell’esperienza, riconducendo quel mondo (il mondo dato nella percezione, nel ricordo,
nell’attesa e nella fantasia) alla soggettività.
5. La correlazione intenzionale: immanenza e trascendenza
Nelle pagine precedenti siamo stati continuamente rimandati alla percezione e all’esperienza
(ricordo, attesa, fantasia, intuizione eidetica) in quanto struttura originaria della manifestatività
dell’essere e, dunque, in quanto campo delle giustificazioni. Dobbiamo ora iniziare ad esplorare
questo campo di esperienza, cominciando appunto dalla percezione, o meglio, da una distinzione
classica e talvolta fuorviante: quella tra sensazione e percezione, tra immanenza e trascendenza.
L’analisi del concetto naturale di mondo non è infatti ancora l’analisi della costituzione
trascendentale. Questa emerge se passiamo dal mondo alla soggettività in cui si costituisce, e questo
cominciamo a farlo se comprendiamo che ogni evento o cosa del mondo naturale si manifesta in
modi di datità soggettiva. Percepisco il cubo in carne ed ossa, non ho una sua immagine, ma lo
percepisco secondo un modo di datità e una certa orientazione. Pertanto, abbiamo due datità: una
datità immanente e una trascendente, e la trascendenza si costituisce attraverso decorsi fenomenici.
Secondo Husserl, «da un lato si chiama fenomeno la coscienza effettiva [reell], cioè la cogitatio
effettiva, e dall’altra parte il contenuto ideale della cogitatio, l’oggettualità intenzionale»22.
21
22
Ivi, p. 10.
Husserl (2005), p. 54.
62
�Percepire e comprendere
Proponendo la distinzione tra immanenza e trascendenza Husserl non allude dunque alla
distinzione tra un interno e un esterno, bensì a una differenza ovvia nel modo di apparire, per cui
l’oggetto che si manifesta è sempre di più (dunque trascendente) rispetto alla sensazione attraverso
cui si presenta di volta in volta. Proprio qui si installa la differenza con la nozione di trascendenza
così come essa si impone nella prospettiva di Heidegger e attraverso cui questi introduce una
torsione profonda nella fenomenologia, poiché per Heidegger la trascendenza consiste nel fatto che
ogni ente rimanda oltre, verso altri enti23, sicché la trascendenza è resa possibile dal mondo in
quanto orizzonte di rimandi tra enti e la trascendenza indica lo specifico modo di essere nel mondo
dell’uomo, che è sempre oltre il proprio presente, sempre oltre l’ente presso cui è, sicché esso è
trascendenza nel fondo del suo essere. È in questo modo che Heidegger introduce il primato della
comprensione sulla percezione.
In Husserl il termine trascendenza assume invece un significato maggiormente ancorato alla
percezione, sicché potremmo indicare i modi soggettivi come i modi del sembrare, come un variare
del modo di apparire attraverso cui si manifesta un oggetto identico. Emerge così un duplice senso
di fenomeno: fenomeno come datità immanente, termine che può essere equivoco, in ogni caso
come manifestazione, come adombramento, forse anche sembianza, e fenomeno come ciò che si
manifesta, l’essere della cosa che resta identico nel variare dei suoi modi di apparire. Entrambi
sono dati in maniera indubitabile. Non solo è indubbio che io vedo questo lato rosso sotto queste
condizioni di luminosità cangianti, ma è anche indubbio che questo lato è manifestazione o aspetto
della bottiglia: la cosa può non esistere, ma è indubbio che io la percepisco e la percepisco come
una cosa che si adombra e si manifesta processualmente, secondo modi di datità! Indubitabile non è
dunque soltanto il dato sensazione, secondo uno stile fenomenistico (per esempio in Hume), ma
anche ciò che nel dato sensoriale si adombra: l’oggetto percepito. In questo modo, attraverso la
distinzione tra immanenza e trascendenza emerge la correlazione intenzionale, come campo
originario della ricerca fenomenologica. La riduzione fenomenologica opera dunque una
conversione dello sguardo: dall’oggetto all’apparire dell’oggetto. Questo apparire, sembrare, non
sono dati di sensazione dentro la coscienza, bensì modi di manifestazione della cosa stessa: sono la
cosa stessa vista prospetticamente. Sono appunto l’adombramento (Abschattung) della cosa stessa.
La coscienza trascendentale è dunque il campo in cui si costituiscono le trascendenze, attraverso
modi di manifestazione immanenti. Ciò che chiamiamo trascendenza non è qualcosa di esterno a
una cosa interna chiamata coscienza, bensì ciò che si offre attraverso modi di datità. Non vi è una
sua raffigurazione, ma essa è ciò che emerge nelle sintesi che si sviluppano tra modi di
manifestazione, ma che eccede (trascende) ogni manifestazione.
Il colore sentito varia continuamente e, in certe condizioni, può non essere quello che
attribuiamo all’oggetto in altre condizioni di luminosità, ma noi non pensiamo che sia cambiato il
colore dell’oggetto, bensì soltanto il suo apparire. Per questo, nella mutevolezza si costituisce
l’identità.
Proprio per questo l’oggetto si costituisce come ciò che nella manifestazione si manifesta, senza
ridursi alla manifestazione. La cosa non è solo il lato o i lati che mi sono dati effettivamente,
sensorialmente. Essa trascende, oltrepassa, è di più dell’importo sensoriale che è giunto o può
giungere a datità. In questo senso Husserl può riprendere la tematica della “cosa in sé”: questa
sarebbe la cosa vista in tutti i suoi aspetti, e non ciò che sta dietro i suoi aspetti. In questo senso
l’oggetto intenzionale è trascendente rispetto alla coscienza, e non nel senso che è al di là della
manifestazione. La cosa è più delle manifestazioni, ma non si trova dietro le manifestazioni. La
cosa in sé sarebbe la cosa data in tutti i suoi possibili modi di manifestazioni, senza più alcuna
anticipazione. Il che è un puro ideale teleologico della conoscenza, qualcosa che non può per
principio mai darsi. La coscienza non indica, dunque un interno tabernacolare, dove sarebbero
contenute le sensazioni, inaccessibile a ogni altro che non sia io, bensì il carattere sintetico e
processuale dell’esperienza.
23
Heidegger (1990).
63
�Vincenzo Costa
6. L’apertura del campo trascendentale
Il compito dell’analisi fenomenologica si viene quindi a configurare come una ricerca tesa a
mostrare come ogni concetto e ogni essere si costituisca in atti soggettivi, in decorsi di
manifestazione. Sviluppare questa ricerca significa operare una chiarificazione del senso dei nostri
concetti. Per esempio, per chiarire il senso della parola Dio, Religione, mente/corpo, storia,
motivazione, causa, ricordo, fantasia dobbiamo innanzitutto delimitare il campo di esperienza e il
modo in cui questi “oggetti” (queste trascendenze) si costituiscono in decorsi di manifestazioni e in
atti soggettivi. Per esempio, che cosa caratterizza un oggetto fantasticato rispetto a un oggetto
ricordato. Per ogni campo di ricerca dobbiamo chiederci:
1) Che tipo di esperienza è?
2) Che cosa si manifesta? (analisi noematica)
3) In quali modi di datità soggettiva si manifesta? (analisi iletica)
4) In quali atti si fenomenizza? (analisi noetica)
5) Quali sono i modi di comportarsi dell’io in questa esperienza? (analisi egologica)
Per esempio, se consideriamo l’esperienza del sacro, dobbiamo chiederci: esiste una percezione
del sacro? L’esperienza del sacro è relativa a un atto specifico (una sorta di percezione del sacro)
oppure in questa esperienza si intrecciano atti diversi (percezione, immaginazione, emozioni)? E
come si intrecciano? Oppure, i replicanti di Blade Runner hanno ricordi, a cui non è mai corrisposto
niente, e tuttavia essi non li confondono con atti di fantasia, per cui la loro differenza è del tutto
interna a differenti modi di datità.
Vogliamo dire che il criterio per dire se qualcosa è esistito o è stato solo fantastico si deve
trovare nelle caratteristiche interne al fenomeno, e va da sé che queste distinzioni devono guidare la
ricerca empirica. Per esempio, si dice che l’empatia sia una simulazione. Ma che cosa distingue una
simulazione fantastica da quella simulazione che starebbe alla base dell’empatia? Se non sappiamo
questo non possiamo neanche avviare una ricerca relativa ai differenti percorsi neurali.
7. Vissuti e linguaggio privato
Questa distinzione tra immanenza e trascendenza può tuttavia dare luogo a una critica, poiché
sembrerebbe ricondurre la costituzione trascendentale a dati di sensazione privati. In realtà,
abbiamo già detto che bisogna stare attenti, ed evitare di intendere le cose nel senso che ricondurre
la giustificazione all’esperienza significhi ricondurla a sensazioni private, come se dicessimo che il
significato della parola rosso consista nella propria sensazione di rosso. Forse qui bisognerebbe
distinguere nettamente tra percezione e significato, delimitando la sfera linguistica attraverso il suo
riferimento al significato, sicché una cosa è percepire i colori e un’altra è saperli esprimere
linguisticamente e saperli comprendere come significati. In ogni caso, è chiaro che fare ricorso a
sensazioni private significherebbe ricorrere a un metro inaccessibile, poiché è come se dicessimo
che ognuno ha una scatola dove può guardare solo lui, e in questo caso è chiaro che niente potrebbe
garantire che usiamo la parola coleottero (o rosso o dolore) allo stesso modo, e «potrebbe ben darsi
che ciascuno abbia nella scatola una cosa diversa»24. Per esempio, un daltonico e io potremmo dire
“rosso” di fronte alla stessa cosa, pur avendo sensazioni del tutto differenti. Se io costituisco il
senso della parola “rosso” attraverso il ricorso all’introspezione mi espongo dunque al rischio del
solipsismo. Ricorrere al vissuto non può pertanto significare fare ricorso a un evento privato e
inaccessibile agli altri, e non vi è dubbio che la costituzione dell’esperienza debba essere una
costituzione intersoggettiva.
E tuttavia, se da un lato bisogna evitare di ricondurre il significato delle parole a una coscienza
tabernacolare a cui solo io ho accesso, dall’altro bisogna anche evitare di giungere a dire che
comprendere il significato di una parola significa apprendere la regola d’uso. Questo potrebbe non
significare davvero molto. Apprendo che viene usata la parola dolore quando qualcuno la usa in un
24
Wittgenstein (1974), p. 293.
64
�Percepire e comprendere
certo contesto. Ma vogliamo sostenere che ne comprendo il significato anche se non la so applicare
ai miei vissuti?
Una cosa è dire che non apprendo la parola dolore attraverso il riferimento al mio vissuto
soggettivo, un’altra è dire che essa non si riferisce anche a questo. Difficile dire sin dove voglia
giungere Wittgenstein, ma se neghiamo che esistono esperienze in prima persona andiamo molto
oltre: una costituzione “solipsistica” è necessaria, e senza essa nessuna regola d’uso potrebbe essere
appresa. In fondo, per apprendere una regola d’uso da un altro devo averne percezione, percepirlo
come un corpo proprio, e attribuirgli una coscienza, e dunque dei vissuti analoghi ai miei. E poi, a
volte mi capita di avere male da qualche parte, e questo è un fatto non linguistico, che conosco
meglio di chiunque altro, e se tu mi dicessi come faccio a sapere che ho male alla caviglia potrei
dire semplicemente: so che la parola dolore si applica quando qualcuno mostra segni e
comportamenti che io posso interpretare come qualcosa di simile al dolore o a qualche sensazione
penosa che esperisco ora. Possiamo più limitatamente dire che possiamo parlare delle nostre
esperienze in prima persona perché vi è una correlazione costante tra il vissuto (l’esperienza
soggettiva) e ciò che si manifesta e che è sotto gli occhi di tutti. Cerchiamo di accennare appena ad
una linea di possibile soluzione di questo problema, perché qui bisogna evitare un equivoco e
comprendere bene il senso della parola costituzione.
Husserl non sta dicendo che la cosa è un insieme di dati di sensazione private. Questa è
l’impostazione classica del fenomenismo, secondo cui prima ho le sensazioni soggettive, poi queste
si collazionano, e la cosa non è altro che un insieme di sensazioni. In questo caso, quando parlo
della cosa, in realtà mi riferisco a sensazioni interne, a cui solo io ho accesso. Locke lo dice con
grande semplicità, quando osserva che i pensieri dell’uomo «sono dentro il suo petto, invisibili e
nascosti agli altri»25. La coscienza diviene allora una sorta di scatola al cui interno sono contenute
immagini, e le parole si riferiscono a questi stati interni. Di qui la ragionevolezza delle obiezioni di
Wittgenstein: quale criterio abbiamo per dire che tu ed io usiamo la parola coleottero nello stesso
senso? Come facciamo a saperlo? Questa domanda colpisce peraltro certamente la posizione di
Ernst Mach, a cui l’intero circolo di Vienna si era richiamato, e che scriveva che «la cosa, il corpo,
la materia non è altro che la connessione degli elementi, dei colori, dei suoni etc., null’altro che le
cosiddette note caratteristiche»26. Quindi, quando diciamo “casa” ci riferiamo a eventi interni. E
analogamente, William James notava che il puro apparire (il fenomeno), può essere visto sia come
qualcosa di relativo a una soggettività psichica sia a un mondo in sé. Per esempio, una certa stanza
viene percepita, ricordata, vista da differenti prospettive. In questo caso essa è considerata come
un’esperienza del soggetto. Ma essa può essere vista come qualcosa che esisteva prima che io
nascessi e che continuerà ad esistere anche dopo la mia morte. Questo secondo modo di intenderla
la colloca tra le cose fisiche che esistono indipendentemente dall’esperienza che faccio di esse 27.
Anche qui, dunque, vi sarebbero sensazioni private, che poi possono essere apprese
soggettivamente o oggettivamente. In maniera diversa stanno le cose per Husserl, secondo cui
le cose non sono manifestazioni, bensì l’elemento identico che si manifesta a me o a chiunque altro
attraverso una molteplicità di manifestazioni, adesso in questo modo adesso in quest’altro, conformemente
alla posizione soggettiva di questo io e alla sua costituzione corporea, normale o anomala etc. 28
L’errore consiste nel confondere il manifestarsi con l’essere vissuto. Secondo Husserl, le cose si
manifestano, ma non vengono vissute, mentre «le apparizioni stesse non si manifestano, esse
vengono vissute»29. Quando io percepisco un oggetto, lo percepisco attraverso modi di datità
soggettiva, da un certo lato, e questi modi vengono vissuti, ma ad essere percepito è un oggetto
identico disposto in uno spazio intersoggettivo e non una sensazione. L’oggetto non è un vissuto,
25
Locke (1972), p. 7.
Mach (1975), p. 41.
27
James (2009), p. 5.
28
Husserl (2008), pp. 14-15.
29
Husserl (1988), p. 142.
26
65
�Vincenzo Costa
ma ciò che si manifesta nel vissuto. Pertanto, la differenza tra soggettivo e oggettivo non è una
differenza tra due modi di intendere la stessa apparizione, ma indica il fatto che l’oggetto percepito
viene percepito sempre attraverso modi di datità soggettiva, secondo adombramenti.
Noi non abbiamo mai dati di sensazione, ma apparizioni di cose. Non vedo una forma e un
colore, ma una bottiglia vista da un certo punto di vista, e che questo colore sia determinato dalla
relazione che la bottiglia intrattiene con una certa fonte di luce (la finestra aperta o la lampada
accesa) è qualcosa che si costituisce e diventa qualcosa di cui sono cosciente (che esiste per me)
solo in quanto ne ho esperienza, solo in quanto l’oggettivo si rende fenomeno. E questa differenza
tra sembrare ed essere si costituisce senza alcun richiamo a dati di sensazione: semplicemente
prendo la bottiglia e ti faccio vedere che se la guardiamo attraverso la luce elettrica essa assume una
colorazione differente da quando la osserviamo alla luce del Sole, e tuttavia resta la stessa bottiglia.
Dunque, non tutti abbiamo le stesse sensazioni, ma tutti vediamo la stessa cosa. E tuttavia la
vediamo secondo modi di datità soggettivi. La stessa cosa si offre soggettivamente. Proprio per
questo è chiaro che apprendiamo l’uso delle parole in relazione a ciò che si manifesta
intersoggettivamente e non in relazione a dati di sensazione, e impariamo nell’esperienza che ciò
che si manifesta può avere modi di manifestazione differenti, a seconda del contesto di luminosità o
a seconda del contesto fisiologico, nel caso del daltonico. Oppure, se ho bevuto troppo alcool posso
vedere la stanza ruotare vertiginosamente, ma posso attribuire ciò al sembrare, continuando a
pensare che l’essere della stanza non è stato alterato.
E tuttavia, non impariamo effettivamente un linguaggio sin quando non lo sappiamo applicare
anche ai modi di manifestazione e ai nostri propri vissuti. Soprattutto non si può costituire un
soggetto personale sin quando questi non impara ad applicare a se stesso, in prima persona, ciò che
ha appreso ad applicare secondo regole d’uso in certe circostanze intersoggettive. Cerchiamo di
articolare meglio le ragioni che potremmo portare a sostegno di questa tesi.
8. Il dolore: prima persona e criterio di controllo
Cerchiamo di chiarire questo aspetto attraverso due esempi, che del resto è meglio tenere separati:
l’esperienza del dolore e l’esperienza dei colori. Sulle prime, collegato alla parola dolore non è un
dato di sensazione, ma un contesto di azione esperito. Originariamente esperisco un contesto di
senso, un’espressione dell’altro, un’azione (tipo: è stato portato in ospedale perché aveva forti
dolori all’addome) e in quel contesto colgo come viene usata la parola dolore.
Per esempio, può essere usata quando l’altro si lamenta, in riferimento ai suoi gemiti (“Quanto
dolore, poverino”), oppure quando gli è venuta a mancare una persona (“È un dolore immenso per
lui”), quando viene piantato da una persona che ama (“Che dolore per lui!”). Al contrario, la regola
d’uso vieta di usarla quando ride, quando scopre che una persona che ama lo ama a sua volta e
quando prende 30 e lode all’esame etc. Qui sarebbe una violazione del gioco linguistico dire:
“Guarda come ride. Si vede tutto il suo dolore”. Oppure: “Ha preso trenta e lode. Che cosa
dolorosa!”. Quando sorprendo me stesso a comportarmi nello stesso modo di quell’altro, quando mi
trovo nelle stesse condizioni intersoggettive ho tuttavia qualcosa in più. Questa volta al
comportamento esterno associo anche un’esperienza interna: ho preso trenta e lode e provo felicità.
Sono stato piantato e sono veramente addolorato.
Ho superato l’esame con trenta e lode, e quando mi dici: Sei felice eh? che sono felice lo so
davvero in prima persona, e lo so perché ho imparato ad applicare la regola d’uso a me stesso,
perché adesso il termine “felice” si arricchisce di una esperienza in prima persona. Non la
comprendo solo in riferimento a contesti d’azione, ma in riferimento a emozioni che vivo in prima
persona. Generalmente, di essere felici non lo scopriamo osservando come ci stiamo comportando.
Prima avevo sentito dire che chi prende 30 è lode è felice. Ora ho fatto questa esperienza in prima
persona. Dunque, qui trasferisco la parola appresa rispetto al comportamento a uno “stato interno”.
In questo trasferimento può crearsi un pericoloso slittamento di senso che abbiamo segnalato.
Posso dire: “Ho una sensazione di felicità”, invece di dire “sono felice”. Posso cioè indicare l’essere
felice come un dato di sensazione interno o come un modo di sentirmi nel mondo, come un sentirsi
66
�Percepire e comprendere
situato nel mondo di cui possiamo descrivere la struttura: essere felici di avere superato l’esame
con 30 e lode significa che cambia il mio modo di essere nel mondo, che un insieme di possibilità si
aprono, mentre l’essere bocciati le avrebbe chiuse, che ho degli orizzonti d’attesa, che posso
proiettarmi verso di essi. Essere abbandonato da una persona amata può significare che vengono
meno gli orizzonti di attesa, che il proprio poter essere si annebbia o viene annientato, sicché non si
ha letteralmente più futuro né possibilità che interpellano l’esistenza, come emerge da espressioni
quotidiane come “mi è crollato il mondo addosso”, “mi manca la terra sotto i piedi” etc. In questo
senso, le emozioni non le “ho”, non sono dentro di me: sono io ad essere dentro di esse, poiché esso
sono un modo di sentirmi nel mondo. Appena dico “ho” sembra che vi sia qualcosa all’interno, un
possesso, un contenuto, cioè qualcosa di contenuto dentro un tabernacolo.
In questo contesto introduttivo ci interessa dunque segnalare che bisogna passare per
Wittgenstein nella critica al fenomenismo e all’idea che il significato delle parole consista nel loro
riferimento a stati soggettivi inaccessibile agli altri. Ma poi bisogna prendere le distanze da una
posizione che non è chiaro se è in grado di spiegare il riferimento delle parole a stati personali, e
dunque che non è chiaro se è in grado di spiegare il fatto che l’apprendimento della regola d’uso è
parziale sin quando non diventa una capacità di applicare a se stessi quello che si sa applicare in
contesti d’uso. Una regola d’uso riferita a contesti potrebbe applicarla anche una macchina priva di
vissuti e dotata di un programma, mentre tutto cambia quando vi è qualcuno che la sa applicare a se
stesso e al proprio mondo interiore: qui emerge il concetto di persona, che è un concetto
intersoggettivo.
Il punto è dunque che da un lato i predicati di tipo mentale (dolore, gioia etc.), che noi
attribuiamo alle persone, non possono sorgere all’interno di un atteggiamento solipsistico, ed
implicano che si abbia già la nozione di sé e di altri. Dall’altro che solo quanto siamo capaci di
usare quelle espressioni rispetto a noi stessi ne afferriamo un significato specifico e ampio, legato
alle nostre esperienze. Riprendendo un ragionamento di Strawson potremmo dire così:
1) Per avere una nozione del proprio sé bisogna avere una nozione di che cosa sono gli stati
mentali, dato che bisogna poter interpretare se stessi come un soggetto dotato di episodi interni;
2) la nozione di stato mentale, tuttavia, non sorge in un atteggiamento solipsistico ma osservando
gli altri e imparando a usare le parole all’interno di un certo contesto (se volete di un gioco
linguistico);
3) di conseguenza, per poter cogliere se stessi come soggetti portatori di stati mentali è
necessario avere una nozione di altri ed essere capaci di ascrivere loro stati mentali. In altri termini,
per potere ascrivere a me stesso stati mentali devo, nello stesso tempo, essere capace di distinguerli
da quelli di altri. Pertanto,
4) l’ascrizione di stati mentali ad altri deve procedere parallelamente all’ascrizione di stati
mentali a se stessi.
5) Così, quando usiamo il termine “dolore” non indichiamo il nostro dolore che, per analogia,
viene esteso all’altro. Il termine dolore indica, invece, un criterio in base al quale un certo
comportamento viene interpretato come correlato a uno stato mentale.
6) Solo quando si giunge a ciò si perviene a una piena comprensione del termine dolore.
Altrimenti avremmo o un linguaggio privato (il termine riferito a uno stato interno) o una deriva
comportamentistica (il termine dolore indica solo un comportamento), mentre io uso legittimamente
il termine dolore per indicare il mio mal di denti.
7) In questo caso, dunque, il nucleo centrale è la correlazione tra comportamento e stato mentale,
e questo significa che se da un lato i predicati personali non si riferiscono a stati mentali interni,
dall’altro non derivano neanche soltanto dall’osservazione di comportamenti, ma dal fatto che
possono essere usati sia alla prima persona (sono depresso) che alla terza (è depresso), sicché
«apprendere il loro uso significa apprendere entrambi gli aspetti del loro uso. Per avere questo tipo
67
�Vincenzo Costa
di concetto si devono attribuire tali predicati tanto a se stessi quanto agli altri, e si deve vedere ogni
altro come un autoattributore»30.
9. Il colore: colore sentito e colore percepito
La nostra discussione sulla percezione esterna potrebbe sembrare tuttavia alludere a una precedenza
del “sembrare” rispetto all’“essere”. Per esempio, prima avremmo diverse sensazioni diverse di
rosso e poi, in qualche modo, l’essere rosso dell’oggetto. Le cose non stanno così. Per chiarire il
punto richiamiamoci liberamente a un esempio contenuto in Empirismo e filosofia della mente di
Sellars. Immaginiamo un venditore di cravatte che ha imparato a chiamare i colori delle cravatte
conformemente a come li chiamano gli altri: questa è rossa, questa è verde. Lo dice davanti agli altri
e gli altri acconsentono. Tutti gli dicono, nella sostanza, che sta usando il termine rosso o verde in
modo appropriato. Tuttavia, a un certo punto viene inventata la corrente elettrica, e tutti imparano
che, in condizioni di illuminazione elettrica, il colore appare diverso, imparano che quella che nel
negozio sembra verde è “in realtà” blu. Tranne il nostro poveretto, che vede il colore delle cravatte
solo nel negozio. Cioè le vede, e questo è quello che ci interessa, senza sintesi della coincidenza,
per esempio prendendo una cravatta, guardandola nel negozio, e poi spostandola progressivamente
e in maniera continua sotto un’altra fonte di luce.
Dopo un poco, viene un conoscente per comprare una magnifica cravatta verde, e il nostro
poveretto gli dice “ecco una magnifica cravatta verde”. E il conoscente ribatte: Ma non è verde, è
blu. E per convincerlo lo porta fuori e gliela mostra alla luce del sole. Qui, pensare o inferire che la
cravatta ha cambiato colore, che sia cambiato l’essere della cravatta, che la luce alteri l’essere blu
sarebbe non comprendere la grammatica dell’esperienza, cioè la struttura delle dipendenze
funzionali, e il poveretto perderebbe la credenza nella costanza ed esistenza continuata degli oggetti
(dei colori degli oggetti). Ma farebbe questo solo se, ragionando troppo, non seguisse quello che
l’esperienza suggerisce a tutti: che è lo stesso colore che in circostanze di luminosità diversa
appaiono diverse. Che cosa ci dice questa storia?
1) Che la differenza tra apparire (manifestazione) e cosa che appare (ciò che si manifesta) si
costituisce attraverso delle sintesi, attraverso le quali l’essere si separa dall’apparire.
2) Che in queste sintesi noi determiniamo un optimum, cioè qual è il colore reale. Impariamo a
distinguere come una cosa sembra e come è, e questo non implica un ricorso ai dati di sensazione
interni, ma semplicemente manifesta la correlazione intenzionale che, nell’atteggiamento naturale,
rimane implicito e che l’atteggiamento fenomenologico rende tematico.
3) Qual è il vero colore lo definisce l’interesse, e lo determiniamo a partire da oggetti. Per
esempio Rosa, amaranto, arancione. Quindi apprendiamo l’uso e il significato dei colori a partire da
oggetti privilegiati, per cui il linguaggio si radica nell’esperienza di possibilità di azioni presenti nel
mondo.
4) Ma poi l’esperienza ci insegna a determinare il vero colore dell’oggetto senza curarci della
mutevolezza dei suoi modi di apparire (di datità). Questa correlazione è data, e l’analisi
fenomenologica semplicemente ripercorre le vie di esperienza che ci autorizzano a “correggere”
l’apparire in direzione dell’essere, per esempio quando, vedendo una cravatta blu sotto una luce che
ce la presenta come verde, non diciamo che è verde: diciamo sembra verde, ma è blu. Lo
determiniamo da quello che viene considerato il punto di maggior chiarezza.
10. Ricapitolazione
Abbiamo cercato di presentare le nozioni di immanenza e trascendenza, e la loro correlazione
intenzionale. Per chiarire che l’immanenza non rimanda a sensazioni “private” e che la coscienza
trascendentale non allude a una coscienza tabernacolare abbiamo liberamente tratto spunti da
Wittgenstein e Sellars. Ma si tratta appunto di meri spunti, che non devono in nessun modo essere
intesi come un confronto critico con questi autori, di cui non stiamo affatto tentando
30
Strawson (1978), p. 89.
68
�Percepire e comprendere
un’interpretazione e di cui lasciamo a margine il senso e la direzione. Ci interessava fare emergere
la posizione di Husserl, senza esprimerci su ciò che “veramente” Wittgenstein o Sellars vogliono
dire.
Abbiamo voluto mettere in luce:
1) che l’immanenza è il modo di datità della trascendenza, e non un contenuto “interno”, privato,
ma la cosa vista da un certo punto di vista, cioè come la potrebbe vedere chiunque se assumesse
quella determinata orientazione spaziale.
2) che vi è una dialettica costante tra immanenza e trascendenza e che gli aspetti immanenti
determinano come la cosa trascendente deve essere intesa.
3) che “sembrare” (apparire) ed essere si costituiscono nello stesso movimento.
4) che una comprensione piena delle parole emergo solo quando le sappiamo applicare (usare)
sia in relazione a contesti sia in relazione ai nostri vissuti.
Per finire dobbiamo correggere un punto. Seguendo Strawson abbiamo, per ragioni di economia
del discorso, usato una terminologia che può essere fuorviante, quando abbiamo detto che una
comprensione piena della parola si ha quando la si sa usar sia in relazione ai nostri stati interni sia in
relazione a quelli degli altri, in quanto persone capaci di ascrivere a se stessi “stati interni”.
Dobbiamo ora rettificare questa terminologia, e vi propongo di usare la seguente terminologia:
comprendiamo pienamente una parola quando la sappiamo usare per indicare sia il nostro sentirci
nel mondo sia il sentirsi nel mondo degli altri. Chiarire questo punto allude però già ad un altro
orizzonte di problemi.
Bibliografia
Avenarius, R. (1927), Der menschliche Weltbegriff, Leipzig.
Heidegger, M. (1990), Principi metafisici della logica, trad. it. a cura di G. Moretto, il melangolo,
Genova.
Husserl, E. (1962), Phänomenologische Psychologie. Vorlesungen Sommersemester 1925,
Husserliana, vol. IX, Nijhoff, Den Haag.
Husserl, E. (1987), Aufsätze und Vorträge, Husserliana, Bd. XXVII, a cura di Th. Nenon e H.R.
Sepp, Kluwer, Dordrecht.
Husserl, E. (1988), Ricerche logiche vol. II, trad. it. a cura di G. Piana, Il Saggiatore, Milano.
Husserl, E. (1991), Rovesciamento della dottrina copernicana nell’interpretazione della corrente
visione del mondo, trad. it. a cura di G. D. Neri, Aut-Aut, vol. 245, pp. 3-18.
Husserl, E. (1993), Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale
Phänomenologie. Ergänzungsband: Texte aus dem Nachlaß 1934-1937, Husserliana, Bd. XXIX,
a cura di R. Smid, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
Husserl, E. (2001), Natur und Geist. Vorlesungen Sommersemester 1927, Husserliana, Bd. XXXII,
a cura di M. Weiler, Kluwer, Dordrecht.
Husserl, E. (2005), Einführung in die Phänomenologie der Erkenntnis. Vorlesung 1909,
Husserliana, Materialien, vol. VII, a cura di E. Schuhmann, Springer, Dordrecht.
Husserl, E. (2007), Filosofia prima. Teoria della riduzione fenomenologica, trad. it. di A. Staiti, a
cura di V. Costa, Rubbettino, Soveria Mannelli.
Husserl, E. (2007), Teoria della riduzione fenomenologica, trad. it. di A. Staiti, a cura di V. Costa,
Rubbettino, Soveria Mannelli.
Husserl, E. (2008), I problemi fondamentali della fenomenologia. Lezioni sul concetto naturale di
mondo, trad. it. a cura di V. Costa, Quodlibet, Macerata.
James, W. (2009), Esiste la coscienza?, trad. it. a cura di S. Francese, in Saggi di empirismo
radicale, Quodlibet, Macerata.
Kuhn, Th. (1978), La struttura delle rivoluzioni scientifiche, trad. it. a cura di A. Carugo, Einaudi,
Torino.
69
�Vincenzo Costa
Locke, J. (1972), Saggio sull’intelligenza umana. Libro terzo, trad. it. a cura di C. Pellizzi, Laterza,
Bari.
Mach, E. (1975), L’analisi delle sensazioni ed il rapporto tra fisico e psichico, trad. it. a cura di L.
Sosio, Feltrinelli/Bocca, Milano.
McDowell, J. (1999), Mente e mondo, trad. it. a cura di C. Nizzo, Einaudi, Torino.
Quine, W. (1996), Parola e oggetto, trad. it. di F. Mondadori, Il Saggiatore, Milano.
Sellars, W. (2004), Empirismo e filosofia della mente, trad. it. a cura di E. Sacchi, Einaudi, Torino.
Strawson, P.F. (1978), Individui. Saggio di metafisica descrittiva, trad. it. a cura di E. Bencivenga,
Milano, Feltrinelli.
Wittgenstein, L. (1974), Ricerche filosofiche, Philosophische Untersuchungen, a cura di M.
Trinchero, Einaudi, Torino.
Abstract
Phenomenology has mostly focused on the concept of world rather than on that of psychological
subject. In this paper, I highlight immanence as a mode of giveness of transcendence rather than a
“private” content. The object is not a multiplicity of data of sensation and the appearance is the
thing as determined from a certain point of view, namely, how could anyone see it in a particular
spatial orientation. Therefore there is a constant dialectic between immanence and transcendence
and the immanent aspects determine how transcendent things must be understood. As a result, being
as consciousness and being as reality are constituted within the same transcendental movement and
a full understanding of words only emerges when we know how to apply them both in relation to
worldly contexts and in relation to our lived experience. This is the meaning of the idea according
to which all reality ultimately exists by virtue of a sense-bestowal.
Keywords: Phenomenology, Meaning, Experience, Lifeworld
70
�IVO DE GENNARO*
Tempo e arte: note per una fenomenologia **
1. Premessa
Le seguenti note hanno lo scopo di portare all’attenzione, in una prospettiva fenomenologica,
un tema di ricerca, oggi scarsamente considerato, che chiameremo «il tempo artistico». Tale
locuzione non fa riferimento a una particolare forma, o variante, del noto fenomeno del
tempo, né al modo in cui quest’ultimo compare, o viene trattato, oggi e in passato, nelle
diverse discipline artistiche. Piuttosto, essa indica un fenomeno (variamente scorto nell’arte
del secolo scorso), il quale, pur essendo detto «tempo», non si lascia tuttavia ricondurre a
quanto la tradizione filosofica pensa in questo nome, né, di conseguenza, alle concezioni del
tempo, scientifiche o del senso comune, che entro quella tradizione si sono formate.
Che tale scorgimento artistico divenga a sua volta scorgibile, e dunque assumibile in un
tentativo di chiarimento filosofico, è d’altronde innanzitutto dovuto – secondo l’ipotesi qui
proposta – alla novità costituita dalla tematizzazione del tempo nel pensiero di Heidegger.
Infatti, tale tematizzazione, con cui in un certo senso si inaugura e si compie il Denkweg del
pensatore tedesco1, reca in dote un orizzonte interpretativo nel quale la “scoperta del tempo”,
avvenuta nell’arte del Novecento, può dispiegarsi e trovare ascolto nella sua (di quell’arte)
verità – a differenza di quanto accade, invece, quando si adotti (sempre riguardo a quell’arte)
una prospettiva informata al concetto di tempo elaborato nella tradizione metafisica. D’altra
parte, quell’orizzonte è quanto di più lontano vi sia da una concezione dogmatica e in sé
conclusa, configurandosi piuttosto come un primo errante “getto d’intesa” in direzione di un
ordine del senso finora non entrato nelle “cure” del pensiero.
Si delinea in tal modo la seguente costellazione ermeneutica (del resto del tutto consueta
per la teoresi filosofica): l’interrogazione tentata dal Denkweg “dissoda” un terreno
fenomenico, detto «tempo» (ovvero «tempo originario»), non ancora assunto tematicamente
nel pensiero esperide, offrendo così un piano di attendibilità al fenomeno «tempo artistico»,
autonomamente scorto e messo in opera nell’arte, fenomeno il cui chiarimento, infine,
sostiene la stessa “primitiva” interrogazione del tempo tentata dal pensiero. Con riguardo a
tale costellazione, in questa sede limiteremo al più stringato richiamo la preparatoria
esposizione del senso del tempo puntualizzato nel Denkweg, privilegiando invece la – pur
cursoria – esplorazione dei tratti del tempo artistico formulati nel pensiero di tre artisti del
Novecento: il musicista Sergiu Celibidache, lo scultore Eduardo Chillida e il pittore Paul
Klee.
2. Il tempo originario: spazio-di-tempo – simultaneità
Il termine «tempo originario» indica una nozione non più metafisica di tempo. Nella
tradizione metafisica, «tempo» è una categoria dell’ente scorto nel suo essere, ovvero del
contingente che, flagrante nella sua sussistenza, si mostra nel riferimento a un discontingente, stabile fondamento, a sua volta ricondotto a un sé-fondantesi principio d’essere.
Indichiamo la nozione di tempo coniata in tale intesa dell’essere con il nome «tempo
metafisico». La determinazione del tempo metafisico dipende dunque ogni volta dall’intesa
dell’essere dell’ente, inizialmente dall’essere scorto come physis e ousia 2 . Il tempo
metafisico, in quanto categoria dell’essente, implica le nozioni di «successione» (degli “attimi
*
Libera Università degli Studi di Bolzano
**
Ringrazio Gino Zaccaria per i suggerimenti forniti durante la comune lettura di questo saggio.
Il riferimento è al tratto di cammino marcato dagli scritti Essere e tempo (1927) e Tempo ed essere (1962).
2
Cfr. Heidegger (1989), pp. 375-376.
1
Bollettino Filosofico 33 (2018): 71-84
ISSN 1593 -7178 - 00030
E-ISSN 2035 -2670
DOI 10.6093/1593-7178/5907
�Ivo De Gennaro
di tempo”) e di «durata» (dell’ente durevolmente collocato “nel” tempo), nozioni che, al
contrario, non hanno un ruolo costitutivo nel tempo originario. A tal proposito, nei Beiträge
zur Philosophie Heidegger scrive:
Nur wo ein Vorhandenes festgehalten wird und festgelegt wird, entspringt der an ihm
vorbeifließende Fluß der „Zeit“ und der es umgebende „Raum“ 3.
Soltanto là dove un che di contingente sia tenuto fisso [in uno scorgimento d’essere], e quindi
stabilito [sul fondamento di quell’essere], scaturisce il flusso del “tempo” che gli fluisce accanto,
nonché lo “spazio” che lo circonda.
Il trattato Essere e tempo 4 , il cui progetto resta formalmente improntato allo schema
metafisico della trascendenza, segna l’esordio del pensiero non più metafisico in quanto
pensiero del tempo originario. Il tempo è ora un tratto del generarsi dell’essere stesso 5, e, in
quanto tale, non scorre accanto al già stabilito ente, né dà luogo a un suo durare. L’essere
stesso, presto pensato, secondo la sua indole geniturale (geschichtlich), come Ereignis –
ovvero, diciamo noi, come addicenza o accortezza6 –, si genera lasciando irrompere, per il
proprio stanziarsi e con l’ingenita scorta dell’uomo, lo spazio-di-tempo (Zeit-Raum)
originario. Quest’ultimo non è la congiunzione di un a sé stante spazio e di un a sé stante
tempo originari, bensì la pristina temprata flagranza dello scoscendimento (Zerklüftung) 7
dell’accortezza e delle sue rotte di conversione (Kehrungsbahnen)8; soltanto da tale pristina
temprata flagranza quello spazio e quel tempo si lasciano innanzitutto scorgere, nel loro scisso
ma mai separato stanziarsi, quali modi d’inveramento dell’Abgrund – ovvero, diciamo noi,
del nulla-di-fondo, o anche, semplicemente, del nulla 9.
Infatti, poiché l’essere stesso si genera, nello stagliarsi dell’Abgrund, in quanto versante
disdirsi (zögerndes Sichversagen) del fondo, lo spazio-di-tempo originario, conformemente,
irrompe secondo i tratti del disdirsi (che disegna la fuga di rotte del tempo originario) e del
versare (che tempra lo spazio originario). Ora, poiché l’Abgrund, il nulla(-di-fondo), è
l’originario stanziarsi del fondo, e il fondo è, a sua volta, lo stanziarsi della verità, ossia della
flagranza (Da) in cui si scorgono a vicenda l’essere stesso e l’essere dell’uomo (in quanto
ertezza che, in essa ingenita, ha da adergere, e, in tal senso, “essere” [sein], quella flagranza),
lo stagliarsi del nulla nell’irrompere dello spazio-di-tempo originario configura quest’ultimo
come località dell’istante d’accortezza (Augenblicksstätte) 10 del Da-sein – ovvero, diciamo
noi, dell’ad-essere.
3
Ivi, p. 382. Nel contesto del tempo metafisico, l’attimo è inteso come un ravvisamento categoriale
dell’essente – in particolare, secondo la definizione aristotelica, il ravvisamento che, dell’essente, scorge la
momentanea collocazione in un adesso determinabile rispetto a un prima e un dopo. Sul concetto aristotelico di
tempo, da cui deriva ciò qui chiamiamo, sommariamente, «tempo metafisico», si veda Zaccaria (2018).
4
Heidegger (1986).
5
Ovvero, come si dirà nel seguito, una sua «funzione», cfr. infra.
6
Sulle traduzioni di Da-sein e Ereignis si vedano De Gennaro e Zaccaria (2007), pp. 77 ss., Zaccaria (2015),
pp. 89 ss., e Zaccaria (2009), pp. 13 ss.
7
Lo spazio-di-tempo (in quanto Augenblicksstätte, cfr. n. 10) «rende accessibile e fermo, nell’ad-essere, lo
scoscendimento dell’essære» (Heidegger [1989], p. 235). Sulla resa di Seyn con «essære» si veda De Gennaro e
Zaccaria (2007), pp. 11-12. Si noti come la parola «scoscendimento» derivi da dis-cum-scindere, e dunque a suo
modo indichi, appunto, la Zerklüftung quale raccolta di scissure mediante cui si addice il disdirsi dell’accortezza,
a sua volta intesa come Unico scisma (Unterschied).
8
Sulla Kehre si veda De Gennaro e Zaccaria (2007), pp. 155 ss.
9
Sullo spazio-di-tempo, e sulle brevi delucidazioni compendiate nei prossimi due capoversi, si veda la
partizione 242 (Der Zeit-Raum als der Abgrund) dei Beiträge (Heidegger [1989], pp. 379-388). Sulle rotte di
conversione si veda infra la n. 10. Sulla traduzione di Abgrund con «nulla» si veda Zaccaria (2009), p. 25.
10
Sull’Abgrund in quanto Augenblicksstätte si veda ivi, pp. 371, 375, e, in particolare, pp. 382, 384, 387. A
p. 387 leggiamo: «Der Ab-grund ist […] die in sich zeitigend-räumend-gegenschwingende Augenblicksstätte des
“Zwischen”, als welches das Da-sein gegründet sein muss». «Il nulla-di-fondo è l’in sé temporizzante-spaziante-
72
�Tempo e arte. Note per una fenomenologia
Fra i tratti del tempo originario che promettono di contribuire a un chiarimento del tempo
artistico, vi sono, in primo luogo, il suo (del tempo originario) configurarsi come simultaneità,
e, in secondo luogo, la sua essenza spaziante 11 . Entrambi i tratti sono impliciti nella
determinazione dello spazio-di-tempo come località dell’istante d’accortezza dell’ad-essere. Il
«configurarsi come simultaneità» fa riferimento alla circostanza che il tempo irrompe in virtù
dell’unico, scindente-fugante disdirsi che disloca (entrückt) nelle simultanee rotte della
venturità (Künftigkeit) e dell’avveniente avvenuto istante (das Gewesende), rotte che, a loro
volta, s’incontrano nell’avvenenza dell’istante d’accortezza (ossia nella Gegenwart in quanto
Augenblick) 12 . L’«essenza spaziante del tempo» indica il suo allocare – nella misura del
versante disdirsi – i modi dell’avvincere (berücken) e del circomprendere (umhalten), in cui si
stanzia lo spazio originario.
Il tempo originario, in sé simultaneo e spaziante, e libero dallo scorrere (dunque dai tratti
della successione e della durata)13, costituisce l’orizzonte ermeneutico per l’esame di alcune
tematizzazioni del tempo nell’arte contemporanea. Tale esame si configura come una “prova
di attendibilità” per quello stesso orizzonte; infatti, esso dovrà mostrarsi capace di dare, a sua
volta, piena attendibilità al tempo artistico, là dove quest’ultimo non si lasci ricondurre alla
determinazione tradizionale del tempo (che discende dalla trascuratezza del tempo originario),
e dunque nemmeno al “tempo dell’orologio”, che di quella determinazione è un esito.
3. Celibidache: contro-tempo e simultaneità
Un caposaldo del pensiero di Sergiu Celibidache14 è la sua intesa del Tempo, parola che, nella
terminologia musicale tedesca, comunemente indica il “tempo” inteso come velocità di
esecuzione15. Al termine del presente tentativo d’interpretazione, renderemo das Tempo con il
conio «il contro-tempo», che tuttavia non deve essere confuso con il corrente concetto di
«controtempo» (o «contro tempo») musicale. Come vedremo, il contro-tempo indica
l’adergenza del tempo originario in quanto spazio-di-tempo dell’inverarsi dell’inizio nella sua
fine, ovvero del suo (dell’inizio) tornare, infine, ad iniziare16.
contro-oscillante località dell’istante d’accortezza dell’“indugio” quale forma in cui dev’essere fondato l’adessere». Il tratto della contro-oscillanza rinvia alla Kehre nell’Ereignis, ovvero al suo (dell’Ereignis) stagliarsi
nelle rotte di conversione di Zuruf (richiamo) e Zugehörigkeit (ingenitezza) (richiamo, e, per converso,
ingenitezza; ingenitezza, e, per converso, richiamo).
11
Il tempo è spaziante, allocante spazio, senza tuttavia mai stanziarsi nel modo dello spazio, ovvero secondo
il tratto del Berücken, o, diciamo noi, dell’avvincere (si veda ivi, p. 386).
12
La locuzione das Gewesende è un conio di Heidegger: incrociando il participio passato di sein (gewesen)
con quello presente di wesen (wesend), essa indica come l’avvenuto istante (das Gewesene) non sia confinato nel
“passato”, ma ancora si stanzi e concerna l’uomo nell’avvento della venturità. L’istante di tale avvento, in cui
s’incontrano, appunto, l’ancora stanziantesi avvenuto istante e la non ancora stanziatasi venturità, è la
Gegenwart.
13
Il nostro tentativo di chiarire il tempo artistico non nega in assoluto i fenomeni (peraltro constatabili) della
successione e della durata; piuttosto, successione e durata vengono messe tra parentesi nel senso (contingente) in
cui caratterizzano il tempo metafisico o tempo dell’ente, per essere ritrovate, quali tratti del tempo originario, o
della simultaneità, nel terzo paragrafo di questo saggio.
14
Il pensiero musicale di Celibidache è documentato in alcuni brevi scritti (tra cui Celibidache [2008]), e in
numerose interviste e trascrizioni di colloqui, per lo più in lingua tedesca o francese (la più ampia raccolta di tali
documenti si trova in Celibidache [2012]). Tra gli studi critici in italiano si veda, in particolare, quello di
Accornero (2016), che espone alcuni concetti di fondo del pensiero del musicista rumeno con dovizia di
riferimenti alle fonti testuali.
15
A tal proposito, nella terminologia musicale italiana si parla di «indicazione agogica», che a sua volta può
tradursi in un tempo metronomico.
16
Che l’inizio torni, infine, a iniziare (che finisca per iniziare nella sua in-finita ultroneità) – questo è,
nell’esperienza di Celibidache, il senso del fare musica, e, prima ancora, del comporla. (Sull’ultroneità si veda
infra la n. 31)
73
�Ivo De Gennaro
Il Tempo – das phänomenologische Tempo17 – è «l’unico ambito entro il quale lo stanziarsi
della musica diviene attendibile» 18 . Come tale, esso resta estraneo a ciò che Celibidache
chiama «tempo meccanico» o «tempo fisico»19, ovvero il flusso di attimi che determina una
durata, tempo il cui scorrere è uniformemente scandito – in un modo che tuttavia risulta, in
senso musicale, «arbitrario»20 – dal metronomo21. Intendere il Tempo nei termini e sul piano
del «tempo fisico», implica confonderlo con la velocità, e, di conseguenza, fraintendere il
senso della lentezza – nozione che, al contrario, è indicativa del Tempo fenomenologicamente
inteso. Ecco come, nel corso di un colloquio, Celibidache discrimina fra lentezza e velocità:
[Interlocutore] Quando Le si dice che Lei, eseguendo la musica di Bruckner, è lento, non si ha
alcuna idea di ciò di cui si tratta.
[Celibidache] Si ha una concezione interamente meccanica della lentezza, si prende la lentezza alla
luce della velocità. Il tempo22 non ha niente della velocità, il tempo è l’attendibilità di cogliere la
moltitudine della ricchezza23 – che non è riducibile. Puoi ignorarla, puoi non lasciarla venire, non
lasciare che si materializzi – questo è affar tuo, ma tutto ciò non ha niente da spartire con la velocità.
Al contrario, i tempo lenti – l’adagio, il largo – sono dei tempo in cui il compositore si esprime nella
24
totalità della sua ricchezza.
E ancora, in altri momenti del colloquio:
La velocità non ha niente da spartire con il tempo; il tempo è la condizione affinché la ricchezza
possa essere percepita. D’altronde, che essa possa generarsi, e quindi essere percepita – nessuno di
questi scorgimenti esistono oggigiorno […].
La velocità non ha niente da spartire con il tempo. La confusione fra tempo e velocità è una
concezione <dovuta alla> totale mancanza di musica nella nostra epoca. Ogni tempo ha un colore
speciale, poiché il suono non è la materializzazione di tutti gli elementi allo stesso tempo; <infatti,>
gli epifenomeni, i fenomeni laterali, appaiono entro il tempo, <e> con il tempo e grazie al tempo il
suono diventa più ricco. Ogni suono è un sistema solare irriducibile: ora, che succede se passo da un
sistema solare a un altro senza aver lasciato il tempo al primo di svilupparsi completamente? È un
taglio nella ricchezza dell’espressione. Mozzo il primo [sistema solare] mediante la presenza di un
altro. Il risultato è un’aridità; rinuncio alla ricchezza. Dunque, la ricchezza è appannaggio della
lentezza, nel tempo lento ha luogo la ricchezza; dunque il tempo lento è uno spettro, ogni tempo ha
uno spettro, ed è una composizione unica di certi valori epifenomenici, che dipende da mille cose:
17
Celibidache (1976), p. 313. Il termine «fenomenologia», con cui Celibidache designa il proprio pensiero, è
mutuato, al pari di diversi concetti dell’intenzionalità trascendentale, dalla filosofia di Husserl. La nostra tesi è
che il senso del «contro-tempo», così come è tratteggiato dallo stesso Celibidache, non si lasci tuttavia chiarire
nella prospettiva della fenomenologia trascendentale.
18
Ibidem.
19
Per «tempo fisico» s’intende il comune concetto di tempo, matematicamente concettualizzato e trattato
nell’odierna fisica.
20
Celibidache (1987), p. 339.
21
«In fenomenologia si insegna che il Tempo non è una realtà in sé sussistente (esso non è in nessun modo
riducibile ai metri della misurazione del mondo [i.e. della contingenza]), bensì una conseguenza viva risultante
da molti fattori concorrenti» (Celibidache [1976], p. 312). E ancora: «Il Tempo può avere un correlato nel mondo
della fisica, ma non ha nulla da spartire con il tempo della fisica e lo scorrere di quest’ultimo. In relazione al
Tempo, tutte le caratterizzazioni temporali come “lento”, “veloce”, “non lento”, “non così rapido”, “troppo
rapido”, “giusto”, “sbagliato”, non possono neanche lontanamente applicarsi. La proposizione secondo cui una
maggiore molteplicità, per poter essere ridotta, abbia bisogno di più Tempo rispetto a una molteplicità minore, è
tanto errata quanto lo è la speranza della scienza di poter giungere ai fondamentali e non più divisibili elementi
ultimi grazie a infinite partizioni. Visto che il Tempo è una condizione unica, esso non può essere più grande, più
piccolo, minore o diverso» (Celibidache [2008], p. 36).
22
Nella traduzione dall’originale francese è lasciata non tradotta la parola tempo, che dice il medesimo del
tedesco Tempo.
23
Ovvero: la moltitudine che ha come sua unente-compaginante origine la ricchezza.
24
Celibidache (1997), pp. 77-78.
74
�Tempo e arte. Note per una fenomenologia
dalla cultura del direttore, dall’acustica della sala, dalla fantasia dei musicisti; tutto ciò ha un ruolo
determinante nell’interpretazione. <Ma> giacché io sostengo che l’interpretazione non esiste, si
tratta piuttosto di un trasporre [umsetzen]: trasformo ciò che intendo in un movimento. […] Infatti,
25
qual è la giustificazione <del tempo>? La ricchezza!
Nell’interpretazione di questo passaggio, l’intesa di ciò che è indicato con la parola francese
tempo è propedeutica rispetto a quella della parola «tempo» (che rende invece il francese
temps). Innanzitutto, è chiaro come, nel presente contesto, «velocità» e «lentezza» non siano
misure collocate sullo stesso piano; in particolare, non sono l’una l’opposto dell’altra (veloce
= non lento, e viceversa) rispetto a una comune scala di frequenza, o di durata, degli eventi
posti in successione. Piuttosto, «velocità» è una nozione riferita al tempo meccanico, che resta
avulso dal senso della lentezza, mentre quest’ultima è assunta come nozione musicale
(dunque riferita al tempo artistico), e a sua volta non si lascia cogliere in termini di velocità 26.
La velocità di esecuzione della sequenza di suoni riferibile a una composizione è un quantum
constatabile da un punto di osservazione esterno alla musica, dove «esterno» non significa
soltanto «oggettivo», ma innanzitutto «oggettivante», ovvero tale da operare una universale
trasposizione in contingenza – e ciò, innanzitutto, in virtù di un “contingentamento” del
tempo originario.
Che ne è, invece, della lentezza, e dunque del tempo? Il tempo – ovvero il Tempo quale
«unico ambito in cui lo stanziarsi della musica diviene attendibile» – è «la condizione
affinché la ricchezza possa essere percepita». Quest’ultima è, nel suo “materializzarsi”, una
ricchezza sonora, dunque riferita ai suoni e ai relativi epifenomeni, o fenomeni collaterali (i
cosiddetti armonici), che si presentano alla coscienza nei loro rapporti di contrasto. Tuttavia,
in tale ricchezza, e nella condizione del suo generarsi, si nasconde l’insonoro, ultimo e
dunque «non riducibile» punto di genesi, in flagrante intenzione di tornare a iniziare; ovvero
anche: l’irriducibile punto di genesi, intento a tornare a iniziare, è, innanzitutto, la ricchezza
custodita nei ricchi contrasti sonori. Sicché l’opera della coscienza consiste ogni volta
nell’anticipante riduzione della molteplicità dei rapporti di contrasto all’unità di quel punto,
che deve pienamente, in-finitamente27 stanziarsi nella ricchezza interamente sviluppata. Nel
pieno stanziarsi dell’originaria dis-contingenza, quale disdetto punto di compaginazione
(composizione, armonizzazione) di tutti i rapporti, la coscienza stessa “si libera” dell’unità
ogni volta ottenuta, in vista del compito di ridurre la successiva molteplicità:
Il tempo preso come oggetto, alla maniera degli idioti che scrivono sul loro spartito “la croma a 72”,
non esiste. Il tempo è la condizione affinché la molteplicità dei fenomeni che si presentano alla mia
coscienza possa essere ridotta dalla forza, in sé unica, che essa [coscienza] possiede: quella di ridurre
la molteplicità, e di farne un intero molto complesso, un’unità di cui appropriarsi, per poi lasciarla,
trascenderla, al fine di trovarsi liberi dinanzi alla successiva unità 28. Più la molteplicità è grande, più
il tempo materializzato, <ovvero> visto nella dimensione fisica del tempo, è lento. Ma in verità il
25
Ivi, p. 78. Le aggiunte inserite fra parentesi acute <…> sono da leggersi come parte integrante del testo.
Non deve trarre in inganno la circostanza che Celibidache citi espressamente i «tempi lenti» (adagio, largo,
ecc.), che, “oggettivamente”, sono meno veloci di quelli, invece, “veloci” (allegro, presto, ecc.). In verità, ovvero
in senso musicale, i “tempi veloci” sono semplicemente “diversamente lenti” rispetto ai «tempi lenti».
27
Ovvero in una finitezza la cui origine resta disdetta e nascosta, sicché il finito è, in quanto tale, lo stagliarsi
di quella stessa, inesauribile e inavvicinabile, origine.
28
Tale «appropriarsi» è un anticipante lasciarsi intonare all’ingenitezza nell’inizio, dunque un addirsi a esso,
il quale (addirsi), mentre erge l’indugevole flagranza dell’inizio stesso, ne asseconda l’unente, compaginante,
liberante iniziare. Tuttavia, l’inizio si compie – finendo per iniziare, e d’inizio finendo – nella finale rescissione
(Entscheidung), in conseguenza della quale la coscienza «si rende libera dinanzi alla successiva unità». Sicché
«ridurre» vuol dire: mediante il tempo, assecondare l’iniziale intenzione di finire, e ciò fino alla “rescissione
ultima” del definitivo ritorno nell’inizio. Le tensioni esperite dalla coscienza mentre percepisce i contrasti sonori
sono dunque propriamente “intenzioni di finire” dell’inizio stesso lungo le “conversevoli” rotte della spaziotemporale flagranza del suo scoscendimento.
26
75
�Ivo De Gennaro
tempo non è lento. Non è né lento né veloce. Oggi, il tempo è divenuto un oggetto che si può
caratterizzare mediante una misura fisica. La convenzione di misurare fisicamente il tempo è idiota.
Il tempo fisico non esiste in musica.29
L’affermazione secondo cui «in verità, il tempo non è lento» non contraddice, ma piuttosto
delucida ulteriormente, quanto è stato detto riguardo alla lentezza e ai tempi lenti. Infatti,
risulta ora più chiaro come la lentezza non si riferisca a una bassa velocità, ma piuttosto al
carattere «condizionale» del tempo. La parola «condizione» deve qui essere intesa nelle due
sue accezioni: quella derivata da condicere «accordarsi, convenire» (che dà il senso del patto,
dell’accordo), e quella derivata da condere «mettere insieme, comporre» (che dà il senso del
modo d’essere, della qualità, della tempra). Il tempo è dunque una tempra (una fermezza) del
e per l’accordo30, il quale (temprato accordo) dà adito a, ossia lascia avvenire, la ricchezza, e
dunque, innanzitutto, il libero-liberante, unico-unente, ultroneo 31 (e in tal senso
“trascendente”) punto di dis-contingenza.
In che consistono, tuttavia, tale tempra e tale accordo?
Seguendo le indicazioni di Celibidache, il tempo in quanto condizione è l’ogni volta unica
fermezza (“retta” nella coscienza) di uno spazio-di-tempo per l’avvento della ricchezza –
spazio-di-tempo che quello stesso avvento genera per sé. Spazio e tempo sono qui da
intendersi in un senso a sua volta non fisico-meccanico, ma come occasioni per il
materializzarsi della ricchezza (nei contrasti dei fenomeni sonori). Lo spazio, inteso come
spazio musicale, è una «funzione», ovvero un aderto (dall’uomo) fungere come punto
dimensionante, di cui la stessa musica fruisce. Tale funzione non è tuttavia un dato
constatabile, ma deve essere creata a partire dalle circostanze acustiche, che a loro volta, in
quanto assunte nell’attenzione musicale, non sono dei dati constatabili. Tale creazione
avviene innanzitutto in virtù dell’azione riduttrice della coscienza, attenta a stringersi in
accordo con il dis-contingente, silentemente accordante punto di unità: «Lo spazio [inteso
come complesso delle circostanze che determinano l’acustica di una sala] diviene una
funzione [ovvero è creato per fungere come spazio musicale], non lo è da solo» 32 , ossia
indipendentemente dalla riduzione all’unità, la quale lo genera, “per stretto accordo”, in
quanto sua (dell’unità, e quindi della ricchezza) tempra spaziale.
Tuttavia, il generarsi dello spazio avviene ogni volta grazie al tempo – quel tempo di cui
sopra si è detto: «i fenomeni laterali appaiono entro il tempo, <e> con il tempo e grazie al
tempo il suono diventa più ricco. Ogni suono è un sistema solare irriducibile. Ora, che cosa
accade se passo da un sistema solare a un altro senza aver lasciato il tempo al primo di
svilupparsi completamente? È un taglio nella ricchezza dell’espressione». Che significa, qui,
«tempo»? Ancora una volta, non la durata riferita a uno scorrere (il “lasso di tempo” scandito
dal metronomo e certificato dall’orologio), bensì il dare spazio (di risonanza) all’avvento che
fuga in forma di istante le rotte del già-(risuonato-)non-più-(risuonante) e del presto(risuonante-)ma-non-ancora(-risuonato). “Lasciar tempo” non significa, allora, interporre un
intervallo nel quale possa attualizzarsi un potenziale sonoro, bensì adergere e sostenere (in
stretto accordo con esso) la verità dell’avvento fugante che, istantaneamente, dà spazio – e ciò
sia per lo sviluppo del singolo suono, sia per la successione dei suoni. Sicché sviluppo e
29
Celibidache (1990), pp. 111-112. Anche qui, il francese tempo è il medesimo del tedesco Tempo, mentre il
nome e l’aggettivo idiot non vogliono indicare una diminuita facoltà intellettiva, bensì la circostanza che,
applicando al tempo una misura ad esso estranea, si resta esclusi dalla musica, ovvero rinchiusi nella sfera della
sua mancanza.
30
«Del e per l’accordo», ovvero: originata dall’accordo stesso per la sua accessibilità e fermezza nell’adessere (cfr. supra, n. 7).
31
Sul concetto di ultroneità si veda Zaccaria (2014), p. 63, n. 48: «“[U]ltroneità” viene dal latino ultroneitas
e significa per noi “dimensione ultima e inoltrepassabile per vigore di originarietà”».
32
Celibidache (1985), p. 320 (enfasi mia).
76
�Tempo e arte. Note per una fenomenologia
successione hanno luogo «entro il tempo», ovvero ogni volta entro la fuga in cui si articola
quell’avvento – meglio: (sviluppo e successione) sono l’articolarsi, mediante istanti di fuga,
dell’avvento stesso. Tali istanti non sono però attimi di ravvisamento (dei già stabiliti suoni)
che si succedono nel “flusso del tempo”, ma piuttosto, a loro volta, funzioni dell’insonoro
avvento del dis-contingente punto di genesi – dell’unico punto di fuga che, di istante in
istante, si rigenera, anzi: si mantiene, in quanto genesi, nella sua iniziale intenzione. Nella
misura in cui, con riferimento al tempo così inteso, sia attendibile parlare di durata,
quest’ultima indica la non constatabile con-tinuità degli istanti, ovvero il loro esser tenuti
insieme, per riduzione fugati in uno nell’armonizzarsi di via via diverse costellazioni di rotte
del già-non-più e del non-ancora33.
La tempra spazio-temporale, ovvero das Tempo, si genera soltanto nella misura in cui è la
sostenuta, aderta verità34 della riduzione all’Uno fugante, e dunque come simultaneità. Infatti,
quest’ultima è il generarsi dell’unico avvento in forma di istantanea spaziante fuga delle rotte
temporali. La condizione per il generarsi – e quindi materializzarsi ed essere percepita – della
ricchezza, richiede che la coscienza, ovvero la “forza” di riduzione all’Uno che costituisce
l’essere dell’uomo, abbia già sempre “trasceso”, ovvero anticipato in ultroneità, la sonorità in
cui la stessa ultronea ricchezza si custodisce. Il senso del trascendere è, appunto, l’iniziale
“stringersi in accordo” con l’insonoro intenzionale Uno nell’adergenza del suo spazio-ditempo (Da-sein). Tale trascendere è dunque propriamente uno scorgere, che riscontra, nella
sua stretta, il venire incontro dell’accordante scorgimento dell’Uno – e così ne scorta,
mediante il suo spazio-di-tempo, la verità. L’ogni volta unica scorta, entro la tempra spaziotemporale, della verità dell’accortezza, la quale (scorta) stringe, in un reciproco accordo,
l’incontrante, unente-fugante Uno e il riscontrante, scorgente-adergente essere dell’uomo (la
«coscienza»), è la condizione della ricchezza nella stretta di incontro e riscontro; in una
parola, tale condizione è un ogni volta unico contro-(spazio-di-)tempo: il contro-tempo: das
Tempo.
Si tratta di un sentimento che in filosofia si chiama “divenire-coscienti”, a differenza dell’esserecoscienti: non afferrare, ma piuttosto costantemente divenire-coscienti, e <così> in ogni istante
sapere dove ci si trova. Devo percepire il do diesis in relazione alla sequenza e alla combinazione di
intervalli che hanno condotto fino a quel do diesis, giacché essi sono contenuti in quest’ultimo. E
così anche il futuro di quel do diesis è contenuto in esso. Dunque, devo percepire nel passato e nel
futuro. Ma dove? Nella simultaneità!35
[Domanda:] Come si trascendono le percezioni sonore? [Celibidache:] Non restando all’inerte
ricezione delle singole percezioni sonore, ma accortamente sentendo in ultroneità rispetto a queste
ultime, coltivando lo scortivo percepire [Wahrnehmen] nella simultaneità, non percependo l’“ora”
come un morto confine tra ciò che è stato e ciò che sarà, ma esperendolo come un unente divenire,
nel quale il passato costantemente diviene futuro.36
33
«Se uno ha il sentimento che <un movimento> sia troppo lungo o troppo breve, è già fuori. La musica non
dura in questo senso. Non vi sono movimenti lunghi e movimenti brevi, soltanto da un punto di vista esterno vi
sono movimenti lunghi, movimenti brevi, movimenti forti, movimenti dolci, ecc.» (Celibidache [1992], p. 37).
Sulla durata si veda la conclusione di questo paragrafo.
34
Secondo Celibidache, la verità (al contrario della bellezza, che è soltanto un mezzo) è il fine della musica,
sicché la musica stessa «è vera» (Celibidache [2012], p. 83). In Celibidache (1997), p. 63, leggiamo: «La verità
che si materializza tramite la musica non è dell’ordine di ciò che può essere dimostrato».
35
Celibidache (1974a), p. 5.
36
Celibidache (1976), p. 306. Lo scortivo percepire, il Wahrnehmen, è un ragguardare. L’Uno della riduzione
è il “ragguardevole” della simultaneità.
77
�Ivo De Gennaro
Il Tempo non è altro che una condizione, un catalizzatore, che rende attendibile la congiungente
identificazione, nella nostra coscienza, della simultaneità verticale con quella lineare.37
Tale «identificazione» non congiunge a posteriori ciò che dapprima nasce e diviene in modo
separato. Piuttosto, essa ri(con)duce all’originario (iniziale-finale) punto scindente-fugante ciò
che, nel medesimo punto, si genera dal reciproco incrocio, ovvero la «simultaneità verticale»
e la «simultaneità lineare». Che sono, e in che si differenziano tali simultaneità? La prima
nomina lo spazio di risonanza per la massa sonora, la cui ricchezza deve ogni volta essere
lasciata generarsi; la seconda indica il fugarsi nell’«ora» delle scisse rotte del già-risuonato e
del non-ancora-risuonante. Il fenomeno originario è lo spazio-di-tempo del punto di genesi (o
dell’inizio intento a finire – a tornare, infine, ad iniziare) in quanto istantaneo spaziante
fugarsi del tempo che, aderto nella scorgente coscienza, è via via la condizione per il
generarsi, e l’esser percepita, della ricchezza nel simultaneo alleviamento della «pressione
verticale»38 e di quella orizzontale.
Il tenersi di quel punto (l’iniziale Uno della riduzione) nello spazio-di-tempo, e dunque la
tenuta di quest’ultimo nel rinnovarsi in ricchezza – di istante in istante – dell’intenzionale
avvento dell’Uno, è quanto può definirsi, in senso musicale, la durata. Quest’ultima non
indica la distanza (l’intervallo) – constatabile sulla “freccia del tempo” – fra il momento
iniziale e il momento finale di un che di essente (nella fattispecie, di un suono o di una serie di
suoni); piuttosto, la durata è la tensiva (“catalitica”) tempra del contro-tempo per l’articolato
succedersi dei suoni: i suoni, in virtù dei loro fugati contrasti, si cedono mutuamente lo
spazio-di-tempo (e in questo senso si può dire che si succedano), e questo proprio mentre si
susseguono in fuga, nella fermezza del punto, gli istanti di simultaneità. La sequenza degli
istanti (il cui contingentarsi dà luogo alla serie degli “istanti” del tempo metafisico) è dunque
una, anzi la conseguenza (il con-seguirsi) del tempo, mentre la durata è la fermezza stessa del
contro-tempo quale condizione del “duraturo” avvento della ricchezza nell’ogni volta risolto
(ridotto, rescisso, “catalizzato”) contrasto dei fenomeni sonori che si succedono «nel
tempo»39.
Mentre la musica non dura nel senso dell’occupazione di un intervallo cronologico da parte
di una serie di eventi sonori, essa ogni volta genera per sé (per il compiuto avvento dell’Uno
in quanto ricchezza) un’immisurabile, ma sostenuta ed esperita, durata spazio-temporale.
Quest’ultima si genera nella musica e per la musica, ossia per il pieno stanziarsi di un inizio
che s’invera nell’occasione di un riccamente articolato succedersi di suoni nella simultaneità.
Il pieno stanziarsi dell’inizio è il suo perfezionarsi nella fine (nel con-fine d’ultroneità) di cui
esso stesso è, in quanto tale, l’iniziare. L’avveniente coincidenza dell’inizio e della fine,
avvertita in coscienza, è la durata dell’«identificazione» delle simultaneità verticale e
orizzontale nello spazio-di-tempo della verità. La musica dura unicamente nel contro-tempo
che lascia avvenire la ricchezza. Mentre dura la musica, non passa alcun “tempo”.
4. Chillida: il gemellaggio di tempo e spazio
Il pensiero scultoreo di Eduardo Chillida è a sua volta, nei suoi riferimenti ultimi, un pensiero
del tempo. A tal proposito, in uno dei suoi scritti leggiamo:
Ho passato la vita nel mio studio – il mio luogo preferito –, per tentare di avvicinarmi a ciò che non
conosco. Qui mi sono accorto che nella mia scultura esiste il tempo. <Vi> esiste <però> in una
37
Ivi, p. 313. («Catalizzare» – dal greco katalyein, «risolvere, portare a fine» – vuol dire, qui, lasciare che si
congiungano – in originaria, puntuale, “cruciale” identità – il generarsi della simultaneità verticale e il fugarsi
della simultaneità orizzontale.)
38
Celibidache (1974b), min. 32:30 ss.
39
In musica, dice Celibidache, «l’evoluzione del tempo» è «di tipo logaritmico»; in altre parole, il tempo
musicale evolve “da dentro” – ovvero secondo la legge del punto di genesi – piuttosto che esser mosso “da
fuori” tramite la mera associazione (o giustapposizione) di intervalli successivi (cfr. ivi, min. 16:25-17:35).
78
�Tempo e arte. Note per una fenomenologia
versione che non è la versione temporale corrente, ma quella di un fratello del tempo: lo spazio. Lo
spazio è un fratello gemello del tempo. Si tratta di due concetti assolutamente paralleli e similari. E
poiché sono molto condizionato dallo spazio, sono sempre stato molto interessato al tempo. Infatti, il
mio tempo è molto lento; tuttavia, questo tempo [i.e. il tempo di cui si dice “lento”, “veloce”, ecc.] è
quello dell’orologio [i.e. il «tempo fisico»], che è quello che non mi interessa. Mi interessa <invece>
il tempo che è armonia, ritmo e dimensioni.40
A partire dallo spazio, unito a suo fratello <gemello> il tempo, sotto l’insistente gravità, sentendo la
41
materia come uno spazio più lento, m’interrogo con stupore su ciò che non so.
Sia lo spazio sia il tempo consistono in – ovvero hanno come loro «protagonista» – un
«limite»: lo spazio, il limite costituito dal punto; il tempo, il limite costituito dal presente42;
entrambi, punto e presente, sono necessariamente senza misura, ovvero senza dimensione:
Non è il mondo della geometria coerente solo quando il punto non ha misura? Perché tutto funzioni,
è necessario che il punto non abbia misura, e tuttavia occupi un luogo. […] Se il presente avesse una
misura, il futuro e il passato non sarebbero dissociati in forza di essa? Che ne sarebbe della vita,
della parola e della musica? Non è il limite il vero protagonista dello spazio, così come il presente,
altro limite, è il protagonista del tempo? Non sarà il luogo un’immobile energia?
[…]
Non è la non-dimensione [l’immensità] del presente ciò che rende attendibile la vita, così come la
non-dimensione [l’immensità] del punto rende attendibile la geometria?43
Occupare un luogo e non aver misura: non sarà questo lo spazio?44
Il luogo implica dimensione e limiti, ma il luogo per essenza, il punto, non ha dimensione né limiti.45
Non è il presente (al pari del punto) un luogo senza misura nel tempo?
Non è il presente (quel luogo senza misura nel tempo) il fondamento e la chiave della vita?46
Il presente senza misura, cioè come non-dimensione o immensità, è l’indugio 47 che, fugando
«passato» e «futuro», si stanzia come «luogo» della loro simultaneità: «Non sono il passato e
il futuro simultanei in un presente che è immisurabile?»48. Proprio da e verso tale indugevole
fuga, verso l’«ignoto» di tale scissura, si stanzia, creativamente interrogandolo, l’artista: «Con
una luce per vedere come non vedo – tra il già-non-più e il non-ancora fui collocato»49.
Ciò che si stanzia fra il già-non-più e il non-ancora non è però un «morto confine» 50 ,
ovvero il presente inteso come l’attuale transeunte attimo entro la serie degli identici attimi
che compongono il cosiddetto fluire del tempo. Infatti, un presente così inteso avrebbe una
misura, implicando così una «dissociazione» fra passato e futuro, i quali risulterebbero per
sempre distanziati di quel singolo puntiforme interstizio. Tuttavia, tale distanziamento per
mezzo di un presente contingentato in forma di misura, implica il subitaneo contingentamento
40
Chillida (2016), p. 53. In Chillida (2009), p. 32, la penultima frase di tale passaggio suona: «In fact, my
time is very slow; traditional time – that of the clock – does not interest me».
41
Chillida (2016), p. 41 e p. 103.
42
Ivi, p. 55. Qui il «protagonista» (protos agonistes) non è il primattore, ma, letteralmente, il primigenio
lottatore o “eluttatore”: il presente e il punto sono, nella loro parallelità, il luogo di eluttazione dell’ineluttabile
nulla-di-fondo verso la custodente tempra (la fermezza) di uno spazio-di-tempo.
43
Ivi, p. 63.
44
Ivi, p. 64.
45
Ivi, p. 70.
46
Chillida (2009), p. 35.
47
Cfr. supra, n. 11.
48
Ivi, p. 37. Analogamente, in Chillida (2016), p. 104, leggiamo: «Non si deve dimenticare che il futuro e il
passato sono simultanei».
49
Chillida (2009), p. 111.
50
Cfr. supra, p. 10, e infra.
79
�Ivo De Gennaro
delle rotte del già-non-più e del non-ancora, facendo sì che, dall’iniziale avvento che fuga per
sé quelle rotte, lasciandole incontrare nell’offerto immenso indugevole istante di simultaneità
(in cui, adergendolo, insiste l’artista), nasca il “tempo” in quanto sequenza di attimi.
Nella medesima offerta del dis-contingente punto di genesi (nel versante disdirsi del
fondo), si genera, per geminazione del tempo – e, in tal senso, come suo portato –, anche il
gemello del tempo stesso, lo spazio 51 . Tale geminazione non implica una (inattendibile)
trasformazione del tempo in spazio 52 . Piuttosto, è l’immenso presente (in cui si nasconde
l’inizio come accortezza) ad allocare – per versante immensità – l’immenso punto d’inizio di
ogni dimensione spaziale, ovvero il «limite» quale unico vero «protagonista dello spazio». In
tal modo, il tempo, offerto in fuga nell’istante d’avvento dell’inizio, dona spazio in virtù del
suo costituirsi quale indugevole luogo del punto di ogni dimensionamento spaziale.
Nei pensieri di Chillida torna la «lentezza»: il tempo che (per geminazione allocando
spazio) «esiste» in scultura, e che «è armonia, ritmo e dimensioni», è lento (a differenza del
«tempo tradizionale» o «tempo dell’orologio», in cui la lentezza è annientata); nel sentimento
dell’artista, la materia è uno «spazio più lento»53 (poiché avvince e circomprende secondo la
sua ogni volta unica tempra custodente), mentre tra i materiali ve ne sono alcuni, come la
pietra e la terracotta, che sono «limitati e lenti» 54 (ovvero capaci di indire e custodire la
lentezza, che è appannaggio del limite); infine, «lo spazio è un materiale molto rapido»
(infatti, è una geminazione del tempo in quanto flagranza del versante disdirsi), ed è «così
vitale che sembra che là <dove si stanzia> non vi sia nulla»55. La lentezza, indice del versante
disdirsi del fondo (quale attendibilità del tratto spaziante del tempo), è gemella della rapidità,
a sua volta indice del suo (del fondo) versante disdirsi (quale attendibilità del tratto temprante
dello spazio). In virtù della lentezza, il tempo si gemina in forma di luogo di una vera
geometria56.
Il conseguente ritmarsi, armonizzarsi, e dimensionarsi dell’offerto spazio-di-tempo – quale
spaziosità del dis-contingente punto di genesi – avviene mediante la formatura dello «spazio
più lento», ovvero dei «materiali» che, a seconda della diversa loro indole o attendibilità di
indizione dello spazio-di-tempo 57 , diversamente indicono in forma («ritmo, armonia e
dimensioni»), e così custodiscono, la verità del versante disdirsi del fondo:
Lo spazio dev’essere concepito in termini di volume plastico […] La forma origina spontaneamente
dai bisogni58 dello spazio, che costruisce la propria abitazione come un animale costruisce il proprio
guscio. Esattamente come quell’animale, anch’io sono un architetto del vuoto.59
51
La geminazione non ha qui il senso del raddoppiamento e della duplicazione, ma quello del rafforzamento,
della tempratura.
52
Lo spazio è rafforzamento del tempo, ma il tempo non è indebolimento dello spazio.
53
Chillida (2016), p. 60 (enfasi mia).
54
Ibidem (enfasi mia).
55
Ibidem. La rapidità dello spazio è la gemella della lentezza del tempo, e a sua volta non ha nulla da spartire
con la velocità in senso fisico-meccanico. Nella rapidità (da «rapire») dobbiamo sentire il senso dell’originario
disostacolare e sgomberare, ovvero il segno della singolare tempestività della Lichtung.
56
A proposito della lentezza quale scorgimento artistico del tratto spaziante del tempo, ovvero del tratto di
fondo dello spazio-di-tempo originario, si rilegga quanto è stato detto supra, alle pp. 3-4, circa l’«essenza
spaziante del tempo».
57
«Lavoro con molti materiali allo stesso tempo, ma sapendo sempre scegliere quello che può essere perfetto
per ogni momento […] Ponendo la mia idea a contatto con un nuovo materiale, si produce un nuovo risultato. /
In tal modo, accetto la reazione del materiale basata sulle sue chiavi interne, e conformo la mia idea al materiale
col quale lavoro. È una continua lotta tra il ferro e lo spazio. Ma il ferro è sempre aperto verso [ovvero per indole
capace di indire e custodire] lo spazio, sia lo spazio implicato nell’opera, sia lo spazio che la circonda» (ivi, p.
60).
58
Tali bisogni, inizialmente dettati dal modo del versante disdirsi in cui il nulla flagra nello scoscendimento
dell’accortezza, configurano una carenza d’opera della spaziosità, e dunque una sua inclinazione verso l’opera
stessa.
80
�Tempo e arte. Note per una fenomenologia
L’artista, insistendo nella ricerca dell’ignoto, sente innanzitutto il generarsi del “tempo lento”
nel suo geminarsi quale luogo del punto di ogni vera geometria, ovvero dell’attendibile
dimensionarsi, ritmarsi, armonizzarsi di un mondo. Grazie al sentimento dei «limiti» e della
lentezza dei materiali (pietra, terracotta, ferro, alabastro, cemento), ovvero della loro diversa
capacità di indire formalmente lo spazio-di-tempo, l’artista lascia che quest’ultimo costruisca
la propria abitazione grazie alla forma che «spontaneamente» origina dalle sue carenze,
ergendosi così, in quanto artista, ad «architetto del vuoto»60.
5. Klee: la pittura come ricreazione della simultaneità
L’accostamento al tema del tempo in Klee conduce direttamente nel fulcro del suo pensiero
pittorico61. Un concetto chiave di quest’ultimo è il «divenire», la cui indole, o ascensiva62
origine, è il «movimento», a sua volta inteso come dis-contingente tratto di «genesi». Nel
diario del 1914 leggiamo: «La genesi, in quanto movimento [avviamento] formale [formale
Bewegung], è l’indole costitutiva dell’opera»63. Nella parola Bewegung, Klee sente il tratto
dell’irruzione di un Weg, ovvero di una via, o rotta, di genesi – l’avvio di una pro-duzione64:
«In senso produttivo, l’essenziale è appunto la via [Weg]; in altre parole, il divenire si pone al
di sopra dell’essere»65. Se dunque il “protagonista” dell’opera è il divenire, ciò dev’essere
inteso nel senso che quest’ultima si costituisce quale messa in forma del divenire stesso, a sua
volta inteso come genesi:
A ogni diveniente si addice movimento, e prima di essere, l’opera diviene, esattamente come il
mondo, prima che esso fosse, secondo il detto “in principio Dio creò”, è divenuto, e inoltre diviene
prima di essere futuro. […] / Tale è l’iniziale movimento [avviamento] produttivo, l’atto d’inizio di
colui che crea. Già tale atto d’inizio è di natura temporale, sia che resti piatto sia che conduca allo
spazio: in esso [atto] è ingenito (del) tempo.66
Il divenire “precede” l’essere. Tuttavia, tale precedenza non è di tipo cronologico, per cui il
divenire occuperebbe, sull’asse del flusso temporale, un segmento posizionato “a sinistra” del
momento a partire dal quale viene constatato l’essere; piuttosto, quel precedere è di ordine
genetico, ovvero si colloca sul piano dell’avvento dell’inizio: «La creazione, in quanto genesi,
vive sotto la superficie visibile dell’opera. / Tale circostanza è vista a ritroso da tutti coloro
che guardano con l’intelletto, mentre soltanto coloro che creano la vedono in avanti (verso il
futuro)»67. Anche in questo caso, sono indicate due direzioni che soltanto apparentemente si
trovano sul medesimo asse, mentre in verità configurano piani diversi e mutualmente
59
Chillida (1999), p. 62. Nell’edizione italiana, questo passo (che nel testo del saggio è invece tradotto
dall’inglese) suona: «[La forma] si consacra da sé ai bisogni di questo spazio …» (Chillida [2010], pp. 21-22).
L’artista crea nella misura in cui – scorgendo e meditando il punto d’inizio, e di conseguenza scegliendo e
lavorando i materiali – asseconda lo spazio nel suo costruirsi la propria abitazione.
60
Nella già citata partizione dei Beiträge, il vuoto (Leere) è inteso come «gestimmt-stimmende Leere des
Ab-grundes» (Heidegger [1989], p. 381), ossia come «intonato-intonante vuoto del nulla-di-fondo». Il seguente
passo riferisce tale vuoto alla Augenblicksstätte: «[Die Leere] ist nur als Da-sein, d. h. als die Verhaltenheit […],
das Ansichhalten vor der zögernden Versagung, wodurch der Zeit-Raum als die Augenblicksstätte der
Entscheidung sich gründet» (ivi, p. 382), «Il vuoto è solamente in quanto ad-essere, cioè in quanto ritenutezza
[…], <ovvero> il trattenersi verso la versante disdizione, mediante il quale si fonda lo spazio-di-tempo in quanto
località dell’istante d’accortezza della rescissione».
61
La ricchezza di motivi temporali nelle opere e negli scritti di Klee è tale che, nel breve spazio di queste
note, dovremo limitarci al tentativo di indicare un attendibile punto d’avvio di una futura, più approfondita
indagine. Per una rassegna di tali motivi si veda il saggio dello storico dell’arte e restauratore Erasmus Weddigen
(Weddigen [2004]).
62
L’ascensività è il tratto originario del nulla-di-fondo.
63
Klee (1988), p. 363.
64
Pro-durre, qui, vuol dire portare alla luce, far apparire, disascondere.
65
Ivi, p. 361.
66
Klee (1987), p. 197-198.
67
Klee (1988), p. 362.
81
�Ivo De Gennaro
escludenti. «A ritroso» significa: in una prospettiva “genealogica”, interessata a ricostruire il
“processo produttivo”, scandito da successivi stati contingenti (una quantità finita di stati, o
momenti-“essere”, messi in sequenza, riferiti all’“opera in divenire”, seguiti da una quantità
in continuo aumento di stati, o momenti-“essere”, riferiti all’“opera compiuta”); «in avanti»,
invece, vuol dire: nell’abissale profondità dell’avvento dell’inizio, nel quale ogni “fase”,
ovvero ogni «dimensione», è simultanea, ovvero riunita, raccolta in un’unica dis-contingente
Gegenwart68. Quest’ultima – un concetto fondamentale nel pensiero pittorico di Klee – è il
“presente” nel senso dell’offerto istante dello spaziante versare-incontro della fuga del disdirsi
del già-non-più e del non-ancora, istante in cui si fermano, attraversandolo, le rotte di
conversione dell’accortezza.
La centralità della Gegenwart appare alla luce della circostanza che la spaziosità del
quadro è una «simultaneità multidimensionale» di figure spaziali, e dunque un dono del
tempo: «infatti, anche lo spazio è un concetto temporale»69. Il “tema” della pittura è proprio
tale simultaneità, che d’altro canto, secondo l’artista, la lingua non permette di «discutere
sinteticamente»70:
A ogni dimensione che trascorre temporalmente dobbiamo dire: “Tu ora divieni passato”; ma forse,
sul piano della nuova dimensione, a suo tempo incontreremo un luogo critico, forse propizio, che
ricrea il tuo presente [Deine Gegenwart wiederherstellt]. / E se, con l’aggiungersi di sempre nuove
dimensioni, sarà sempre più difficile raccogliere in un presente, nella loro simultaneità [simultan
vergegenwärtigen], le differenti parti di tale compagine, si tratterà di avere molta pazienza. / Ciò che
alle cosiddette arti spaziali riuscì già molto tempo fa, e che anche l’arte temporale della musica creò,
in sonante pregnanza, nella polifonia – questo fenomeno simultaneo e multidimensionale, che fa sì
che il dramma raggiunga il suo punto culminante, purtroppo in ambito verbale-didattico resta
sconosciuto.71
Il “trascorrere” è la modalità “piatta” del tempo, che non «conduce [i.e. non dà luogo] allo
spazio». Là dove, invece, s’incontri il «luogo critico», ovvero il dislocante, movente-avviante
(e dunque «propizio») punto di genesi, il versante disdirsi, fugato in simultaneità, si
costituisce in un presente, che a sua volta dà luogo al simultaneo divenire di ogni dimensione.
La ricreazione del presente, in quanto re(-i)stituzione, nell’opera, della simultaneità che dà
luogo all’armonioso dimensionarsi delle figure spaziali, può valere come formula per il senso
della creazione artistica che, secondo il noto motto kleeiano, «non rende il visibile, ma rende
visibile»72. Tale ricreazione può anche dirsi «ripristino», giacché il suo senso è, appunto, il
“rimettere in pristino”, mediante l’opera, l’istante del sempre(-sarà-stato)-pristino avvento del
versante disdirsi del fondo quale allocante punto di genesi, e dunque la pristina datità (il
perennemente avveniente esser-stato-dato) del movimento73.
68
«In avanti» (ab ante; nach vorwärts) vuole appunto dire: a partire dalla Gegenwart quale spazio-di-tempo
(o vicinanza) del disdetto inizio. A tal proposito, si pensi al rimbaudiano «[la poésie sera] en avant», su cui
s’interroga Heidegger in Rimbaud vivant (Heidegger [1983], pp. 225-227).
69
Klee (1987), p. 62.
70
Ivi, p. 73.
71
Ibidem.
72
Ivi, p. 60. Infatti, la “colorata” simultaneità multidimensionale delle figure spaziali è l’elemento per ogni
apparire – l’elemento del “farsi luce” che rende visibile. Weddigen nota come la formula kleeiana «“Es werde
Licht” weisse / Genesis, auf schwarzem Zustand» (Klee [1988], p. 493). («“Si faccia luce” – bianca genesi su
nero stato») «illumini nel modo migliore il vettore genetico della creazione artistica» (Weddigen [2004], p. 7, n.
37).
73
«Dal punto di vista cosmico, il movimento è il primo e ultimo dato [l’indole donata, offerta, in ultroneità:
das Gegebene], e, in quanto forza infinita, non necessita di alcun particolare impulso energico» (Klee [1987], p.
199). In «dato» e «datità» deve sentirsi non il factum del dare, bensì il libero darsi in ultroneità, nel senso
temporale del versante disdirsi: il movimento è perenne avvento, in disdetto versare, dell’irrevocabile essersidato del punto di genesi.
82
�Tempo e arte. Note per una fenomenologia
Il tempo è per indole «ingenito» nell’atto d’inizio: proprio in virtù di tale ingenitezza (e
non, invece, in quanto serie di attimi raggruppati in intervalli) esso è Spielraum74, spazio di
gioco, ovvero l’occasione propizia che è richiesta affinché il «punto divenga movimento e
linea», e «tale linea si sposti <divenendo> superficie, o nel movimento da superfici a spazi»,
mentre «[s]oltanto l’assolutamente esiguo, il punto in sé morto, è senza tempo»75. Più ricca la
simultaneità multidimensionale, più chiaramente stagliato, nel suo nascondersi, l’onniavviante
punto di genesi, «organo centrale di ogni avviatezza spazio-temporale» 76 . Da qui si
determinano, infine, l’indole della pittura, e, insieme, il luogo dell’abitare artistico:
La pittura polifonica è superiore alla musica in virtù della circostanza che, nella prima, l’indole
temporale è in maggior misura indole spaziale. <Sicché> il concetto della simultaneità emerge qui in
modo ancor più ricco.77
Là dove l’organo centrale di ogni avviatezza spazio-temporale [zeit-räumliche Bewegtheit], che si
chiami cerebro oppure cuore del creato, promuove [veranlasst] tutte le funzioni – chi, essendo
artista, non vorrebbe abitare in quel luogo?78
Bibliografia
Accornero, G. (2016), La fenomenologia musicale di Sergiu Celibidache, in Id. et al. (Eds), Il
suono vivo. Storia, composizione, interpretazione, Edizioni ETS, Pisa.
Celibidache, S. (1974a), Interview mit Dr. Klaus Lang am 29.11.1974, http://www.gerhardgreiner.de/inter.pdf, pp. 1-7.
Celibidache,
S.
(1974b),
Lezione
di
fenomenologia
musicale,
https://www.youtube.com/watch?v=S9hvDv7OwRQ
Celibidache, S. (1976), “Über Musik und Musikleben heute. Gespräch mit Heinz Ludwig”,
Das Orchester, vol. 24, pp. 305-317.
Celibidache, S. (1985), Es gibt keine Alternative zur Musik, in Schmoll, R. (Hrsg.), Die
Münchner Philharmoniker von der Gründung bis heute, Wolf, München, pp. 315-324.
Celibidache, S. (1987), “Zum 75. Geburtstag von Sergiu Celibidache. Ein Gespräch”, Musica,
vol. 41, pp. 336-341.
Celibidache, S. (1990), “De la direction d’orchestre. Entretien realisé par Myriam
Anissimov”, Le monde de la musique, n. 130, pp. 60-64.
Celibidache, S. (1992), Musik dauert nicht, in Schmidt-Garre, J. (Hrsg.), Celibidache. Man
will nichts – man läßt es entstehen, Pars, München, pp. 29-42.
Celibidache, S. (1997), Rencontres avec un homme extraordinaire. Textes réunis par
Stephane Müller et Patrick Lang, K-films Editions, Paris.
Celibidache, S. (2008), Über musikalische Phänomenologie, Celibidachiana I, WißnerVerlag, Augsburg.
Celibidache, S. (2012), La musique n’est rien. Textes et entretiens pour une phénoménologie
de la musique, Actes Sud, Arles.
Chillida, E. (1999), Chillida, 1948–1998, Guggenheim Museoa Bilbao, Bilbao.
Chillida, E. (2009), Writings, Richter Verlag, Düsseldorf.
Chillida, E. (2010), Lo spazio e il limite, Marinotti Edizioni, Milano.
Chillida, E. (2016), Escritos, La Fábrica, Madrid.
De Gennaro, I.-Zaccaria, G. (2007), Dasein: Da-sein. Tradurre la parola del pensiero,
Christian Marinotti Edizioni, Milano.
74
Ivi, p. 63.
Ivi, p. 198 (cfr. anche ivi, p. 63).
76
Dal catalogo della mostra Paul Klee in Jena 1924 (Jena 1999), cit. in Weddigen (2004), p. 31.
77
Klee (1988), pp. 440-442.
78
Cfr. n. 75.
75
83
�Ivo De Gennaro
Heidegger, M. (1983), Aus der Erfahrung des Denkens, GA Bd. 13, Vittorio Klostermann,
Frankfurt a. M.
Heidegger, M. (1986), Sein und Zeit, Niemeyer, Tübingen.
Heidegger, M. (1989), Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), GA Bd. 65, Vittorio
Klostermann, Frankfurt a. M.
Klee, P. (1976), Schriften, Rezensionen und Aufsätze, DuMont, Köln.
Klee, P. (1987), Kunst-Lehre, Reclam, Leipzig.
Klee, P. (1988), Tagebücher 1898-1919, Hatje/Niggli, Stuttgart/Teufen.
Weddigen,
E.
(2004),
“Klee:
Dauer,
Zeit
und
Uhr-Zeit”,
https://erasmusweddigen.jimdo.com/modernere_kunst.php
Zaccaria, G. (2009), L’inizio e il nulla, Christian Marinotti Edizioni, Milano.
Zaccaria, G. (2014), La provenienza dell’arte. Atena e l’enigma, Ibis, Pavia.
Zaccaria, G. (2015), Pensare il nulla. Leopardi, Heidegger, Ibis, Pavia.
Zaccaria, G. (2018), Gli inizi del tempo. Sofocle, Aristotele, http://www.scienzanuova.org/wpcontent/uploads/Gli-inizi-del-tempo.pdf
Abstract
Phenomenological thinking looks upon art not merely as a possible object of philosophical
investigation, carried out by a specific discipline, i.e. aesthetics; rather, it considers art –
notably its provenance and destination – as a hermeneutic task capable of furthering the scope
of thinking itself. In other words: phenomenology understands itself as paving the way for a
new style of thinking precisely thanks to, and through, its dialogue with art, aimed at letting
art speak as and for itself. The status of art as a constitutive task for thinking shows in a
particularly marked manner when basic notions such as truth, space and time explicitly
become the “subject matter” of art in ways that traditional philosophical understanding of
those notions does not seem to be able to adequately grasp. This essay tentatively examines a
few instances of 20th century artistic approaches to time – notably in music, painting and
sculpture – in order to outline the hermeneutic task that they pose to contemporary thinking.
The interpretive horizon for this outline is provided by Heidegger’s later reflection on time, as
can be found i.a. in his posthumous treatise Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis).
Keywords: Art, Celibidache, Chillida, Heidegger, Klee, Metaphysical Time, Originary Time,
Time
84
�FRANCESCA DE VECCHI*
Il paesaggio sociale: essenza e forme degli atti di empatia
1. Introduzione
In questo articolo parto dalla tesi fenomenologica che attribuisce all’empatia [Einfühlung] un ruolo
fondamentale rispetto alla pluralità dei fenomeni intersoggettivi e collettivi che caratterizzano il
paesaggio sociale. Questa tesi risale alle fenomenologie dell’empatia e della simpatia elaborate da
Edith Stein e da Max Scheler, rispettivamente in Sul problema dell’empatia [Zum Problem der
Einfühlung] (1917) e in Essenza e forme della simpatia [Wesen und Formen der Sympathie]
(1913/23)1. Secondo questa tesi l’empatia è l’atto fondamentale del paesaggio sociale, abitato da
individui psico-fisici e personali, perché è l’atto in virtù del quale ci rendiamo conto che nel mondo
vi sono altri soggetti, i quali sono essi stessi, come noi, portatori di esperienze vissute; l’empatia è
allora l’atto che fonda la possibilità dell’incontro con gli altri e della relazione umana e personale in
generale. Sempre secondo questa tesi, il paesaggio sociale è inoltre caratterizzato anche da altri
fenomeni intersoggettivi e collettivi, come la simpatia [Mitfühlung] e varie forme di intenzionalità
collettiva (sentimenti, credenze, intenzioni collettive) a livello degli atti personali, da un lato, e
l’unipatia [Einsfühlung] e il contagio affettivo [Gefühlsansteckung] a livello sub-personale o prepersonale, dall’altro. Questa pluralità di fenomeni fa del paesaggio sociale un crocevia, fitto e
intricato, di variegate esperienze «eterotropiche», di incontro e relazione, partecipazione alla vita
altrui, interdipendenza io-tu, condivisione e costituzione di un “noi”, imitazione delle esperienze
altrui, identificazione tra individui, etc.2.
È questa una tesi della fenomenologia classica, del primo ventennio del secolo scorso, che però
solo recentemente è stata riscoperta e discussa, anche a fronte dell’interesse sorto nel dibattito
*
Università San Raffaele – Milano
1
Vi è sicuramente una differenza terminologica tra Stein e Scheler nella denominazione del fenomeno del rendersi
conto dell’esistenza di altri individui e delle loro esperienze: Stein parla di Einfühlung, mentre Scheler di Nachfühlen o
di Nacherleben, ma entrambi con queste differenti espressioni denotano lo stesso atto intersoggettivo fondamentale che
permette a un soggetto di rendersi conto che di fronte a lui vi è un altro soggetto e di coglierne le esperienze. Si veda
Stein (1917) che riprende la terminologia già usata da Theodor Lipps nelle sue opere di estetica e psicologia (si veda ad
esempio Lipps (1903)) e si riferisce al concetto stesso di “empatia” di Edmund Husserl esposto nei manoscritti su cui
Stein stessa aveva lavorato e che saranno poi pubblicate come Ideen II (1912-1928) e Scheler (1913/23).
2
Per un’adeguata presentazione di questa tesi che attribuisce un ruolo cruciale all’empatia nella costituzione del
mondo comune e condiviso si vedano innanzitutto i lavori di Stein (1917) e Scheler (1913/23). Occorre però precisare
che vi è una differenza sostanziale nelle posizioni di Stein e Scheler: Scheler ritiene che l’empatia sia fondata
nell’unipatia [Einsfühlung], uno stato pre-personale di fusione dei vissuti che caratterizza le prime fasi di vita
dell’essere umano ed è radicato nella sfera del vitale (cfr. Scheler p. 62 «un minimo di unipatia non specifica è
semplicemente costitutivo per l’apprensione di ogni essere vivente» e pp. 51-67, 116-118). In ogni caso, sia Stein sia
Scheler concordano sull’idea che l’empatia sia l’atto intersoggettivo fondamentale e che essa costituisca la condizione
di possibilità della simpatia. Recentemente, si veda: Zahavi (2014), Part II. Empathic Understanding, pp. 95-196, che
discute proprio questa tesi; Boella (2018), § “La scoperta dell’altro: rileggere Edith Stein”; De Monticelli (2008), pp.
96-100, che definisce l’empatia come l’atto di “percezione psicologica dell’altro in quanto tale”; De Vecchi (2014), in
cui mi riferisco alle varie forme di intenzionalità presenti nel mondo sociale e protagoniste della sua costituzione come
diversi tipi di “intenzionalità eterotropiche”.
Bollettino Filosofico 33 (2018): 85-99
ISSN 1593 -7178 - 00030
E-ISSN 2035 -2670
DOI 10.6093/1593-7178/5908
�Francesca De Vecchi
filosofico contemporaneo per i temi dell’intenzionalità collettiva e dell’ontologia sociale, da un lato,
e della cognizione sociale nelle scienze cognitive e nelle neuroscienze, dall’altro3.
A partire da questa tesi, che assumo qui come presupposto e sfondo, vorrei nel mio articolo
presentare e discutere quella che chiamo “l’eidetica dell’empatia”: un’analisi dell’essenza e delle
forme degli atti di empatia 4, che risale al lavoro di Stein, e che è fondata sui concetti eidetici sia di
intero, costituito dai limiti delle co-variazioni possibili delle sue parti, sia di fondazione e
dipendenza ontologica. L’“eidetica dell’empatia” è naturalmente un’applicazione dell’eidetica
husserliana al fenomeno dell’empatia 5. L’idea di fondo è quella di considerare l’empatia come un
unico tipo di atto che presenta una pluralità di modificazioni possibili e che fonda altri atti che
dipendono esistenzialmente da essa. L’eidetica dell’empatia presenta allora l’empatia come un “tipo
di atti” che in quanto intero è suscettibile di variazioni relativamente alle parti che lo costituiscono
in modo essenziale – variazioni che sono limitate dalla struttura essenziale stessa dell’empatia, e
che, se ne oltrepassano il limite, fuoriescono dal tipo “atto di empatia”, diventando fenomeni di
altro tipo. L’eidetica dell’empatia inoltre mostra le relazioni di fondazione e dipendenza ontologica
tra l’empatia e altri atti: simpatia e forme di intenzionalità collettiva.
Nel mio articolo vorrei discutere alcuni esempi dell’eidetica dell’empatia e mostrare la fecondità
e la novità di questo approccio che a mio avviso permette di integrare e precisare la tesi
fenomenologica classica dell’empatia come atto fondamentale del paesaggio sociale nella pluralità
dei fenomeni intersoggettivi e collettivi. Correlativamente, la prospettiva aperta dall’eidetica
dell’empatia consente inoltre di affrontare temi e problemi cruciali del concetto di empatia e della
fenomenologia dell’intersoggettività e socialità in generale: in che senso l’empatia è la «percezione
diretta» di un altro e del suo vissuto? L’empatia è un atto che possiamo soltanto compiere o non
compiere, oppure sono possibili gradi di compimento dell’empatia? Che cos’è l’empatia negativa?
Qual è il ruolo della corporeità nel confine che distingue me e l’altro nell’empatia? Quali sono i
tratti essenziali della condivisione affettiva, da un lato, e della simpatia, dall’altro, e perché non
sono empatia pur essendo fondati su di essa? E infine, e più in generale, qual è l’apporto
dell’eidetica dell’empatia all’ontologia fenomenologica qualitativa?
2. Il tipo degli atti di empatia
Vorrei ora innanzitutto mostrare che l’empatia è un tipo specifico di atti: è infatti a partire da questo
dato che è possibile lavorare sull’empatia come intero costituito da parti suscettibili di
modificazioni e variazioni all’interno del tipo-intero “empatia”. Il fatto che l’empatia sia un “tipo
specifico di atti” significa che si tratta di un tipo unico di atti, irriducibile ad altri tipi, anche a quelli
a essa più somiglianti, e che tale tipo di atti costituisce una classe all’interno della quale vi sono
singoli e individuali atti di empatia che possono presentare modificazioni e variazioni.
Nella seconda sezione del suo libro sull’empatia, intitolata “L’essenza degli atti di empatia” [Das
Wesen der Einfühlungsakte], Stein afferma che l’empatia è un «tipo fondamentale di atti [Grundart
3
Per una riflessione sull’attenuazione dell’attenzione sul problema dell’empatia da parte della fenomenologia, dopo
gli anni ’30 del secolo scorso, e sulla riscoperta e riattivazione della ricerca fenomenologica alla luce delle scoperte dei
neuroni specchio, a partire dagli anni ’90, si veda la ricostruzione di Boella (2018), pp. 82-107. Dan Zahavi e Shaun
Gallagher sono senza dubbio tra gli attori principali di questa riscoperta che ha portato alla costruzione di un dialogo
fecondo con le scienze cognitive e le neuroscienze (cfr. Gallagher-Zahavi 2008). Inoltre lo stesso Zahavi ha messo a
confronto posizioni fenomenologiche sull’intenzionalità intersoggettiva e collettiva con le teorie dell’intenzionalità
collettiva in ontologia sociale, come quella di J.R. Searle (si veda Zahavi 2014 e Searle 1995, 2010). E nel corso
dell’ultimo decennio sono stati pubblicati parecchi lavori che mettono in luce il contributo fenomenologico su temi di
ontologia sociale e intenzionalità collettiva: Konzelmann Ziv-Schmid (2014), Salice-Schmid (2016), Moran-Szanto
(2015).
4
Usando l’espressione “essenza e forme degli atti di empatia”, sto naturalmente parafrasando il titolo dell’opera di
Scheler, Essenza e forme della simpatia.
5
Si veda Husserl (1901, IIIRL) e Husserl (1913); per un approfondimento dell’idea husserliana dei vincoli alle covariazioni possibili delle parti che definiscono ogni intero in quanto tale, rinvio De Monticelli (2018).
86
�Il paesaggio sociale: essenza e forma degli atti di empatia
von Akten] nei quali viene colta l’esperienza vissuta estranea» 6 . È questo un tratto essenziale
dell’empatia: il fatto che il suo ambito specifico di competenza siano gli altri soggetti e le loro
esperienze. L’empatia è infatti quel tipo di atti in cui ci rendiamo immediatamente conto che
davanti a noi vi è un altro soggetto, e che nel mondo quindi vi sono altri individui psicofisici e
personali costituiti da corpi vivi e senzienti [Leib], che sono soggetti di esperienze e di atti personali
come noi – «il mondo in cui vivo non è solo un mondo di corpi fisici [Körper]: è un mondo in cui vi
sono, oltre a me, anche altri soggetti di esperienze vissute, e io so di questo vivere»7.
Al fine di corroborare la tesi dell’unicità e specificità proprie del tipo degli atti di empatia, Stein
procede a una mappatura eidetica del tipo “empatia”, confrontando l’empatia da un lato con la
struttura tipica di altri atti intuitivi, del tutto differenti dall’empatia quali la percezione esterna
[äußere Wahrnehmung], il ricordo [Erinnerung], l’attesa [Erwartung] e la fantasia [Phantasie], e
dall’altro con atti intuitivi la cui struttura mostra somiglianze di famiglia con l’empatia, quali
l’unipatia [Einsfühlung] à la Theodor Lipps, il sentire-con [Mit-fühlen] o simpatia à la Scheler, e il
sentire collettivo8. In entrambe le tipologie di atti, differenti e simili all’empatia, Stein evidenzia che
sono inoltre presenti dei nessi di fondazione: l’empatia è fondata sulla percezione esterna, da un
lato, e la simpatia e il sentire collettivo sono fondati sull’empatia, dall’altro.
Questo confronto con altri tipi di atti consente a Stein di sostanziare di evidenza la sua analisi dei
tratti essenziali del tipo “empatia” e di affinare la sua tesi sull’unicità e specificità del tipo degli atti
di empatia.
2.1. L’esperienza sui generis dell’empatia
In seguito al confronto tra empatia e percezione esterna, ricordo, attesa, fantasia, Stein approda alla
conclusione che l’empatia è un tipo di atti «originario» [originär] in quanto compiuto in prima
persona dal soggetto empatizzante, ma è al contempo un tipo di atti il cui contenuto non è originario
[nicht-originär] perché appartiene all’altro: è il vissuto dell’altro e non il mio quello che io colgo
nell’empatia9.
Mentre io vivo quella gioia che è provata da un altro, non provo alcuna gioia originaria: essa non scaturisce
in maniera viva dal mio io, né ha il carattere di essere stata viva in precedenza come la gioia ricordata, e
tanto meno essa è meramente fantasticata, priva cioè di una vita reale; è invece l’altro soggetto quello che
prova in maniera viva l’originarietà, sebbene io non viva tale originarietà; la sua gioia, che scaturisce da lui,
è originaria, sebbene io non la viva come originaria. Nella mia esperienza vissuta non originaria, io mi
sento per così dire accompagnato da un’esperienza vissuta originaria, la quale non è vissuta da me, ma
esiste in me, e si manifesta nella mia esperienza vissuta non originaria. In tal modo abbiamo con l’empatia
un tipo di atti di esperienza sui generis [eine Art erfahrender Akte sui generis].10
Stein sancisce che l’empatia è un tipo di atti in cui facciamo esperienza, ma di un altro: in cui
cogliamo intuitivamente dati di realtà della vita di un altro; un tipo di atti in cui proprio il fatto che
l’esperienza còlta sia di un altro, fa sì che l’esperienza sia sui generis, vale a dire peculiare rispetto
agli altri atti intuitivi in cui l’esperienza è propria. Dicendo quindi che l’empatia è «un tipo di atti di
esperienza sui generis», Stein trae le giuste conclusioni, derivanti dal fatto che ogni esperienza è
radicata in modo originario nel corpo vissuto, proprio di ogni soggetto, e che dunque l’empatia,
come tipo di atti che colgono l’esperienza di un altro, non può che essere contrassegnata dalla
6
Stein (1917), pp. 13-14.
Ivi, p. 12.
8
Si veda Stein (1917), “II. L’essenza degli atti di empatia”, pp. 11-52. Occorre precisare che Stein, oltre al
fenomeno di identificazione descritto da Lipps, chiama anche «unipatia» [Einsfühlung], ciò che in realtà, nella sua
descrizione, è specificamente un fenomeno di intenzionalità collettiva affettiva, e al quale io continuerò a riferirmi come
tale nel mio articolo. Le citazioni di Stein (1917) sono di mia traduzione (le due traduzioni italiane esistenti sono state
pubblicate precedentemente all’edizione critica del testo di Stein, del 2008).
9
Ivi, pp. 15-16, 20.
10
Ivi, p. 20.
7
87
�Francesca De Vecchi
differenza tra me e l’altro. È per questo che nell’empatia si ha un’“esperienza sui generis”: non è il
tipo di esperienza standard, che facciamo, solitamente, a partire da noi stessi. La definizione
dell’empatia data da Stein salvaguarda quindi correttamente il confine tra me e l’altro, tra il
soggetto empatizzante e il soggetto empatizzato, confine che corrisponde esattamente ai limiti che
sussistono tra il mio corpo vivo e il corpo vivo dell’altro. Su questo punto tornerò fra poco (cfr.
infra § 3. Empatia e somiglianze di famiglia).
L’empatia è inoltre irriducibile ad altri atti intuitivi non originariamente offerenti quali il ricordo,
l’attesa e la fantasia 11 . Il soggetto empatizzante non è infatti lo stesso soggetto del vissuto
empatizzato, come invece accade nel caso del ricordo, dell’attesa e della fantasia, in cui si tratta
sempre dello stesso soggetto, che è perciò caratterizzato da una «coscienza di identità» e da una
«continuità nei vissuti»12: il soggetto ricorda, attende e fantastica riferendosi ai suoi propri vissuti
originari.
Occorre poi precisare che il fatto che l’empatia sia un atto di esperienza significa che essa è un
atto in cui cogliamo intuitivamente la datità dell’altro e del suo vissuto, e non un mero sapere
relativo all’altro e al suo vissuto; la differenza tra “sapere relativo all’altro” e “fare esperienza
dell’altro” è una differenza cruciale, che contraddistingue l’empatia rispetto ad altri atti in cui
veniamo semplicemente informati di quello che un altro sta vivendo, senza averne alcuna intuizione
– Tizio mi racconto come sta Caio. Si tratta quindi di una differenza che definisce in modo
essenziale l’empatia, e che è fondata sul topos fenomenologico della distinzione tra contenuto
intuitivo – il dato – e contenuto concettuale di un atto intenzionale 13.
2.2. Empatia e percezione esterna
Vale la pena soffermarsi un momento su ulteriori dettagli della comparazione tra empatia e
percezione esterna discussa da Stein, al fine di comprendere meglio i diversi ambiti di competenza
di questi due atti intuitivi, la cui differente struttura è fondata nelle differenti tipologie ontologiche a
cui appartengono le datità proprie di questi due atti – individui psicofisici e personali da un lato,
meri corpi fisici, cose dall’altro.
Nel confronto attuato da Stein, empatia e percezione esterna sono presentati come due atti
correlativi e omologhi rispetto alla percezione del mondo. Come la percezione esterna è l’atto con
cui cogliamo le cose, i meri corpi fisici che sono nel mondo, così l’empatia è l’atto per mezzo del
quale cogliamo gli altri individui in quanto tali, in quanto soggetti di esperienze, che abitano quello
stesso mondo. Cose, meri corpi fisici da un lato, e individui psico-fisici, soggetti viventi e di
esperienze dall’altro, hanno fenomenologicamente due modi del tutto diversi di darsi a conoscere e
costituiscono quindi due tipi di datità ontologicamente differenti, alle quali corrispondono due tipi
di atti intuitivi diversi: la percezione esterna, da un lato, e l’empatia dall’altro.
È proprio a partire dalle diverse datità delle cose, da un lato, e degli altri individui psicofisici e
personali, dall’altro, che Stein molto precisamente mette in evidenza una differenza sostanziale tra
empatia e percezione esterna.
Il dolore non è una cosa e non mi è dato nel modo di una cosa […]; la faccia sconvolta dal dolore – detto
più esattamente: il mutamento dei lineamenti del volto, che empaticamente colgo come faccia sconvolta dal
dolore – posso considerarla da ciascun lato che voglio; di fatto però non pervengo mai ad un
“orientamento” in cui, al posto di quella faccia mi viene a datità il dolore stesso.14
11
Ibidem.
Ibidem.
La distinzione tra atti non intuitivi o di significare o di pensiero, da un lato, e atti intuitivi, dall’altro, risale in
primis alle Ricerche Logiche di Husserl (1901). Stein approfondisce la differenza tra «esperienza dell’altro» e «sapere
dell’altro» in Stein (1917) § 4. La controversia tra la visione della rappresentazione e quella dell’attualità [Der Streit
zwischen Vorstellungs- und Aktualitätsansicht], pp. 30-33.
14
Stein (1917), pp. 14-15.
12
13
88
�Il paesaggio sociale: essenza e forma degli atti di empatia
L’empatia è un atto intuitivo irriducibile alla percezione esterna perché l’altro e il suo vissuto non
sono cose e non mi si danno a conoscere come le cose. Anche se giro intorno all’altro non avrò mai
un’intuizione del suo dolore “in carne e ossa”. Il vissuto dell’altro non è quindi un contenuto che il
soggetto empatizzante possa portarsi a datità originaria, “in carne e ossa”, come un qualunque
oggetto fisico, che colgo frontalmente in modo originario e i cui lati nascosti posso sempre,
progressivamente portare a datità originaria. Il dolore dell’altro lo colgo soltanto nella e unitamente
alla faccia che lo esprime.
Di conseguenza il rapporto tra empatia e percezione esterna non è solo caratterizzato da
un’omologia data nei differenti e complementari ruoli di atti di intuizione, cioè di esperienza, di
parti differenti del mondo – cose e corpi inanimati, la percezione; individui psico-fisici e personali,
l’empatia. Bensì, tra questi due atti vige anche una relazione di fondazione: l’empatia è infatti
fondata sulla percezione esterna. È soltanto a partire dalla percezione esterna, dalla “percezione
sensibile” del corpo dell’altro (che colgo con i miei cinque sensi) che posso dunque, empatizzando,
cogliere quello stesso corpo, non più come mero corpo [Körper], ma come corpo vivo [Leib] – che
posso allora nell’empatia cogliere quel volto in tutto il suo essere espressione della vita dell’altro.
In conclusione, l’empatia è un atto intuitivo, che ha per oggetto un dato di esperienza, ma è
differente dalla percezione esterna e da altri atti intuitivi originalmente offerenti che hanno la loro
datità presente in carne e ossa (come anche l’intuizione eidetica, la percezione affettiva dei valori e
la riflessione, precisa Stein) come esperienza vissuta in prima persona 15 . Il dato specifico
dell’empatia, infatti, è proprio dell’altro e io non posso farne esperienza in prima persona,
originariamente. Empatizzando colgo immediatamente il dolore dell’altro in e unitamente a il dato
percepito esternamente, ma non ne faccio mai esperienza “in carne e ossa”, cioè originariamente e
in prima persona, come invece accade per il mio proprio dolore di cui faccio esperienza in prima
persona.
2.3. La percezione diretta dell’altro
Ecco perché, secondo la tesi fenomenologica classica, l’empatia è un atto di intuizione di
«percezione diretta» dell’altro in quanto tale e dei suoi vissuti: perché essi sono colti direttamente,
nel loro darsi nel e unitamente al corpo intuito nella percezione esterna.
Per comprendere precisamente la tesi dell’empatia come atto di «percezione diretta», occorre
inoltre distinguere tra il contenuto dell’empatia che è l’altro in quanto tale, e il contenuto
dell’empatia che è l’esperienza vissuta dall’altro. L’altro in quanto tale è indubbiamente un
contenuto originario dell’empatia come atto di intuizione: nell’empatia ci rendiamo conto che di
fronte a noi vi è un altro individuo psico-fisico e personale, e non un mero corpo, una cosa, facendo
esperienza di esso in prima persona; in altri termini, l’altro in quanto tale è una mia propria
esperienza, “in carne e ossa”. Diversamente, il vissuto dell’altro che colgo nell’empatia non è una
mia propria esperienza originaria.
Questa distinzione è trascurata dalla letteratura sull’empatia ma è implicita nell’analisi di Stein e
ancora di più in quella di Scheler. Il punto interessante relativo a questa distinzione è che vi è un
nesso di dipendenza esistenziale reciproca tra io e vissuti, nel senso che se vi è un io vi sono anche
dei vissuti di cui l’io è il soggetto, e se vi sono dei vissuti, vi è necessariamente anche un io a cui
tali vissuti appartengono16. Di conseguenza, nel momento in cui empaticamente colgo l’altro, qui e
ora di fronte a me, lo colgo immediatamente anche come soggetto di una qualche esperienza, e ho al
contempo un’intuizione originariamente offerente, in prima persona, dell’altro in quanto tale, e non
originariamente offerente, non in prima persona, della sua esperienza.
15
Ivi, p. 15.
Vorrei precisare che Stein non si sofferma qui su questa distinzione, che è però cruciale nella definizione
dell’empatia come atto intuitivo a fondamento dell’intersoggettività. Diversamente Scheler, nella sua descrizione
dell’atto di “ri-sentire” o “rivivere” il vissuto dell’altro, esplicita questo punto, si veda Scheler (1913/23), “II.
Distinzioni tra i fenomeni del co-sentire”, pp. 43-66.
16
89
�Francesca De Vecchi
A scanso di equivoci, è opportuno precisare che il fatto che il vissuto dell’altro non mi sia dato in
modo originario, non implica affatto che non mi sia dato in modo diretto, qui e ora, e tantomeno
implica che per coglierlo io debba ricorrere a inferenze e conclusioni per analogia, da un lato, e a
processi imitativi e simulazionisti dall’altro 17 . Come abbiamo visto, empatizzando colgo
immediatamente, qui e ora, il vissuto dell’altro, in e unitamente al dato della percezione esterna che
fonda l’empatia.
Inoltre, la differenza tra intuizione originaria, in prima persona, e intuizione non originaria, non
in prima persona, si attesta nell’intensità o, più in generale, nella qualità dell’esperienza: più pallida
ed esangue, «come un’ombra» [schemenhaft] rispetto al corpo, è l’esperienza che ha il «carattere
della non-originarietà» [Nichtoriginaritätscharackter], mentre «vividamente in carne e ossa»
[leibhaft-lebendig] è l’esperienza nel caso dell’originarietà18.
La tesi dell’empatia come percezione diretta dell’altro è poi fenomenologicamente corroborata
dal fatto che il vissuto dell’altro, qualora esso sia un sentimento [Gefühl], è un vissuto che in base
alla sua essenza deve essere necessariamente espresso, ed è a partire dalla relazione essenziale tra
vissuto ed espressione, che possiamo cogliere direttamente, qui e ora, l’esperienza dell’altro:
cogliamo la vergogna nel rossore del volto, l’ira nel pugno serrato, la preoccupazione nella fronte
aggrottata, etc. Sentimento ed espressione costituiscono un intero essenziale che è un tratto cruciale
dell’eidetica dell’empatia e ha un ruolo fondamentale nelle specifica definizione dell’empatia come
percezione diretta dell’altro e dei suoi vissuti19.
3. I gradi dell’empatia
Possiamo ora entrare nel cuore della struttura eidetica dell’empatia, e mostrare che l’empatia, in
quanto unico tipo specifico di atti, è suscettibile di modificazioni che corrispondono alle covariazioni possibili delle parti che lo costituiscono come intero, all’interno del limite posto dal tipo
stesso degli atti di empatia. Questo significa che se l’empatia, come abbiamo visto, è un tipo unico e
specifico di atti, all’interno di questo tipo sono possibili modificazioni, tali che vi possono essere
atti di empatia differenti: diverse forme di empatia che appartengono tutte al tipo o specie essenziale
“empatia”.
L’argomento principale presentato da Stein a riprova dei molti modi di darsi dell’empatia
consiste nella scoperta di differenti «gradi di compimento» [Vollzugstufen]: Stein individua
precisamente tre gradi possibili di realizzazione degli atti di empatia.
Il primo grado consiste nel semplice «affiorare del vissuto» [das Auftachen des Erlebnisses]
dell’altro: ad esempio «il dolore che “leggo” sul volto dell’altro». A questo primo livello di
empatia, io, soggetto empatizzante, ho soltanto un’intuizione vaga e vuota dell’esperienza dell’altro,
che mi si presenta ancora nella forma di un oggetto.
17
Si vedano gli argomenti presentati da Stein contro le teorie della conclusione per analogia e la teoria
dell’imitazione: Stein (1917), le cosiddette “teorie genetiche dell’empatia”, pp. 32-42; Stein riprende in buona parte gli
argomenti addotti da Scheler (1913/23), “II. Distinzioni tra i fenomeni del co-sentire”, pp. 43-66. Una discussione
approfondita di questi argomenti in riferimento alla letteratura recente si trova in Gallagher-Zahavi (2008), cap. IX,
“Come conosciamo gli altri”.
18
Stein (1917), p. 28.
19
Sull’unità essenziale costituita da sentimento ed espressione, si veda Stein (1917), § “Il fenomeno
dell’espressione”, pp. 68-72, e § “Il corpo vivo dell’altro come portatore del fenomeno dell’espressione”, pp. 93-102.
Occorre poi segnalare la posizione specifica di Scheler (1913/23; tr. it. 2010), che, diversamente da Stein, porta
all’estremo l’analogia tra percezione esterna e atto di intuizione dell’esperienza vissuta dell’altro (l’“empatia” di Stein)
che qui Scheler chiama appunto «percezione interna» dell’altro, o «percezione dell’altro» [Fremdwahrnehmung] (p.
225): «Noi possiamo anche percepire internamente gli altri, in quanto cogliamo il loro corpo vivo come campo
espressivo dei loro vissuti: nel fenomeno visivo delle mani giunte, la preghiera è data proprio come la cosa materiale –
che ci è data anche come cosalità (insieme al fatto che possiede un interno e un lato posteriore) – nel fenomeno della
visione» (pp. 44-45). Sull’idea che l’empatia sia un atto di «percezione diretta» dell’altro, si veda anche GallagherZahavi (2008, capitolo 9), Zahavi (2011), Gallagher (2008).
90
�Il paesaggio sociale: essenza e forma degli atti di empatia
Il secondo grado degli atti di empatia è il momento dell’intuizione riempiente di quello che
l’altro sta vivendo: ora comprendo il vissuto dell’altro nella sua specificità ontologica, come
qualcosa di soggettivo, e quindi non più come un oggetto. Colgo il vissuto dell’altro nella sua unità
di senso, in relazione con la situazione rispetto alla quale l’altro sta provando quel vissuto. È questo
il momento che Stein chiama della «spiegazione riempiente» [erfüllende Explikation] del vissuto
dell’altro, che costituisce il massimo punto di avvicinamento del soggetto empatizzante al soggetto
empatizzato, il punto in cui il soggetto empatizzante si trova per così dire «tirato dentro»
[hineingezogen] il vissuto dell’altro, e, a partire da questa nuova postazione, può ora guardare
all’oggetto a cui il vissuto dell’altro è rivolto, collocandosi presso il soggetto empatizzante.
[…] mentre mi abbandono alle tendenze implicite nel vissuto (e cerco di portare a datità più chiara lo stato
d’animo [Stimmung] in cui l’altro si trova), quel vissuto non è più un oggetto in senso proprio, bensì mi ha
tirato dentro di sé: ora io non sono più rivolto a quel vissuto ma sono in esso rivolto al suo oggetto, sono
presso il suo soggetto, sono al suo posto.20
Infine, il terzo grado di realizzazione degli atti di empatia corrisponde al momento della
«oggettivazione in cui si sintetizza il vissuto esplicitato»: è il momento in cui «dopo la
chiarificazione conseguita nello sviluppo delle tendenze implicite, il vissuto si presenta di nuovo
davanti a me come oggetto». È il momento in cui il soggetto empatizzante torna alla distanza di
partenza rispetto al soggetto empatizzato.
Il punto fondamentale dell’analisi di Stein dei «gradi di compimento» degli atti di empatia è che
essi costituiscono diverse possibili «modalità di compimento» [Vollzugsmodalitäten] di questi atti.
Quando compiamo un atto di empatia, infatti, non realizziamo sempre tutti i tre i gradi, e «spesso ci
si accontenta di uno dei più bassi». L’empatia è dunque un tipo di atti che può avere diverse «forme
di compimento» [Vollzugsformen] 21 , corrispondenti a differenti gradi in cui si sviluppa l’intero
processo dell’atto. L’empatia non è quindi semplicemente un tipo di atto che possiamo compiere o
non compiere, ma un tipo di atto che, se compiuto, può attuarsi in diversi modi: realizzare tutte e tre
le fasi del suo processo di attuazione, oppure limitarsi soltanto alla prima di queste fasi.
Il fatto che l’empatia sia un atto che possiamo compiere in modo completo, realizzando tutti i
gradi, oppure in modo parziale, arrestandoci al primo grado, e che quindi l’empatia sia un atto che
presenta varie modalità di realizzazione, è un punto del tutto nuovo e cruciale per lo statuto
ontologico dell’empatia e il suo ruolo come fondamento delle relazioni intersoggettive e
interpersonali. Quando abbiamo a che fare con gli altri, nel paesaggio sociale, compiamo atti di
empatia sia completi sia parziali: a volte diamo seguito a quello che dapprima, in un’intuizione vaga
e vuota, abbiamo soltanto intravisto dell’altro, e di esso allora otteniamo un’intuizione riempiente
che ci permette di cogliere il vissuto dell’altro nel suo contesto motivazionale, e quindi nella sua
unità di senso, oppure, per i motivi più vari, interrompiamo il processo di compimento degli atti di
empatia, e arrestiamo l’incontro con l’altro alla prima fase di empatia che ci consegna la datità del
vissuto dell’altro soltanto in una forma abbozzata. In entrambi i casi, tuttavia, anche quando
l’empatia si limita al primo grado e quindi alla modalità di compimento più scarna e vuota, essa è
comunque un atto con il quale abbiamo gettato le condizioni di possibilità dell’incontro con l’altro,
perché nell’empatia ci siamo innanzitutto resi conto che di fronte a noi vi è un altro; l’incontro con
l’altro può poi avere un seguito, ed essere sviluppato e trasformato in una relazione, estemporanea o
stabile, a partire da atti di empatia iterati e di empatia reciproca22.
L’idea che vi siano gradi e forme differenti di attuazione dell’empatia costituisce inoltre un
argomento importante per l’ontologia qualitativa: la possibile gradualità del compimento degli atti
20
Stein (1917), p. 19.
Tutte le citazioni di questo paragrafo (§ 2. I differenti gradi dell’empatia) riferiscono a Stein (1917), p. 19.
22
Sull’empatia reciproca e iterata, cfr. Stein (1917), pp. 28-30. Il tema della reciprocità caratterizza la dimensione
della socialità in Husserl: gli atti costitutivi della socialità sono atti di relazione reciproca; si veda Husserl (1910) e
Husserl (1912/28), § 51 La persona nella collettività delle persone.
21
91
�Francesca De Vecchi
di empatia è infatti un’esemplificazione della questione, propria dell’ontologia qualitativa, della
gradualità di essere, intesa come gradualità di esistenza, che può risultare più o meno piena, più o
meno riuscita, rispetto ai paradigmi eidetici di realizzazione dell’essere di una certa cosa. Si tratta di
un tema di grande interesse e soprattutto di filiazione specifica della fenomenologia che si
caratterizza così come «ontologia fenomenologica qualitativa», a partire dall’idea husserliana che le
essenze delle “cose” sono propriamente «essenze vaghe», e quindi qualitativamente definibili, a
differenza delle idealità matematiche e geometriche23.
L’idea dei vari gradi di compimento dell’empatia e delle sue differenti modalità o forme di
realizzazione costituisce il secondo elemento portante del percorso all’interno dell’eidetica
dell’empatia che sto qui cercando di tracciare – il primo elemento portante l’ho individuato nella
definizione di empatia come un unico e specifico tipo di atti di esperienza sui generis. Ora, con
l’idea dei gradi di empatia, spero di aver sostanziato la definizione dell’empatia come unico e
specifico tipo di atti di esperienza: dovrebbe infatti essere chiaro che gli atti di empatia
costituiscono un’unica specie o classe di atti a cui appartengono singoli e differenti atti di empatia,
ognuno dei quali può essere compiuto in diverse forme, corrispondenti a diversi gradi di
realizzazione. Vi possono quindi essere atti di empatia soltanto abbozzati o pienamente sviluppati.
L’idea dei vari gradi di empatia è allora una prima e fondamentale esemplificazione dell’eidetica
dell’empatia: del fatto che l’empatia è un tipo di atti che sono suscettibili di modificazioni, di
variazioni possibili delle parti del tipo-intero empatia, all’interno del tipo stesso.
4. Empatia e somiglianze di famiglia: unipatia, simpatia e sentire collettivo
Mettiamo ora a frutto quest’idea dei vari gradi di compimento dell’empatia e delle sue differenti
modalità o forme di realizzazione nel confronto con atti che assomigliano all’empatia ma non lo
sono. In questi casi, infatti, le modificazioni delle parti che costituiscono gli atti di empatia come
intero-tipo sono tali che gli atti in questione non sono più atti di empatia, ma atti di altro tipo. Si
tratta dei casi di unipatia [Einsfühlung], sentire-con o simpatia [Mitfühlung], e condivisione di
sentimenti o intenzionalità collettiva affettiva, presentati da Stein nell’ultimo paragrafo della
seconda sezione «Essenza degli atti di empatia» 24 . Nella descrizione di questi altri fenomeni,
intersoggettivi e collettivi, Stein sottolinea l’andamento cangiante e dinamico, l’intrecciarsi fitto e
mutevole delle esperienze che, in vari modi e a diversi livelli, facciamo l’uno rispetto all’altro e ad
altri nel paesaggio sociale. In particolare, Stein procede esponendo, una dopo l’altra, una serie di
modificazioni che sono tutte variazioni sul tema dell’intenzionalità eterotropica, e che avvengono a
partire dallo stesso fatto: l’irrompere nella nostra vita di un altro e della sua esperienza, motivata da
avvenimenti del mondo. La gioia per il superamento di un esame è a seconda dei momenti e
dell’evolversi della situazione, sia la mia propria gioia per quell’avvenimento, sia la gioia dell’altro
che colgo nell’empatia, sia la gioia con cui partecipo alla gioia dell’altro nel sentire-con, in cui
provo gioia per l’evento che motiva la gioia dell’altro, sia la gioia per quell’evento che ora provo
originariamente io in prima persona mettendomi al posto dell’altro nell’unipatia, sia infine la gioia
che noi tutti stiamo provando insieme dopo che ognuno di noi ha colto nell’empatia, e poi
nell’empatia reciproca e iterata, la gioia dell’altro.
4.1. L’unipatia e la fuoriuscita dal tipo “empatia”
Con “unipatia” [Einsfühlung], Stein si riferisce al fenomeno di identificazione del soggetto
empatizzante con il soggetto empatizzato che secondo Theodor Lipps costituisce invece la genuina
23
Sul tema dell’ontologia qualitativa, o anche dell’ontologia fenomenologica qualitativa, che non posso
approfondire in questa sede, rinvio a Lanfredini (2006) e Lanfredini et al. (2016), a De Vecchi (2016 e 2018); sul tema
delle «essenze vaghe», il riferimento è naturalmente Husserl (1913).
24
Cfr. § 3. Confronto con altre descrizioni dell’empatia – in particolare quella di Lipps – e continuazione
dell’analisi, Stein (1917), pp. 21-30.
92
�Il paesaggio sociale: essenza e forma degli atti di empatia
empatia25. Stein naturalmente contesta la posizione di Lipps, a partire dal fatto che l’empatia è il
fenomeno in cui cogliamo il vissuto dell’altro non originariamente, in quanto appartenente all’altro,
e quindi non come nostro vissuto. Al di là della questione terminologica legata all’uso corretto o
scorretto della parola “empatia” [Einfühlung], il punto che Stein sottolinea è che se vogliamo
individuare l’atto specifico in cui facciamo esperienza di un altro e del suo vissuto, allora questo
atto non può essere un atto in cui il soggetto empatizzante si identifica con il soggetto empatizzato:
in questo caso, infatti, il soggetto empatizzante varca indebitamente il confine che lo separa dal
soggetto empatizzato, e, identificandosi con esso, pone fine a ogni tipo di esperienza e di relazione
con l’altro.
[Lipps] chiama empatia l’esperienza piena dei vissuti estranei, anzi considera essa, soltanto essa,
un’empatia piena, rispetto alla quale il concetto che noi abbiamo dell’empatia è solo un grado preliminare
imperfetto. […] noi contestiamo […] che possa verificarsi una perfetta coincidenza con l’altro io […] e
cioè che i due io possano diventare un solo io. Lipps confonde due fatti distinti: l’essere tratto dentro un
vissuto dato prima oggettivamente e il riempimento delle tendenze in esso implicite, da un lato, e il
passaggio dall’esperienza vissuta non–originaria all’esperienza vissuta originaria, dall’altro.26
Il punto che m’interessa mostrare è che l’unipatia à la Lipps, nella descrizione qui presentata da
Stein, è fondata sull’empatia e si realizza precisamente attraverso una modificazione “illegittima”
del secondo grado dell’empatia: nel momento di massimo avvicinamento del soggetto empatizzante
al soggetto empatizzato, in cui l’io empatizzante si trova presso l’altro e ha un’intuizione riempiente
della datità del suo vissuto, che riesce ora a cogliere nell’unità del suo contesto motivazionale,
accade che l’io empatizzante varca il confine tra sé e l’altro, si mette al suo posto sostituendosi a
esso, e avverte in prima persona, originariamente, il vissuto provato dall’altro.
Lipps parla qui di «empatia piena», intendendo in questo senso un’empatia che satura
l’intuizione del vissuto dell’altro, in un modo tale che l’altro ne è immediatamente cancellato:
l’«empatia piena» è dunque un’empatia che va oltre il limite che salvaguarda la distinzione tra me e
l’altro propria dell’empatia, e fuoriesce dal tipo empatia. L’empatia, infatti, per essere l’atto di
esperienza di un altro e del suo vissuto, deve necessariamente non essere satura, in modo da
preservare la trascendenza dell’altro. Il passaggio dall’empatia all’unipatia è quindi costituito dalla
modificazione di una parte dell’atto di empatia – il momento dell’intuizione riempiente – che non
può invece essere modificata in tal modo, pena l’uscita dal tipo empatia. In questo senso, il caso del
passaggio dall’empatia all’unipatia ben esemplifica l’eidetica dell’empatia come analisi delle covariazioni possibili delle parti dell’empatia come intero: in questo caso, infatti, avviene una
modificazione che supera i vincoli propri delle co-variazioni possibili delle parti che definiscono
l’empatia.
Finché l’empatia permane piena empatia dice Lipps, non è presente alcuna distinzione tra l’io proprio e l’io
estraneo (è appunto questo che ci è impossibile accettare come empatia), bensì i due io sono un unico io.
Ad esempio: io sono un unico io con l’acrobata e, osservandolo, partecipo interiormente [innerlich
mitmache] ai suoi movimenti. […] Io non sono un unico essere con l’acrobata, ma sto solo «presso» di lui;
io non compio realmente i suoi movimenti, ma solo «quasi», vale a dire non solo non compio i movimenti
dall’esterno (cosa del resto rilevata pure da Lipps), ma quel che «interiormente» corrisponde ai movimenti
del corpo proprio – ossia il vissuto dell’«io muovo» – non è originario per me, bensì è non-originario.27
La teoria di Lipps dell’empatia come empatia piena, che è allora unipatia, implica che l’io
empatizzante si metta al posto dell’io empatizzato simulando interiormente i movimenti corporei
dell’io empatizzato: mimando interiormente i movimenti dell’acrobata, empatizzo in modo pieno
l’esperienza dell’acrobata, cioè mi metto al suo posto, sostituendomi a lui. Nell’empatia invece, in
25
Il riferimento principale di Stein è la trattazione di Lipps in Ästhetik (1903).
Stein (1917), pp. 27-28.
27
Ibidem.
26
93
�Francesca De Vecchi
cui i confini tra me e l’altro rimangono intatti, io non sono uno con l’acrobata, ma sono soltanto
presso di lui, come Stein ha mostrato relativamente al secondo grado dell’empatia. «Non compio
realmente i suoi movimenti»: l’esperienza «io muovo» il mio corpo non è originaria per me che la
sto cogliendo, empatizzando il vissuto dell’acrobata, ma è propria solo dell’acrobata.
Occorre soffermarsi un momento sul fatto che, nella descrizione dell’empatia piena di Lipps,
Stein osserva che in questo caso il soggetto empatizzante «partecipa interiormente» [innerlich
mitmachen] al vissuto dell’altro imitandolo: riproducendo nella propria mente i movimenti
dell’altro, e quindi identificandosi con esso. È questa una descrizione ante litteram della teoria della
simulazione, così come è stata scientificamente fondata nella scoperta dei neuroni specchio:
percependo il movimento dell’altro, io attivo i miei neuroni, quegli stessi che si attiverebbero se
compissi quel movimento in prima persona 28 . In questo tipo di descrizione, «l’esperienza “io
muovo” il mio corpo» non è più suscettibile della distinzione esperienza originaria, da un lato, ed
esperienza non originaria, dall’altro. Il confine tra me e l’altro è saltato, proprio perché è saltato ciò
che qualitativamente distingue un vissuto esperito in prima persona, originariamente, e un vissuto
che è proprio dell’altro e che può essere esperito da me soltanto non-originariamente. La differenza
qualitativa tra un’esperienza originaria e una non originaria è fondata nel corpo proprio dei soggetti
dell’esperienza. Ma, al livello proprio della descrizione dei neuroni specchio, questa differenza
qualitativa scompare: non vi è differenza tra ciò che esperisco nel mio corpo vivo originariamente e
ciò che esperisco non originariamente nel mio corpo vivo – in quanto è esperito originariamente nel
corpo vivo dell’altro. Ne consegue che è indifferente con quale corpo io viva una certa esperienza:
tanto la vivo in ugual modo, sia che la viva come propria del mio corpo, sia che la viva come
propria del corpo dell’altro29.
Se al livello di descrizione dei neuroni specchio, l’io e l’altro vivono la stessa esperienza, sia che
essa appartenga originariamente all’io o all’altro, e se, quindi, la differenza qualitativa tra originario
e non originario, tra proprio ed estraneo, viene del tutto meno, allora questo suggerisce che la
descrizione neuro-scientifica di ciò che accade a livello dei neuroni specchio può adeguatamente
costituire il fondamento neurobiologico di fenomeni unipatici e di identificazione tra soggetti; ma,
rispetto al fenomeno dell’empatia in quanto atto in cui facciamo non originariamente esperienza del
vissuto dell’altro, tale fondamento non sembra invece rendere conto dell’eccedenza individuale che
distingue un io da un altro .
Infine, se questa linea di analisi è corretta, essa apre a una prospettiva di indagine
fenomenologica, non solo nuova e promettente, ma anche necessaria, sul tipo di esperienza
intersoggettiva e collettiva che sembra essere predominante nei cosiddetti social network:
quest’esperienza, infatti, non è allora quella dell’empatia, ma piuttosto quella del contagio affettivo
28
Per un’introduzione sulla scoperta dei neuroni specchio e sulle corrispondenti teorie neuro-scientifiche, si veda, ad
esempio, Rizzolati-Sinigaglia (2006) e Gallagher-Zahavi (2008, cap. IX). È importante rilevare come le teorie
simulazioniste si distinguano in due categorie, quelle della simulazione esplicita in cui l’imitazione è ritenuta essere un
atto volontario e cosciente (cfr. ad esempio Goldman (2005)), e quelle della simulazione implicita in cui l’imitazione è
descritta come del tutto involontaria e inconsapevole, e quindi propria del livello sub-personale (cfr. ad esempio
Gallese-Guerra (2016)). La «partecipazione interiore» di Lipps, nella descrizione di Stein, che io ho qui inteso come
una modificazione dell’atto di empatia, quindi come un atto che si compie a livello personale, sembrerebbe tuttavia
sfuggire a entrambe le categorie di simulazione, poiché l’innesto del processo imitativo nella partecipazione interiore
che subentra all’intuizione riempiente, nella modalità “degenerata” del secondo grado dell’empatia, non sembra avere le
sembianze di un atto volontariamente prodotto dal soggetto empatizzante. D’altro canto, Stein sembra invece attribuire
alla descrizione dell’empatia di Lipps l’idea di una simulazione implicita ante litteram, nel momento in cui in un passo
relativo alla «teoria dell’imitazione» [Nachahmungstheorie], quale teoria genetica dell’empatia, descrive la
«partecipazione interiore» in termini di impulso imitativo: «la vista di un gesto suscita in me l’impulso a imitarlo, e così
faccio – se non esteriormente almeno “interiormente”. […] In tal modo, assieme a quel gesto si compie anche il vissuto
corrispondente», cfr. Stein (1917), p. 35.
29
In questa prospettiva, viene quindi meno anche il senso di «mietà» [Meinheit] che fenomenologicamente
contrassegna ogni esperienza che vivo, come mia; sul senso di mietà si veda il capitolo su “Coscienza e autocoscienza”
in Gallagher-Zahavi (2008).
94
�Il paesaggio sociale: essenza e forma degli atti di empatia
e dell’unipatia in cui la barriera di confine tra me e l’altro, costituita dal mio corpo vivo di fronte al
corpo vivo dell’altro, è annullata. In altri termini, proprio perché il modo di presenza degli individui
nei social network non è quello della relazione in presenza, del faccia a faccia che necessita dell’in
carne e ossa, in cui la corporeità degli individui è essenziale, allora, in questo paesaggio sociale
modificato, il fenomeno principale sembra non più essere l’empatia, fondata sul corpo vivo di
ciascuno come corpo proprio e individuale in senso essenziale, ma sull’identificazione dell’unipatia
e del contagio.30
4.2. La fondazione della simpatia sull’empatia
Tornando ora ai fenomeni propri del paesaggio sociale non modificato nella realtà virtuale dei
social network, Stein distingue l’empatia anche da un altro fenomeno che è simile a essa ma non è
empatia. È il sentire-con o simpatia [Mitfühlen]: l’atto in cui proviamo un certo sentimento per il
fatto che l’altro prova quel sentimento in relazione a una determinata situazione; è un atto di
partecipazione al sentire dell’altro, ad esempio di partecipazione alla gioia [Mitfreude] o alla
sofferenza [Mitleide] dell’altro rispetto a un certo evento. D’accordo con Scheler 31, Stein sostiene
che la simpatia è un atto fondato nell’empatia, e che quindi dipende esistenzialmente dall’empatia:
posso provare gioia per il fatto che l’altro sta provando gioia per quella determinata situazione,
soltanto se prima, in un atto di empatia, mi sono resa conto della gioia dell’altro. A differenza
dell’empatia, la simpatia, precisa Stein, è un atto intuitivo in cui vivo originariamente il mio
vissuto: non si tratta più della gioia dell’altro di cui faccio non originariamente esperienza
nell’empatia, ma si tratta ora del mio vivere la mia propria gioia, in relazione al fatto che l’altro
prova gioia per una certa cosa32.
In questa prospettiva, il contenuto della gioia simpatizzata è differente da quello della gioia
empatizzata: esse hanno la differenza qualitativa propria di un vissuto non originario, da un lato, e
di un vissuto originario dall’altro; ed è proprio in virtù di questa differenza qualitativa che è soltanto
l’empatia, e mai la simpatia, a essere l’atto con cui possiamo cogliere la gioia dell’altro in quanto
tale 33.
4.3. La fondazione di sentimenti condivisi sull’empatia
Veniamo ora all’ultimo fenomeno sociale presentato da Stein nella sua mappatura eidetica
dell’empatia. Si tratta del fenomeno del sentire collettivo, da Stein qui infelicemente chiamato
ancora “unipatia” – come l’unipatia à la Lipps. La descrizione di Stein identifica, infatti, un vero e
proprio caso di intenzionalità collettiva affettiva, fondato sull’empatia: la situazione in cui una
pluralità di soggetti provano lo “stesso” sentimento in relazione a un certo fatto.
Un’edizione straordinaria dà notizia che una fortezza è capitolata. La notizia suscita in coloro che l’hanno
appresa un sentimento di entusiasmo, di gioia, di esultanza. Tutti proviamo “lo stesso” sentimento. Sono
forse qui crollate le barriere che separano un io dall’altro? Possiamo forse dire che l’io si sia liberato dal
suo carattere monadico? Non del tutto! Io provo la mia gioia e colgo, empatizzando, quella dell’altro, e
vedo che la gioia è sempre la stessa. Mentre vedo questo, pare che si smorzi in me quel carattere di nonoriginarietà nei riguardi della gioia estranea e che a poco a poco quella gioia pallida ed esangue
[schemenhaft] coincida con la mia gioia che io provo in maniera viva [lebendig] e in carne ed ossa
[leibhaftig]; inoltre, pare che tutti provino la loro gioia in maniera viva, non diversamente da come essa è
provata da me. Ciò che gli altri ora avvertono, l’ho visivamente dinanzi a me, assume la forma di un corpo
30
Per un’analisi approfondita dei fenomeni del contagio e dell’unipatia, si rinvia a Scheler (1913/23), trad. it. 2010.
Stein si riferisce esplicitamente a Scheler (Stein 1917), p. 25, nota 11. Si veda anche Scheler (1913/23), trad. it.
2010, «II. Distinzioni tra i fenomeni del “co-sentire”», pp. 41-66.
32
Si veda Stein (1917), pp. 23, 25-26.
33
Cfr. Stein (1917), p. 25. Sul sentire-con e sul suo rapporto con l’empatia si veda naturalmente anche l’analisi
puntuale ed esaustiva elaborata da Scheler (1913/23), trad. it. 2010.
31
95
�Francesca De Vecchi
proprio e vive attraverso il mio sentire; […] dall’“io” e dal “tu” emerge il “noi” in guisa di un soggetto di
grado più elevato.34
Stein ben mostra qui come l’intenzionalità collettiva affettiva possa essere fondata nell’empatia:
cogliendo la gioia dell’altro nell’empatia, mi rendo conto che anche l’altro prova gioia per
quell’avvenimento per cui io stessa sto provando gioia; la mia gioia, così come la provo io
originariamente, è allora la “stessa” gioia che prova l’altro, a sua volta originariamente. La qualità
non originaria, «pallida ed esangue [schemenhaft]» che caratterizza l’esperienza empatizzata si
modifica, e assume la qualità propria dell’esperienza originaria, còlta in «in maniera viva [lebendig]
e in carne ed ossa [leibhaftig]». E quell’altro, e un altro ancora e tutti gli altri che sono qui presenti,
in ulteriori atti di empatia, provano «lo stesso sentimento» di gioia e se ne rendono conto.
Stein descrive quindi l’intenzionalità collettiva affettiva come un fenomeno che si costituisce a
partire dai sentimenti individuali – la mia, la tua, la sua gioia, – còlti nelle empatie reciproche che
permettono a ognuno di fare esperienza del sentimento dell’altro. Di conseguenza, l’intenzionalità
collettiva affettiva presuppone qui l’empatia, e non l’identificazione unipatica con l’altro:
presuppone l’incontro e la relazione con l’altro, in cui io mi rendo conto di quello che l’altro sta
vivendo in quanto altro, ed esclude l’immedesimazione con l’altro. Per questo motivo il fenomeno
descritto da Stein non è unipatia, se con “unipatia” intendiamo il fenomeno di identificazione à la
Lipps35.
Occorre soffermarsi un momento sull’espressione «lo stesso sentimento» usata da Stein per
caratterizzare la condivisione affettiva. Che cosa infatti significa che proviamo la “stessa gioia”?36
Questa espressione può essere intesa sia in un senso debole sia in un senso forte. Il senso debole:
proviamo la stessa gioia significa che tutti noi proviamo gioia per quell’avvenimento, la proviamo
tutti in prima persona, in modo originario, vivo e in carne e ossa. Il senso forte si riferisce invece
alla qualità individuale della gioia provata: è possibile che proviamo tutti la stessa qualità di gioia?
In altri termini, il modo in cui sono gioiosa e provo gioia io per quell’avvenimento è uguale al modo
in cui tu e l’altro siete gioiosi e provate gioia per quello stesso avvenimento? In realtà,
fenomenologicamente, ognuno prova una qualità specificamente individuale dei sentimenti che
vive, a seconda della sua capacità personale di sentire il valore o il disvalore di certi stati di cose e
di farli risuonare dentro di sé in sentimenti a essi corrispondenti, vale a dire a seconda della sua
identità personale in senso essenziale – a seconda del grado di sviluppo e maturazione della sua
sensibilità affettiva, dell’ordine di priorità dei valori che caratterizza la sua personalità, della
gerarchia dei valori che è presente in quella persona in quel determinato momento37.
Stein accenna a questo problema del modo individuale e individualizzante in cui viviamo i
sentimenti:
Possiamo considerare ancora un’altra possibilità: gioiamo dello stesso avvenimento, ma la gioia che ci
riempie non è proprio la stessa: forse per l’altro la gioia si è dischiusa in maniera più ricca.
34
Stein (1917), pp. 28-29.
Bisogna precisare che il fenomeno di intenzionalità collettiva qui descritto da Stein, che è fondato nell’empatia, è
differente dal «sentire insieme l’uno con l’altro» [miteinanderfühlen], individuato da Scheler come una modificazione
del sentire-con [mit-fühlen], in cui si ha direttamente un “noi”, senza passare dai singoli “io” e da lì, attraverso
successivi atti di empatia, al noi, come invece nella condivisione di sentimenti delineata da Stein. Infine, Scheler
chiama propriamente «unipatia» [Einsfühlung] il fenomeno sub-personale di condivisione di sentimenti e contenuti
mentali di vario tipo, in cui siamo pervasi da vissuti altrui e li viviamo cose se fossero nostri; questo fenomeno non si
fonda affatto sull’empatia, e al contrario, secondo Scheler, è l’unipatia che sta a fondamento dell’empatia. Su questi
fenomeni ulteriori del paesaggio sociale individuati da Scheler, si veda Scheler (1913/23), in particolare pp. 47, 232233.
36
Sul problema dell’intenzionalità collettiva affettiva e sulle emozioni condivise, si veda Schmid (2009), e Salmelavon Scheve (2014).
37
Per ragioni di spazio, non posso in questa sede approfondire il tema dell’identità personale in senso essenziale.
Rinvio a Stein (1917), “III. L’empatia come comprensione della persona spirituale”, Scheler (1916a, 1916b), De
Monticelli (2009).
35
96
�Il paesaggio sociale: essenza e forma degli atti di empatia
E osserva che nell’atto empatico abbiamo proprio la possibilità di cogliere questa differenza
individualizzante, relativa al modo in cui ognuno vive lo “stesso” sentimento: empatizzando riesco
a cogliere aspetti propri del modo in cui l’altro sta vivendo quel sentimento che io non avevo colto.
[…] giungo a quei “lati” che erano rimasti chiusi alla mia propria gioia, ed ora la mia gioia si accende e
solo ora avviene la completa coincidenza con la gioia empatizzata.
Nell’empatia posso allora rendermi conto che la mia gioia originaria, in prima persona, per
quell’evento, non ha la stessa qualità individuale che l’altro sta provando per quell’evento, a sua
volta originariamente. Attraverso l’empatia posso cogliere gli aspetti di quella gioia dell’altro che io
stessa invece non avevo provato. E può accadere che allora, una volta che ho còlto gli aspetti
qualitativi della gioia vissuta dall’altro, io a mia volta viva in prima persona una gioia che ora
comprende anche quegli aspetti. In questo senso, l’empatia è l’atto che mi consente di uscire dai
limiti, spesso angusti, della mia esperienza personale, e di arricchirla nell’incontro e nella relazione
con l’altro.
Lo stesso può accadere agli altri, e così, mentre empatizziamo, arricchiamo il nostro sentire e “noi”
sentiamo ora una gioia diversa da quella che sentivamo “io”, o “tu”, o “lui”, restando isolati.38
4. L’empatia negativa
Stein introduce il concetto di «empatia negativa» che mutua da Lipps, e lo declina in modo nuovo
rispetto a Lipps, il quale con «empatia negativa» intende il non realizzarsi del passaggio al vivere
pieno e originario nel secondo grado di empatia – e quindi, correlativamente, il realizzarsi
dell’empatia à la Stein. Stein con «empatia negativa» intende invece il bloccarsi dell’empatia nel
suo sviluppo tipico – i tre gradi dell’empatia –, e s’interroga su che cosa possa motivare tale blocco,
impedendo all’atto di empatia di compiersi in modo completo. In particolare Stein si chiede cosa
possa ostacolare il passaggio dal primo grado di intuizione, ancora vaga e vuota del vissuto
dell’altro, al secondo grado di riempimento e coglimento del vissuto nel suo contesto di senso.
Inoltre, Stein si chiede anche che cosa possa impedire all’empatia di fondare e quindi per così dire
di sfociare in un atto di simpatia, di partecipazione affettiva al vissuto dell’altro.
Rispetto a tutti questi casi, Stein osserva, che è possibile che essi non si realizzino perché l’io
empatizzante è pervaso da vissuti dal contenuto contrastante con quello empatizzato.
Facciamo un esempio: nello stesso istante in cui un amico mi dà una notizia gioiosa, tutto il mio essere è
già riempito da un sentimento doloroso motivato dalla perdita di una persona cara. Il dolore impedisce alla
gioia che colgo empaticamente di dar luogo ad una “partecipazione al sentire”. Qui sorge un conflitto
[…].39
Il tema dell’empatia negativa è allora di grande interesse nella prospettiva dell’ontologia qualitativa
che caratterizza l’eidetica dell’empatia, come ho cercato di mostrare in questo articolo da vari punti
di vista della qualità dell’esperienza vissuta. L’empatia negativa pone infatti al centro della
discussione sull’empatia il problema della qualità degli atti di empatia – più o meno compiuti, più o
meno completi – e quindi del modo in cui individualmente rispondiamo, in conformità alla nostra
identità personale in senso essenziale, all’esperienza degli altri e dei loro vissuti, e alle qualità di
valore, positive o negative, degli stati di cose del mondo a cui essi sono connessi.
Bibliografia
Boella, L. (2018), Empatie. L’esperienza empatica nella società del conflitto, Raffaello Cortina
Editore, Milano.
38
39
Stein (1917), p. 29.
Ivi, pp. 26-27.
97
�Francesca De Vecchi
De Monticelli, R. (2008), Ontologia del nuovo, Bruno Mondadori, Milano.
De Monticelli, R. (2009), La novità di ognuno, Garzanti, Milano.
De Monticelli R. (2018), Il dono dei vincoli. Per leggere Husserl, Garzanti, Milano.
De Vecchi, F. (2014), Three Types of Heterotropic Intentionality. A Taxonomy in Social Ontology,
in Konzelman Ziv, A.-Schmid, H.B. (eds.), Institutions, Emotions and Group Agents.
Contribution to Social Ontology, Springer Verlag, Dordrecht, pp. 117-137.
De Vecchi, F. (2016), “The Existential Quality Issue in Social Ontology: Eidetics and
Modifications of Essential Connections”, Humana.Mente, vol. 31, pp. 187-204.
De Vecchi, F. (2018), “Fenomenologia: la filosofia come eidetica e ontologia qualitativa del
concreto”, Giornale di metafisica (in corso di pubblicazione).
Gallagher S. (2008), “Direct perception in the intersubjective context”, Consciousness and
Cognition, vol. 17, n. 2, pp. 535-543.
Gallaher, S.-Zahavi, D. (2009), La mente fenomenologica, Raffaello Cortina Editore, Milano.
Goldman, A. (2005), Imitation, Mindreading and Simulation, in Hurley, S.-Chater, N. (eds.),
Perspectives on Imitation II, MIT Press, Cambridge Mass., pp. 79-94.
Lanfredini, R. (2006), La nozione fenomenologica di dato, in Id. (ed.), A priori mentale. Uno studio
fenomenologico, Milano, Guerini, pp. 59-94.
Lanfredini, R.-Liberati, N.-Giannotta, A.P.-Pagni, E. (2016), “The Enactive Approach to
Qualitative Ontology: In Search of New Categories”, Humana mente: Journal of Philosophical
Studies, vol. 9, n. 31.
Lipps, Th. (1903), Ästhetik. Psychologie des Schönen und der Kunst. Erster Teil: Grundlegung der
Ästhetik, Voss, Hamburg und Leipzig.
Husserl, E. (1901), Ricerche Logiche, trad. it. a cura di G. Piana, Il Saggiatore, Milano 1968.
Husserl, E. (1910), “Soziale Ontologie und deskriptive Soziologie”, in Husserliana XIII,
Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass, 1905-1920, a cura di I. Kern,
Martinus Nijhoff, Den Haag 1973, pp. 98-104.
Husserl, E. (1913), Idee per una fenomenologia pura e una filosofia fenomenologica, Volume
primo: Introduzione generale alla fenomenologia pura, trad. it. a cura di V. Costa, Einaudi,
Torino 2002.
Husserl, E. (1912/1928), Idee per una fenomenologia pura e una filosofia fenomenologica, Volume
secondo, trad. it. a cura di V. Costa, Einaudi, Torino 2002.
Schmid, H.B. (2009), Plural Action. Essays in Philosophy and Social Sciences, Springer,
Dordrecht.
Salmela, M.-von Scheve, Ch. (eds.) (2014), Collective Emotions, Oxford University Press, Oxford.
Scheler, M. (1913/23), Essenza e forme della simpatia, trad. it. a cura di L. Boella, Franco Angeli,
Milano 2008.
Scheler, M. (1916a), Il formalismo nell’etica e l’etica materiale dei valori, trad. it. a cura di R.
Guccinelli, Bompiani, Milano, 2013.
Scheler, M. (1916b), Ordo amoris, trad. it. a cura di E. Simonotti, Morcelliana, Brescia 2008.
Searle, J.R. (1995), La costruzione della realtà sociale, Einaudi, Torino.
Searle, J.R. (2010), Creare il mondo sociale, Raffaello Cortina Editore, Milano.
Stein, E. (1917), Zum Problem der Einfühlung, in Edith Stein Gesamtausgabe, Band 5,
herausgegeben von M.A. Sondermann, Herder, Freiburg 2008.
Zahavi, D. (2011), “Empathy and Direct Social Perception: A Phenomenological Proposal”, Review
of Philosophy and Psychology, vol. 2, n. 3, pp. 541-558.
Abstract
Starting from Stein’s phenomenological account of empathy, I argue for an eidetics of empathy,
according to which empathy is one type of acts that, as a whole, is subject to variations of its parts.
Eidetics of empathy shows that a variety of acts of empathy, characterised by different degrees of
98
�Il paesaggio sociale: essenza e forma degli atti di empatia
fulfilment, is possible. Moreover, it allows to take into account adequately crucial issues in
phenomenology of intersubjectivity and social ontology: in what sense empathy is the «direct
perception» of others and their lived experiences? What is «negative empathy»? What are the
essential features of sympathy and emotional sharing, as different from empathy?
Keywords: Social Landscape, Eidetics of Empathy, Degrees of Empathy, Negative Empathy,
Qualitative Ontology
99
�STEFANO GONNELLA*
Elementi per una nuova fenomenologia dell’a priori culturale
Una prima coordinata per il tema di questo contributo potrebbe essere tracciata ricorrendo alle
stringate ma illuminanti parole con cui il fenomenologo americano Dorion Cairns qualificava in un
suo manoscritto del 1938 l’itinerario intellettuale di Edmund Husserl1. La riflessione filosofica di
Husserl, stando a Cairns, era costantemente accompagnata e motivata da due fondamentali
avversioni: un’insofferenza nei confronti di qualsiasi oscurità rinvenibile nei concetti, nelle
affermazioni, nelle teorie e un’antipatia nei confronti di tutte quelle credenze che non fossero state
da lui scrupolosamente giustificate attraverso dirette osservazioni in prima persona2.
Niente di nuovo, si potrebbe aggiungere, per lo meno per quanto riguarda moventi e propositi,
più volte enunciati dallo stesso Husserl, anche con toni accorati, come nella famosa pagina di diario
del settembre 1906, in cui il lavoro filosofico di giustificazione e chiarificazione sembra addirittura
intrecciarsi con il senso stesso dell'esistenza 3. Chi ha scelto il mestiere di pensare, chi è stato
chiamato alla filosofia, secondo Husserl, per vivere autenticamente deve fare chiarezza sul
significato, la portata e le possibilità della ragione, adoperando la ragione stessa. Compito
ovviamente arduo, gravido di difficoltà e aporie, dalle quali il fondatore della fenomenologia, com’è
noto, non distoglierà mai lo sguardo, riconoscendovi il senso ultimo della filosofia in quanto
impresa conoscitiva razionale. Ma la risposta alla vocazione filosofica, come trapela da questi rapidi
cenni, non è una mera operazione intellettuale, avulsa dalla vita, bensì è una presa di posizione
radicale e intransigente, che coinvolge l’intera sfera personale.
Tale coinvolgimento esistenziale riecheggia nelle parole che Husserl formulerà nella premessa
all’edizione inglese delle Idee, avvertendo che «il presente scritto non sarà di nessun aiuto a colui
che già è sicuro della propria filosofia e del proprio metodo filosofico, che non ha mai conosciuto la
disperazione di chi, per avere avuto la disgrazia di essersi innamorato della filosofia, si vide già
all'inizio, già da studente, posto di fronte a una scelta nella confusione delle filosofie, rendendosi
conto di non aver scelta perché nessuna di quelle filosofie aveva provveduto a liberarsi
autenticamente di tutti i presupposti, che nessuna era sorta dal radicalismo di una responsabilità e di
una garanzia di sé quali sono richieste dalla filosofia»4. Dall’incertezza e dall’instabilità provocate
dalla mancanza di fondamenti si può dunque provare ad uscire, ma la radicalità di quella garanzia di
sé che la filosofia richiede, impone al ricercatore di intraprendere vie non ancora battute, in piena
autonomia e indipendenza da qualsiasi altra disciplina, e soprattutto in totale libertà da qualsiasi
presupposto occulto e non indagato5.
L’impegno ad abbandonare o almeno a riconoscere e mettere in questione i propri presupposti
dovrebbe essere scritto a lettere cubitali nel “mansionario” del filosofo, come requisito preliminare
nella ricerca di un terreno non evanescente per il proprio sapere; procedendo, come precisa Husserl,
*
Università di Siena
1
Cairns (2002).
Ivi, p. 219.
3
«In primo luogo nomino il compito generale che devo risolvere per me, se voglio chiamarmi filosofo. Intendo una
critica della ragione. […] Io non posso veramente e veracemente vivere senza venire in chiaro, in linee generali, sul
senso, l'essenza, i metodi, i punti di vista fondamentali di una critica della ragione, senza aver immaginato, progettato,
stabilito e fondato un generale abbozzo per essi» Si tratta di un brano riportato da Walter Biemel nella sua «Einleitung»
a Die Idee der Phänomenologie, Hua II, pp. VII-VIII, per illustrare il momento di crisi intellettuale attraversato da
Husserl negli anni immediatamente successivi alla pubblicazione delle Ricerche logiche (1900-01).
4
Husserl (2002b), p. 433.
5
Ivi, p. 432.
2
Bollettino Filosofico 33 (2018): 100-113
ISSN 1593 -7178 - 00030
E-ISSN 2035 -2670
DOI 10.6093/1593-7178/5909
�Elementi per una nuova fenomenologia dell’a priori culturale
sulla base di un metodo assolutamente trasparente. Tuttavia, uno dei punti su cui si sono
maggiormente distinte e divaricate le posizioni dei fenomenologi, riguarda proprio la possibilità di
liberarsi da qualsiasi presupposto e l’effettiva consistenza del tentativo di applicare un metodo
assolutamente trasparente, fondando le proprie affermazioni e convinzioni filosofiche sulla base di
intuizioni immediate, compiute in prima persona6. Eppure, si tratta di una questione ineludibile, alla
quale occorre rispondere, se non altro perché «il filosofo non può non chiedersi che cosa sta
facendo. Non può percorrere una strada, usare un metodo e non chiedersi conto di quel metodo,
affidandosi semplicemente al risultato eventuale: la domanda filosofica, a differenza di quella
scientifica, è sempre autoreferenziale» 7. Dunque, a differenza di quanto accade alle altre discipline,
umanistiche o scientifiche, fare ricerca in campo filosofico conduce, o almeno dovrebbe condurre, a
interrogarsi sulla genesi, sul fondamento, sulla giustificazione delle proprie pratiche e del proprio
procedere.
«La peculiarità dell’interrogazione filosofica è di volgersi su se stessa, di chiedersi anche che
cos’è interrogare e che cos’è rispondere. Non appena è posta, tale domanda alla seconda potenza
non può essere cancellata. Ormai non ci si potrà più comportare come se non ci fosse mai stata
domanda»8. Queste parole di Merleau-Ponty, oltre a sancire lo stadio aurorale della riflessione
filosofica, aggiungono un sottile richiamo all’intransigenza con cui bisognerebbe tener fede alla
domanda, una volta emersa. Una domanda inesorabile, che rivolgendosi a se stessa risulta al
contempo necessaria e paradossale.
In effetti, che la si voglia considerare o meno una filosofia tra le altre, la fenomenologia sembra
essere ulteriormente spinta anche dalla singolarità del proprio metodo a fare i conti con una sorta di
istituzionale autoreferenzialità. Tuttavia, questo compito rigorosamente filosofico implica una
questione preliminare, solo in apparenza meramente tecnica: quali sono gli strumenti con cui è
possibile indagare il metodo fenomenologico? Irresistibile tentazione è quella di accogliere la
risposta netta e sbrigativa: con il metodo fenomenologico stesso9. In effetti, «la stessa
fenomenologia, da questo punto di vista − e Husserl spesso l’ha detto − deve essere sottoposta ad
analisi fenomenologica»10. Ma questa, più che una risposta, sembra essere una dilazione, uno
slittamento verso i margini del discorso fenomenologico, dal quale non si può uscire se non
riconoscendone l’impraticabilità e il fallimento teoretico 11.
1. Il metodo della visione e la visione del metodo
Fin dagli inizi del suo itinerario di ricerca, Husserl avverte che le sue descrizioni non potranno
essere pienamente comprese a meno che non si affronti direttamente, in una diretta evidenza
vissuta, l’effettivo tipo di esperienza in questione, per poi giudicare se e quanto adeguatamente la
descrizione verbale rifletta o riesca a rappresentare tale esperienza12. Da questo punto di vista risulta
6
Cfr. Behnke (2010), pp. 49 s.
Sini (2000), pp. 122 s.
8
Merleau-Ponty (2003c), p. 138.
9
Come ricorda perentoriamente Merleau-Ponty: «La fenomenologia non è accessibile se non a un metodo
fenomenologico» Merleau-Ponty (1965), p. 16.
10
Paci (1963), p. 249. Si tratta di un compito che soprattutto Eugen Fink, sotto lo stimolo e la guida di Husserl,
cercò di portare avanti, nella forma di una dottrina trascendentale del metodo. Cfr. Fink (2009); Mezzanzanica (2001).
11
Una strategia per una risposta potrebbe essere quella di cercare di ricostruire la genealogia della fenomenologia
come impresa conoscitiva. «Genealogia del metodo di Husserl, ad esempio, e degli oggetti di cui parla la sua
fenomenologia. Genealogia, ad esempio, ancora, del suo assumere l’intuizione come fonte conoscitiva prima e ultima,
la riduzione come via d’accesso privilegiata al senso di determinate formazioni d’esperienza, la variazione eidetica
come generale procedimento euristico, il ri-vivere il vissuto o il descrivere cose e incontri di cose o il praticare
l’epoché» Leoni (2005), p. 213.
12
Nella Prefazione alla seconda edizione delle Ricerche logiche (1913), Husserl scrive: «Infatti, se queste ricerche
possono essere sentite come utili da coloro che hanno interessi fenomenologici, ciò dipende dal fatto che esse non
presentano soltanto un programma (uno di quei programmi sublimi di cui tanto abbonda la filosofia), ma tentativi di un
lavoro rivolto ai fondamenti (Fundamentalarbeit) che viene effettivamente eseguito sulle cose afferrate ed intuite
7
101
�Stefano Gonnella
del tutto comprensibile e calzante la similitudine tra la stesura di una descrizione fenomenologica e
la compilazione della mappa di un territorio sconosciuto ad opera di un esploratore13. Il testo
caratteristico di una qualsiasi descrizione fenomenologica, in poche parole, dovrebbe funzionare
come una carta geografica (Landkarte) capace di guidare il lettore sul campo stesso di indagine, di
modo che egli possa compiere da sé le sue osservazioni, valutare ed eventualmente integrare e
correggere le analisi già fatte14. Il metodo grazie al quale tali analisi sono state condotte dovrebbe
quindi poter essere applicato ed eseguito in prima persona, per approdare, o meno, ai medesimi
risultati; oppure scoprire strada facendo che tali risultati sono parziali, presentano aspetti
problematici, richiedono ulteriori analisi. Ma nel caso della riflessione rivolta al metodo stesso, oltre
a scarseggiare opportune descrizioni e mappe idonee cui fare riferimento, si potrebbe facilmente
correre il rischio della vuota ricorsività15.
Il richiamo alla visione diretta, com’è noto, è un aspetto centrale del metodo fenomenologico, da
cui non è possibile prescindere senza abbandonare il campo di indagine originariamente aperto da
Husserl. Tuttavia, come è stato più volte evidenziato, non si tratta di un appello ingenuo
all’immediatezza, poiché «imparare a vedere, a distinguere e a descrivere ciò che sta dinanzi agli
occhi esige studi specifici e ardui»16. Come sappiamo, per cominciare a osservare ciò che abbiamo
effettivamente davanti agli occhi, per rivolgerci alle “cose stesse” così come effettivamente si
presentano, ovvero per accostarci ai fenomeni senza preventivamente “spiegarli via”, ricorrendo
alle garanzie delle teorie scientifiche o alle rassicuranti concezioni del senso comune, occorre un
rivolgimento dell’attenzione17. Per imparare a vedere, a distinguere e a descrivere ciò che abbiamo
dinanzi agli occhi, occorre innanzitutto sospendere quello che Husserl definiva “atteggiamento
naturale” e aprire così l’inaudito campo di indagine dei fenomeni. E qui, più che mai, non contano
le speculazioni astratte, non si tratta di assimilare astruse costruzioni teoriche, magari rivestendo di
un gergo oscuro le consuete e familiari banalità: occorre appunto provare a vedere in prima persona,
cominciando ad esercitare lo «sguardo fenomenologico». Perché, come ammoniva Adolf Reinach:
«Parlare della fenomenologia è la cosa più vana del mondo, fintantoché manca ciò che solo può
dare, a ogni discorso, la concreta pienezza e l’intuitività: lo sguardo fenomenologico e
l’atteggiamento fenomenologico»18.
In altri termini, per comprendere concretamente le modalità con cui si dispiega l’atteggiamento
fenomenologico, dovremmo provare ad assumere tale atteggiamento e cominciare a praticarlo in
prima persona19. Indicazioni apparentemente limpide e inequivocabili, ma in realtà dense di
elementi enigmatici e di implicazioni da chiarire. In ogni caso, cosa vuol dire in concreto praticare
un metodo come quello fenomenologico, esercitandolo «sulle cose afferrate ed intuite
immediatamente»? Oltre alla difficoltà, rimasta in sospeso, di applicare il metodo al metodo stesso,
immediatamente; e queste ricerche, quando procedono criticamente, non si perdono nella discussione di punti di vista,
ma lasciano invece l’ultima parola alle cose stesse ed al lavoro intorno ad esse» Husserl (1988), p. 7 s.
13
Cfr. Husserl (1975), p. 60.
14
Cfr. Reeder (2010), pp. 39 ss.
15
Ad esempio, procedendo l’esercizio di genealogia della fenomenologia, sembra difficile evitare l’effetto di una
sorta di mise en abyme, nella quale l’operazione analitica si replica su se stessa, tendenzialmente all’infinito. «Epochè
dell’epoché, a tutti gli effetti. Descrizione della descrizione. Fenomenologia genetica dell’ambizione genetica della
fenomenologia. Ecco che la fenomenologia scende, o scenderebbe, o potrebbe scendere, sul terreno dell’ultima prova
(in un certo senso, della sua prima prova, che è la prova del suo senso, del senso dei suoi oggetti, del senso delle sue
operazioni, e dunque del senso del senso di cui essa va in cerca e alla cui nascita essa stessa dà l’impulso decisivo).
Leoni (2005), p. 214.
16
Husserl (2002a), p. 5.
17
«Non è facile pensare i fenomeni. Non è facile soprattutto quando, pensandoli, li si vuole salvare, invece di
“spiegarli via”. […] E per quanto ci sforziamo di pensare i fenomeni – da buoni fenomenologi – come manifestazioni
non vane e non illusorie delle realtà che sembrano presentarci, bottiglie, grattacieli, montagne, una sorta di atavica
grammatica mentale ci induce a credere tacitamente che l’entità di queste cose, la loro realtà insomma, risieda piuttosto
nella base che non si vede che nel dato che si vede […]. De Monticelli (2005), pp. 8 ss.
18
Reinach (2008), p. 167.
19
Reeder (2010), p. 39.
102
�Elementi per una nuova fenomenologia dell’a priori culturale
bisogna rilevare che il primato della sperimentazione diretta nella riflessione e nella descrizione
fenomenologica non sempre ha ricevuto la dovuta attenzione, anche da parte di coloro che si
professano fenomenologi20.
Le parole, vale a dire le descrizioni stilate dal fenomenologo, come spiega Sini con la consueta
perspicuità, esigono di essere “comprese”, vale a dire dovrebbero essere “rivissute”
dall’interlocutore. Questo significa che il cammino verso la comprensione dei fenomeni oggetto di
studio può anche essere intrapreso a partire dalle parole e dai loro significati, ma non bisogna
dimenticare che l’analisi fenomenologica non è un’analisi linguistica, non è un lavoro di
decantazione concettuale, bensì è un’opera di chiarificazione che prende di mira – o perlomeno
prova a prendere di mira – esattamente ciò a cui parole e significati si riferiscono.
Il tema dell’incontro ha un valore particolare in campo fenomenologico. Lester Embree, in una
sua articolata introduzione alla ricerca fenomenologica, definisce la fenomenologia come la
disciplina che si occupa del nostro incontrare le cose e, in maniera complementare, come la
disciplina che tratta delle cose in quanto incontrate21. Proprio per evidenziare le caratteristiche di
questo approccio analitico, l’autore impiega in diversi luoghi del suo testo il termine encountering,
che nell’edizione italiana viene invece tradotto nella quasi totalità delle volte come “esperienza”. In
effetti potremmo anche essere d’accordo sul fatto che «[l]a fenomenologia è, da parte a parte e a
dispetto di una vulgata contraria, una filosofia dell’esperienza»22.
C’è dunque un riferimento esplicito al momento vivente dell’esperienza – quello che Embree
esprime con il verbo experiencing, anch’esso nella traduzione italiana puntualmente assorbito dal
sostantivo “esperienza” – una struttura fluente che i fenomenologi prendono in considerazione e che
appare in occasione di un incontro direttamente vissuto23. È in questo luogo dell’incontro che si
manifesta e viene costituito il senso delle cose, in accordo con legalità essenziali e secondo
condizioni di possibilità che i fenomenologi si sforzano di cogliere e di descrivere, accostandosi a
quella che viene concepita come dimensione fenomenologico-trascendentale dell’esperienza. Si
potrebbe dire, con un gioco di parole, facendo a loro volta esperienza dell’analisi dell’esperienza.
2. Il campo fluente della coscienza intenzionale
Questa pretesa di rivolgere lo sguardo ai meccanismi e alle procedure stesse che presiedono
all’indagine fenomenologica potrebbe sembrare un’inutile complicazione. Eppure si tratta di un
punto rilevante, ricorrente in vari luoghi della letteratura fenomenologica, che porta con sé una serie
di questioni, non ultima la domanda sullo statuto e l’effettiva consistenza delle strutture eidetiche
che dovrebbero essere isolate applicando i protocolli dell’analisi fenomenologica.
Al cuore del metodo fenomenologico, c’è il gesto dell’epoché, su cui generazioni di
fenomenologi si sono interrogati, a partire dagli allievi diretti di Husserl, incontrando difficoltà e
inciampando in paradossi, fino a non ritenere necessario il suo compimento, come nel caso di
20
«There is a strong and clear emphasis in Husserl and other major phenomenological figures on the species of
research best called investigation, yet the vast majority of soi disant phenomenologists today engage instead in a species
of research that some call philology and others call scholarship. The latter species includes editing, interpreting,
reviewing, and translating, and its methods are no different from those used in scholarship on other traditions of
philosophy and science. Scholarship is extremely valuable because the works of many are difficult to understand, but it
is not an end in itself. It is essentially instrumental. Its purpose is to assist investigation, which is where phenomenology
is phenomenology» Embree (2005).
21
Cfr. Embree (2011).
22
Di Martino (2007), p. 32. Tuttavia, come lo stesso Di Martino precisa in un’altra occasione, «[l]’esperienza di cui
si occupa Husserl non è da intendersi in senso empirico, bensì in senso fenomenologico-trascendentale. Ma ciò non ha
nulla a che vedere con un costrutto intellettualistico, una proiezione idealistica: al contrario, essa identifica il momento
vivente dell’esperienza quale luogo di tutte le emergenze e rivelazioni di senso» Di Martino (2012b), p. 18.
23
«Ecco dunque delineato un principio che poi, pur con tutte le differenze, sarà sostanzialmente recepito da tutti
quei pensatori che, a qualche titolo, si sono ispirati alla prospettiva fenomenologica: nella descrizione dell’esperienza
per come essa si dà, gli elementi che entrano in gioco (anche se normalmente non vengono avvertiti, il che spiega le
infinite dispute metafisiche al riguardo) sono: ciò che si manifesta, colui a cui si manifesta, e il manifestarsi stesso, da
intendersi come il fatto che qualcosa si manifesti a qualcuno» Vanzago (2006), p. 90.
103
�Stefano Gonnella
Heidegger, o considerandolo semplicemente impossibile, come nel caso di Derrida 24. Uno degli
aspetti sicuramente più controversi di questo gesto inaugurale riguarda l’esito dell’operazione di
sospensione, vale a dire, ciò che viene tecnicamente considerato come residuo insospendibile
dell’epoché. Seguendo l’impianto husserliano, l’esercizio dell’epoché fenomenologica dovrebbe
condurre innanzitutto a riconoscere il primato della coscienza come regione peculiare e assoluta
dell’essere25. Tutto ciò che la tesi generale dell’atteggiamento naturale comprende sotto l’aspetto
ontico, ogni esistenza e ogni realtà in sé, viene sospeso dal regime dell’epoché, eccezion fatta
appunto per la regione coscienza, la cui caratteristica fondamentale ne impedisce la sospensione26.
Ora, la coscienza non è un contenitore vuoto, una sacca da riempire di oggetti, bensì un campo di
atti, o vissuti intenzionali, che concorrono a costituire le cose di cui facciamo esperienza, donando
loro il senso e determinandone così i caratteri27. Secondo la dottrina elaborata da Husserl,
l’intenzionalità «è ciò che caratterizza la coscienza in senso pregnante»28. La proprietà
fondamentale della coscienza, in altre parole, è di essere costituita da un flusso di Erlebnisse
intenzionali, ovvero da un insieme mobile e stratificato di atti connotati dall’intenzionalità.
Sorvolando sulla presenza di Erlebnisse non intenzionali, pure appartenenti alla sfera della vita
cosciente, se la teoria fenomenologica è corretta, qualsiasi esperienza e qualsiasi modalità di
conoscenza risultano essere atti o momenti di atti passibili di essere analizzati e descritti nelle loro
tipiche configurazioni29. L’analisi e la descrizione fenomenologica si svolgono grazie
all’attivazione di uno sguardo peculiare, uno sguardo capace di dirigersi sul fenomeno in quanto si
dà e così come esso si dà nel campo della coscienza intenzionale. In questo senso, il fenomeno è
una datità assoluta, la cui visione è resa possibile dall’esercizio dell’epoché e dalla conseguente
“riduzione” della realtà trascendente del mondo alla sfera delle cogitationes – intese non in senso
psicologico – e alla pura immanenza del campo di coscienza 30. A differenza di quanto accade in
presenza di una realtà trascendente, per Husserl nell’immanenza pura della sfera delle cogitationes è
possibile cogliere direttamente una datità assoluta, l’assoluta autodatità (Selbstgegebenheit) del
fenomeno31.
Nel campo della coscienza, fenomenologicamente ridotto, dovrebbe dunque essere possibile fare
esperienza, incontrare, cogliere l’assoluta datità dei fenomeni in cui si articola la nostra vita
cosciente e le loro caratteristiche essenziali32. Ma come già accennato, «al fine di cogliere l’essenza
non occorre una percezione sensibile; si tratta qui di atti intuitivi di tutt’altra specie, che possono
essere effettuati in qualsiasi momento»33. In qualsiasi momento e senza ricorrere alla percezione
24
Cfr. Sukale (1976b), Seron, Giovannangeli (2002).
Cfr. Husserl (2002a), pp. 76 s.
26
Cfr. Ivi, § 32. Ad essere sospesa è appunto una “tesi”, la tesi che il nostro senso comune assume in modo acritico
e “naturale”, ponendo ingenuamente l’esistenza in sé delle cose, indipendentemente dagli atti intenzionali della
coscienza impegnata a conoscere. Ciò che viene sospeso, com’è noto, non viene annullato o annichilito, bensì
mantenuto dall’epoché come fenomeno di conoscenza, accessibile allo sguardo riflettente del fenomenologo.
27
Nelle parole di Husserl, «l’oggettualità non è una cosa che se ne sta dentro la coscienza come in un sacco, quasi
che la conoscenza sia una vuota forma ovunque uguale, un sacco vuoto sempre identico, in cui si caccia una volta
questo, una volta quello. Invece noi vediamo nella datità che l’oggetto si costituisce nella conoscenza […]» Husserl
(1992), p. 119. Cfr. Brough (2008).
28
Husserl (2002a), p. 209. «Il titolo del problema, che abbraccia l’intera fenomenologia, è l’intenzionalità. Esso
esprime in effetti la proprietà fondamentale della coscienza; tutti i problemi fenomenologici, compresi quelli iletici,
trovano posto in esso» ivi, p. 361. «I momenti di coscienza si dicono anche intenzionali, ove però la parola
intenzionalità non significa altro che questa proprietà universale e fondamentale della coscienza, di esser coscienza di
qualcosa, di portare in sé come cogito il suo cogitatum» Husserl (1997a), p. 64.
29
«Lo statuto ontologico dell’oggetto è il suo carattere intenzionale. La pretesa di realtà, ad esempio, è propria degli
oggetti di percezione e non di quelli di fantasia. Con la pretesa di realtà è dato un caratteristico stile di trascendenza e
uno corrispondente di esperienza. Sarà l’esperienza correttamente perseguita a decidere se l’oggetto in questione è, fino
a prova contraria, reale nel modo in cui pretende di esserlo» De Monticelli (2000), p. 13.
30
Cfr. Husserl (1992), p. 72.
31
Ivi, p. 74.
32
Ivi, pp. 100 s.
33
Reinach (2008), p. 180.
25
104
�Elementi per una nuova fenomenologia dell’a priori culturale
sensibile, perché l’esperienza intuitiva dell’essenza, «il suo afferramento intuitivo non implica
affatto la posizione di una qualunque esistenza individuale»34. Anzi «bisogna persuadersi che al
vissuto empirico si contrappone, come presupposto del suo senso, il vissuto assoluto; che
quest’ultimo non è una costruzione metafisica, bensì qualcosa che si mostra in maniera indubitabile
nella sua assolutezza attraverso un corrispondente mutamento di atteggiamento, e che si offre alla
intuizione diretta»35.
Questa breve incursione nei fondamentali della teoria fenomenologica dovrebbe servire a
puntualizzare alcune questioni emergenti da quella diplopia teoretica che cerca di giustificare il
metodo applicandolo preventivamente al metodo stesso. Ad esempio, il fenomenologo che indaga le
modalità e la struttura intenzionale della conoscenza, cerca di isolare e descrivere la rete dinamica
di vissuti tramite cui enti, realtà mondane, idealità, ecc. si costituiscono nella sfera immanente della
coscienza, incluse le più sofisticate elaborazioni teoretiche e le conoscenze scientifiche. Ora, tra
tutte le attività cognitive di livello superiore dovrebbero a rigore rientrare anche le medesime
operazioni mentali compiute in atteggiamento riflessivo dal fenomenologo, quando egli appunto si
impegna ad analizzare le configurazioni essenziali della coscienza. In altre parole, anche la
tematizzazione dell’intenzionalità operata dal fenomenologo, è a sua volta un’operazione
intenzionale e dunque non si vede perché l’analisi dei vissuti in cui si dispiega la coscienza non
dovrebbe essere senz’altro estesa anche a quella sua particolare declinazione che è la vita fungente
del fenomenologo in azione.
Si tratta di una questione che soprattutto Eugen Fink ha cercato di risolvere, provando a
distinguere tra una coscienza “fenomenologizzante” e la coscienza abitualmente impegnata nei
procedimenti di costituzione intenzionale del mondo36. In breve, l’io fenomenologizzante dovrebbe
essere caratterizzato da una specifica intenzionalità che potremmo definire “di coglimento”,
contrapposta all’intenzionalità posizionale della coscienza, quella che pone la tesi generale
dell’atteggiamento naturale. In ogni caso, anche l’atto del coglimento, così come quello della
descrizione, per quanto operanti in regime di sospensione, dovrebbero mantenere necessariamente
una loro struttura intenzionale.
L’io fenomenologizzante, pur attraverso l’esercizio dell’epoché e l’operazione della riduzione,
nel suo vedere e cogliere direttamente una specifica e assoluta datità, non si vede perché non
dovrebbe eseguire comunque un atto caratterizzato da una sua specifica intenzionalità37. Ma
ammettendo ciò, il residuo fenomenologico dell’epoché e del conseguente coglimento, più che
essere una autodatità assoluta, si rivelerebbe come il noema di un atto intenzionale, un atto operato
da una specifica noesis, quella del fenomenologo, e dunque anch’esso frutto di un’intenzionalità
costitutiva di senso38. In questo caso ci troveremmo di fronte a un’autodatità che, essendo
intenzionalmente costituita, a rigore non può essere un’autentica autodatità. Qual è allora la
possibilità effettiva di compiere le operazioni prescritte da Husserl ed esercitare finalmente lo
sguardo puro richiesto dall’atteggiamento fenomenologico? La riflessione della fenomenologia su
sé stessa conduce a delle zone d’ombra e mostra aspetti non sufficientemente indagati39.
34
Husserl (2002a), p. 20.
Ivi, p. 139.
36
«Se l’oggetto della dottrina trascendentale degli elementi è la costituzione del mondo […], il “soggetto” ne è lo
spettatore trascendentale, l’io fenomenologizzante» Fink (2009), p. 24.
37
«È in qualche modo ancora “costituente” lo spettatore trascendentale che alla costituzione del mondo non prende
parte? E, nel caso, quale senso avrebbe ancora la “costituzione”?» (Ivi, p. 25). E più avanti, Fink si chiede: «il fare che
interroga e chiarisce costitutivamente (la scoperta della costituzione), è esso stesso “costituente”?» (Ivi, p. 34).
38
Cfr. Overgaard (2015), p. 189.
39
«Dunque qualcosa di ancora inafferrato permane nel campo della “trascendentalità”: per l’appunto, lo “spettatore”
fenomenologicamente teorizzante. Null’altro appunto che questo spettatore è il tema della dottrina trascendentale del
metodo che, quindi, è la scienza fenomenologica del fenomenologizzare, la fenomenologia della fenomenologia» Fink
(2009), p. 25.
35
105
�Stefano Gonnella
3. L’evidenza dell’evidenza
L’impianto della fenomenologia husserliana è fin dai suoi albori quello di una istituenda scienza
filosofica, che per dispiegarsi ritiene indispensabile sviluppare una riflessione trascendentale il cui
compito è dissolvere le oscurità e le contraddizioni che affliggono il sapere scientifico e filosofico,
indagando l’essenza della conoscenza e chiarendo il senso essenziale dell’oggettualità in generale 40.
Secondo questa impostazione, il compito di una critica della conoscenza potrebbe essere svolto
solamente da una fenomenologia intesa come dottrina delle essenze, dotata di un metodo capace di
isolare in piena evidenza delle datità originarie e assolute, a partire dalle quali comprendere e
spiegare ogni conoscenza particolare in maniera fondata e definitiva41.
In questo procedimento, l’evidenza che caratterizza e accompagna il coglimento intuitivo delle
strutture essenziali dei fenomeni indagati, viene ritenuta sufficiente a garantire i risultati
dell’indagine42. Tuttavia, la sospensione che colpisce tutte le certezze del senso comune e ogni
sapere scientifico al fine di ricondurne la validità al loro fondamento ultimo, non sospende anzi
mantiene saldo il presupposto che debba esserci qualcosa come un fondamento della conoscenza e
confida che l’esercizio dell’epoché possa in qualche modo aprire la strada che conduce al suo
coglimento43.
Abbiamo detto che l’atteggiamento fenomenologico dovrebbe consistere (coincidere) con una
intenzionalità di coglimento, distinta dall’intenzionalità posizionale. L’analisi fenomenologica si
svolge in stato sospensivo, sospende ogni Sinnssetzung ed ogni Seinssetzung, ovvero sospende le
attività di tipo posizionale – sia di senso che di esistenza – che caratterizzano la coscienza in
atteggiamento naturale. Il suo metodo non può quindi fare ricorso all’intenzionalità del soggetto
empirico, bensì chiede di fondarsi su una visione d’essenza in grado di cogliere ed articolare la
struttura dell’evidenza originaria, raggiunta attraverso la riflessione fenomenologica e la libera
variazione immaginativa. Ma se il metodo fenomenologico consiste appunto in una serie di
tecniche, di pratiche, di protocolli che possono e debbono essere applicati evitando qualsiasi
Setzung, occulta o esplicita che sia, è inevitabile porsi la questione dello statuto e delle condizioni di
possibilità della fenomenologia stessa.
Ad esempio, seguendo una suggestione che ha interessato alcuni fenomenologi, l’idea che si
diano delle essenze adeguatamente intuite e assolutamente date, delle datità ultime dotate di una
valenza universale, sembrerebbe implicare che in qualche misura il cosiddetto atteggiamento
naturale, l’atteggiamento che intende i propri costrutti come delle datità in sé e non come l’esito di
un’attività posizionale di senso e di esistenza, non sia comunque passibile di essere completamente
sospeso, messo tra parentesi, e mantenga invece una sorta di ipoteca nascosta sul procedimento
dell’analisi fenomenologica 44.
La sfida più ardua per la fenomenologia consiste appunto nel tematizzare ciò che viene
preventivamente esentato dal vaglio analitico, cercando di verificare se si tratti o meno di un suo
presupposto dogmatico non ancora indagato a sufficienza. «L’autoconsapevolezza trascendentale
del compito che alla fenomenologia è assegnato consiste anzi nel rendersi conto che non vi sono
dati che si offrono nella loro incontaminata purezza, che ogni dato è già il risultato di complicate
40
Cfr. Husserl (1992), p. 60. «L’analisi è in ogni passo analisi d’essenza e indagine degli stati di cose generali da
costituirsi nell’intuizione immediata. […] La fenomenologia procede per sguardi chiarificatori, determinazioni di senso
e distinzioni di senso. Essa confronta, distingue, collega, pone in relazione, divide in parti, o separa momenti. Ma tutto
ciò entro il puro guardare» (Ivi, pp. 96 s.).
41
Cfr. Husserl (2002a), p. 53. «According to Husserl, to philosophize means to search for the act that is the absolute
starting point and to derive all knowledge from that. For Husserl, transcendental consciousness is and remains that
starting point» Mizuno (1979), p. 37.
42
Cfr. Husserl (1997a), p. 84. «Fin dove arriva l’intuizione, l’avere coscienza intuitivo, giunge anche la possibilità
della corrispondente “ideazione” (come ero solito dire nelle Ricerche logiche) o della “visione d’essenza”. Nella misura
in cui l’intuizione è un’intuizione pura [...], l’essenza intuita è un che di adeguatamente intuito, un che di assolutamente
dato» Husserl (1994a), p. 55. Cfr. Paci (1959), p. 148.
43
Cfr. Lanfredini (1994), p. 60.
44
Cfr. De Boer (1980), pp. 108 ss.; Nedel (1995), p. 295.
106
�Elementi per una nuova fenomenologia dell’a priori culturale
operazioni intenzionali»45. Lasciando in sospeso la questione se questa autoconsapevolezza della
fenomenologia sia o meno di natura trascendentale, questa costatazione ripropone la perplessità
teoretica di cui stiamo cercando di seguire alcuni esiti.
Attraverso una ricognizione dei manoscritti husserliani del Gruppo F, Vorlesungen und Vorträge,
Vincenzo Costa ha messo a fuoco alcuni aspetti non molto frequentati della riflessione di Husserl
sul ruolo e il senso della storia nei processi di costituzione intenzionale operati dalla soggettività
trascendentale, ponendo il problema dello statuto della visione di essenza su cui si basa il metodo
fenomenologico nella sua modalità statica46. Ritorna l’obiezione già avanzata da De Boer, ossia il
fatto che non è l’essenza che viene a manifestarsi nella variazione, bensì la variazione è sin da
principio guidata dall’essenza 47. «Se l’eidos si è costituito, e se la costituzione è un processo
genetico, allora l’eidos si è costituito in una storia: ma questa irruzione della storicità non apre un
varco alla fattualità bruta e selvaggia delle tradizioni culturali?» 48.
4. Con e oltre la fenomenologia husserliana
In un suo articolo dedicato alle ricerche svolte da Gerhard Funke sulla fenomenologia
trascendentale, Jan Patočka nota come l’operazione della riduzione metta capo ad una ontologia in
cui la realtà si manifesta attraverso la mediazione del vissuto intenzionale, ma assumendo alcuni
taciti presupposti non giustificati fenomenologicamente 49. Secondo l’impianto fenomenologico
ortodosso, l’atto di riflessione che apre l’accesso alla sfera delle datità immanenti afferma al
contempo la presenza immediata della soggettività, ponendo surrettiziamente la tesi dell’ego senza
indagarla né rendere conto della sua effettiva possibilità. Ora, si domanda Patočka, cosa accadrebbe
se questa tesi della coscienza egocentrata venisse sottoposta all’epoché? Se il fenomenologo
estendesse la sospensione anche alla presenza dell’ego, ritenuta ovvia? Forse potremmo scoprire
che la presunta immediatezza della coscienza a sé stessa, della autodonazione dell’ego, è in realtà
un pregiudizio che impedisce di cogliere l’effettivo a priori, fungente sullo sfondo, che rende
possibile, tra l’altro, il manifestarsi di un io nel campo della coscienza50.
L’epoché così intesa, prosegue Patočka, potrebbe allora essere lo strumento idoneo per mettere
finalmente fuori gioco ogni presunta esistenza, mondana o meno che sia, consentendo l’accesso non
più solamente a ciò che appare, bensì anche all’apparire in quanto tale51. Dell’io non facciamo mai
esperienza direttamente, mentre abbiamo a che fare con una struttura della manifestazione che
chiamiamo mondo e che viene culturalmente impaginata ricorrendo all’io come centro
d’organizzazione52.
L’epoché radicale proposta da Patočka potrebbe dunque aprire la via d’accesso al campo di
manifestazione universale dove appaiono sia il mondo che il soggetto dell’esperienza53. Quanto alla
possibilità di intuire direttamente le proprie cogitationes ricorrendo ad uno sguardo interiore
concepito sul modello dello sguardo esteriore, secondo Patočka non è altro che un mito54. Dunque,
una visione dell’apparire in quanto tale sarebbe possibile solo a condizione che l’unico vero a priori,
l’a priori del mondo, venga liberato dal suo fungere anonimamente e finalmente tematizzato in
45
Costa (1999), p. 29.
In effetti, «questa caratteristica ‘storicità’ della soggettività trascendentale sembra rendere problematico il metodo
eidetico e la sua pretesa di giungere ad universali astorici» Ivi, p. 30.
47
Ibidem: «Poiché infatti nella variazione eidetica è l’eidos stesso che deve guidare la variazione, dato che l’essenza
deve già essere nota perché possa essere riconosciuta, allora ciò “significa − scrive lo stesso Husserl − che essa è
passivamente già costituita, e la visione dell’eidos si basa nell’afferramento intuitivo attivo di ciò che è così già
costituito” [Husserl, Erfahrung und Urteil, p. 414]. Ma non si crea così una circolarità? Passivamente già costituito da
chi e come? Da quale soggettività? E in quale tempo? Oppure fuori dal tempo?».
48
Ibidem.
49
Cfr. Patočka (1988b), pp. 256 s.
50
Ivi, p. 257.
51
Cfr. Ibidem.
52
Cfr. Ivi, p. 258.
53
Cfr. Ivi, p. 259.
54
Cfr. Ivi, pp. 258 s.
46
107
�Stefano Gonnella
quanto fenomeno. Essendo questo anche il modo più corretto per accedere alla dimensione della
soggettività rispettando e comprendendo il suo effettivo statuto ontologico 55.
Al di là delle molteplici considerazioni che suggerisce questo testo, è appena il caso di notare
come l’idea di una fenomenologia asoggettiva, non egocentrata, qui solo fugacemente accennata,
venga sviluppata da Patočka nel tentativo di dissipare alcune oscurità rilevate nell’assegnazione di
limiti all’applicazione dell’epoché, provando così a rendere conto, fenomenologicamente, di quanto
effettivamente si dà nel campo analitico di presenza, ovvero attenendosi a dirette osservazioni fatte
in prima persona, e aprendo un conseguente percorso di autocritica della fenomenologia 56.
Un altro sentiero verso la fenomenologia della fenomenologia è quello tracciato dalle riflessioni
di Marc Richir, il quale, come Patočka, affronta il tema della Lebenswelt nel tentativo non tanto di
risolvere o dissolvere la questione filosofica del fondamento, quanto di chiarire il senso di alcune
ovvietà comunque fungenti, più o meno occultamente, anche nell’apparato concettuale
fenomenologico57. Rispettando i protocolli dell’analisi fenomenologica, ma cercando di
radicalizzarne l’applicazione, Richir segnala acutamente come il concetto stesso di mondo-dellavita sia in realtà sovradeterminato da un apparato teoretico che ne deforma sostanzialmente i veri
lineamenti, svuotandolo di quella forza fondazionale che presuntivamente dovrebbe avere, in
quanto dominio di evidenze originarie, come voleva Husserl58. Per Richir, occorre misurare «fino a
che punto le analisi fenomenologiche costitutive delle realtà intramondane e della realtà del mondo
non siano esse stesse sottese, già da sempre, da quelle sustruzioni di cui importa spiegare le
surrezioni»59. In pratica, Richir rovescia la lettura husserliana, che vedeva il mondo delle obiettività
e delle verità scientifiche come una “sustruzione”, ossia come una costruzione razionale – ad
esempio, una teoria scientifica – realizzata a partire dall’esperienza intuitiva del primario e
originario mondo-della-vita e poi postulata come fondamento del mondo-della-vita da cui invece è
derivata60. Di queste sustruzioni, argomenta Richir, occorrerebbe piuttosto spiegare le “surrezioni”,
ossia gli slittamenti o meglio le sottrazioni di senso da loro operate ai danni del mondo-della-vita.
C’è dunque un’ipoteca nascosta in questa immagine del mondo-della-vita che riconosciamo come
tale e viviamo abitualmente solo grazie ad una sua pregressa impaginazione concettuale o più
precisamente, come sostiene Richir, attraverso una sua codificazione simbolica61.
Se all’epoché fenomenologica deve essere assegnato il compito di mettere fuori circuito ogni
apparato e ogni sovrastruttura concettuale capace di alterare e nascondere sotto il velo delle ovvietà
del senso comune e dei costrutti scientifici l’effettivo darsi dei fenomeni, allora si impone una sua
radicalizzazione: l’epoché deve essere estesa fino a sospendere l’ipotizzata originarietà del soggetto
trascendentale, mostrandone piuttosto la concrezione operata da parte di una comunità
intersoggettiva62. Ma questa comunità, prima e ultima titolare dei processi di costituzione di senso
che assegnano al mondo-della-vita la sua forma familiare, non è una comunità di soggetti
trascendentali disincarnati63. Non collocata in un corpo, né codificata e istituita in una collettività
condivisa di lingue, pratiche e discorsi, la comunità pensata da Richir, grado zero della costituzione
di senso, rischia di essere evanescente e inafferrabile. E in effetti, le indicazioni metodologiche su
55
Cfr. Ivi, p. 260.
Cfr. Patočka (1998c), p. 219.
57
«Richir veut mettre l'accent, à l'instar de Fink, sur ce qu'il y a de plus radical dans le projet phénoménologique de
Husserl, à savoir la réduction, grâce à l’époché, de l'ontique au transcendantal. Si les Méditations cartésiennes
soulignent déjà cette radicalité, le radicalisme phénoménologique de Richir la surpasse par l’époché hyperbolique sur
laquelle il repose» Ghitti (1999), p. 586.
58
Cfr. Richir (1990), p. 47.
59
Ibidem.
60
«Il contrasto tra l’elemento soggettivo del mondo-della-vita e del mondo “obiettivo” e “vero” sta semplicemente
in questo: che quest’ultimo è una sustruzione teoretico-logica, la sustruzione di qualche cosa che di principio non è
percettibile, di principio non esperibile nel suo essere proprio, mentre l’elemento soggettivo del mondo-della-vita si
distingue ovunque e in qualsiasi cosa proprio per la sua esperibilità» Husserl (1997b), p. 156.
61
Cfr. Richir (1990), pp. 47 s.
62
Cfr. Ivi, p. 52.
63
Cfr. Ivi, pp. 52 s.
56
108
�Elementi per una nuova fenomenologia dell’a priori culturale
questo punto sembrano sfumare, rinviando ad una sorta di procedimento per sottrazione, in
negativo, da realizzare mettendo tra parentesi tutto l’apparato concettuale occidentale64.
Indicazioni sicuramente inevitabili, se si vuole mantenere l’adesione ai protocolli della
fenomenologia. Tuttavia, una volta aperti “alla incoatività indeterminata dei sensi” di una specifica
comunità, non si comprende bene come possa essere svolta la riflessione fenomenologica
prescindendo dall’impianto concettuale occidentale, il quale, a rigore, dovrebbe abitare anche la
mente del fenomenologo. Resta tuttavia un’ulteriore e promettente indicazione, con la quale Richir
sembra annunciare un futuro percorso di ricerca per la fenomenologia, invitando a sospendere
l’etnocentrismo patologico che preclude o falsifica ogni approccio alle altre culture.
5. Attraverso l’esperienza antropologica
L’esperienza diretta dovrebbe essere la pietra di paragone e il prioritario ambito di giustificazione
degli asserti fenomenologici, tuttavia le riflessioni di Patočka e di Richir evidenziano come alcune
sovrapposizioni concettuali tendano ad alterare l’esperienza diretta di ciò che effettivamente si dà
nel campo analitico, limitando indebitamente l’esercizio dell’epoché e della riduzione. Si tratta di
una questione che ha interessato anche Anthony Steinbock, il quale richiama l’attenzione sul rischio
che queste ipoteche metodologiche intacchino proprio quella datità che dovrebbe invece guidare
l’analisi fenomenologica65.
Ripercorrendo alcune articolate meditazioni di Max Scheler, Steinbock ricorda che l’a priori, in
quanto tale, non può in alcun caso essere un prodotto dell’intelletto o un concetto elaborato dalla
ragione, bensì deve risultare come una datità che organizza il modo in cui incontriamo e
apprendiamo le cose nel mondo66. Le strutture essenziali dell’a priori, in altre parole, guidano e
regolano i modi in cui concepiamo le cose, le analizziamo e formuliamo le nostre asserzioni sul
mondo in cui viviamo 67. Tuttavia, non siamo mai consapevoli di questa funzione di guida delle
nostre percezioni e delle nostre conoscenze svolta dall’a priori68.
Il punto interessante sollevato da Steinbock riguarda il fatto che tale a priori, non essendoci
identità tra tutte le diverse forme di razionalità che si dispiegano nelle varie comunità
intersoggettive, non potrebbe in alcun modo corrispondere a o derivare da una disposizione innata e
invariante dell’uomo in quanto essere razionale, dunque a regolare e impaginare la nostra visione
del mondo sarebbe una sorta di paradossale “a priori culturale”69. Si tratta di una nozione che
richiede sicuramente di essere circostanziata in tutta la sua complessità, ma che apre anche in questo
caso la possibilità di indirizzare le risorse della fenomenologia verso la tematizzazione delle altre
tradizioni culturali, che oltre alla loro “fattualità bruta e selvaggia”, offrono forme di razionalità
semplicemente incommensurabili con la razionalità occidentale 70.
Molte sono le rotte che si potrebbero delineare nell’oceano della letteratura fenomenologica,
seguendo la bussola di queste brevi annotazioni, ma è senz’altro il caso di ricordare che si tratta
comunque di percorsi già intravisti da Husserl, con la lucidità e la consueta umiltà, con la quale
affrontava i problemi suscitati dal suo stesso procedere. Ad esempio si potrebbe citare il famoso
carteggio con Lucien Lévy-Bruhl, di cui parlava già nel 1951 Merleau-Ponty. «È auspicabile che si
64
«Bisogna quindi (…) mettere fuori gioco tutta la nostra concettualità occidentale, filosofico-scientifica, per aprirci
alla incoatività indeterminata dei sensi da cui si potrà generare la nostra riflessione (fenomenologica) su ciò che è già
riflessione di questa o quella istituzione simbolica, socio-politica, nei suoi orizzonti simbolici di senso. In tal modo,
l’apertura alla Lebenswelt fungerà per lo meno da istanza critica rispetto a ogni etnocentrismo, a ogni approccio alle
altre culture che vede in esse solamente delle modalità deficienti rispetto alla nostra» Ivi, p. 53.
65
«At issue for phenomenology most radically are modes of givenness. The fact that phenomenology is distinctive
by virtue of its attention to givenness makes it all the more imperative for us not simply to presuppose the type or model
of givenness in play or to exclude arbitrarily other possible modes of givenness» Steinbock (2004), p. 160.
66
Cfr. Ivi, p. 170.
67
Cfr. Ivi, p. 171.
68
Cfr. Ibidem.
69
Cfr. Ivi, p. 172.
70
Cfr. Ivi, p. 173.
109
�Stefano Gonnella
possa leggere presto, nelle opere complete di Husserl, la lettera che egli scrisse a Lévy-Bruhl l’11
marzo 1935, dopo aver letto La mythologie primitive. In questa lettera egli sembra ammettere che il
filosofo non può raggiungere immediatamente un universale di semplice riflessione e che non è in
grado di fare a meno dell’esperienza antropologica, né di costruire, mediante una variazione
semplicemente immaginaria delle proprie esperienze, ciò che costituisce il senso delle altre
esperienze e delle altre civiltà»71.
Questa apertura all’antropologia e all’etnologia sembra nascere dal riconoscimento di alcuni
limiti dell’impianto analitico della fenomenologia classica72. Ad essere messi in questione sono il
metodo della libera variazione immaginativa, non più ritenuta sufficiente a isolare delle strutture
eidetiche universali, e la presunta autotrasparenza della riflessione, la quale «non è più il ritorno a
un soggetto pre-empirico detentore delle chiavi del mondo»73. Si dà il caso che per concepire un
soggetto pre-empirico occorra postulare l’esistenza di una struttura intenzionale universale e
condivisa da tutte le comunità umane, annichilendo così in partenza l’alterità dell’altro74.
Si può e si deve dunque intraprendere un nuovo cammino di ricerca. Tuttavia, come nota ancora
Merleau-Ponty, «[l]’analisi intenzionale che ritroverà e ricostruirà le strutture del mondo arcaico
non potrebbe limitarsi a esplicitare quelle del nostro: ciò che dà senso a tali strutture è infatti
l’ambiente, l’Umwelt, di cui esse sono lo stile tipico; non si può dunque comprenderle se non si
comprende come il tempo scorra e come l’essere si costituisca in quelle culture»75.
Queste considerazioni ci ricordano che le operazioni analitiche del fenomenologo si svolgono
sempre all’interno di una cultura, quella occidentale, i cui modelli di razionalità e i cui paradigmi di
spazio e di tempo vengono assunti come assoluti ed occultamente proiettati in qualsiasi campo di
indagine76. Si tratta allora, come abbiamo intravisto, di provare a radicalizzare la sospensione,
abbandonando l’idea di poter raggiungere in piena evidenza, con un atto di intuizione, la datità
assoluta dell’universale, e farsi invece carico della propria determinazione culturale, aprendo un
nuovo ambito di ricerca, rivolto questa volta all’esperienza antropologica e all’incontro con le altre
culture77.
Questo non significa chiudere il discorso della fenomenologia dirottandolo definitivamente verso
altre discipline, bensì vuol dire allargare il campo di applicazione e la portata del lavoro
fenomenologico78. Abbracciando di nuovo e rilanciando l’idea di Husserl della filosofia come
compito infinito, intesa non più come impegno di un singolo pensatore, bensì come impresa
collettiva di generazioni di ricercatori79. Ma per fare questo occorre esercitare, portando alle
estreme conseguenze la fenomenologia della fenomenologia, una radicale sospensione di tutti i
presupposti, a partire da quelli ritenuti insospendibili dall’analitica classica husserliana,
riconoscendone innanzitutto la natura di costrutti culturali di cui occorre indagare la genesi80.
71
Merleau-Ponty (2003b), p. 146. Diversi anni dopo l’auspicio di Merleau-Ponty, la lettera è stata pubblicata in
Husserl (1994b), pp. 161-164; cfr. Husserl (1994b), Sato (2014), Buongiorno (2010).
72
Cfr. Depraz (1993), p. 123.
73
Merleau-Ponty (2003b), p. 142. Cfr. Merleau-Ponty (1965), p. 93.
74
Cfr. Depraz (1993), p. 119.
75
Ivi, pp. 146 s.
76
Cfr. Conci, Ales Bello (1991). Cfr. Conci (2001).
77
Cfr. Derrida (1987).
78
«Se il filosofo non si attribuisce più il potere incondizionato di pensare da parte a parte il proprio pensiero – se
ammette che le sue “idee”, le sue “evidenze” sono sempre, in una certa misura, ingenue e che (essendo prese nel tessuto
della cultura cui egli appartiene) per conoscerle in verità non basta scrutarle e farle variare nel pensiero, ma bisogna
confrontarle con altre formazioni culturali, vederle sullo sfondo di altri pregiudizi –, non ha con ciò abdicato, e rimesso
i suoi diritti alle discipline positive e alla ricerca empirica? Niente affatto» Merleau-Ponty (2003b), p. 147.
79
Cfr. Gurwitsch (2009), p. 308.
80
«Parlando di deviazione attraverso la simbolica, mettevo in questione un presupposto comune a Husserl e a
Descartes, e cioè l’immediatezza, la trasparenza, l’apoditticità del Cogito. Il soggetto, affermavo, non conosce se stesso
in maniera diretta, ma soltanto attraverso i segni depositati nella sua memoria e nel suo immaginario dalle grandi
culture. Questa opacità del Cogito non concerneva, in linea di principio, la sola esperienza della volontà cattiva, ma
tutta la vita intenzionale del soggetto» Ricœur (1998), p. 41.
110
�Elementi per una nuova fenomenologia dell’a priori culturale
Bibliografia
Behnke, E.A. (2010), Working Notions: A Meditation on Husserlian Phenomenological Practice, in
Nenon, T-Blosser, P. (Eds.), Advancing Phenomenology. Essays in Honor of Lester Embree,
Springer, Dordrecht-Heidelberg-London-New York, pp. 45-70.
Brough, John B. (2008), “Consciousness is not a Bag: Immanence, Transcendence, and Constitution
in The Idea of Phenomenology”, Husserl Studies, vol. 24, n. 3, pp. 177-191.
Cairns, D. (2002), The First Motivation of Transcendental Epoché, in Zahavi, D.-Stjernfelt, F.
(Eds.), One Hundred Years of Phenomenology. Husserl’s Logical Investigations Revisited,
Kluwer, Dordrecht-Boston-London, pp. 219-231.
Bertels, Petersma (a cura di) (1980), Filosofi del XX secolo, Armando Editore, Roma.
Buongiorno, F. (2010), “Die anthropologische Welt. La ricerca husserliana per un’antropologia
fenomenologica”, Lo Sguardo. Rivista di Filosofia, vol. 3, n. 4, pp. 1-13.
Conci, D. A.-Ales Bello, A. (1991), Per una antropologia fenomenologica. Ragioni e metodo, in
AA. VV., Ethos e cultura. Studi in onore di Ezio Riondato, vol. I, Editrice Antenore, Padova, pp.
573-598.
Conci, D. A. (2001), I selvaggi e noi. Una relazione conoscitiva inedita, in Cavazzoli, L. (a cura di),
La diversità in età moderna e contemporanea, Name, Genova, pp. 105-117.
Conni, C. (2005), Identità e strutture emergenti. Una prospettiva ontologica dalla Terza ricerca
logica di Husserl, Bompiani, Milano.
Costa, V. (1999), L’estetica trascendentale fenomenologica. Sensibilità e razionalità nella filosofia
di Edmund Husserl, Vita e Pensiero, Milano.
De Boer, Th. (1980), Edmund Husserl, in Bertels, C. P.-Petersma, E. J. (a cura di), Filosofi del XX
Secolo, Armando, Roma, pp. 101-114.
De Monticelli, R. (1998), La conoscenza personale. Introduzione alla fenomenologia, Guerini,
Milano.
De Monticelli, R. (2000), “L’intenzionalità e la pietra filosofale (ovvero, quello che ha veramente
detto Husserl)”, Rivista di estetica, n.s., 14, 2, anno 40, pp. 13-15.
De Monticelli, R. (2005), Prefazione, in Conni, C., Identità e strutture emergenti. Una prospettiva
ontologica dalla Terza ricerca logica di Husserl, Bompiani, Milano, pp. 7-19.
Depraz, N. (1993), “L’ethnologue, un phénoménologue qui s’ignore? L'apport de la
phénoménologie
aux
sciences
sociales”,
Genèses,
vol.
10,
pp.
108-123,
https://doi.org/10.3406/genes.1993.1159.
Derrida, J. (1987), Introduzione a Husserl, L'origine della geometria, trad. it. a cura di C. Di
Martino, Jaca Book, Milano.
Di Martino, C. (2007), “Esperienza e intenzionalità nella fenomenologia di Husserl”, Memorandum,
vol. 13, pp. 32-52.
Di Martino, C. (2012a) (a cura di), Attualità della fenomenologia, Rubbettino, Soveria Mannelli.
Di Martino, C. (2012b), Introduzione, in Id. (a cura di), Attualità della fenomenologia, Rubbettino,
Soveria Mannelli 2012, pp. 9-22.
Embree, L. (2005), “Continuing Husserlian Phenomenology”, On the Future of Husserlian
Phenomenology, Internet project organized by the Husserl Archives at the New School for Social
Research
in
Memory
of
Alfred
Schutz,
New
York,
October
2005,
http://www.newschool.edu/nssr/ husserl/Future/Part%20One/Embree.html.
Embree, L. (2011), Reflective Analysis. A First Introduction into Phenomenological Investigation,
Zeta Books, Bucharest; Analisi riflessiva. Una prima introduzione all’investigazione
fenomenologica, trad. it. a cura di A. Bottone, Edizioni Studium, Roma.
Fink, E. (2009), VIª Meditazione Cartesiana. L’idea di una dottrina trascendentale del metodo
(Parte I), Franco Angeli, Milano.
111
�Stefano Gonnella
Ghitti, J.-M. (1999), “Les Méditations phénoménologiques de Marc Richir”, Revue Philosophique
de Louvain, vol 97, n. 3-4, pp. 581-605.
Gurwitsch, A. (2009), Some Fundamental Principles of Constitutive Phenomenology, in The
Collected Works of Aron Gurwitsch (1901-1973), vol. I, Springer, Dordrecht-HeidelbergLondon-New York, pp. 307-329.
Husserl, E. (1975), Introduction to the Logical Investigations. A Draft of a “Preface” to the Logical
Investigations, 1913, M. Nijhoff, The Hague.
Husserl, E. (1988), Ricerche logiche. Vol. I, trad. it. a cura di G. Piana, Il Saggiatore, Milano.
Husserl, E. (1992), L’idea della fenomenologia, a cura di C. Sini, Laterza, Roma-Bari.
Husserl, E. (1994a), La filosofia come scienza rigorosa, trad. it. a cura di C. Sinigaglia, Laterza,
Roma-Bari.
Husserl,
E.
(1994b),
Briefwechsel.
Husserliana
Dokumente,
Band
III/7.
Wissenschaftlerkorrespondenz, Kluwer, Dordrecht, pp. 161-164.
Husserl, E. (1997a), Meditazioni cartesiane, trad. it. a cura di F. Costa, Bompiani, Milano.
Husserl, E. (1997b), La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, trad. it. a.
cura di E. Filippini, Il Saggiatore, Milano.
Husserl, E. (2002a), Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica. I, trad. it.
a cura di V. Costa, Einaudi, Torino.
Husserl, E. (2002b), Postilla alle Idee, in Id., Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia
fenomenologica. I, trad. it. a cura di V. Costa, Einaudi, Torino., pp. 418-434.
Husserl, E. (2008), “Lettera a Lucien Lévy-Bruhl di Edmund Husserl”, trad. it. a cura di V. De
Palma, Studi culturali, vol. 5, n. 1, pp. 75-82.
Lanfredini, R. (1994), Husserl. La teoria dell’intenzionalità, Laterza, Roma-Bari.
Leoni, F. (2005), Senso e crisi. Del corpo, del mondo, del ritmo, ETS, Pisa.
Merleau-Ponty, M. (1965), Fenomenologia della percezione, trad. it. a. cura di A. Bonomi,
Bompiani, Milano.
Merleau-Ponty, M. (2003a), Segni, trad. it. a cura di A. Bonomi, Il Saggiatore, Milano.
Merleau-Ponty, M. (2003b), Il filosofo e la sociologia, in Id., Segni, trad. it. a cura di A. Bonomi, Il
Saggiatore, Milano, pp. 135-153.
Merleau-Ponty, M. (2003c), Il visibile e l’invisibile, trad. it. a. cura di A. Bonomi, Bompiani,
Milano.
Mezzanzanica, M. (2001), “La discussione tra Husserl e Fink e l’idea di una fenomenologia della
fenomenologia”, Magazzino di filosofia, n. 5, n. 2, pp. 63-80.
Mizuno, K. (1979), “The Paradox of the Phenomenological Method”, Analecta Husserliana, vol. 8,
pp. 37-53.
Nedel, A. (1995), “Of Intentional Consciousness. Pattern, Constitution, and Behavior (A New
Approach to a Post Hoc Reading of Husserl’s Ideas I)”, Philosophy Today, vol. 39, n. 3, pp. 295310.
Overgaard, S. (2015), “How to Do Things with Brackets: The Epoché Explained”, Continental
Philosophy Review, vol. 48, n. 2, pp. 179-195.
Paci, E. (1959), “Tempo e riduzione in Husserl”, Rivista di filosofia, vol. 50, n. 2, pp. 146-179.
Paci, E. (1963), Funzione delle scienze e significato dell’uomo, Il Saggiatore, Milano.
Patočka, J. (1998a), Qu’est-ce que la phénoménologie?, J. Millon, Grenoble.
Patočka, J. (1998b), Epoché et réduction, in Id., Qu’est-ce que la phénoménologie?, J. Millon,
Grenoble, pp. 249-261.
Patočka, J. (1998c), Le subjectivisme de la phénoménologie husserlienne et l’exigence d’une
phénoménologie asubjective, in Id., Qu’est-ce que la phénoménologie?, J. Millon, Grenoble., pp.
217-248.
Patočka, J. (2010), Che cos’è la fenomenologia? Movimento, mondo, corpo, trad. it. a cura di G. Di
Salvatore, Edizioni Fondazione Centro Studi Campostrini, Verona.
112
�Elementi per una nuova fenomenologia dell’a priori culturale
Reeder, H. P. (2010), The Theory and Practice of Husserl’s Phenomenology, Zeta Books,
Bucharest.
Reinach, A. (2008), La visione delle idee, trad. it. a cura di S. Besoli e A. Salice, Quodlibet,
Macerata.
Richir, M. (1990), Per una riabilitazione della “Lebenswelt”: tempo, storicità, storia nella
fenomenologia, in Vattimo, G. (a cura di), Filosofia 89, Laterza, Roma-Bari, pp. 45-61.
Ricœur, P. (1998), Riflession fatta. Autobiografia intellettuale, trad. it. a cura di D. Iannotta, Jaca
Book, Milano.
Ronchi, R. (a cura di) (2006), Filosofia teoretica (1968-2008). Una introduzione, UTET, Torino.
Sato, Y. (2014), “The Way of the Reduction via Anthropology: Husserl and Lévy-Bruhl, MerleauPonty and Lévi-Strauss”, Bulletin d’analyse phénoménologique, vol. 10, n. 1, pp. 1-18.
Seron, D.-Giovannangeli, D. (2002), “Jacques Derrida’s Profound and Radical Questioning of
Husserlian Phenomenology”, Analecta Husserliana, vol. 80, pp. 460-469.
Sini, C. (1965), La fenomenologia, Garzanti, Milano.
Sini, C. (2000), Idoli della conoscenza, Cortina, Milano.
Steinbock, A. (2004), Personal Givenness and Cultural a prioris”, in Carr, D.-Cheung, C.-F. (Eds.),
Space, Time, and Culture, Springer, Dordrecht, pp. 159-176.
Sukale, M. (1976a), Comparative Studies in Phenomenology, Martinus Nijhotf, The Hague.
Sukale, M. (1976b), World and Epoché in Husserl and Heidegger, in Id., (1976a), Comparative
Studies in Phenomenology, Martinus Nijhotf, The Hague, pp. 101-120.
Vanzago, L. (2006), Io/Altro, in Ronchi (a cura di), Filosofia teoretica (1968-2008). Una
introduzione, UTET, Torino, pp. 87-112.
Abstract
At the heart of the phenomenological method lies the move of epochè, whose residual should be
caught by a phenomenologizing consciousness quite different from the natural consciousness
involved in the intentional constitution of the world. However, this phenomenological residual is
part and parcel of an intentional act performed by the phenomenologist as well. Thus, the filling of
the eidetic structures unveiled by the epochè should correspond to a peculiar noema of this
“catching intentionality”. The paper suggests to suspend the hidden belief in the absolute evidence
of the residual of the epochè and to take on the issue of its cultural definition. This choice doesn’t
mean to leave the phenomenological way, rather it requires to sharpen the analytical tools of
phenomenology through a more radical performance of epochè (E. Fink, M. Henry, M. Richir), and
to reintroduce the research about the still neglected cultural a priori (A. Gurwitsch, D. A. Conci, A.
Steinbock) across phenomenological anthropology (M. Merleau-Ponty, A. Schütz, L. Embree).
Keywords: Cultural A Priori,
Phenomenological Residual
Epochè,
Intentionality,
113
Phenomenological Anthropology,
�BURT C. HOPKINS*
Remarks on Appearing and Appearance in Husserl
1. The Dialectical Context of Appearance in Plato
In Plato the “phainomenon” occurs in the dialectical investigation of the unknown, the context of
which is the mutual recognition in the souls of the interlocutors in a dialogue that the sought-after
knowledge of what they are talking about is not in their possession. It thus means not simply
“appearance” but more precisely the appearance in speech (logos) of what is sought after but
recognized by the soul (at that moment, at least) to be unknown. In order for what is unknown to
nevertheless show up as an appearance, speech must posit it as something already known, in the full
knowledge that what is posited is only a supposition (hypothesis). The speech of a soul with
knowledge of its ignorance is therefore the medium of appearance. Examples of appearances in Plato
include virtue, piety, knowledge, being, false speech, Eros, beauty, the sophist, the statesman, etc. One
consequence of the cognitive context of the Platonic phainomenon is that its truth status is initially
necessarily in question, because as the appearance of what is sought-after and therefore unknown, it
cannot be established at the outset whether what appears is a likeness (eikon) to what is sought-after or
only its distorting semblance (phantasma). Eventually, it is established that the true sources (archai) of
the manifestation of the visible appearances in perception (phantasia) and public opinion (doxa) are
the appearances (phainomena) of invisible forms (eidê) in dialectical speech. Because complete
knowledge of the eidê is not the provenance of mortals, however, separating their likeness from their
semblance in their appearance is the work of a non-demonstrative science, namely, philosophy,
understood as dialectic.
2. The Incorrigible Status of Appearance in Aristotle
In Aristotle, the appearance is initiated by sense perception (aisthêsis), which is posited as intrinsically
true, in the sense of being the incorrigible reception of the intelligible form (eidos) of the being that is
beyond the “porch” of the soul, whose action upon the soul leaves in it its lasting impression: the
visible form (morphê) of the image (phantasm). As incorrigible, the content of the appearance is in
complete fidelity with its eidetic source (archê) and therefore cannot be corrected vis- à-vis its origin.
The medium of appearance is therefore exclusively the soul. Appearance, as the phantasm unmediated
by logos, thus for Aristotle rules out semblance from the start. Moreover, in their function as the
inseparable basis for knowledge of the eide of the beings external to the soul, the phantasmata rule out
semblance from the appearances of the eidê in the soul as well. Investigation of the eidê is therefore
the work of not only a demonstrative science, but the highest such science, first philosophy (prôtê
philosophia), which investigates the sources (archai) and causes of the forms present in all things that
have being (ousia).
_____________________________
*
Université de Lille | UMR-CNRS 8163 STL
Bollettino Filosofico 33 (2018): 114-128
ISSN 1593 -7178 - 00030
E-ISSN 2035 -2670
DOI 10.6093/1593-7178/5942
�Remarks on Appearing and Appearance in Husserl
3. Continuity and Departure from Plato and Aristotle of Appearance in Husserl
Appearance in Husserl, like in Plato, initially occurs within a cognitive context, namely, the
investigation of the source and legitimacy of the ideal units of meaning appealed to but unaccounted
for by the science of knowledge’s account of the foundations of mathematics and logic. However, like
Aristotle, sense perception initiates the appearance in the soul, with the consequent impression, again
like Aristotle, being incorrigible. The medium of the appearance is therefore exclusively the soul,
which means that for Husserl like Aristotle, what appears is initially unmediated by logos. Moreover,
in contrast to Plato, where the condition necessary for the appearance is the positing of the unknown in
the guise of something already known, for Husserl, as for Aristotle, the condition necessary for the
appearance is the impression left in the soul by the external object.
However, unlike in either Plato or Aristotle, for Husserl the soul’s knowledge of the appearance is a
function of its perceptual relation to itself, rather than a function of the logos of souls with a
knowledge of their ignorance, as in Plato, or of a demonstrative science of the archai of the forms of
things that have being, as in Aristotle. Husserl denominated the soul’s perceptual self-relation
reflection, which he misleadingly characterized as “inner intuition” or “inner perception”; misleadingly
because it invited and continues to invite the misunderstanding that ‘reflection’ in Husserl’s
phenomenology means introspection. Introspection understood as the perception of the mind as an
internal object in contrast to the perception of the object in external perception, the so-called external
object. But despite Husserl’s misleading terminology, from the Logical Investigations on it is clear that
from the standpoint of his phenomenology the antithesis between inner and outer perception is
1
«false» . Thus, he writes in the Appendix to the First Edition of the LI:
Having regard to the fact that all sorts of lived-experiences (including the lived-experiences of outer intuition,
whose objects are therefore called outer appearances) can be made objects of reflective, inner intuition, we call
all lived-experiences in an ego’s experiential unity ‘phenomena’. Phenomenology is accordingly the theory of
lived-experiences in general, inclusive of all matters, whether intrinsic (reellen) or intentional, given in lived2
experiences, and evidently discoverable in them.
Here it is clear that by “reflective, inner intuition” Husserl does not mean the inner perception of his
mentor Brentano, whose object is exclusively the psyche, let alone the introspection the British
Empiricists, whose interiority is determined by the status of its object, the mind, as an inner object in
contradistinction to the external status of the object of outer perception. This is to say, the inner
direction of the phenomenological reflection in question is emphatically not determined by its
opposition to the outer direction of external intuition. And this is what allows Husserl to say that even
the lived-experience of outer intuition can be made the object of reflective, inner intuition. If the
opposition to something external doesn’t determine the inner characteristic of the reflection Husserl is
talking about here, what, then, does? The answer is phenomenological evidence, understood as the
immanence – of the lived-experience made into the object that appears in phenomenological reflection
– to the intuitive regard of that reflection itself. What is immanent here is the phenomenon, which is to
say, the appearance of the lived-experience in its multifaceted composition. What makes it immanent
1
2
LI, p. 254.
Ivi, p. 862.
115
�Burt C. Hopkins
is the methodical stance of the phenomenologist, which analyzes the object that appears to his or her
3
reflective regard exclusively in terms of the scope and limits of that object’s appearance to that regard .
4. Heidegger’s Notion of Phenomenon is Radically Distinct from Appearance in Husserl
It is important to note that Husserl’s account of the phenomenon here, which articulates «the concept
4
of what appears, or of what could appear, of the intuitive as such» , must be sharply distinguished from
Heidegger’s account of the phenomenon in phenomenology in Section 7 of Being and Time. There
Heidegger’s notion of phenomenon takes its bearings from the Platonic formulation, which, we’ve
seen, in addition to a likeness, can mean a distorting semblance. Heidegger stipulates, however, that
the phenomenological concept of phenomenon excludes that of its “Greek” meaning as a semblance,
and he therefore reserves for its meaning exclusively «that which shows itself in itself (Sich-an-ihmselbst-zeigende), the manifest»5. He bases this stipulation on his claim that the phenomenon’s meaning
as semblance «is founded»6 on its meaning the manifest. His account of phenomenon is thus removed
from the dialectical context of the Platonic meaning, in which, as we’ve seen, the very distinction
between an appearance that is veridical (likeness) and distorting (semblance) is radically in question.
Being in question, this distinction cannot be assumed to be in force and thus a matter of knowledge at
3
Jan Patočka’s influential argument (2015), which claims that in Husserl’s account of the appearance that which is
responsible for its appearing, namely, the lived-experiences in which it appears, paradoxically do not appear, inexplicitly
passes over in silence Husserl’s account of precisely the appearance of lived-experiences articulated by Husserl and
discussed here. Patočka’s argument has its basis in two highly questionable interpretations of Husserl’s account of what
is involved in explicitly phenomenological access to the object’s appearance. The first assumption is that the appearance
of the object in external perception is paradigmatic of the appearance of all objects for Husserl. As will be shown below,
by “object” Husserl’s phenomenology means a stable identity in the flux of lived-experience. Thus, while the appearance
of the object in outer perception no doubt satisfies this criterion, it does not do so exclusively (see below). The second
assumption is that the dynamic relationship between straightforward givenness of an object and the reflective
thematization of the lived-experience in which it is given, which characterizes natural reflection, is a dynamic that carries
over into the phenomenological attitude and thus characterizes reflection in the phenomenologically proper sense. The
problem with this assumption is that the very dynamic it articulates presupposes both the methodological stance of the
phenomenologist and the appearance of the dynamic in question in the immanent evidence of that stance’s reflective
regard. This is to say, that this assumption conflates the natural meaning of reflection as inner perception, which is based
on the opposition between inner and outer perception, with the phenomenological meaning of reflection, whose
methodical regard, in this instance, is responsible for thematizing the very dynamic in question. That a thinker with the
stature of Klaus Held has embraced (1981) the main thrust of Patočka’s argument regarding the implications of the lack
of access to the appearing responsible for the appearance in the initial unthematic givenness of lived-experience, speaks
to the challenge Husserl’s phenomenology presents to the basic opposition assumed by the natural attitude between inner
and outer perception. The challenge, specifically, of not slipping back into that attitude’s natural understanding of the
distinction between inner and outer perception when articulating the phenomenal dynamic between thematic and
unthematic modes of appearing within the phenomenological attitude. The articulation of the latter by the regard of
phenomenologically methodical reflection is what is behind the claim about the non-appearance of the appearing of the
lived-experiences responsible for the object’s appearance. Methodologically, then, the non-appearance in question
nevertheless appears in terms of its non-thematic mode of lived-experience. The appearance of what is non-thematic here
is not in any way paradoxical. It only seems as such insofar as the natural meaning of reflection as initially unthematic –
and therefore, non-appearing – inner perception remains operative in the phenomenological attempt to thematize the
dynamic of appearing and appearance.
4
LI, p. 862.
5
BT, p. 51.
6
Ibidem.
116
�Remarks on Appearing and Appearance in Husserl
the outset of an investigation for Plato, but rather it can only be established on the basis of the
dialectical interrogation of what appears in the cognitive interrogation of a sought-after unknown.
The Platonic notion of phenomenal likeness, however, is nevertheless implicit in Heidegger’s
account of the phenomenological concept of phenomenon as self-showing, given the contrast he draws
between its mode of showing itself in itself and the semblance’s making «a pretention of showing
7
itself» . For Plato, as we’ve seen, the sought-after unknown appears with its hypothetical positing as
something already known. In back of Heidegger’s phenomenological distinction between the «positive
8
and primordial signification of phainomenon» , which shows itself from itself, and its «privative
9
10
modification» in which «it can show itself as something which it is not» , therefore, is the cognitive
context of the Platonic appearance. But missing from Heidegger’s account of this distinction is the
cognitive problem of making the unknown appear. One result of the absence of this cognitive problem
in Heidegger’s account of the phenomenological concept of phenomenon is that it introduces a
distinction within the concept of phenomenon, between the showing itself that is inseparable from
what is manifest, and the in itself that is verified by the manifest as the showing that is indeed what it
11
purports to show and therefore make manifest .
Because, as we’ve seen, the precedent for Husserl’s phenomenological concept of appearance is
Aristotle’s concept of appearance, which rules out semblance without the need for dialectical
intervention, Heidegger’s concept of phenomenon introduces a distinction not present in Husserl’s
concept. Appearance for Husserl thus does not entail the “self-showing” of anything “in itself”. It is
showing, appearance, pure and simple. Or, rather, it is such once the phenomenon has been doubly
purified, of 1) transcendent apperception and 2) the psycho-empirical reality of the soul and empirical
reality in general. The first purification is fully realized in Husserl’s phenomenological reduction, or
better, transcendental phenomenological reduction. The second is realized in what is called the ideation
of essences in the LI and thereafter their eidetic intuition. Once suitably purified, pure phenomenology
12
subjects the phenomenon «to a purely immanent, purely descriptive examination into essence» .
5. Reduction and Purification of Phenomenon in Husserl and the Meaning of ‘Intentional Object’
The reduction’s purification of the phenomenon also clears up an ambiguity in the phenomenological
meaning of the intentional object that plagued the LI and continues to plague readers of Husserl who
cannot catch the nuance that the reduction introduces to the concept of phenomenon. Husserl initially
(in the First Edition of LI) distinguished what belongs to the intrinsic (reellen) content of the livedexperience from the intentional object referred to by that lived-experience, which left ambiguous the
following: whether by ‘intentional object’ phenomenology understood the transcendent object
7
Ibidem.
Ibidem.
9
Ibidem.
10
Ibidem.
11
Heidegger radically distinguishes the Kantian notion of “appearance” from the meaning he stipulates for the
phenomenological concept of phenomenon, because of the Kantian concept’s connection to that which doesn’t appear,
namely the “thing in-itself”. On the basis of this distinction Heidegger rejects any association of “appearance” with
phenomenon. However, because neither in Plato nor Aristotle is the phenomenon inseparable from the notion of a nonappearing thing in-itself, “appearance” is a perfectly acceptable translation of phenomenon in the Ancient Greek
philosophical context.
12
LI, p. 863.
8
117
�Burt C. Hopkins
simpliciter, supposedly both beyond and other than lived-experience, or whether it understood by
‘intentional object’ the object of such lived-experience insofar as it appears to it as an objective content
of its conscious moment. The reduction makes it clear (or should make it clear) that by ‘intentional
object’ phenomenology means the object as it appears to consciousness, not the putative object that is
somehow external to the mind and independent of human experience. Husserl is a total Humean in this
regard. Experience is the only possible basis for knowledge of the objectivity of objects supposedly
transcendent to the mind. Any knowledge claims about the being of an object that lack an experiential
basis therefore likewise lack any possible intelligibility, because the claim that an object is completely
transcendent to human experience must deny the only possible cognitive basis upon which that claim
can be confirmed as true: the experience in which the putative evidence for that claim must necessarily
be made manifest. The claim that an object is completely transcendent and therefore other than human
experience thus cannot escape the aspect of that experience that provides the motivating evidence for
asserting the object’s transcendence. The phenomenological commitment to evidence therefore rules
out in principle the legitimacy of any cognitive claims about the object and its putative objectivity that
bypass the sole basis for making such claims: the lived-experience inseparable from the evidence
which presents the grounds for the object’s transcendence.
The exclusive meaning of the intentional object, as that which appears to the conscious moment of
lived-experience, is what is codified by the transcendental phenomenological reduction. It stipulates
the “bracketing” of the “index” of the transcendent existence that is coincident with the positing of the
intentional object as a being beyond and therefore other than lived-experience. With this, the belief that
naturally accompanies the positing of a being that is completely independent of lived-experience is
“put out of play”, in the sense that the performer of the reduction pulls back from the assumed truth of
that belief. As a result, the transcendental phenomenological reduction privileges the intentional
object’s meaning in terms of that which appears to lived-experience. The privilege here, it must be
emphasized, is methodological. Thus, what the reduction stipulates is decidedly not that the being of
the intentional object is coincident with its appearance to consciousness. The existence of objects
transcendent to lived-experience is therefore not rejected by the reduction but rather radically affirmed,
precisely insofar as what it brackets and puts out of play is not the legitimacy of the intentional
object’s status as a being that is transcendent to consciousness. What is rejected by the reduction,
rather, is the acceptance of the truth of that status in the absence of its evidential substantiation. In
other words, the reduction functions to neutralize the belief native to the intentionality of livedexperience that its intentional object is really transcendent to it, pending an investigation of the
evidence that alone is capable of justifying this belief.
This need for evidential substantiation arises from the critical concerns that guide Husserl’s early
pre-phenomenological philosophical investigations of mathematics and logic. These critical concerns
are foundational. On Husserl’s view, the prevailing late 19th century philosophies of the sciences of
mathematics and logic were epistemically wanting, in that they were unable to account for the ideal
and formalized meanings appealed to by the cognitive claims of these sciences. Specifically, Husserl
argued that both empirical and rational epistemologies appealed to ideal and formalized meanings
whose givenness in experience they nevertheless either explained away empirically or argued away
rationally. Husserl’s phenomenological investigation of the appearance of the intentional object to
lived-experience was thus the outgrowth of his critical preoccupation to provide a philosophical
account of the ideal and formalized meanings presupposed by late 19 th century mathematics and logic.
The concept of appearance in Husserl’s phenomenology, in the sense of the pure phenomenon, is thus
inseparable from these critical concerns. But it is not reducible to them.
118
�Remarks on Appearing and Appearance in Husserl
6. Appearance of the Pure Phenomenon in Ideation and Eidetic Intuition
A case in point is ideation’s development into eidetic intuition. Originally, ideation was formulated by
Husserl as the method to bring to evidence, as pure phenomena, the ideal structures presupposed by
logic. Its point of departure is the lived-experience of general meaning, which is brought to
prominence and then isolated in an intuition. It accomplishes the former by generating a manifold of
lived-experiences and the latter by thematizing the logical content of the unity that encompasses the
instances of general meaning common to each of the discrete lived-experiences composing the
manifold. Crucial to the generation of the manifold in question was that its composition exceed
empirically given lived-experiences. The comparison of empirically given general meaning can only
make prominent and isolate in intuition empirical generalities, and not the “pure” – because
unconditional – universality coincident with logical meaning. Generation of a manifold that is
unrestricted by empirical limits requires the imaginative variation of an originally given empirical
manifold. Despite Husserl’s initial characterization of this variation as “free”, from the beginning the
crucial methodical protocol for the imaginative extension of the empirically given manifold was that
the variation involved be guided; guided initially by 1) the empirical style characteristic of the unity
yielded by the comparison of the empirically general meaning common to the members of the
empirically given manifold and then by 2) the pure essence eventually yielded by the empirical style’s
imaginative extension.
Husserl’s early critics, alas, either missed or disregarded this protocol with their worry that ideation
disregarded or otherwise undervalued the empirical or factical dimension of experience. For Husserl,
the empirical is clearly there in the phenomenon from the start; as the undeniable point of departure for
the comparison that yields the empirical style that functions as the guiding clue for the ideation proper,
the empirical dimension of experience, or better, its intelligible structure, is manifestly not disregarded.
Nor does the highlighting of its intelligible structure undervalue, for instance, its ontological status,
since that status is the very basis for the appearance of the pure phenomenon in ideation. This same
early criticism is equally misguided when directed at the eidetic intuition developed out of ideation.
Eidetic intuition follows the same methodological protocols as ideation, save for its extension of the
guiding clue to include empirical styles common to all aspects of lived-experience, not just those
whose unfolding yields the idealities that comprise the species of pure logic.
One critic, however, who didn’t miss the important methodological protocol here was Heidegger.
His criticism raised the crucial issue of Husserl’s pre-phenomenal starting point, by questioning the
ontological originality of Husserl’s empirical formulation of perceptual lived-experience. Heidegger’s
critique thus accepted the phenomenological legitimacy of Husserl’s account of the pure phenomena of
logic and the eidetic intuition of the eidê that structure perceptual lived-experience, save for Husserl’s
interpretation of the ontologically foundational originality of these structures. I’ll return to Heidegger’s
powerful and in many ways fateful (for the development of transcendentally pure phenomenology)
critique, but now will address the critical concern in back of Husserl’s own critique of ideation and the
initial formulation of eidetic intuition. Psychologism.
7. Husserl’s Self-Critique of his Early Platonistic Account of the Phenomenon of the Pure Logical
Species
Husserl’s original formulation of ideation explicitly embraced what he himself characterized as
Platonism, in an effort to account for the formal universality of the logical species despite its
presentation in lived-experience. The problem raised by the presentation of logical objectivity in livedexperience concerned precisely how the formal universality that is inseparable from logical meaning
can be maintained in the face of its appearance in a lived-experience that is neither formal nor
119
�Burt C. Hopkins
universal. Husserl thought he could do this by maintaining that rather than be presented directly in
lived-experience as its intentional object, the ideal species instead was instantiated by livedexperience, in its acts of logical cognition. This, of course, raised – and for those who still find
Husserl’s account of instantiation compelling, raises – the question of the status of the un-instantiated
species. Husserl’s answer, following Bernard Bolzano, was that the status in question was that of an
“objectivity in-itself”, the meaning-content of which was intrinsically untouchable by livedexperience. While this notion took care of one crucial concern of psychologism, or better, of logical
psychologism, Husserl soon recognized that it left the phenomenological status of the logical species
completely unaccounted for, in the sense that it presupposed rather than brought to evidence the
species’ rational being. In his view, then, the solution to the problem of psychologism he advanced in
the LI was not philosophical, as it presupposed uncritically a rational psychology.
Husserl’s philosophical response to the evidential shortcomings of the LI’s rational psychology is
what is behind his phenomenology’s transcendental turn. Following this turn, the formal universality
of logical meaning is, after all, now recognized as something given in the non-formal and nonuniversal flow of lived-experience, albeit in a lived-experience in which the positing of contingent and
causally determined psycho-empirical reality has been neutralized by the transcendental
phenomenological reduction. The immanent subjective status of such lived-experience Husserl now
understood to include the non-flowing ideality of all objective meaning, and not just the formal
universality of logical meaning. Analyzing how, within the Heraclitean flow of transcendentally
reduced lived-experience, the ideality, or better, irreality of objective meaning is given, in the precise
sense of its non-flowing and therefore motionless appearance in that flow as an identity inseparable
from its unity, became the primary task of Husserl’s transcendental phenomenology. At stake in this
task for Husserl, which he referred to as “constitutional analysis”, is nothing less than establishing
phenomenology as a bona fide philosophy. The failure to account for the subjective constitution of
objective meaning, for Husserl, is tantamount to the failure to overcome psychologism in its most
sophisticated guise: transcendental psychologism.
8. Husserl’s Account of the Distinction between Reell and Irreell Part-Whole
Relations and the Constitution of Irreality
Husserl’s account of irreality as something that despite its constitution “in” lived-experience, and thus
that despite the flowing, subjective character of the latter in which it makes its necessary and
irrevocable appearance, nevertheless exhibits the hallmarks of the objective character of meaning,
focuses on the distinction between reell and irreell part-whole relations. Lived-experience for Husserl
is an immanent temporal whole composed of parts that intrinsically belong to that whole, in the precise
13
sense that «they can be found in its immanent temporality» . Husserl characterizes this intrinsic
relation of belonging in terms of the parts’ reell inclusion in the temporal unity characteristic of the
whole of the lived-experience. This means that the manifold of those parts, that is, the manifold of
14
hyletic data (sense impressions), the «intentional characters» of that hyletic data, and the synthesis of
those intentional characters into appearances of objective meaning, «have a reelle unity of livedexperience and a certain peculiar species (Art) of being bound to one another, which is called the
15
synthesis of appearances» . The phenomenal relation between these reell parts, which are «ever
13
PP, p. 132.
Ivi, p. 133.
15
Ivi, p. 132.
14
120
�Remarks on Appearing and Appearance in Husserl
16
17
new» and «temporally separated» . contrasts with the phenomenal relation between the appearing
object that appears in and through them. The latter, despite its appearance in the manifold parts
intrinsic to lived-experience, is not manifold but maintained by Husserl to be «one in numerical
18
identity» . Thus, while no reell part can be identical with another, owing to its temporal discreteness
as a phase belonging to the manifold whole of a lived-experience, the appearance of the object
manifest in each part, as a phase of that manifold, is irreell for Husserl. It is so in the precise sense of
its identity being maintained despite the manifold manner of its appearance. Husserl puts it this way:
But if we restrict ourselves to what is exhibited and shown within the streaming perception itself, we see, then:
the synthesis of streaming appearances in the same object [im selben Objeckt] . . . has the marvelous specific
property on the one hand of being a reell synthesis and on the other hand containing in every phase something
irreell, namely, of having ‘in’ itself in separated phases evidently the same numerically identical object which
is called irreell in relation to the immanent synthesis of lived-experience. It could also be called ideal in this
relation because it is evidently the same, whereas the separate phases of lived-experience cannot intrinsically
(reellen) contain anything identical.
19
That is, objective meaning is constituted as something that is not reell in the precise sense that: 1) it
does not share the non-identity of the subjective phases of the manifold that composes the temporal
unity of lived-experience, and 2), unlike the reell inclusion of those phases in that temporal unity, the
objective meaning is not an intrinsic part of that unity. The phenomenal result of 1) for Husserl is the
invariance inseparable from objective meaning, in the exact sense of the appearance of the object
remaining one and the same throughout the variations of the descriptively characterized “flowing” or
“streaming” synthesis of the non-identical reellen phases of lived-experience that exhibit the appearing
of the object’s appearance. And the phenomenal result of 2) is the transcendence inseparable from the
objective appearance, in the exact sense of its not being an intrinsic (reell) part of the lived-experience
in which it nevertheless appears.
9. Husserl’s Account of the Universal Homogeneity of Objectivities as Objectivities
Husserl’s account of the constitution of the irreality of objective meaning on the basis of its identity as
numerically one beyond the manifold of its appearing thus addresses the status of the evidence in
which the logical species is given. This evidence, we’ve seen, Husserl himself admits is not addressed
in his Platonist account of objective meaning. Thus, rather than account for the objectivity of formal
logical meaning by appealing to an objectivity in-itself that is instantiated by acts of lived-experience
but otherwise radically other than the acts that instantiate it, Husserl’s account of the givenness of
irreality now situates it in terms of its appearance in, rather than instantiation by, lived-experience.
Husserl is quite clear, however, that this account of irreality deals not just with the objectivity of
20
formal logical meaning but with all objectivities, «as objectivities» . While such objectivities include
the formal and universal meaning of the logical species, they also include non-formal and nonuniversal objectivities, like Beethoven’s Kreutzer Sonata and the perceptual objects given in external
16
Ibidem.
Ibidem.
18
Ibidem.
19
Ivi, p. 134.
20
FTL, p. 155.
17
121
�Burt C. Hopkins
and internal perception. Thus, Husserl’s account of the transcendence and unity characteristic of
21
objectivities as objectivities is focused on «the universal homogeneity of objectivities» .
The homogeneity at issue here is the constitution of the irreality of any object whatever in the
manifold of lived-experience that yields the object’s objectivity in the numerical identity, the being
one, of its appearance in contrast to the non-identity of the reellen phases of the manifold that
comprise the lived-experience in which it appears. Husserl radically distinguishes the universality of
this homogeneity from the ideational generalization that yields the universal meanings of logical
objectivity. The latter are given in evidence that is initially generated by the comparison of the livedexperience of particular objects, which yields the general meaning in question as an overlapping
coincidence of the particulars under it. Thus, Husserl writes:
The manifold of objectivities of the understanding, which in the latter case constitute the extension of the
universal, must, as belonging to its objective content, be rigorously distinguished from the multiplicity of
meaning (Sinn) in which this generality is intended at any given time, in which, therefore, it is posited, whether
22
in an empty intention or intuitively.
What must be distinguished, then, is the manifold of lived-experiences whose phases, composed of
reellen intentional parts, manifest a manifold of meaning that intends the numerical unity constitutive
of the irreality that in turn manifests the transcendence characteristic of all objectivity, from the
manifold of objectivities that compose the extension of a given generic universality. (The manifold of
these objectivities, it is important to note, for Husserl «can be individual particulars but also, in the
23
case of higher generalities, can themselves again be objectivities of the understanding») . The
manifold constitutive of the irreality of objectivity posits that objectivity as something that is
homogeneous, in the precise sense that the unity of the intentional meaning posited by the lived24
experiences belonging to this manifold is, as Husserl puts it in FTL, «the Same» . The manifold of
objectivities of the understanding, in contrast, are composed of both different universalities (e.g.,
‘nature’, ‘spirit’) and different levels of universality (‘material ontology’, ‘formal ontology’). Thus, in
contrast to the homogeneity posited by the manifold of lived-experiences constitutive of the irreality of
objectivity per se, the understanding posits objectivities that are heterogeneous.
10. Husserl’s Account of the Distinction between the Manifold of Lived-Experiences in which the
Irreality of the Object Appears from the Manifold of Individual Objects Embraced by the
Extension of the Universal
Despite the radical difference between the manifolds constitutive of the homogeneity of all
objectivities as objectivities and the heterogeneity of the content of those objectivities, that is, the
heterogeneity of the generic universals proper to the regions of being (including phenomenological
“being”) and the manifold objects that comprise their extension, Husserl maintains that, «like every
25
objectivity of the understanding, a general objectivity is irreell» . However, he sharply distinguishes
21
Ibidem.
EJ, p. 317/264 (original German, then English translation, page numbers).
23
Ibidem.
24
FTL, p. 145.
25
EJ, p. 316/263.
22
122
�Remarks on Appearing and Appearance in Husserl
the «manifold of constitutive lived-experiences in which it [the irreality of the object] appears» from
«the extension of the objects which . . . [the general objectivity] embraces in the manner of
26
generality». Thus, Husserl holds that «[e]ven if it is given intuitively, so that we intuit the universal
from a cogiven object pertaining to this generality as a particularity, it is certainly exemplified in this
27
object, but not in the constitutive lived-experience in which it is intuitively given» . Husserl’s stress
of the fact that the lived-experience does not exemplify the irreality of the object, of course, marks the
significant reversal of his earlier position, which, we saw, maintained precisely the opposite: that the
objectivity of the species was indeed exemplified by the lived-experience.
Husserl’s mature view of the constitution of objectivity also refines his earlier position regarding its
temporality. His earlier account of the ideal status of objectivity invited the interpretation of its
temporal status as extra-temporal, in the sense of being beyond and therefore outside the subjective
flow of lived-experience and with that other than the immanent streaming of the temporality of that
flow. His mature view, however, as we’ve seen, locates the constitution of objectivity’s irreality in
precisely that streaming, albeit not its perceptual givenness, with its temporal modality of the present.
Thus, Husserl writes, «[p]erception is never a full objectivating performance, if we understand such
28
performance to be indeed the seizing upon an object itself» . Husserl’s reason for this is that we
accept perception (internal and external) «as a seizing upon an object itself, only because we are tacitly
29
taking into account possible recollection, repeatable at will» . Husserl elaborates that «[w]hen
30
actualized, recollection gives for the first-time original certainty of the being» of the subjective or
objective «object in the full sense . . . as something acquired originaliter and identifiable at will,
something to which we can ‘always go back again’ and which one can recognize in a reactivation as
31
32
the selfsame» . Husserl notes he himself was «misled» in the Logical Investigations regarding the
33
«very different roles» that the “self-giving” [Selbstgebung] of objectivities plays, accordingly as they
are given in perception as real [reale] or in recollection as ideal [irreell]. Because irreell objectivities
34
«have no temporal loci to bind them individuatingly» . Husserl now maintains that «such an irreality
has the temporal being of supertemporality, of omnitemporality, which, nevertheless, is a mode of
35
temporality» . From this it follows according to Husserl that «[m]erely because of an essentially
possible alteration of attitude or focus [Einstellungsänderung], any clear explicit recollection of an
ideal species changes into a perception of it – something naturally excluded in the case of temporally
36
individuated objects» .
26
Ibidem.
Ibidem.
28
FTL, p. 157.
29
Ibidem.
30
Ibidem.
31
Ibidem.
32
Ivi, p. 158 n. 1.
33
Ivi, p. 158.
34
Ibidem.
35
EJ, p. 313/261.
36
FTL, p. 158.
27
123
�Burt C. Hopkins
11. Husserl’s Incomplete Account of the Essential Relation between the Manifolds Constitutive of
Homogeneous and Heterogeneous Unities
Husserl’s account of the status of the appearance of the objectivity of the intentional object presented
here, which reflects how we find it in his mature works on logical and mathematical objectivity (FTL
and EJ), represents a radical departure from his Logical Investigations. On my view, the radicality of
37
that departure has not been sufficiently appreciated, let alone registered . To wit, whereas in the LI the
unity of the objectivity of the appearance appeared in the perceptual manifold of a lived-experience
that exemplified the logical species, in Husserl’s self-critique of this account, we’ve seen that the
manifold constitutive of the irreality is not the manifold intrinsic to individual perceptual livedexperiences. Rather, irreality is constituted in the manifold of individual lived-experiences themselves
that compose the recollective modification of self-givenness, such that the Same, in the sense of the
numerical identity of the unity of objective meaning, appears in the recollective manifold. As we have
seen, Husserl himself thematizes the difference between the manifold and unity at issue here. He does
so in the distinction he makes between the constitution of the omnitemporality of the irreality
characteristic of all objects as objectivities and the manifold and unity at issue in the constitution of the
general universality of objects of the understanding. In the latter, the unity of the general object in
question is indeed exemplified by the manifold of individual objects that comprise its extension.
However, nowhere to my knowledge does Husserl ever address how these two manifolds and their
unities are related phenomenologically. That is, Husserl nowhere addresses the issue of how the
manifold of lived-experiences constitutive of the homogeneous unity of the irreality of objectivity is
related to the manifold of individual objects constitutive of the heterogeneous unities of the generic
universalities that comprise the objects of the understanding. And related to this lacuna, indeed,
essentially related to it, Husserl likewise does not address the issue of the relation between the two –
by his own admission – radically distinct unities constituted by the different manifolds in question.
That is, the relationship between the constitution of the homogeneous unity of the object’s irreell
transcendence and heterogeneous unity of that same object’s content marked by Husserl’s analyses is
not further explored by him.
12. Neither Heidegger nor Derrida’s Critiques of Husserl take into Account his Mature, Albeit
Incomplete, Account of the Constitution of Homogeneous and Heterogeneous Unity
Before turning to the question of whether Husserl’s phenomenological method possesses the resources
to explore these issues, I want to situate them within the context of the foci of the critiques of Husserl’s
transcendental phenomenology advanced by his two most trenchant and influential critics, Heidegger
and Derrida. Heidegger’s critique of the perceptual point of departure of Husserl’s phenomenology, to
which we’ve already had occasion to allude, does not take into account Husserl’s fully developed selfcriticism of his Platonistic account of the logical species and ideality generally. As we’ve seen, that
criticism explicitly shifts the locus of the constitution of the irreality proper to objective meaning from
the manifold constitutive of an individual perceptual lived-experience to the manifold of the individual
lived-experiences that comprise recollection. Derrida, in contrast, does take Husserl’s self-critique into
account, and thus focuses on what he characterizes as the “repetition” that Husserl’s recollective
account of the omnitemporal constitution of irreality introduces. However, Derrida’s claim that
37
For instance, Held’s otherwise excellent account of the constitution of objective identity in Husserl’s mature
account of time (1981), focuses exclusively on the manifolds constitutive of the homogeneous irreality of objectivity, and
thus does not mention the manifolds constitutive of heterogeneous objectivity, let alone the problem of their
phenomenological relation in the constitution of objective identity.
124
�Remarks on Appearing and Appearance in Husserl
Husserl’s account falls short of its goal because of repetition’s intrinsic incapacity to transcend the
alterity and difference inseparable from the presentational origin of irreality, elides completely
Husserl’s acknowledgment that there is an essential relation between the homogeneous and
heterogeneous constitution of unity.
Heidegger’s and Derrida’s critiques’ limitations on these points provide the occasion to consider
whether Husserl’s last work, The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology,
might address or otherwise provide resources for exploring the nature of the essential relation between
the two different manifolds identified by his mature account as constitutive of the appearance of the
intentional object. On the surface, it would appear that Husserl’s main concern in that work is far from
the problem of the constitutive relation between the homogeneous appearance of irreality in the
manifolds of recollective lived-experiences and the heterogeneous appearance of its universal content.
That is, that work’s historical reflection, with its task of reactivating the sedimented accomplishments
of meaning whose forgotten constitution is behind the crisis of European sciences, seems remote from
the ahistorical epistemological concerns that guide his mature account of the appearance of the
objectivity of the intentional object.
13. The Historical Reflection and Reactivation of the Constitution of the Sedimented Meaning behind
the Husserl’s Account of the Crisis of European Sciences Adumbrates the Essential Relation
Between Homogeneous and Heterogeneous Unity
However, a closer look reveals that the very relationship left unexplored in Husserl’s mature
epistemological account of the constitution of the irreality of the object’s appearance is adumbrated by
his account of the backward historical reflection that reactivates the sedimented constitution of
meaning in the Crisis. This account is directed toward the end of clarifying the foundation of the
meaning of the generic universalities that constitute the formal and natural sciences that are in crisis
over precisely that meaning. On the one hand, there is the recollective character of this historical
reflection. Granted, what is reactivated in the recollection at issue is not the past-present of a livedexperience that originated in the individual phenomenologist initiating the reflection, but rather the
conditions of possibility of a past-present whose origination belongs to the historical horizon of the
individual phenomenologist. But that said, the structure of the historical recollection remains the same
as that of the individual recollection: the meaning intended by the historical recollection, like that of
the individual recollection, appears as numerically identical, despite the manifold character of its
appearing. On the other hand, there is the specific generic content of the universality whose meaning
constitution is being reactivated by the historical reflection. As we’ve seen, the ahistorical constitution
of the appearance of objects of the understanding in ideation and eidetic variation is initially guided by
the empirical style that emerges in the comparison of individual objects. So, too, is the historical
reflection intent on reactivating the constitution of the sedimented meaning connected with the
foundational crisis of European sciences a guided reflection, or, better, so too is the reactivation it
initiates guided. Granted, this guiding style and, indeed, the origin of its very intelligibility, unlike the
guiding style in the eidetic variation constitutive of generic universality, is something that is radically
and therefore historically in question. It is in question because of Husserl’s discovery that the empirical
style of modern natural science is characterized by an historically dated mathematization of the
perceptual life-world that alienates that science from its true source in that life-world. So much so, in
fact, that Husserl maintains in the Crisis that rather than exclude historical investigation, the truly
radical epistemological grounding of the meaning that determines European sciences demands it. That
is, the radical phenomenological investigation into the historical origin of the meaning (Sinn) that
guides empirical science is demanded because of the principled failure of ahistorical epistemological
125
�Burt C. Hopkins
investigations, including Husserl’s own investigations, to render intelligible the meaning in question’s
foundation.
This last demand, and the recognition of the radical historicity of the meaning constitutive of both
the exact and empirical European sciences, is, I submit, what provides the connection between the
manifold of recollection constitutive of the homogeneous unity of the irreality of objectivity with the
manifold of objects that constitutes the extension of the heterogeneous unity that composes the content
of that objectivity. This is to say, the extension of the recollection constitutive of the irreality of the
appearance of objectivity beyond the historical present is motivated by the following: the recognition
that the meaning of the guiding empirical style inseparable from the appearance of the generic
universality appealed to by the epistemological attempt to provide the foundations of the various
European sciences is in crisis. It is in crisis in the precise sense that the evidence appealed to in turn by
these epistemologies to ground the concepts constitutive of these sciences, is incapable of rendering
them fully or even minimally intelligible.
14. The Limits of Heidegger’s Critique of Husserl’s Account of the Appearance
of the Phenomenon and the Superiority of Husserl’s Account
Returning now to Heidegger’s fateful critique of Husserl’s transcendental phenomenology, on the
grounds of the supposed lack of ontological originality of the perceptual point of departure of its
methodical reflections, we can see the following: that Husserl’s mature thought not only is not limited
by a point of departure in perception, but also that the historicity of the meaning that provides guiding
clues for the appearance of the objectivity of the object in its historical reflection is not limited, as is
Heidegger’s phenomenology, by an ontological narrative rooted in profundity. We’ve seen that despite
rejecting the Kantian notion of appearance because of its connection with the notion of an unapparent
thing in-itself, Heidegger nevertheless introduces the distinction between 1) what shows itself in the
manifest and 2) the phenomenon itself. This distinction is behind his claim in BT that the phenomenon
of phenomenology is precisely «something that proximally and for the most part does not show itself
38
at all» . This claim, in turn, is in back of Heidegger’s related claim, contra Husserl, that the true
meaning of phenomenological description is interpretation (Auslegung), a claim that itself Heidegger
thinks legitimizes the hermeneutical recasting of the phenomenological method. With this recasting,
however, the phenomenological commitment to evidence, formulated precisely in terms of what is
manifest in the appearance, is jettisoned, and replaced with “profound” meta-phenomenological
speculations about why the phenomenon itself is not showing itself in itself. The profundity in question
being rooted in historical narratives about the ontologies responsible for the concealment and
withdrawal of the non-self-showing phenomenon of Being.
The phenomenological superiority of Husserl’s notion of appearance, I submit, is that it remains
tied to evidence. Granted, the evidence for the essential relation between the unities apparent in
homogeneous and heterogeneous manifolds is complex, but even when extended, as I have suggested,
to the historical recollection tasked with the reactivation of sedimented meaning (Sinn), it is never
profound. This is because for Husserl and thus Husserlian phenomenology, the interrogative move
beyond the limits of the content of what appears in the appearance is always motivated by references
or indications that are manifest in the evident appearance itself. Indeed, the cognitive interest of the
methodical reflection that, as we have seen, is the sine qua non for the appearance in Husserl’s
phenomenology, is what recognizes the methodological need to extend its reach beyond what is
38
BT, p. 59.
126
�Remarks on Appearing and Appearance in Husserl
evident in any available appearance. Because, however, of the methodical protocol of Husserlian
phenomenology to advance its cognitive claims solely on the basis of what is given in the appearance,
the extension of any given phenomenological reflection is necessarily guided by what appears to its
regard. Thus, the inadequacy of what appears is nothing profound. For example, the incomplete
appearance of the whole of the perceptual object in external perception, or the likewise incomplete
appearance of the whole of the streaming of time in immanent consciousness, both of which motivate
reflection to extend its regard beyond what appears in any phase of its awareness of the phenomenon,
in order to realize the cognition of the essence of the lived-experience in question, does not involve
anything that is non-evident. In the perspectival appearance of the external object, or the incomplete
appearance of time, there is therefore no evidence of the withdrawal or concealment of the being of the
object of perception or of time.
It is likewise the case with the evidence in which the mathematization of nature appears. For
example, inseparable from the evidence in which the arithmetization of geometry appears is the
absence of any reference to intuitable lines and shapes. Inseparable from the meaning (Sinn) of this
arithmetization is its lack of reference to the shapes of the perceptual life-world and their idealization
in Euclidean geometry. This meaning, then, is capable of functioning as the guiding clue for historical
reflections bent on recollectively reactivating the conditions of possibility of the lived-experiences that
belong to the historical horizon of the reflecting phenomenologist, which are presupposed by the
arithmetization of intuitive geometry. Of course, not just any phenomenologist is capable of extending
the scope of phenomenological reflection beyond the recollective horizon of the past-presents
constitutive of their own lived-experience to uncover the primal evidences for the sciences at issue
here. As Husserl puts it, «what counts as primal evidence for the sciences is determined by an educated
person or a sphere of such persons who pose new questions, new historical questions, questions
concerning the inner depth-dimension as well as those concerning an external historicity in the social39
historical world» .
15. Appearance and Truth in Plato, Aristotle, and Husserl
I want to conclude by returning to the relation of appearance in Husserl to its two Greek precedents in
Plato and Aristotle. Recall that in Plato there can be no demonstrative science of the appearance,
because what appears is necessarily related to the unknown that has been hypothetically made to
appear, toward the end of the dialectical interrogation of the truth of its appearance in relation to that
unknown. Recall, also, that in Aristotle a demonstrative science of the appearance is possible, because
of its incorrigibility vis-à-vis its eidetic source. While truth and falsity have their provenance in the
synthesis of appearances, it is the incorrigible elemental manifestation of those appearances that
nevertheless make it possible to establish demonstratively the truth or falsity of a given demonstration.
For Husserl, likewise, the elemental appearances are incorrigible. However, because their very
appearance is the product of twin methodological interventions, the transcendental reduction and
eidetic variation, the question of their truth is not straightforward. Whereas for both Plato and
Aristotle, the answer to the question of truth is inseparable from the cognition of beings other than the
being of the soul of the knower, the object of cognition in Husserl’s phenomenology is first and
foremost that of the soul of the knower. This is because, as we’ve seen, the appearance in Husserl’s
phenomenology irrevocably and necessarily makes its appearance in the methodological reflection of
consciousness’ (or, if you will, the soul’s) self-perception. Hence, the question that dogged Husserl’s
39
Crisis, p. 382/373 (German and English pages, respectively).
127
�Burt C. Hopkins
thought and tortured the thinker of that thought from his earliest to his final phenomenological works:
how to slay the spectre of psychologism that is inseparable from his phenomenology’s reflective mode
of access to the appearance? While his mature account of the appearance of objectivity establishes its
non-identity and therefore transcendence from the intrinsic (reellen) parts of the lived-experience in
which the evidence for its appearance necessarily appears, the question remains whether this account
of the transcendence in immanence of the appearance is sufficient to overcome what Husserl himself
identified in his mature work as the problem of “transcendental psychologism”. Taking up that
question, let alone endeavoring to answer it, however, is the task for another occasion.
Bibliography
Heidegger, M. (1962), (BT) Being and Time, trans. J. Macquarrie and E. Robinson, Harper and Row,
New York 1962.
Husserl, E. (1970), (Crisis) The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology,
trans. D. Carr, Northwestern University Press, Evanston (Ill.).
Husserl, E. (1973), (EJ) Experience and Judgment, trans. J. S. Churchill and K. Ameriks,
Northwestern University Press, Evanston.
Husserl, E. (1969), (FTL) Formal and Transcendental Logic, trans. D. Cairns, Martinus Nijhoff, The
Hague.
Husserl, E. (2001), (LI) Logical Investigations, 2 vols, trans. J. N. Findlay, Routledge, London and
New York.
Husserl, E. (1977), (PP) Phenomenological Psychology, trans. J. Scanlon, Martinus Nijhoff, The
Hague.
Held, K. (1981), “Phänomenologie der Zeit nach Husserl”, in Perspektiven der Philosophie. Neues
Jahrbuch, vol. 7, pp. 185-221.
Patočka, J. (2015), Husserl’s Subjectivism and the Call for an Asubjective Phenomenology, in Chvatík,
I., Učník, L., Williams, A. (eds.), Asubjective Phenomenology. Jan Patočka’s Project in the
Broader Context of his Work, Traugott Verlag, Nordhausen, pp. 17-40.
Abstract
A strand in the contemporary engagement with Husserl’s phenomenology is united by the
critical judgment that the appearing of the appearance paradoxically does not appear in that
phenomenology. I argue that it does. My argument has three parts. The first argues that,
contra Heidegger, the appearance in Husserl doesn’t involve the “self-showing” of anything.
The second argues that the appearance in Husserl is a phenomenon doubly purified, from 1)
its index of existence and 2) its empirical facticity. The third argues that the appearing of the
appearance appears in manifolds of lived-experiences that in turn appear in the only
foundation that – from beginning to end – Husserl sought to establish for a philosophical
science: the reflectively accessed unities of sense (Sinn) given in these manifolds that alone
are capable of manifesting phenomenological evidence.
Keywords: Appearance, Phenomenological Reflection, Phenomenological Manifold, Husserl,
Phenomenological Evidence
128
�MARYLOU SENA*
Plato is not Platonism:
Musings on the Derivative De-eroticized Nature of the Modern Subject1
Anyone interested in reading Plato with Nietzsche’s genealogical account of metaphysics in
mind will have to consider the distinction Nietzsche sees within the history of metaphysics
between Plato and Platonism. While related genealogically, the two are never to be equated
given the professed wisdom of each. In truth, Kantian Platonism (when historically unmasked)
knows, on the bases of its own professed wisdom and “probity”, that it stands in opposition to
Plato when claiming that nonsensuous being is «altogether unattainable for cognition»2 And it is
certain that such an effacement of nonsensuous being (of its luminous nature and knowledge) is
an affront to Plato and in particular to the wisdom of the Delphic god Apollo (the «god of light»)
that philosophy is to serve. Plato, then, is no more Platonism than Platonism is Plato. But while
Plato and Platonism are not to be equated, Nietzsche’s own relationship to this distinction within
the history of metaphysics, first and foremost, stresses that Plato is not Platonism; for above all
else, Nietzsche is determined to «save» luminous being and its knowledge as he passes though
and overcomes the history of metaphysics that ends in the atheism of positivism3.
Of course, the statement “that Plato is not Platonism” has taken on a life of its own given the
general soundness of its claim and its historical life at play within the history of metaphysics
itself. But in Nietzsche, the claim has an exact meaning that captures at once the full magnitude
and significance of his genealogical account of the complex origin and history of metaphysics.
That Plato is not Platonism means, first and foremost, that Plato’s ontological view of the world
in a particular way is what is most proper to metaphysics. And here, as Plato insists, only the
«outward look» of the soul in the form of sophrosyne is able to see the true world (the world as it
is) where «true being» is structurally set apart from the mimetic realm of «nonbeing», of
sensuous appearances, of sensuousness as such4. And while Plato, as we know, thinks of these
*
Seattle University
1
At the onset of this paper I would like to express my gratitude to Dr. J. Patrick Burke and Dr. Arthur Fisher for
their sublime collegiality and friendship. As Nietzsche has it, such friends are «pure air», «solitude», and without a
doubt «bread and wine».
2
Heidegger (1979), p. 206.
3
In this spirit we have Nietzsche’s Zarathustra who seeks a way beyond the words of the soothsayer that «all is
empty, all is the same, all has been» with the aid of his Apollinian dream (Nietzsche, 1954, pp. 245-246).
4
Heidegger, I believe, is right to stress that for Nietzsche Plato’s view of the world, while divided ontologically,
is structurally a whole since the mimetic nature of sensuousness is understood in terms of «true being» (Heidegger,
1979, p. 201). True being (luminous being) sets the standard. What’s more, whether recognized or not, it is the
«primal referent» in terms of which sensuous mimetic likenesses are first known and judged as such (as likenesses,
appearances, images). On the bases of true being and the ascertainable of it as «being there», the very nature of
sensuousness is defined mimetically as deficient in being. In this spirit, Plato tells us in his Phaedrus at 249c that
«such things are not beings; they are only such things (ha nyn einai phamen) of which we now say that they are»
(Heidegger’s translation, 1979, p.194). However, Plato immediately tells us at the same location in the text that the
value of mimetic appearances lies in being the «means of remembrance» (Plato, 1989, p, 496, 249b4-249d2). In six
Bollettino Filosofico 33 (2018): 129-144
ISSN 1593 -7178 - 00030
E-ISSN 2035 -2670
DOI 10.6093/1593-7178/5943
�Marylou Sena
two regions of being together as a structural whole, only the nonsensuous (luminous) being of
the “Ideas” and of the gods are said to have true being. Plato then is metaphysics; the
metaphysical origin of his metaphysical view of the world, as Nietzsche deeply recognizes, is
based in the «outward look» of the soul’s form named sophrosyne5.
At the same time Nietzsche’s claim (that Plato is not Platonism) means that Plato is
responsible for an ensuing history of metaphysics that has proven to be derived from and
ontologically inferior to the metaphysical view of the world that Plato holds to be objectively
true. Plato’s view of the world (where nonsensuous being is structurally set apart from sensuous
nonbeing) determines in advance the derivative views of the world that make up the history of
metaphysics as “Platonism”. To be clear, the history of metaphysics after Plato, as Nietzsche
sees it, is directly «derived from» and «ontologically inferior to» Plato’s metaphysical view of
the world. In this spirit, Nietzsche speaks of Christianity as Platonism, of Kantian modernity as
Platonism, of science as Platonism, and so on. Broadly speaking, the authors of these epochs, in
striking contrast to Plato, take pride in what they believe to be the radical limits of human reason
and therefore of the radical unknowability of true being’s nonsensuous luminous nature. And
since the history of metaphysics is directly derived from and at the same time inferior to Plato’s
metaphysics, the former bears Plato’s name but in its derivative form of “Platonism”. What’s
more, due to the derivative nature of Platonism, Plato must be distinguished from it. With this
final distinction, we have a brief outline of Nietzsche’s formal conception of metaphysics: while
metaphysics is both Plato and Platonism, Plato is not Platonism6.
But what exactly is the real foundation (fundamentum in re) for Nietzsche’s distinction within
metaphysics between Plato and Platonism? What exactly for Plato is most proper to the Real that
Platonism is not able to see and that therefore defines its derivative deficient nature? What in
particular does Heidegger maintain that Nietzsche wants to «preserve» in Plato as he «twists
free» from the history of metaphysics of Plato and Platonism? Without a doubt, «luminous
consecutive paragraphs (249c5-251a), Plato repeatedly tries to make his point: that it is not easy for the soul «to be
put in mind thereof by things here (my emphases, 250a). Only the few (the lovers of beauty) «behold that which is
imaged» (250b); «Such a one, as soon as he beholds the beauty of this world, is reminded of true beauty» (249e).
Everything, then, in the sensuous realm of «earthly likenesses» (images), when seen as such (as images), aids us in
recollecting what is (although forgotten) paradoxically there now (true luminous being). See Plato (1989), pp. 496497, 249c-251a.
5
Nietzsche (1967), p. 71.
6
The whole of this paper takes seriously Nietzsche’s claim at the core of his account of metaphysics. As
Heidegger understand Nietzsche’s claim, Plato’s initial separation of nonsensuous essences from sensuousness
(which leaves the latter with the denigrated status of «appearances» without «true being») leads to the strength of the
Kantian claim of Modern Platonism that the former (nonsensuous essences) cannot be know (Heidegger, 1979, pp.
205-206). At the same time, Heidegger recognizes that Nietzsche’s distinction between Plato and Platonism also
allows one to make a case for Plato who has it that nonsensuous essences (luminous being) can be known insofar as
the soul is in the form of sophrosyne. In his Nietzsche, as I hope to show, Heidegger makes such a case and argues
from Plato’s eroticized conception of the logos that «nonsensuous eidetic seeing» is possible. But while Nietzsche
has it that a case can be made within the history of metaphysics for either Plato or Kantian Platonism, Heidegger
also knows that Nietzsche’s new conception of metaphysics (based as it is in his new concept of the soul) is neither
Ancient nor Modern. In this respect Heidegger recognizes that Nietzsche thinks he ultimately overcomes the
Kantian claim of Modern Platonism when seeing from the perspective of a different form of the soul another way in
which to «preserve» a relationship to luminous being (Heidegger, 1961, p. 234). For rather than unconditionally
denying the knowability or the existence of luminous being and its sublime, omnipotent nature, Nietzsche sets
luminous being back into sensuous nature. Here we have one of Heidegger’s most important insights into
Nietzsche’s thought: «that the sensuous corporeal, in itself possesses this being-beyond itself». that sensuousness
«surpasses itself» in scintillating shining as «transfiguration» See Heidegger (1979), pp. 212, 217. See also Sena
(2004), pp. 139-159.
130
�Plato is not Platonism: Musings on the Derivative De-eroticized Nature of the Modern Subject
being» is most proper to the Real (and therefore to any conception of metaphysics). Above all
else, its knowledge is to be «preserved» even if Nietzsche calls into question the nonsensuous
and posited nature that Plato assigns to it7. But how is it possible to «preserve» a relationship to
luminous being, and what’s more, to more than one conception of it? What «foundation» lets us
see the respective value of each conception without having to deny one at the cost of the other?8
Here, I believe Nietzsche knows (better than anyone before or after him) that Plato accomplishes
this task when establishing the complex nature of the soul as the critical foundation for
philosophy; the strength of Plato as a thinker, the magnitude and significance that Plato has for
Nietzsche, is based in Plato’s nuanced insistence that the complex nature of the soul (given the
plurality of its possible forms) is the starting point for a concept of philosophy that is able to see,
at least in principle, the respective value of more than one metaphysical view of the world9.
Plato then, in striking contrast to Platonism, secures from within the complex nature of the
soul a form of the soul that is able to take hold of the luminous nature of true being. As Plato has
it, only the outward regard of this particular form of the soul (sophrosyne) is able to see true
being and, in turn, bear the full weight of its aesthetic and poetic task: of bringing-forth the «true
in the beautiful». Platonism, on the other hand, coincides with the break from the aesthetic, from
what Plato characterizes as having true being (the Ideas and the gods) that everywhere informs
Plato’s mobile living thoughts and his measured luminous prose. What’s more, instructed by
Nietzsche, Heidegger advances a reading of Plato that suggests that Platonism’s break from the
aesthetic and its overall agnostic view of the world (religious or scientific) is based in a de7
Here I should stress that Heidegger tells us that for the sake of his «own inquiry» he wants to trace the history
of metaphysics so as to «see how Nietzsche, in spite of his will to subvert, preserved a luminous knowledge
concerning what had occurred prior to him» (Heidegger, 1979, p. 203). For both Plato and Nietzsche, there is no
doubt that in order for «luminous knowledge to be preserved» (bewahrte, Heidegger, 1961, p. 234) the soul must be
in a form that has access to it.
8
My focus in this paper is on the distinction Nietzsche makes within the history of metaphysics and not on his
foundational critique of it as based in Plato’s privileged form of the soul named sophrosyne. Heidegger, I believe, is
right to make much of this all-important distinction (Heidegger, 1979, pp. 200-220) and right in recognizing that the
distinction occurs within the history of metaphysics. In other words, the distinction between Plato and Platonism is
not meant to suggest that Plato somehow for Nietzsche is outside of the history of metaphysics that evolves out of
him as Platonism. Without a doubt, metaphysics for Nietzsche is based in Plato’s conception of the soul named
sophrosyne (Nietzsche, 1978, §15, p. 71) given the modern «tendency» (Tendenz) of its form (Nietzsche, 1978, §13,
p. 64) and its view of the world. But Plato, as Nietzsche knows, constantly refers back to the complex nature of the
soul as the starting point (the foundation) for any other competing or different conception of being even when
deciding upon sophrosyne as the only form of the soul that is able to catch sight of «luminous being». The full
significance of Plato for Nietzsche (Plato’s strength as a thinker) lies in the fact that Plato establishes the complex
nature of the soul as the starting point for his own or for any other competing conception of being. For this reason,
Plato above all others would be open to Nietzsche’s claim that there is another form of the soul that is able to access
«luminous being». In other words, even if Nietzsche sets himself apart from a history of metaphysics of Plato and
Platonism, Nietzsche nevertheless «preserves a relationship» (Heidegger, 1979, p. 203) to luminous being when
claiming that it is definitive of his «new interpretation of sensuousness». In so far as Nietzsche’s postmodern view
of the world cannot be traced back to the soul in the form of sophrosyne, he stands outside the metaphysics of Plato
and Platonism and marks the inception of a new branch of metaphysics that owes its origin to a different form of the
soul. Be that as it may, my intention here is not to privilege one form of the soul and its respective view of the world
(be it Ancient, Modern or Postmodern) over the others. Rather, I want to establish at the onset of this paper an
orientation to a history of philosophy that (in keeping with both Plato and Nietzsche) starts with the complex nature
of the soul and therefore recognizes that each form of the soul and its view of the world (be it Ancient, Modern or
Postmodern) is to be valued in its own right.
9
In fact, Plato never tires of reminding us that all of the soul’s possible forms are to be dialectically held open
for on-going critical investigation even after deciding upon sophrosyne as the form of the soul that is able to catch
sight of luminous being.
131
�Marylou Sena
eroticized conception of the rational capacity of the soul that in one way or another attempts to
function on its own without the influence of eros10, For this reason, Heidegger insists that
Nietzsche sets Plato’s aesthetic view of the world apart from the unaesthetic protracted history of
Platonism and its modern agnostic (religious or scientific) views of the world.
In light of these initial opening remarks on Nietzsche’s formal distinction between Plato and
Platonism, I now would like to advance a reading of Plato’s Phaedrus that isn’t based in
Platonism, that takes seriously the luminous, aesthetic nature of Plato’s prose and the difficulty
of accessing them in light of a history of Platonism that from Nietzsche’s perspective is blind to
the aesthetic11. Towards this end, I will begin (in the first section one of this paper) by advancing
Heidegger’s own efforts here that lead him to Nietzsche (l936-37) and to his reading of Plato’s
Phaedrus with Nietzsche’s all-important distinction in mind between Plato and Platonism. In his
reading, Heidegger connects Platonism to a de-eroticized conception of the logos. However,
Heidegger never gives us an analysis of the form of this de-eroticized soul that is responsible for
the derivative function of its logos and its limited secular «ontic» view of the world12. What’s
more, Heidegger fails to see that Plato does. Indeed, in his Phaedrus, Plato gives us a sustained
account of this new form of the soul that first takes shape in the one who argues for the
«benefits» of being a «non-lover»; it alone is responsible for a derivative function of the logos
and its agnostic view of the world.
In the second section of this paper (before directly advancing my own reading of Plato), I
want to address the basic form and essence of the soul that belongs to sophrosyne since it is from
its perspective that Plato sees the derivative form of the non-lover’s soul (defined by a derivative
form of sophrosyne) and the limits of its rational capacity and function. Towards this end, I want
to consider the way in which Plato’s radical critique and re-appropriation of the Apollinian and
of the Dionysian tradition (one of the subtexts of his Phaedrus) informs his conception of the
soul’s most basic form and all of its «measured» and «dithyrambic» prose13. Here I will suggest
that the form of Sophrosyne is Apollinian, and what’s more, that it is the only form of the soul
that for Plato secures the soul’s unified essence in its «manic» (and dithyrambic) state of being.
With these preliminary and preparatory reflections in mind, I will advance in the third and
final section of this paper a reading of Phaedrus that places at the center of its dramatic setting
Plato’s own sustained account of the nature and origin of this new non-lover’s de-eroticized
conception of the logos as based in a «derivative» form of sophrosyne. Thankfully, both
Hackforth and Griswold draw attention to Plato’s distinction here between his own «immortal»
10
See Gonzalez’s (2015) thoughtful account of Heidegger’s recently published 1932 seminar notes on Phaedrus
(along with the student protocols). Gonzalez focuses on the distinction that Heidegger sees between an «ontic»
nonerotic conception of the logos (definitive of Platonism) and Plato’s «ontological» erotic conception of it (logos
erôtikos). The latter secures the soul’s being (its ousia/physis) but only insofar as eros does not take the form of
«possession» and «sink into a mere lust for the sensible» (Gonzalez, 2015, p.236). See also Heidegger where he
directly connects eros to the soul’s active state of recollection. In this state man is «cast beyond himself, so that he is
stretched, as it were, between himself and Being and is outside himself. Such elevation beyond oneself and such
being drawn towards Being itself is erōs» (Heidegger 1979, p. 194).
11
What’s more, so certain of the limits of human reason, the history of metaphysics fails to look to the complex
nature of the soul for why this is the case.
12
See Gonzalez (2015) who shows us that Heidegger connects the derivative «ontic» character of Platonism to a
de-eroticized conception of the logos.
13
While the philosophical tradition and the scholarly works on Plato largely pass over Plato’s on-going critique
and re-appropriation of the Apollinian and the Dionysian, Derrida (no doubt, informed by Nietzsche) takes seriously
this «original structure of the Dionysian and of the Apollinian» and Plato’s own relationship to it (Derrida, 1978,
p.28). Of course for Nietzsche, this «original structure» lies at the core of Greek religion and myth.
132
�Plato is not Platonism: Musings on the Derivative De-eroticized Nature of the Modern Subject
conception of sophrosyne and the «mortal» derivative form of it that takes shape in the nonlover’s soul14. It is this very distinction that Plato sees that in fact set him apart from Platonism.
My final reflections, however, will not end here; for it is not the case that Plato forces us to
choose between his own conception of sophrosyne and what he sees as a derivative form of it.
Instead, Plato has us «observe from within ourselves» how all of the diverse and opposing ways
of seeing the world are based in us, in the complex nature of the soul. With this knowledge of the
soul’s complex nature in mind, Plato, no doubt, believes he ends the ensuing historical conflict
between this new mortal sophrosyne and immortal sophrosyne. Since both forms of sophrosyne
belong to the complex nature of the soul, their separate respective views of the world (the one
agnostic, the other divine) must be recognized as legitimate15, even if the value of the former is
to the latter as «lit lanterns are to» the bright morning light16.
1.
“Plato is not Platonism”, and yet we know Platonism’s break from the «luminous knowledge»
(helles Wissen) of Plato’s text persists and is readily apparent in the «unaesthetic» accounts of
Plato’s prose17. It is as if the luminous character of Plato’s prose, in keeping with the luminous
knowledge that informs them and gives them their immortal shape, remains in the shadows,
«gleamed in darkness unseen» and unknown (Sappho). Platonism, as Nietzsche has it, is the
history of this break from the aesthetic where the luminous knowledge of nonsensuous being that
enters Plato’s thought and that shapes his prose becomes forgotten. As Heidegger reads
Nietzsche’s account of its protracted birth, Platonism finally finds the strength and the means to
confront its own secret discontent (harbored in the souls of its authors so to speak) and breaks
free from what it suspects are the mere phantoms and ghosts of Plato’s thought called its Ideas;
Platonism finds the strength to be itself through Kant when denying the paradoxical nonsensuous
visionary capacity of the soul. If eidetic «nonsensuous seeing» is theoretically impossible for
human cognition, what then can be said of the truly aesthetic? What can be said of the luminous
light of nonsensuous being? And too, what of the sacred mysteries of old and of their rites of
initiation and imitation that Plato esteems so highly and re-appropriates as his own? Like death
itself, «nothing can be known about [nonsensuous being]». Worst of all, «nothing can be decided
for or against it» (that it is or that it is not)18. For if the sublime referent of nonsensuous being is
lost to sight, how then can it be recollected? And too, how does sensuous being now appear in
the absence of (in this break from) the aesthetic? If Heidegger is right in his reading of
Nietzsche, sensuousness now appears in Platonism as merely «earthly, as what it is not»19. Void
of spirit, sensuousness is no longer seen as mimetic (in its capacity to point beyond itself) and
reminiscent at all times of its own sublime origin that we too, as Plato has it, recollect, whether
14
See Griswold (1986), p. 75 and Hackforth’s translation of Plato’s Phaedrus in Plato (1989), pp. 491-492,
244d2-5.
15
Here, of course, everything depends upon recognizing the «inward» reflective capacity of the soul, of the
«turning of its gaze back upon itself». Thanks to this «inward regard» (an astonishing capacity of the soul in its own
right) we are able to «observe» from within «ourselves» (Plato, 1989, p. 485-237d) how it is that our soul’s
«outward regard» and view of the world shifts when we move (as we are able to do) from one form of the soul to
another.
16
Nietzsche (1954), p. 95.
17
Heidegger (1961), p. 234.
18
Heidegger (1979), p. 206.
19
Ivi, p. 204.
133
�Marylou Sena
we recognize this or not, in the referential play of difference that is already underway and alive
in every simple perceptual act of identity.
But Plato is not Platonism, and the “limits” of human cognition is not a given that can’t be
overcome. But what path leads to a reading of Plato that isn’t tarnished by Platonism? How
exactly is Plato to be distinguished from a history of thought (of Platonism) that grows out of
him and that relegates the region of luminous being to the unknowable? For Heidegger, and for
those who follow him in the wake of his thought, the only assured path lies in identifying the
origin of metaphysics. But with Nietzsche’s distinction between Plato and Platonism, this matter
of the origin becomes complicated and complex. How exactly is Plato to be distinguished from a
history of thought that grows out of him and that relegates the region of luminous being to the
unknowable? Compelled by Nietzsche’s distinction between Plato and Platonism, Heidegger
returns to Plato after Being and Time in search of Plato’s own account of an origin that
historically divides and separates him from Platonism. If we for a moment consider how
Heidegger advances beyond his own initial account of the origin of metaphysics in Being and
Time when returning to Plato in 1936-37, the complex nature of this origin, so essential to my
own reading of Plato in what follows, will become clearer.
Already in Being and Time (before pondering Nietzsche’s radical distinction between Plato
and Platonism in 1936-37), Heidegger we know attempts to overcome a history of metaphysics
when identifying its place of origin in the being of Dasein that paradoxically passes over itself,
over its ontological ecstatic state of being (its Da-sein). The origin of metaphysics lies in this
enigma of man, in Dasein’s ontological distance from itself: that Dasein is «ontically closest» but
«ontologically farthest» from itself20. Dasein’s ontic state of being, a state of being that passes
over itself, is responsible for the history of metaphysics characterized by a vorhanden
understanding of Sein. In its derivative ontic state of being, Dasein «merely looks (eidos) at
beings». In this derivative ontic state of holding back from any involvement, of merely looking
(eidos) at beings «the vorhanden perception of the world is consummated»21. What’s more, in
terms of this ontic vorhanden understanding of Sein, Dasein, in turn, understands itself (as
vorhanden). But the recognition of Dasein’s eclipse of itself (of its ontological distance from
itself) as the onset of metaphysics is not the overcoming of it as Heidegger warns on the last page
of Being and Time and so persists in the question:
It has long been know that ancient ontology works with ‘Thing-concepts’ and that there is a danger
of ‘reifying consciousness’. But what does this «reifying» signify? Where does it arise? Why does
Being get ‘conceived’ ‘proximally’ in terms of the present-at-hand (vorhanden) and not in terms of
the ready-to-hand (zuhanden), which indeed lies closer to us? Why does this reifying always keep
coming back to exercise its dominion?22
Heidegger advances an answer to his own complex question, and, what’s more, sees something,
no doubt, of a vorhanden «tendency» in his own account of the primordial meaning of the logos
as «legein» (“letting be seen”) when returning again to Plato after Being and Time, but this time,
as I have stressed, with Nietzsche’s distinction between Plato and Platonism in mind 23. Here
Heidegger follows Plato who has us observe «from within ourselves» how nous cannot reach the
height of its aesthetic aim of inquiry «where true being dwells» without the aid of tempered
20
Heidegger (1962), p. 69.
Ivi, pp. 88-89.
22
Ivi, p. 487.
23
See Heidegger (1979), pp. 200-210.
21
134
�Plato is not Platonism: Musings on the Derivative De-eroticized Nature of the Modern Subject
desire. If nous is to go beyond «acquired opinion» (doxa) to the subject itself of a given inquiry
(so as to then judge the opinion in terms of the subject itself) it needs desire. But desire must
serve the aim of nous and in this way become aesthetically transformed24. For when nous and
desire are together in this form of sophrosyne, the soul first secures its ecstatic essence (its
ousia). And now, in reaching out beyond itself, it has for the first time the sublime referent of its
shared aim in sight25.
If we are willing to take Nietzsche’s distinction seriously (that Plato is not Platonism), we
have then Plato’s text in striking contrast to a history of Platonism and its readers who dehistoricize its sublime prose. What’s more, we have Phaedrus where Plato gives his own
historical account of this break from the luminous knowledge of nonsensuous being and locates
the origin of it in the nonlover’s soul. Put different, Plato, stands at a witness to the birth of what
Nietzsche in fact identifies as modern Platonism and its break from the realm of luminous being
where too the gods dwell26. Appropriately named, this new form of the nonlover’s soul,
derivative in its kind of sophrosyne, takes shape in ignorance of its own soul’s complex nature.
For the nonlover, in passing over its own soul, fails to see that its profession of wisdom (so
contrary to Plato’s own) is but a form of hubristic pride that overlooks desire (epithumia) as one
of the soul’s ruling and guiding «principles» (“ideas” 237d7). Worst of all, a wisdom (agnostic in
character) that prides itself in what it knows through its «own intelligence» (244c9) and at the
same time prides itself in knowing that what it knows in principle falls short of «true being»
«sanctions the complete neglect» of the gods27. The initial connection is clear: In passing over
itself, the nonlover cannot see the light of luminous being nor hear the «unbidden» voice of its
sublime prose.
No doubt, Plato’s acute awareness of this historical break from «true being», from a living
mythos, brings new significance to what he sees as the soul’s paradoxical task of first having to
recollect itself in order to recollect in turn its own sublime origin. The luminous light of
nonsensuous being is what is closest and present to the soul (and at times, becomes more
exceedingly so) and yet it is unseen and forgotten. In the process of giving us his dialectically
account of the soul’s complex nature, Plato identifies not two but three forms of the soul:
sophyrosyne (rational desire), derivative (mortal) rational sophrosyne, and irrational desire.
Sophrosyne (rational desire) is to be set apart from the latter two hubristic forms of the soul (that
take shape in the absence of self-knowledge) since it is the only form of the soul that is nonhubristic, that does not pass over itself, and that in recollection of itself secures its unified
essence. Now the hubristic form of irrational desire is readily recognized throughout the history
of metaphysics and throughout Platonic scholarship, while the hubristic form of rationality, of
mortal derivative sophyrosyne, clearly is not. In fact, in his Phaedrus, Plato’s set his privileged
form of sophrosyne (rational desire) dialectically apart from the two hubristic forms of the soul,
of irrational desire, and rational sophrosyne28. Employing the use of dialectics, Plato reminds us
that the soul of sophrosyne (rational desire) alone is modeled after the gods it serves and in this
24
Plato (1989), p. 485, 237c-238e. Also see Gonzalez (2015).
In other words, when nous and desire (epithumia) are defined on their own and attempt to function on their
own, they each fall far short of securing the soul’s unified essence (its ousia) and its aesthetic aim.
26
In this spirit, Plato is the first in the history of philosophy to recognize the enigma in man: that his soul
foolishly investigates things outside of itself before investigating itself. See Plato (1989), p. 478, 230a. Without a
doubt, this historical reality continues on as our own.
27
Plato (1989), p. 491, 244c9.
28
From the perspective of immortal sophrosyne, Plato sees the limits of both the nonlover’s soul in its derivative
form of sophrosyne and the soul’s form of hubristic, irrational desire.
25
135
�Marylou Sena
way has access to the luminous light of nonsensuous being. As Plato would have us see, the
voice of his text, properly speaking, is historicized from out of a luminous ground. Unlike the
hubristic forms of the soul, the soul of immortal sophrosyne (rational desire) has as its immediate
horizon the gods it serves; at the same time, it has the more expansive horizon of luminous
being, where all of the gods are said to dwell, and above all else, where «the idea of the Good»
reigns supreme29. Before advancing a reading of Plato’s Phaedrus that magnifies Plato
dialectically distinction between his own conception of sophrosyne (of rational desire) and the
new derivative form of it (of rational sophrosyne), I want to briefly consider the nature of the
Apollinian and the Dionysian (a subtext of the Phaedrus) that Plato, no doubt, takes into
consideration when establishing the basic form (Apollinian) and essence (Dionysian) of the soul
that bears the name sophrosyne.
2.
The value of the Socratic soul of sophyrosyne cannot be stressed enough if we keep in mind that
Plato’s radical confrontation and appropriation of the sublime structure of the Apollinian and the
Dionysian takes place in Plato’s conception of the soul that takes the form of sophrosyne. Plato, I
believe, has his mind set on establishing the form of the soul that best reflects this sublime
structure of the Apollinian and the Dionysian so as to have access to the realm of untarnished
beauty where «true being» dwells. The soul’s form that best reflects this structure is named
sophrosyne; its name is to be repeated daily as the charm30. Above all else, we know the form of
sophrosyne is modeled after the god Apollo and accordingly has access to aspects of his sublime
being. What’s more, it is only by virtue of its Apollinian form (purged of hubristic desire) that
the soul, in turn, secures it Dionysian ecstatic essence of self-movement. Who can doubt the
sublime repose of the Apollinian that defines and delimits, cloaks and sustains, all of Plato’s
sophronic (measured/Apollinian) prose? And what of the transformative quality and effects of
this immortal voice that takes shape when, in true measure, Socrates, the «aesthetic listener»,
effaces and displaces his own voice (as the author of any of its discourses and prose) in
deference to it? We really do not need the prophetic report from Alcibiades of how the voice of
the Apollinian that resonates in the Socratic soul («without any instrument at all», Symposium,
215c) casts its sublime seductive lure and transformative spell on mankind as a whole 31. In
Plato’s art of «writing speech», of «writing sound» (not to be confused with the «pompous»
writing of the mantic «speech writers», Phaedrus, 257c6), we too are brought under the charm of
its spell. Here we encounter what Plato knows: That in this wondrous art (of «writing speech» of
«writing sound») no prearrangements of words are to be had in advance 32. There is only
Parmenides’ divine dictum of listening from a given subject and the ensuing art in which «the
first words that occur» (Apology, 17c) from it are left to speak and take form on their own. As
Alcibiades remarks, the simplicity of the Socratic style and choice of words (notwithstanding
their often ironic tone) only seems to increase the effects alive in the sublime ordering and
configuration of them.
29
Plato (1989), p.744, 508e.
See Plato’s Charmides (Plato, 1989, pp. 102, 155e, 113, 167a9, 121-122, 75d-176b).
31
All quotations from Plato’s dialogues (unless otherwise indicated) come from The collected Dialogues of
Plato (Plato, 1989).
32
Plato’s way of «writing speech» so to speak, of «writing sound», is not to be confused with the mantic
«speech writer» (Plato, 1989, p. 503-257c, 258a) whose mortal prose are derived primarily from the rational
capacity of the mind. This new mantic way of writing and speaking belongs to and is based in the nonlover’s soul of
derivative moral sophrosyne.
30
136
�Plato is not Platonism: Musings on the Derivative De-eroticized Nature of the Modern Subject
On the other hand, Plato’s confrontation and appropriation of the Dionysian (the other half of
this sublime structure) is always more complex since it entails his initial critique of what he sees
as the historically misguided conception and enactment of it. In Phaedrus, Plato carries out his
revaluation of the Dionysian (his critique and re-appropriation of it) at the pivotal place of desire
where a judgment must be made about its complex nature so as to decide upon the form of the
soul that is truly dithyrambic33. And so we have Plato’s nuanced critique in the Phaedrus of what
he takes as a misinterpretation of the Dionysian soul: To say that the soul’s structure of irrational
desire is truly dithyrambic is to sin against the great god Pan. Sophrosyne (tempered desire) is
the only form of the soul (where desire turns away from the body and serves the aim of nous)
that secures the soul’s unified essence, its truly dithyrambic manic state; it is alone the form of
soul that follows after its god; it alone is the form of soul in whom the god mimetically appears,
even if remaining more often than not unnamed and unknown. Sophrosyne, Apollinian in form,
is the medium (the instrument) of the Dionysian sublime rhythmic overflow. Contrary to
Aristotle, Plato knows that the «phenomenon called the Dionysian» identified in the
«Dithyramb»34 songs of old, remains the «hidden verse» in all prose35. This remains the case
even if we grant Nietzsche his case: that the outward look of Plato’s soul of sophrosyne (in the
turning of desire away from the body towards nous) is responsible for something of the
displacement of the Dionysian from itself, from its own sensuous being and rhythmic ground36.
But again, Plato is acutely aware of this interpretation of the Dionysian as definitive of
sensuousness and too of instinctual life. But this, as Plato insists, is a misinterpretation and a
view of the Dionysian that comes from the soul whose form (irrational desire) and aim signifies
the «compulsion» and «anarchy» of the instincts and not the liberation from them37. Be that as it
may, one encounters Plato’s re-appropriation of the all-beguiling aspect of the Dionysian in the
ecstatic state of being that defines the soul of sophrosyne (of rational desire), in the mimetic and
ecstatic character of sensuous appearances and in the free bestowing and movement of all
thought (dianoia). In seeing the sublime mimetic character of sensuous appearances and of
ascending nonsensuous thought, in making proper «use of such means of remembrance»
(hypomnemasin, Phaedrus, 249e7-8), the nonsensuous ground/origin of our being is historicized
once again. Derrida puts it well: This «original structure» of the Dionysian and the Apollinian is
not in history; it is rather «in an unexpected sense», «the opening of history, historicity itself»38.
Plato’s sublime soul of sophrosyne, equally Apollinian and Dionysian, is then the standard and
the perspective from which Plato sees the limits of the soul in the new form of the nonlover.
Without a doubt, the significance of this historical change in the nonlover’s soul to a derivative
mantic state of sophrosyne (of rational sanity) is alive and represented in the temporal movement
of Plato’s Phaedrus and captured in its dramatic setting39.
33
See Plato’s Phaedrus at 238c8-238d8 (Plato, 1989, p.486).
Aristotle (2006), p. 24.
35
See Calasso (2001) who convincingly argues for the sublime rhythmic ground of all prose. I am grateful to the
whole of this work on the nature of «absolute literature» (Calasso, 2006, p.24).
36
The displacement means that the Dionysian is no longer seen as definitive of sensuousness as such. As
Nietzsche has it, the displacement of the Dionysian is based in the Platonic soul of sophrosyne where the nature of
desire is set apart from the body.
37
See Plato’s Phaedrus at 241e (Plato, 1989, p. 489).
38
Derrida (1978), p.28.
39
Without a doubt, Plato tries to capture the irony of these first «sane poets», of their derivative state of madness
and of their derivative mantic works of sanity throughout the Phaedrus. See for example, Plato (1989), 229c-230b,
244a-245c3.
34
137
�Marylou Sena
3.
Plato’s “unaesthetic” readers (those who read him through the lens of Platonism) have not taken
seriously enough the dramatic setting of the myth of Boreas and Oreithyia in Plato’s Phaedrus as
signifying the lived, historical currents in which Plato knowingly positions his philosophy. One
current, as Plato’s Socrates would have it, reaches back in memory to the timeless origin of myth
and its manic forms of art. The other current, forgetful of this timeless origin, marks the birth of
the earliest seeds of what we today know as characteristic of modernity and with it the further
decline of myth. Plato’s Socrates, the opposing spirit to the latter, locates the birth and the nature
of this new modern, «hubristic» rational spirit and its new agnostic way of knowing in the
crafting of a new soul40. This new soul of the «nonlover» when seen from the perspective of the
Socratic soul of divine sophrosyne, is a soul of limited capacity, derivative in its form of
sophrosyne, defined and characterized in its limited, agnostic, capacity of knowing as giving rise
to a derivative mantic state of madness and form of art 41. This new state of soul and art of the
nonlover is derivative and named mantic (and not manic) since the source of its knowing no
longer originates from divine dispensation—from a state of soul open to divine manic madness-but rather from what Plato ironically calls the man-made madness of rational sanity (based in the
soul of mortal rational sophrosyne) where knowing originates from mere human intelligence
(244c-244d5). We know this change in the soul’s basic state, in the «outward look» of its being,
of its «ideas» (237d7), is dramatized in the Phaedrus in the figure of Lysias, «son of Cephalus»
and as we know, it is already alive in Plato’s Republic, in the Father of its discourse and in the
two heirs of his prose. In striking contrast to this genealogy, we have the sublime voice of Plato’s
text that takes aesthetic shape in the original writing of its discourses and in all of its prose. Far
from being erased in the writing of his text, this sublime voice is the ever-living spirit of its
sculptured prose. And so we are led in the Republic, as Plato’s Socrates is led, to a confrontation
with Cephalus’ foolish and wretched idea of piety where the business of the possession of
worldly goods in the service of what is «beneficial» to self-interest holds sway42. At the same
time, threatening this calculus of the sane, and equally alive in the Polis, is the unaesthetic
ravings of «agitated wantonness» of hubristic desire, at the base of the soul in its most
unwelcomed form.
Under the shade of the agnos tree (230b3-4) then, alongside the Platon tree, so we are told,
near the site of the Altar of Bores, Plato’s Socrates takes hold of this momentous historical
change in the soul’s basic state and new agnostic way of knowing43. With astonishing insight, he
tells us that this new soul of rational sophrosyne, what Hackforth long ago thoughtfully
translated as «rational sanity», is derivative in soul, defined by a hubristic, agnostic form of
reason where the rational function of the soul is defined alone (244c7-9) on its own without
desire so as to redefine and restrict the whole of the soul to only its rational principle (idea,
237d7). Plato’s Socrates is clear: The outward look of the soul’s rational principle (idea, 237d7)
undergoes a radical change in its nature and capacity when left to function on its own without
40
Plato (1989), p. 491, 244c.
See Griswold (1996), p.75. Griswold calls attention to the nonlover’s derivative form of sophrosyne and to its
reductionistic view of the world. My own reflections attempt to continue the work he has done here by pondering
the necessary relationship between the soul in the derivative form of sophrosyne and its secular view of the world.
42
Plato (1989), p. 479, 230e4-231c.
43
Ivi., p. 478-479, 230b.
41
138
�Plato is not Platonism: Musings on the Derivative De-eroticized Nature of the Modern Subject
«innate desire», the other «leading and guiding» principle (idea, 237d7) of the soul. In its
shrunken state, bereft of desire, the rational principle of the soul becomes limited in its view of
the world and capacity of knowing. What’s more, this «one-eyed principle of soul», limited in its
«outward look» to a secular view of the world, in principle cannot change or broaden its scope of
knowing by the power of its own rational gaze no matter how refined or advanced its
technological instruments might become. As Plato would have us see, the nature of its rationality
is radically determined in advance given the limits of its soul’s singular form. This new soul’s
lack of reflective inward regard towards itself is readily apparent to the Socratic soul given the
folly of its claim of being a nonlover. And yet, no matter how foolish the claim may be, the very
attempt to hold true to it gives rise to a derivative rational form of the soul that is «more puffed
up with pride than Typhon» (230a). Restricted then to the use of only its rational principle, the
soul fails to secure the celebrated unity of aim and its essence of self-motion/movement (of
moving from within itself out beyond itself) 44.
Now by way of contrast we know that Socratic divine sophrosyne (237e-238a) is not wholly
rational. Instead, sophrosyne, in the form of «rational desire», refers to the celebrated unity of the
soul; sophrosyne names the essential structural whole of the lover’s soul in the unity of its
essence and capacity as ever-existing out beyond itself in the manic state of self-movement.
Unlike the soul of rational mortal sophrosyne and its state of sanity, the Socratic soul of divine
sophrosyne brings along with it a «comprehensive view of the world» and the hope of the soul’s
experience of immortality. Defined by its Apollinian structure and form, Socratic sophrosyne is
unified in it outward look and aim. For when desire turns away from the unaesthetic want of
«bodily pleasure» and follows the council and blissful aim of nous, the soul becomes of one
mind (homonoeiton, 237d9) and is at the height of its aesthetic objective capacity. At the same
time, by virtue of its Apollinian form, it secures the height of its Dionysian ecstatic state of selfmovement. As ecstatic, the intermediary dwelling place of the soul (being in the body but not of
the body) lies in memory (249c6-249e6), in drawing ever near, in «drawing nigh to the divine»
(249d). Steadfast and at rest in its primordial ecstatic (truly dithyrambic) state of being «in itself»
and «out beyond itself», a way lies open to the being of the things that are; but most notably a
way lies open to the gods and the gifts of the manic arts that come from them.
Plato’s Socrates stands at the crossroad of this momentous change in the soul’s basic form to
a derivative mantic state of rational sophrosyne without however participating in it. For those
who do participate in this new form of the soul characteristic of the nonlover and its new mantic
way of knowing, go over to it, at least in part, out of a fear of eros. Ironically, the sane (those
with a soul of rational sophrosyne) fail to see that what they fear and flee in the face of is
themselves. In striking contrast to the «cleverness» and «folly» of the sane, Socrates knows that
eros, as a desire, is based in the soul and, therefore, cannot be dismissed. True to the dictate of
Apollo, he knows that eros in all of its competing and opposite forms is and remains a desire
(epithumia) defining one of the soul’s ruling and guiding principles (“ideas” 237de). Desire
together with nous determines us in our being and therefore is operative in every human
engagement45. Cloaked then in his Apollinian inward regard, seeking at all times «precision in
44
Its essence lies in being the source of its own motion. See Plato’s Phaedrus (Plato, 1989, p. 493, 245e). Also:
See Gonzalez’s (2015) on Heidegger’s treatment of the soul’s form and essence (ousia).
45
Plato’s Diotima tells us «we all make the same mistake» of limiting our conception of love to one activity; we
call the one thing we are «devoted to» by the name «love». We fail to see that every activity is a desire of the
beautiful/good and therefore should be called love, even though we give different proper names to each activity
(Plato, 1989, p. 557, 204b3-204d7).
139
�Marylou Sena
matters of soul» Socrates instructs the youth not to be won over «by an argument that seeks to
scare us into preferring the friendship of the sane» (245b) over a lover. As Socrates has us see,
«the friendship of the sane» is the derivative mantic form of love based in the nonlover’s soul of
rational sophrosyne: «False is the tale that when a lover is at hand favor ought rather to be
accorded to one who does not love, on the ground that the former is mad, and the latter sound of
mind. That would be right if it were an invariable truth that madness is an evil, but in reality, the
greatest blessings come by way of madness, indeed of madness that is heaven-sent» (244a). The
soul of winged desire, open as it is to heaven-sent madness, is not to be confused with its
opposite, what Plato’s Socrates calls hubristic desire, based in the soul’s form of «irrational
(alogos) desire» (238b8), where desire gains mastery over reason’s rule, dragging the whole of
the soul downward towards the aim of the pleasures of bodily beauty. The latter is well known as
an abomination of soul for Plato’s Socrates (aborted in its truly Dionysian dithyrambic
movement towards its most proper spiritual aim) and is named hubris (237d-238c)46. And while
the nonlover’s hubristic soul of rational sophrosyne and its friendship of sanity are deeply
preferred (244a) to the hubris of the «agitation» and «compulsion of irrational (alogos) desire»,
both are opposites of the truly wise dithyrambic soul of divine immortal Socratic sophrosyne
where desire follows reason’s rule and in the celebrated unity of its primordial essence as
accenting self-motion/movement, the soul of the lover, moving from within itself, reaches out in
mania beyond itself in imitation (mimesis) of a god. Now, it is obvious that the hubristic soul of
«irrational desire» is the opposite of the manic soul of «rational desire», of divine/immortal
sophrosyne. It takes, however, more than one reading of the Phaedrus to see that for Plato’s
Socrates, the nonlover’s soul in the derivative form of mantic «rational sanity»
(mortal/sophrosyne) is also the opposite of the soul of rational desire and its sohyrosyne47.
Socrates tells us that it is when stressing that the whole of his second speech in the Phaedrus
attempts to show «that love is not a thing sent from heaven for the advantage (my emphasis)
both of lover and beloved» (245b), in the crude derivative mantic form of the «friendship of the
sane». Socrates continues, «What we have to prove is the opposite, namely that the madness of
love is a gift of the gods, fraught with the highest bliss. And our proof assuredly will prevail with
the wise, though not with the learned (my emphases)»48. The soul of rational desire, «praised for
its wisdom» dialectically stands then alone on the right side of wisdom in opposition to the two
hubristic forms of the soul defined by hubristic desire and hubristic rationality. And while the
«learned» soul of rational sanity (of derivative sophyrosyne) is to the right of irrational desire,
both are dialectically «censured» and placed on the left «side of folly»49.
Fleeing then in the face of the seductive lure of hubristic irrational desire (a form of eros for
Plato’s Socrates all too human), the sane seek refuge in the «clever» and «foolish» claim of
being able to eradicate desire from their engagements and of «regulating their services by the
scale of their own means, with an eye to their own personal interest» (231a). In fact, Lysias
insists that the sane (in contrast to lovers) are never reproached «on the score of behaving to the
46
Socrates’ first speech paradoxically tells the truth about what eros is not.
See Griswold (1996, pp. 74-76) who contrasts «mortal sophrosyne» with «divine sophrosyne».
48
Plato (1989), p. 492, 245c. The «learned» (defined as the mantic form of the soul, of derivative sophrosyne)
use reason to regulate their own affairs in advance with the aim of personal «advantage», the «wise» (defined by the
temperate form of the soul, immortal sophrosyne) are open to the «bliss» and «wisdom» bestowed upon them from
the gods.
49
Ignorant of themselves, the sane fail to see the folly of their claim of being nonlovers. Since desire is one of
the leading principles (ideas, 237d7) of the soul «that we follow», that determines us at all times in our being (237de), it is foolish to think it can be eradicated.
47
140
�Plato is not Platonism: Musings on the Derivative De-eroticized Nature of the Modern Subject
detriment of their own interest» (231a, 234b)50. This new soul’s ability to regulate its own affairs
in advance, in accord with its own personal interest and advantage, is celebrated, ad nauseam by
the “I” of the nonlover and accordingly stands at the beginning of his discourse, setting the stage
for all that is to follow: «You know how I am situated and I have told you that I think it to our
advantage that this should happen. Now I claim that I should not be refused what I ask simply
because I am not your lover» (my emphases, 230e-231a). Lysias, who mimetically stands in for
this nonlover, crudely argues for the advantage and benefit of friends over lovers since friends in
contrast to lovers never «reproach» each other when placing their own self-interest above each
other, while nevertheless agreeing to sexual gratification between friends. Never, perhaps, is
Socrates more ironic than when answering to this «crude» arrangement; indeed intending the
opposite, he asserts, «splendid!» and «what an attractive democratic theory that would be!»
(227d).
Of course, the mimetic character of Socrates’ irony, intended here to mirror back the face of
«folly» and of the «ridiculous», is grounded and sustained in its mimetic value by the real
character and knowledge that Socrates has of his own soul and of its competing forms. Instructed
by his own soul’s inward regard, Plato’s Socrates knows that this celebrated, self-serving, «I» of
the nonlover, oblivious to its own soul, does not see the hubristic shift in its soul’s rational
function and its aim that takes place when, in the censuring of desire, its soul’s rational capacity
is thrown back upon itself and functions in the derivative form of mantic knowing. To catch sight
of the origin and nature of mantic knowing, «we must observe from within ourselves» the
relationship between the birth of this new form of the soul and the derivative capacity of its
rational nature that comes from it. The relationship is clear: The very attempt to reduce the soul
to the use of only its rational principle (idea) means that the locus of knowing is displaced.
Knowing is no longer recognized as based in the being of the things that are extraneous to the
soul. Restricted to the use of only its rational principle, diminished in its ecstatic state, the
rational capacity of the soul is thrown back upon itself and takes on a derivative nature where it
functions as the primary cause and ground of its own knowing. Thrown back upon itself, limited
in it ecstatic capacity with no true aim in sight, the “I”, («more puffed up with pride than
Typhon», 230a) becomes conspicuously present to itself and to the nature of its own rationality.
But without the referent of the complex nature of the soul, the “I” cannot see that the form of its
own soul determines in advance the radical limits of its rational nature. Thrown back upon itself,
the “I” becomes «posited» and conspicuously present to itself as the primary cause of its own
knowing, but, again, of a knowing that falls short of the Real, that at all times is restricted to the
«inventive», contrived (σοφιζόµενος, 229c) realm of what is plausible and therefore
probable51. And while this new rational subject is right in seeing that its rationality in principle
falls short of the Real (for whom then the truth of any subject is not attainable), it fails to see that
this is because of its soul’s limited form and diminished ecstatic outward look. Finally, if we
keep in mind that this new way of knowing is based in the soul as such, we can understand the
full scope of its historical significance and application: The change in the non-lover’s soul to the
state of rational sanity means that all of the manic arts become derivative and mantic (man-
50
Socrates as we know, in stark contrast to the nonlover, regulates his affairs in service of the god Apollo.
See Sallis (1974, p. 114) who has it that the word σοφιζόμενος at 229c means both «devise» and «contrive». It
appears that Hackforth wants to interpret Plato word σοφιζόμενος as «inventive» where he then uses it at 229d, line
4. In other words, Plato’s word σοφιζόμενος appears only at 229c and not at 229d.
51
141
�Marylou Sena
made)52. Its «unaesthetic» outward regard applies to nothing less than the whole of the world. In
place of the divinely inspired manic arts, this new soul constructs for itself a method based in the
limits of its rationality that nothing can withstand: Probability (εἰκὸς, 229e). With truth no longer
in sight, this new rational subject at best is relegated to the practical aim of service to humanity
in the interest of what Plato calls a «worldly wisdom» and a «[meagerly] measure of worldly
goods» (256e). Its rationality is servile, and Platonism begins.
But Plato is not Platonism. In 1951-52 Heidegger again returns to Plato and reaffirms once
again Nietzsche’s important distinction between Plato and Platonism. And once again Heidegger
speaks of the «necessity» of thinking together legein and noein («the letting-lie-before and the
taking-to-heart») as a way of answering to the derivative understanding of the logos and of its
break from mythos. But this time, Heidegger is somewhat dismissive of the distinction between
Plato and Platonism in light of what he calls the «withdrawal of the gods». To make matters
worse, Heidegger has it that this «withdrawal» is inherent to the gods and therefore without a
historical beginning that can be overcome:
Mythos and logos become separated and opposed only at the point where neither mythos nor logos
can keep to its original nature. In Plato’s work, this separation has already taken place. Historians
and philologists, by virtue of a prejudice which modern rationalism adopted from Platonism,
imagine that mythos was destroyed by logos. But nothing religious is ever destroyed by logic; it is
destroyed only by the God’s withdrawal.53
But Heidegger’s remarks here are less than helpful and turn away from the very problem that
Plato sees and confronts when identifying in the soul of the nonlover a rational form of hubris.
Plato is clear: The break from mythos (from the luminous light of nonsensuous being) is
coincident with the hubristic rational form of the nonlover’s (nonerotic) soul54. Any attestation to
the timeless origin of mythos is impossible given the restricted form and outward look of its
gaze. In an effort to remedy this break, Plato’s Socrates speaks of the soul’s paradoxical need to
first recollect itself55. Towards this end, Plato’s Socrates dialectically distinguishes three forms
of the soul. Immortal sophrosyne is «praised for its wisdom» and placed on the «right». Hubristic
desire and hubristic rationality are «censured for their folly» and placed on the «left». But Plato
must have known that the tension between the forms of the soul increases with the historical
birth of the third form of the nonlover’s soul. Plato leaves it to us to ponder if hubris is «two» in
kind or if in fact it is «one»; Plato must have known, if hubris is one, then the question must be
raised: Is the erotic conflict at the core of the soul centered around hubristic desire and its aim of
bodily pleasure (irrational desire) or is it in the typhonic “I” that in fact becomes hubristic when
it denies eros? If we add Nietzsche to these final reflections (for Nietzsche above all others
52
Accordingly, the manic lover’s art of recollection and «procreation in beauty» becomes the mantic
«friendship of the sane» with the aim of self-interest and sexual gratification. The manic art of divine purification
becomes man-make purification with the aim of what is beneficial to human health. The manic art of the Muses
becomes man-made poetry with no «instructive» aim in sight: For those who «come to the gates of poetry without
the madness of the Muses, persuaded that skill alone will make him a good poet, then shall he and his works of
sanity with him be brought to nought» (245a). And finally, the manic art of prophecy becomes man-made prophecy.
Here, nature is taken as a sign indicative of approaching physical events. In divine prophecy, the whole of nature
takes on the phenomenal structure of a sign in which a divine presence might make itself known.
53
Heidegger (1968), p. 10.
54
It is not the case that the gods turn away from us, but rather that we have turned away from them.
55
Socrates is insistent: Before the soul can know the truth of anything «extraneous to itself», it must secure its
Apollinian, sophronic form. See Plato (1989), p. 478, 230a3.
142
�Plato is not Platonism: Musings on the Derivative De-eroticized Nature of the Modern Subject
follows Plato’s musings on the soul) it is clear that his judgment is not against eros as tied to the
body but rather against the hubristic “I” that denies eros (as based in the body). In this spirit
Nietzsche has it that the Socratic soul of sophrosyne, while manic, nevertheless has modern
«tendencies» that are, in fact, in keeping with what Plato wants to say about the logos of the
nonlover56. But there is no Nietzsche without Plato, and there is no Plato (nor the burden of
philosophy as Plato understood it) without Apollo’s call for self-examination. The fact that Plato
has the strength and the courage to see (along with the form of hubristic desire) a rational
hubristic form of the soul shows us that he is supremely worthy of being called a «thinker of the
unthought», who stands «at the gates of poetry», who in true piety thinks ahead by thinking back
in Memory (Mnemosyne)57.
Bibliography
Aristotle (2006), Poetics, trans. J. Sachs, Focus Publishing/R. Pullins Company, Newburyport.
Calasso, R. (2001), Literature and the Gods, trans. T. Parks, Vintage International/Random
House Inc., New York.
Derrida, J. (1978), Writing and Difference, trans. A. Bass, University of Chicago Press.
Gonzalez, F. (2015), “‘I Have to Live in Eros’: Heidegger’s 1932 Seminar on Plato’s Phaedrus”,
in Epoché: A Journal for the History of Philosophy, vol. 19, n. 2.
Griswold, C. (1996), Self-Knowledge in Plato’s Phaedrus, Pennsylvania State University Press,
University Park.
Heidegger, M. (1979), Nietzsche, The Will to Power as Art, Volume 1, trans. D.F. Krell, Harper
and Row Publishers, San Francisco.
Heidegger, M. (1961), Nietzsche 1, Günther Neska Verlag, Pfullingen.
Heidegger, M. (1962), Being and Time, trans. J. Macquarrie & E. Robinson, Harper & Row,
New York.
Heidegger, M. (1968), What is Called Thinking, Harper & Row, New York.
Nietzsche, F. (1954), Thus Spoke Zarathustra, in The Portable Nietzsche, trans. W. Kaufmann,
Viking Penguin Inc., New York.
Nietzsche, F. (1967), Werke in Zwei Bänden. Die Geburt Der Tragödie, Band 1, Carl Hanser
Verlag, München.
Nietzsche, F. (1972), The Birth of Tragedy, trans. W. Kaufmann, Random House, New York.
Plato (1989), The Collected Dialogues (including the Letter), edited by E. Hamilton and H.
Cairns, Princeton University Press, Princeton.
Sena, M. (2004), “Nietzsche’s New Grounding of the Metaphysical: Sensuousness and the
Subversion of Plato and Platonism”, Research in Phenomenology, Brill Academic Publishers,
volume 34, pp. 139-159.
56
Nietzsche (1967), pp. 82, 87, 91. See also Zarathustra Prologue §3 (Nietzsche, 1954, pp. 125-126) where
Nietzsche maintains that the basic structure of the Platonic soul is defined by contempt and contentment. For insofar
as the Platonic soul of sophrosyne has contempt for the body (believing this to be the virtue of the soul and therefore
leaving the body «meager, ghastly and starved»), its own soul’s rational capacity is thrown back upon itself; unable
to receive the sense and meaning of things, its rational capacity is restricted to a life of contentment that is manmade and limited to «the invention of happiness». Such is the «tendency», as Nietzsche has it, of the Platonic soul.
57
Heidegger (1968), pp.10-11.
143
�Marylou Sena
Abstract
One of the enduring problems of phenomenology concerns the dispute over the nature of the
modern subject (subjectivity) that is responsible for its own agnostic and atheistic views of the
world. In an effort to understand the “obscurity” around the nature of the modern subject,
Heidegger turns to Plato (1936-37) bearing in mind Nietzsche’s distinction between Plato and
Modern Platonism. From the perspective of Plato’s eroticized conception of the logos, based as it
is in the soul’s form of sophrosyne, Heidegger draws the following conclusion: the Kantian claim
of Modern Platonism that the nonsensuous being of Plato’s Ideas and of the gods cannot in
principle be known is based on a de-eroticized, derivative, conception of the logos. But
Heidegger fails to see Plato’s own astonishing account of how this new logos of the “non-lover”
is based in a derivative form of sophrosyne.
Keywords: Heidegger, Plato, Soul, Logos, Sophrosyne
144
�CARLO SINI*
Husserl e la natura degli antichi Greci
Nel maggio del 1935 Edmund Husserl tenne a Vienna una celebre conferenza, il cui testo venne
riprodotto come terza Dissertazione nel suo ultimo libro, La crisi delle scienze europee e la
fenomenologia trascendentale, rimasto incompiuto (Husserl 1961). Dal testo della conferenza,
dedicato a La crisi dell’umanità europea e la filosofia, ricaviamo un tema particolare, relativo al
rapporto tra scienza della natura e scienze dello spirito: tema che non ha smesso sicuramente di
essere attuale e che nondimeno filosofi e scienziati sembrano per lo più lasciare sullo sfondo delle
loro ricerche e dei loro metodi, senza cioè farsi carico dei problemi e dei paradossi che quel tema
accompagnano.
Diamo anzitutto la parola a Husserl. Soltanto le scienze naturali, egli osserva, possono indagare
la natura puramente come tale (ivi, p. 330). Possono cioè astrarre da ogni altro elemento che non
sia riducibile alla oggettività pura, alla mera “cosalità” misurabile del mondo naturale: per
esempio tali scienze possono calcolare la caduta di un grave, assunto nella astrazione della sua
pura oggettività fisica, della sua “massa”, senza chiedere se si tratti di un sasso o di un corpo
umano, se vi siano responsabilità personali nella sua caduta e così via. Questo tipo di astrazione le
scienze dello spirito non possono invece perseguirlo o realizzarlo: gli scienziati delle scienze dello
spirito (storici, psicologi, sociologi, archeologi, antropologi ecc.) non possono “astrarre” dalla
pura natura per trovarsi davanti agli occhi o tra le mani la natura “spirituale” degli esseri umani.
Non possono farlo (sicché già il supporlo sarebbe una insensatezza), «perché la spiritualità
animale, la spiritualità delle “anime” umane e animali […] si fonda singolarmente e causalmente
sulla corporeità». Lo spirito cioè, il Geist, non esiste separato dal corpo vivente o Leib. In questo
ambito di problemi si può solo ricorrere a descrizioni, a una “storiografia dello spirito”. Per
esempio, uno storico dell’antica Grecia non può fare a meno di considerare la geografia greca,
l’architettura, la maniera di coltivare la terra e di allevare gli animali, l’educazione fisica e gli
strumenti dell’educazione morale e intellettuale e così via. Non può cioè prescindere dalla vita
concreta dei corpi greci, che non sono puri corpi naturali, ma sono appunto corpi “storici”, cioè a
loro modo storicamente formati e conformati e storicamente attivi. Tutta la loro cultura è in
cammino con i loro corpi, quando i Greci camminano, cavalcano o solcano il mare.
Ma qui cade appunto il problema. Scrive Husserl:
Lo storico, lo studioso dello spirito e della cultura in tutte le sue sfere, ha certamente, tra i suoi
fenomeni, la natura fisica; per tornare al nostro esempio, la natura dell’antica Grecia. Ma questa
natura non è la natura nel senso delle scienze; è bensì ciò che per gli antichi Greci valeva come
natura, quella che si apriva di fronte ai loro occhi, la realtà naturale nella dimensione del mondodella-vita (Lebenswelt). Più precisamente: il mondo storico circostante dei Greci non è il mondo
obiettivo nel senso delle scienze; è bensì la loro rappresentazione del mondo, è cioè la validità
soggettiva del mondo, con tutte le realtà incluse in questa validità, tra l’altro: gli dèi, i dèmoni, ecc.
(ivi, pp. 330-331).
Si ravvisa dunque una netta contrapposizione: da un lato il mondo naturale della fisica, frutto di
specifiche operazioni astrattive (massa, peso, gravità, velocità, accelerazione ecc.) in riferimento a
___________________________
*
Università degli Studi di Milano
Bollettino Filosofico 33 (2018): 145-149
ISSN 1593 -7178 - 00030
E-ISSN 2035 -2670
DOI 10.6093/1593-7178/5912
�Carlo Sini
ogni corpo considerato in quanto tale, cioè fuori da ogni componente “storica”; dall’altro lato il
“mondo circostante” (Umwelt), costituito dalle validità intersoggettive dei corpi storicamente
esistenti (per esempio il mondo circostante degli antichi Greci). Questa nozione di “mondo
circostante”, dice Husserl, «può essere applicata esclusivamente nell’ambito della sfera
spirituale». Come per tutte le umanità vissute sul pianeta, c’è il fatto che anche noi
viviamo in un nostro particolare mondo circostante, che a esso vanno tutte le nostre preoccupazioni e i
nostri sforzi […]. Il nostro mondo circostante è una formazione storica in noi e nella nostra vita storica.
Perciò non c’è nessun motivo per cui chi tematizza lo spirito puramente come tale debba perseguire una
spiegazione, che vada al di là della sua sfera. In generale: considerare la natura che vale nella prospettiva
del mondo-della-vita come un che di estraneo allo spirito e fondare le scienze dello spirito sulle scienze
naturali, presumendo di renderle esatte, è un controsenso (ivi, p. 331).
Controsenso o no, di fatto il cammino delle scienze dello spirito, o delle cosiddette scienze
umane, non ha mai smesso, nel corso di più di un secolo, di imitare spasmodicamente la
oggettività delle scienze della natura e i loro metodi analitico-quantitativi: sociologi,
economisti, psicologi, psicoanalisti, psichiatri, neurologi, biologi, logici, linguisti, antropologi
[…] tutti insieme allegramente in un cammino consapevolmente “riduzionistico”, sicuramente
non privo di risultati specialistici entusiasmanti e però, insieme, di opinioni pseudoscientifiche
nelle quali il paradosso sopra segnalato dà luogo a equivoci, a pure mostruosità concettuali e a
discorsi superstiziosi e irrazionali, peraltro diffusamente inavvertiti. In proposito, la soluzione
presa generalmente per buona è, sostanzialmente, la seguente: il mondo circostante considerato
dal punto di vista dei vari popoli storici è il frutto delle loro soggettive immaginazioni e
opinioni, con le quali essi hanno antropomorficamente e fantasiosamente rivestito la natura in
sé delle cose; il mondo delle scienze moderne è invece quello che, tramite esperienza ed
esperimento, descrive oggettivamente, in un cammino infinito, come sono fatte davvero le cose
considerate in loro stesse, cioè come è fatto il mondo, l’uomo, questo stesso dire e pensare e
così via. Ancora una versione del vecchio dualismo “cartesiano”. Peccato che nel sostenere
tutto ciò, qualcosa sia stato dimenticato. È stato completamente dimenticato, dice Husserl,
che le scienze naturali (come tutte le scienze in generale) sono costituite da una serie di operazioni
spirituali, quelle compiute dagli scienziati attraverso la loro collaborazione. Come tali esse rientrano,
come tutti gli altri eventi spirituali, in un ambito che deve essere spiegato dal punto di vista delle
scienze dello spirito. Non è forse un controsenso, un circolo vizioso, spiegare l’evento storico “scienza
naturale” dal punto di vista delle scienze naturali, ricorrendo alla scienza della natura o alle leggi della
natura le quali, in quanto operazione spirituale, rientrano esse stesse nel problema? (ivi, p. 331).
Il problema della scienza, aveva già detto Nietzsche, non si può spiegare con la scienza.
Due controsensi dunque: spiegare le scienze dello spirito con metodologie del tutto estranee e
inappropriate rispetto ai loro fenomeni specifici (per esempio spiegare un pensiero riducendolo
alla registrazione di un’attività cerebrale); e ancora spiegare le scienze della natura come se le loro
attività fossero un prodotto di quelle stesse leggi naturali che sono lo specifico risultato delle loro
operazioni spirituali.
Sembrerebbe allora evidente che ciò che ci occorre è una scienza complessiva; una scienza che,
a partire dalle concrete operazioni dei corpi storicamente viventi degli esseri umani, e in
particolare dei ricercatori, ricostruisca genealogicamente l’evento spirituale complessivo del
sapere umano via via verificatosi nel tempo delle civiltà e delle culture. Nella seconda
Dissertazione della Krisis (dedicata al confronto tra scienza naturale e scienza dello spirito, con
particolare riferimento alla psicologia, testo scritto prima del 1930), Husserl ipotizza appunto una
sorta di scienza universale che renda tematiche le umanità storiche: anzitutto noi a partire dalla
146
�Husserl e la natura degli antichi greci
nostra, con le sue eredità interne ed esterne, sino a concepire una «scienza del tutto o filosofia
universale». Scrive Husserl:
Tutto ciò è ancora molto superficiale, non sono ancora state considerate le idee normative delle umanità
e della loro cultura, quelle che determinano la vita degli uomini, nella loro singolarità e nel loro
accomunamento e che rappresentano un dovere secondo cui vanno prese le decisioni [che regolano
universalmente la vita propria e la vita della comunità]. Ciò porta dunque a considerare il “senso”
immanente della storia […]. Finalmente la scienza personale universale sembra trasformarsi in una
scienza del tutto, in una filosofia universale e, eideticamente, in un’ontologia universale. Perché tutto
procede da noi, dagli uomini viventi, da noi che poniamo problemi scientifici – e noi siamo persone e il
nostro mondo comune è per noi il tema di tutti i temi, di tutte le problematiche possibili, e quindi anche
delle questioni ultime e supreme dell’umanità. […] Qui il nostro punto di partenza: noi, noi che
compiamo considerazioni universali personali, che introduciamo in esse la nostra considerazione
universale del mondo circostante, ecc., noi stessi siamo uomini, uomini europei, uomini che siamo
divenuti storicamente; in quanto storiografi produciamo a nostra volta la storia del mondo e la scienza
del mondo, in tutti i sensi, una compagine culturale storica motivata dalla storia europea in cui ci
troviamo. Il mondo che è per noi è a sua volta una nostra formazione storica, come noi stessi, nel nostro
essere, siamo una formazione storica. Qual è, in questa relatività, l’irrelatività che essa presuppone?»
(ivi, pp. 326-327).
Il tema del precategoriale, del mondo-della-vita, con la geniale rivalutazione della doxa come
sapere di primo genere o sapere primordiale dell’intera umanità, sapere che è al centro della
ricerca della Krisis, questi temi costituiscono l’ultimo orizzonte della fenomenologia husserliana:
qualcosa che per certi versi va oltre l’esistenzialismo sartriano e merleau-pontyano e, volente o
nolente, heideggeriano; così per esempio pensava Enzo Paci, nella sua rivalutazione della
fenomenologia genetica o, come lui diceva, della “scienza nuova”. Restano nondimeno diversi
problemi, che, a mio avviso, non inducono a soluzioni “ontologico-trascendentali” e alla ricerca di
una irrelatività che sia a fondamento della relatività o del relativo di tutte le relazioni, come
sembra pensare l’ultimo Husserl. Formuliamo in proposito qualche considerazione e delle
indicazioni necessariamente molto succinte.
Anzitutto il ricorso husserliano alle operazioni spirituali ultimativamente fondanti (e in questo
senso “trascendentali”) non sembra in grado di correggere il dualismo cartesiano problematico che
affligge i saperi della modernità europea, il loro “naturalismo” dogmatico, come diceva
giustamente, ma purtroppo inascoltato, Husserl. Né è tale l’opposizione variamente ribadita tra
soggettivo e oggettivo. Paci insisteva, per parte sua, sul tema del Leib, del corpo proprio vivente in
quanto luogo di costituzione del senso (e quindi ricordava in particolare i manoscritti raccolti nel
secondo e terzo volume delle Ideen). Ma il corpo non è “vivente” grazie a una animazione
prodotta da misteriose attività “spirituali” intenzionalmente rivolte al mondo circostante.
Nonostante l’importanza straordinaria delle descrizioni fenomenologiche regalateci da Husserl,
impostare in questo modo il problema significa ricadere in una qualche forma di criptospiritualismo o di idealismo, come alcuni infatti hanno lamentato.
Il punto di partenza, diceva giustamente Husserl, non può essere che qui dove ci troviamo, nella
storica dimensione della doxa concretamente vissuta e attuata; qui dove, come Husserl ricorda,
siamo presi quotidianamente dai nostri progetti di vita, dalle nostre convinzioni, dai nostri
innumerevoli saperi comuni e dalle nostre competenze professionali, dalle relazioni molteplici che
attraversano e orientano le nostre vite, dalle eredità del passato, dalle aspirazioni verso il futuro, da
collaborazione e competizione, amicizia e avversione e così via. Non si tratta di mettere
metodicamente tra parentesi tutto ciò per tentare di accedere a un terreno descrittivo supposto
neutrale e infine, chissà come, trascendentalmente “costituente”: progetto che è comunque
147
�Carlo Sini
anch’esso già “costituito”, che è una figura della opinabilità storica di una certa filosofia europea,
giunta a uno snodo critico della sua vicenda, come lo stesso Husserl vide alla fine e sottolineò con
coraggio, ma senza poter indicare poi una concreta via d’uscita.
Alla via d’uscita possiamo qui alludere richiamando e in certo modo utilizzando liberamente
proprio una espressione husserliana, tratta dalla celebre Appendice Terza della Krisis: Sprachleib,
corpo-vivente-linguistico. Corpo, direi io, della universale conversazione, dell’universale discorso
intersoggettivo, che sin dai primordi rappresenta il ponte che traghetta quotidianamente la vita
nella dimensione dell’umano. Non però una espressione primordiale dello spirito intenzionale,
come sostanzialmente sembra suggerire Husserl, ma, al contrario, la retroflessione progressiva
delle operazioni strumentali del corpo “lavorativo” umano, o corpo primordiale della cultura. Qui
giocano un ruolo essenziale gli strumenti esosomatici della primordiale “tecnica” umana: non
qualcosa di aggiunto all’umano, ma il terreno di coltura stesso dell’umano, nella fondamentale
traduzione del corpo vivente (Leib) in corpo-cosa (Körper) e infine in corpo-strumento. È qui che
lo strumento principale della trascrizione “spirituale” dell’azione originariamente tecnica è
appunto il corpo vivente linguistico, articolato nei discorsi attivi, gestuali, propositivi, interattivi,
illocutivi, ecc. del dire comune da tempo immemorabile in cammino. Specchio di ogni altra azione
strumentale, che già si è di per sé retroflessa sul soggetto agente rendendolo sempre più
consapevole della sua azione e in questo senso sapiente, il corpo linguistico, strumento
esosomatico per eccellenza, si svolge e si realizza nella sua duplice, costante attività
intersoggettiva: come veicolo aggregante la comunità (con la sua storica Umwelt) e come veicolo
costitutivo di “oggettività” conoscitive comuni, tramandate a partire dal tesoro e dal patrimonio
stesso delle parole, come pensava per esempio Vico. Strumento regio, dicevano Aristotele e
Giordano Bruno, luogo di coltivazione della humanitas e della storia infinita iscritta nel lavoro
sociale e nel patrimonio dei suoi saperi.
Storia dell’intreccio invisibile e sempre attivo del dire e del fare, che trasformano continuamente le relazioni sociali e gli strumenti del lavoro e della conoscenza comune; sono essi i generatori
dell’infinito mondo della doxa, del mondo dell’opinare, del conoscere, del credere, del costruire,
del discorrere “eracliteo” (come diceva Husserl). Su questa stessa direttiva di marcia incontriamo
la nascita storica della scienza galileiana, con i suoi discorsi e i suoi strumenti, recuperati
all’interno dei saperi doxastici della comunità e da essi fecondati e sorretti, come comprese
Husserl. Un sapere intenzionale specifico, liberato però dalle superstizioni “naturalistiche” e
“oggettivistiche”. Un sapere universalizzante e calcolante, la cui oggettività diviene, non la
caratteristica immaginaria di un mondo “in sé”, supposto indipendente dalla nostra esperienza e
dagli strumenti del lavoro umano e della ricerca culturale, ma la finalità sociale, consapevolmente
perseguita, della costruzione progressiva del sapere comune al massimo grado della fruibilità e del
successo planetari. Un sapere costitutivo del soggetto idealmente universale e “mondiale”, e
tuttavia concretamente vivente nella storicità delle sue relazioni comunitarie, aperte dall’infinito
intreccio dei discorsi comuni, dal loro reciproco influenzarsi, dalle loro storie, dalle loro biografie
e autobiografie, dalle loro mappe sempre provvisorie e nondimeno indispensabili all’orientamento
comune e personale. Cammino della verità conoscitiva e disegno di un destino “cosmico”
comunitariamente intersoggettivo, che figurativamente circonda la terra e la accompagna. Come
diceva Husserl, un compito infinito.
Bibliografia
Husserl, E. (1961), La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, trad. it. a
cura di Enrico Filippini, Il Saggiatore, Milano.
148
�Husserl e la natura degli antichi greci
Abstract
The essay moves from Husserl’s Vienna Conference of May 1935, reproduced in The
Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology, to carry out a
phenomenological analysis of the relationship between the natural sciences and the
sciences of the spirit.
Keywords: Husserl, Crisis, Natural Sciences, Sciences of the Spirit, Living Body (Leib)
149
�PAOLO SPINICCI *
Due domande sulla natura dell’immaginazione
1.
Possiamo forse cominciare così, prendendo tra le mani un vecchio libro di filosofia: il Trattato sulle
sensazioni di Étienne Bonnot, abate di Condillac. In questo libro, che non ha il fascino teorico dei
grandi classici dell’empirismo settecentesco e che appartiene a un passato divenuto ormai silenzioso
per noi, vi è qualcosa che ci attira e che ci invita a riflettere. Si tratta di un passo ben noto: Condillac ci invita ad immaginare una statua di marmo, in tutto simile a noi, cui sia data per incanto la
possibilità di acquisire passo dopo passo le diverse forme della nostra sensibilità. Questo strano gioco ha un fine prestabilito: deve consentire a noi, spettatori filosofi, di assistere alla nascita in vitro di
una mente umana in un corpo di marmo, per inscenare così di fronte a nostri occhi di lettori le origini della conoscenza umana, le forme prime della nostra vita d’esperienza che appartengono ad un
passato che non è più accessibile per noi1.
L’epilogo di questo racconto filosofico non è difficile da immaginare: ogni nuova sensazione
imprime un diverso movimento agli ingranaggi della mente e la statua si trasforma così, sotto ai nostri occhi, in un soggetto capace di vivere e di sentire. Il gioco, tuttavia, potrebbe continuare: potremmo chiederci che cosa accadrebbe ad una statua che sappia percepire e ricordare, che provi piacere e dolore, e forse anche collera o simpatia, ma che non sia capace invece di immaginare, qualunque cosa di preciso questa parola significhi. Noi siamo fatti così: sappiamo immaginare molte
cose, ma che cosa accadrebbe se all’improvviso non fossimo più capaci di abbandonare il terreno
della realtà e se ogni nostra esperienza fosse per questo vincolata a ciò che c’è o è stato?
Non è facile rendersi conto di quali e quanto ramificate siano le conseguenze di questa strana
sorta di cecità, ma alcune considerazioni si impongono con una certa forza. Se fossimo affetti da
una qualche forma di cecità immaginativa non saremmo più capaci di inventare racconti e di ascoltarli: ci sarebbe ancora spazio per la cronaca, ma non sapremmo più dare un senso qualunque al
“c’era una volta …” che apre le porte dell’immaginazione narrativa e al “vissero felici e contenti”
che infine le richiude, riconsegnandoci alla realtà. Uno stesso ordine di considerazione varrebbe per
molti giochi ed in particolare per quelle forme ludiche che ci invitano ad assumere ruoli e che, per
esempio, ci chiedono di “far come se” una grossa scatola di cartone fosse una casa in cui entrare o
uscire a piacimento o un ramo di un albero una spada con cui sfidare a duello un nemico. Forse non
tutti i giochi implicano l’esercizio dell’immaginazione – non è facile dire se due cani che si azzuffano per gioco debbano davvero calcare per questo il terreno dell’immaginazione (o di ciò che noi
chiamiamo così) – ma è certo che il gioco infantile è ricco di fantasia e che i giochi di un bambino
sarebbero semplicemente impensabili se non vi fosse un libero esercizio dell’immaginazione. Ora, il
raccontare e il giocare sono forme che hanno un ruolo importante nella nostra vita, e di fatto nei
racconti, così come nella dimensione ludica, prende forma un ampliamento rilevante della nostra
umana esperienza ed impariamo a reagire a situazioni complesse che potrebbero accaderci e che è
utile mettere in scena, per comprenderle prima che facciano il loro ingresso nella vita reale 2. Senza
l’immaginazione la nostra vita sarebbe davvero molto diversa – su questo, credo, si possa davvero
*
Università degli Studi di Milano
1
«A tale scopo immaginammo una statua organizzata internamente come noi e animata da uno spirito privo d'ogni
sorta d'idee. Supponemmo inoltre che l'esteriore tutto di marmo non le permettesse l'uso d'alcun senso e ci riserbammo
la libertà di aprirli a piacer nostro alle diverse impressioni che possono ricevere» Condillac (1970), p. 6.
2
Su questo, si veda soprattutto Gottschall (2014), pp. 63-84.
Bollettino Filosofico 33 (2018): 150-159
ISSN 1593 -7178 - 00030
E-ISSN 2035 -2670
DOI 10.6093/1593-7178/5913
�Due domande sulla natura dell’immaginazione
facilmente convenire.
Potremmo continuare in questo strano gioco che in fondo ci invita a percorrere a ritroso (e con
qualche libertà) il cammino che Condillac ci propone e che sembra mostrarci la via che da una mente umana conduce ad una statua di marmo, ma piuttosto che avventurarci su questo terreno vorrei
richiamare l’attenzione su un presupposto che sembra essere in qualche misura all’origine delle
considerazioni di Condillac o almeno del suo esperimento mentale – un presupposto che potremmo
formulare così: l’immaginazione è una facoltà che rimanda ad una specifica capacità della nostra
mente, è un saper fare che appartiene alla natura umana. Aggiungerla alla dotazione delle capacità
della statua significa disporre la sua vita intellettuale in un orizzonte nuovo che è punto per punto
determinato dalle nuove funzioni che sono insite in quella facoltà: se alla statua si aggiunge
l’immaginazione, questa nuova facoltà mentale la renderà capace di fingere, di raccontare fiabe e di
comprenderle, di recitare e di partecipare ad una rappresentazione teatrale o a un rito religioso, di
immergersi nei giochi di far finta, ma anche di cogliere ciò che è presente come alterabile, gli eventi
accaduti come possibili, e così via. E ciò è quanto dire: l’esperimento di Condillac sembra invitarci
a pensare che vi sia una diretta corrispondenza tra ciò che sa fare la statua umana e la sua natura e
che si possa quindi supporre che se una qualche tribù umana non si concedesse il lusso della narrazione dovremmo immaginare una qualche diversità nella struttura della sua statua, proprio come
pensiamo che ci sia qualcosa di diverso negli occhi di un daltonico se la sua reazione al colore è diversa da quella della maggioranza delle persone – ma le cose stanno davvero così? Possiamo davvero pensare che ad ogni differenza sul terreno delle possibilità immaginativa faccia capo una differenza di capacità psichiche nel soggetto che le esercita?
A questa prima domanda se ne affianca una seconda che potremmo formulare così:
l’immaginazione è un fatto tra gli altri (una certa configurazione del nostro cervello che consente
determinate operazioni particolari) o è, in senso generale, un concetto generale che allude ad un saper fare, una nozione che deve essere formulata per indicare l’origine comune di un insieme di contenuti ideali che possono essere appunto concettualmente assimilati e che ci sembra possibile raccogliere sotto un’identica matrice? In questo caso, l’immaginazione non sembra ricondurci ad una
qualche configurazione del nostro cervello, ma ad una facoltà la cui natura non deve essere indagata
autonomamente, ma deve essere pensata alla luce dei suoi effetti, secondo un modello che ha esso
pure una sua chiara eco nelle psicologie razionali settecentesche e che si ritrova anche in Kant che
indica nell’intelletto il titolo generale di una facoltà che deve essere posta nell’animo umano e la cui
forma deve essere pensata soltanto alla luce della tavola delle forme di unità del giudizio. Insomma, dobbiamo pensare all’immaginazione come ad un fatto che caratterizza una parte del mondo
animale o come ad un nome sotto cui raccogliere un insieme di possibilità che appartengono in linea
di principio alla sfera di ciò che può essere pensato e detto – il discorso finzionale, le ipotesi controfattuali, le assunzioni, …?
A questa seconda domanda sembra, di primo acchito, più facile dare una risposta. In fondo, una
delle ragioni che rendono così interessanti le finzioni settecentesche sull’origine è che ci consentono
di gettare uno sguardo sull’altrimenti. L’esperimento mentale di Condillac fa altrettanto: ci invita a
pensare che sia possibile una forma di vita senza immaginazione – qualunque cosa di preciso si
debba intendere con questo termine. Di qui una conclusione cui sembra davvero difficile sottrarsi:
l’immaginazione c’è, di fatto, ma avrebbe potuto non esserci, proprio come avrebbero potuto non
esserci gli artigli se la storia evolutiva avesse preso una diversa piega. In fondo i pesci ne sono privi
– degli artigli, intendo – e sembrano cavarsela egregiamente lo stesso. Insomma: l’immaginazione è
una risorsa animale tra le altre e proprio come di fatto possiamo pensare (e incontrare) animali privi
di artigli, così possiamo senz’altro comprendere come potrebbe essere una vita umana senza immaginazione, per quanto difficile possa essere poi addentrarsi nei dettagli di un simile esperimento
mentale. L’immaginazione è un fatto, che avrebbe potuto non esserci – ma appunto: le cose stanno
davvero così? è davvero ovvio che stiano così? È a queste due domande che dobbiamo cercare di
dare una risposta.
151
�Paolo Spinicci
2.
Da un punto di vista biologico le radici dell’immaginazione sono molteplici, e ci riconducono tanto
alla capacità di produrre immagini mentali, quanto ai processi di controllo e di simulazione dei movimenti propri e altrui. Ma per quanto sia ragionevole attendersi che vi siano differenze rilevanti tra
le capacità umane e quelle di altri animali – già Aristotele dubitava che vermi e insetti potessero
immaginare alcunché – è difficile credere che tra noi umani e i primati superiori vi sia una differenza di capacità così rilevante da giustificare punto per punto lo iato che separa le nostre produzioni
immaginative dalle loro. Del resto, i rituali fanno parte della vita di ogni cultura, ma il teatro sembra
avere una storia relativamente recente e un discorso analogo vale per la letteratura fantastica o per il
genere del mockumentary: ciascuno di questi generi ha una sua grammatica peculiare che definisce
il come della sua natura immaginativa e il posto che esso occupa nell’universo dell’immaginazione,
e sarebbe sbagliato pensare che siano solo diverse forme esteriori in cui l’immaginazione assolve
sempre ad un identico scopo. Ai gesti dei rituali religiosi ed ai miti non si crede, se a questa parola
si attribuisce il suo senso consueto, ma si presta egualmente fede, mentre non si crede né si presta
fede ad una fiaba che ci coinvolge in un mondo che non c’è, che non ha senso cercare, e che si situa
in un tempo del tutto distinto dal nostro; anche alle fantasticherie (che occupano tanta parte delle
nostre giornate) non si crede affatto, ma i sogni ad occhi aperti condividono con le utopie l’eco impallidita di una trama progettuale: si fantastica di un futuro che non sa né vuole dire quando diventerà presente, ma che è ciò nonostante sito sullo stesso asse temporale in cui siamo e viviamo, quotidianamente3. E ancora: l’immaginazione del gioco non è identica all’immaginazione teatrale ed
entrambe sono in parte diverse dall’immaginazione letterarie – piccole sfumature che tuttavia rendono articolato il concetto di immaginazione e ci vietano di dire che immaginando facciamo sempre
esattamente la stessa cosa4. Le forme dell’immaginazione (di quello che chiamiamo immaginazione
sul terreno del linguaggio quotidiano) sono molte, ma sarebbe sbagliato pensare che ad essi necessariamente corrisponda una qualche specifica facoltà che sappia spiegarle in ogni dettaglio e che,
per così dire, le contenga nella loro interezza. L’immagine della statua di Condillac contiene insomma un possibile invito al fraintendimento: ci spinge a pensare che ci sia qualcosa come un interruttore a due posizioni che possiamo accendere e spegnere e che il disporre di un insieme di funzioni mentali porti con sé immediatamente e necessariamente l’insieme corrispondente dei comportamenti socialmente codificati che su di esse poggiano. Ma non è così: l’immaginazione, per come ne
parliamo quando ci disponiamo sul terreno della quotidianità, è un nome cui è possibile ricondurre
una molteplicità aperta di giochi linguistici che non è possibile anticipare a priori. Non basta inserire un chip nella statua perché diventi fin da principio ovvio che sia possibile recitare o comprendere
un racconto fantastico, perché recitare e narrare racconti fantastici sono forme che appartengono alla nostra cultura. Certo, perché siano accessibili per noi, le forme socialmente codificate
dell’immaginazione debbono poggiare su un insieme di capacità di natura psicologica: se Aristotele
ha ragione, i mockumentary sono per sempre preclusi alle formiche, ma questo non significa che –
data la nostra natura – dovesse necessariamente darsi un genere finzionale che avesse questa forma.
Accanto alla fisiologia, vi è anche la storia dell’immaginazione e delle sue articolazioni, e non basta
venire in chiaro su ciò che accade nella statua per tracciare una mappa delle possibili forme in cui
l’immaginare può realizzarsi. Tracciare questa mappa è compito di un’indagine descrittiva, e qui la
fenomenologia come analisi concettuale che non pretende di andare al di là della dimensione descrittiva può trovare lo spazio necessario per una sua possibile applicazione.
Alla prima domanda che abbiamo formulato si deve dare dunque una risposta negativa e ricono3
Sulle fantasticherie e sul loro rapporto con la forma letteraria delle utopie si veda Piana (2004).
Riconoscere che nella nostra cultura vi sono molte e diverse forme dell’immaginazione non significa ancora negare
che vi siano proprietà che accomunano le diverse procedure immaginative e che le caratterizzano in profondità. Che vi
sia qualcosa come un nucleo comune alle diverse forme dell’immaginazione è una tesi che ritengo sia sostanzialmente
corretta e che troviamo in diverse forme in molti autori, e tra questi Husserl (2002), Piana (1978), o Currie e Ravenscroft (2002).
4
152
�Due domande sulla natura dell’immaginazione
scere che il fatto che la vita umana sia caratterizzata da una molteplicità di giochi linguistici che cadono sotto il concetto di immaginazione non significa ancora affermare (e tanto meno negare) una
qualche rilevante diversità della nostra “facoltà immaginativa” rispetto a quella degli altri primati.
L’immaginazione ha una storia, e sarebbe un errore credere che essa sia interamente contenuta in
una qualche capacità psichica che, per così dire, racchiuda in sé la trama aperta delle sue forme.
Si badi bene: sottolineare che vi è una storia dell’immaginazione e delle sue forme e che è possibile un’indagine fenomenologica che tracci una tassonomia aperta delle sue forme non significa necessariamente sostenere che non vi sia spazio anche per una comprensione naturalistica che vada al
di là dell’indicazione delle facoltà che la rendono concretamente possibile. È un fatto che anche della storia della cultura è possibile una comprensione in termini adattivi e opere come quelle di Jonathan Gottschall o Brian Boyd (2010) hanno mostrato bene in che senso si possa asserire che la narrazione, come altre forme che caratterizzano la vita culturale umana, può essere illuminata da considerazioni biologico-evolutive. Gli uomini sono animali che hanno l’istinto del narrare e il narrare
è un’attività che, nel contesto della vita umana, ha un valore biologico: ci consente di sperimentare
off-line situazioni complesse, ci permette di condividere le stesse emozioni, ci insegna a raccordare
in unità le vicende nella forma di un racconto – se mai c’è stata una tribù di uomini che non ha indugiato nella narrazione è ragionevole sostenere che si debba essere estinta, e per buone ragioni. Insomma: è ragionevole pensare che la nostra storia evolutiva dell’uomo abbia inciso in qualche modo sulla nostra predisposizione ad immergerci in contesti immaginativi.
Queste considerazioni sembrano ricondurre le nostre considerazioni in prossimità della nostra
seconda domanda. Ci eravamo chiesti se l’immaginazione è un fatto che avrebbe potuto non esserci
e a questa domanda, avevamo osservato, è senz’altro possibile dare una prima risposta affermativa:
le capacità su cui poggia la nostra prassi immaginativa sono frutto della selezione naturale e non c’è
nulla che le renda necessarie. Le facoltà che ci consentono di figurarci quel che potrebbe accadere o
che ci permettono di pensare altrimenti la forma di un evento o di un oggetto sono utili in un animale che ci assomigli e che abbia una vita psichica simile alla nostra. Per tornare al nostro esempio: gli
artigli sono utili strumenti di offesa in chi ha zampe che possono sferrare un colpo a distanza o che
possono consentire di afferrare qualcosa: sarebbero meno utili in animali che ne fosse privi, come i
pesci o i serpenti o i vermi. Fingere, raccontare, ritualizzare, o fare ipotesi sono artigli che sono utili
in un contesto determinato e sono tanto poco necessari quanto lo siamo noi stessi e le nostre forme
di vita5. Le forme dell’immaginazione che conosciamo e che caratterizzano in profondità le nostre
forme di vita avrebbero dunque potuto non esserci – sono un fatto tra gli altri che testimonia di una
direzione casuale del processo evolutivo. È andata così, ma avrebbe potuto andare diversamente e
nulla ci garantisce che in un futuro più o meno remoto, insieme agli uomini, l’immaginazione non
scompaia dal repertorio delle forme che caratterizzano la vita animale. Può darsi che nel futuro non
ci siano più uomini e che le formiche si prendano su di noi una rivincita che non possono, per loro
sfortuna, nemmeno immaginare.
Queste considerazioni sembrano essere più che sufficienti per rispondere anche alla seconda domanda che abbiamo formulato, e tuttavia, prima di metterla definitivamente da canto, è necessaria,
io credo, una riflessione più approfondita perché è possibile, io credo, un diverso modo di formulare
e di intendere questo interrogativo. Per cercare di far luce su questo punto dobbiamo tuttavia concederci una breve digressione.
3.
In un passo delle Ricerche filosofiche, Wittgenstein ci invita a immaginare una situazione straniante: dobbiamo immaginare un congegno meccanico che ci consenta di agire sulle altre persone proprio come ci consente di agire il nostro linguaggio (Wittgenstein (1967) § 492). Si tratta, di primo
acchito, di un pensiero di cui non sappiamo comprendere la ragione, ma basta addentrarsi un poco
5
Anzi, a voler essere più precisi, sono ancora meno necessari perché di fatto gli stessi risultati avrebbero potuto essere ottenuti in altro modo – la selezione avrebbe potuto premiare altre caratteristiche rilevanti nella nostra natura.
153
�Paolo Spinicci
nella lettura delle Ricerche filosofiche e riflettere sull’immagine che ci propone perché si faccia
avanti un tema su cui è importante riflettere. Pensiamo innanzitutto al linguaggio animale: il gallo
canta per richiamare le galline (Wittgenstein (1967), § 493) e i pesci cambiano di colore per comunicare il loro stato, e in un caso e nell’altro è ragionevole attendersi che la comunicazione sia un fatto retto da processi puramente fisiologici e che il linguaggio sia in questi casi un dispositivo naturale che agisce causalmente e che determina causalmente quella regolazione dei comportamenti animali cui la comunicazione ambisce. Parliamo di animali e del loro linguaggio, ma nelle pagine wittgensteiniane un simile discorrere non è giustificato dal desiderio, in fondo arbitrario, di segnare in
qualche modo la differenza tra natura e cultura, ma dalla volontà di asserire due tesi strettamente
connesse l’una all’altra.
La prima tesi è che nulla ci vieta di considerare che anche il nostro linguaggio potrebbe essere fatto così – che anche per il linguaggio umano è del tutto lecito studiare come possa concretamente
agire, per controllare causalmente il comportamento di una comunità di parlanti. Possiamo
senz’altro pensare che le cose stiano così:
io considero l’apprendimento della lingua tedesca come la regolazione di un meccanismo per reagire a un
certo tipo di influssi; e per noi può essere del tutto indifferente se l’altro abbia imparato la lingua oppure se,
fin dalla nascita, sia fatto in modo tale da reagire alle proposizioni della lingua tedesca non diversamente
dall’uomo comune, che abbia imparato il tedesco (Wittgenstein (1967), § 495).
Wittgenstein scrive proprio così – è indifferente, e ancora una volta è necessario mettere da canto un
fraintendimento possibile. Se è indifferente non è perché si possa ridurre lo spazio logico delle proposizioni ad un insieme di eventi causali, ma per sottolineare il fatto che del linguaggio è lecito parlare anche così - come di un evento causale tra gli altri. Così, se questa è la domanda che ci poniamo:
se ci venisse mostrato in quale maniera le parole “Vieni da me!” agiscono sulla persona a cui sono rivolte,
cosicché alla fine, in certe condizioni, i suoi muscoli vengono innervati, ecc. – quella proposizione perderebbe per noi il carattere di proposizione?6
Tutti, credo, saremmo disposti, di primo acchito, a rispondere negativamente. E per una ragione
relativamente ovvia: del grido “vieni da me!” potremmo infatti rendere conto non solo come di un
meccanismo particolare che agisce sugli altri, ottenendo uno scopo predeterminato, ma anche come
uno strumento linguistico che ha un suo significato che coincide con le regole che di consueto ne
determinano l’uso. Della forma linguistica “vieni da me!” possiamo in altri termini parlare disponendoci su due diversi livelli: quello fisico-causale che si dispiega nelle relazioni fisiche e chimiche
che dal suono percepito conducono ad un qualche movimento corporeo e quello delle consuete iterazioni linguistiche: ti ho ascoltato e ho per questo esaudito la tua richiesta, seguendo una prassi cui
sono stato addestrato.
È una distinzione importante che ha una sua storia illustre7, e tuttavia si rischia di non comprendere il senso di queste considerazioni se si pensa a questi due piani come se si trattasse di due diverse spiegazioni di uno stesso fenomeno. Le cose non stanno così. Di una spiegazione volta a chiarire
come stanno di fatto le cose si può parlare solo quando ci si dispone sul terreno dei nessi causali –
sul piano reale degli eventi. Quando invece mettiamo in luce il significato che sul piano degli usi
linguistici spetta ad una proposizione non spieghiamo nulla: ci limitiamo a descrivere come usiamo
6
Wittgenstein (1967), § 493.
Nella riflessione filosofica occidentale compare, che io sappia, per la prima volta nel Fedone (98b-99b), quando
Socrate, in un’esplicita polemica contro la prospettiva naturalistica di Anassagora, contrappone alle cause meccaniche
che sono all’origine del suo trovarsi seduto in prigione – la posizione delle sue ossa, dei suoi muscoli e dei suoi tendini
– le ragioni profonde che lo hanno spinto a non fuggire dal carcere e ad accettare il verdetto di condanna degli Ateniesi.
Cause e ragioni non si escludono e non si sovrappongono, anche se ovviamente si incrociano in vario modo, poiché è
sempre di Socrate e del suo essere seduto nella cella in cui morirà che si discute.
7
154
�Due domande sulla natura dell’immaginazione
quelle parole e come reagiamo ad esse.
Non spieghiamo nulla, e non ci poniamo la domanda di come possa accadere che, se pronuncio
le parole “vieni da me”, ti vedrò poi arrivare, sempre che tu abbia voglia di prestarmi ascolto: i giochi linguistici non si spiegano, ma – appunto – si descrivono e le regole che li sorreggono non sono
qualcosa che stia al di là di essi, ma sono la forma in cui si manifesta il loro valore d’uso, la struttura che consente la loro ripetibilità e intersoggettività. Ne segue che una teoria filosofica (sempre che
sia lecito parlare davvero in questo caso di una teoria) può essere più modesta8: non pretende di
spiegare alcunché e non cerca di andare al di là della dimensione dei giochi linguistici, ma per – così dire – si accontenta di descriverli, restando al loro interno. Nessuno, tuttavia, ci costringe a fare
così e alla prospettiva che resta imprigionata nella dimensione dei giochi linguistici è del tutto lecito
affiancare una prospettiva esterna che li considera per quello che obiettivamente sono: eventi che
appartengono al mondo. In qualche modo, le nostre parole debbono agire realmente su chi ci ascolta
e questo significa che deve essere possibile andare al di là del linguaggio e ricondurre i gesti linguistici e la loro comprensione a eventi causali: su questo punto si può convenire.
Molte cose mutano se assumiamo l’una o l’altra prospettiva. Se ci disponiamo all’interno della
prospettiva del linguaggio e se ci disponiamo su un terreno meramente descrittivo, la domanda che
si interroga su come di fatto il linguaggio agisce su chi lo comprende è semplicemente fuori luogo,
così come sarebbe fuori luogo interrogarsi – sul terreno della logica o dell’aritmetica – su che cosa
accada nel nostro cervello quando eseguiamo un calcolo. Dire che «la grammatica descrive soltanto,
ma non spiega in nessun modo, l’uso dei segni» (Wittgenstein (1967), § 496) significa evidentemente asserire questo stesso ordine di considerazioni: significa dichiarare che se ci disponiamo nella prospettiva interna al linguaggio – se non abbandoniamo insomma il piano descrittivo – non vi è
alcuna ragione per domandarsi in che modo il linguaggio realmente funzioni. Che funzioni e che
abbia un senso è semplicemente il punto da cui partiamo, ed è un punto che non chiede necessariamente una spiegazione.
Non si tratta di una rinuncia: su questo punto è opportuno insistere. Posso comprendere che sotto
la superficie dei giochi linguistici vi sia una trama causale che chiede di essere spiegata, così come è
del tutto ragionevole interrogarsi su che cosa consenta ad un calcolatore di effettuare una serie di
operazioni logiche: sarebbe invece del tutto privo di senso cercare di vincolare il senso di quel comprendere o di quell’interrogare alla luce dei fatti nei quali ci imbatteremmo se ci addentrassimo sul
terreno delle spiegazioni.
Sarebbe privo di senso per diverse ragioni. In primo luogo, è opportuno sottolineare che non vi è
nulla che ci costringa a farlo. Se anche sapessi che cosa accade in me quando penso la proprietà
commutativa dell’addizione, non per questo l’avrei compresa meglio o avrei trovato una ragione in
più per farla valere. Un fatto non giustifica un principio. In secondo luogo, vincolare la comprensione del linguaggio ad una qualche spiegazione causale significa attirare contro le proprie tesi gli
argomenti di cui ci si avvale per rifiutare la prospettiva dello psicologismo: ridurre i principi e le regole su cui poggia il ragionare a fatti di natura mentale è privo di senso, perché i fatti non sono né
principi né regole, e non è possibile in generale asserire in una teoria ciò che nega i presupposti
obiettivi di una teoria qualsiasi. Una proposizione che neghi un fatto è falsa – ed è falsa la tesi secondo la quale quando pensiamo una proposizione aritmetica accadono cose radicalmente diverse
nella nostra mente, ma è pur sempre una mossa legittima nel linguaggio; non lo è invece una proposizione che neghi i principi logici fondamentali – la proposizione che dicesse che il principio di
identità significa ogni volta che lo pensiamo qualcosa di diverso non sarebbe falsa, ma priva di senso perché affermarla significa negare le condizioni della sua sensatezza. Questo è quello che accade
se assimiliamo le leggi logiche ai fatti9.
8
Uso questo termine in un’accezione non poi troppo dissimile da quella di McDowell in In Defence of Modesty, ripubblicato in McDowell (1998), pp. 87-107.
9
La tesi secondo la quale lo psicologismo è obiettivamente una forma di scetticismo che nega le condizioni di possibilità di una teoria in generale è sostenuta da Husserl nelle Ricerche logiche (Husserl (1968), I, p. 226).
155
�Paolo Spinicci
Vi è, tuttavia, una terza ragione che ci impedisce di seguire questo cammino. Così come non
posso dimostrare razionalmente la razionalità della ragione poiché ogni simile dimostrazione sarebbe circolare e presupporrebbe (con buona pace di Cartesio) il risultato cui pretende di giungere, allo
stesso modo non posso nemmeno cancellare la specificità dello spazio logico delle ragioni perché la
proposizione che pretendesse di affermare che non vi sono proposizioni vere o false, ma soltanto
accadimenti pretenderebbe di essere colta nel suo essere non un accadimento, ma una proposizione
vera. Proprio come il Barone di Munchhausen non poteva sollevarsi dalle profondità del mare tirandosi per il codino della parrucca, così non possiamo cercare di argomentare al di fuori dello spazio
razionale in cui ci muoviamo: non possiamo farlo, perché non possiamo pretendere che i nostri argomenti possano sollevare (o sprofondare) razionalmente la ragione costringendola in uno spazio
che non è il suo. Se argomentiamo, siamo nello spazio logico delle ragioni, e non possiamo uscirne
per fondarlo o per negarlo. Dobbiamo semplicemente accettarlo – ed è questo in fondo il senso di
questa osservazione che Wittgenstein ci propone nelle pagine di Della certezza:
Non devi dimenticare che il gioco linguistico è, per così dire, di imprevedibile. Voglio dire: non è fondato,
non è ragionevole (o irragionevole). Sta lì - come la nostra vita.10
4.
Non credo sia difficile scorgere il nesso che lega queste considerazioni così generali al nostro problema, cui dobbiamo ora senz’altro tornare, lasciandoci alle spalle la digressione in cui ci siamo
brevemente immersi. Avevamo formulato una domanda – l’immaginazione è un fatto che avrebbe
potuto non esserci? – e abbiamo proposto una prima risposta affermativa: se ci chiediamo se
l’evoluzione avrebbe potuto prendere altre vie e se è pensabile un mondo in cui nessuna specie animale sia capace di immaginare alcunché, allora la risposta è ovviamente affermativa. Poteva certo
accadere che l’immaginazione fosse un nome vuoto sotto cui non cade alcuna facoltà reale, proprio
come poteva accadere (e come probabilmente è di fatto accaduto quando la vita ha iniziato a manifestarsi) che non esistessero animali capace di ragionare – qualunque significato si voglia dare di
preciso a questa parola. Questi fatti sono entrambi possibili – non c’è dubbio, ma non implicano che
si possa prescindere dallo spazio logico delle ragioni per asserirli. Si può senz’altro pensare un
mondo in cui la ragione sia un nome vuoto e si può senz’altro immaginare che la specie umana sia
diventata incapace di recitare o di raccontare storie: si può farlo senza che questo implichi una contraddizione perché ciò che neghiamo non è lo spazio logico delle ragioni, ma un insieme di tesi che
possono essere asserite in esso e che concernono l’esserci di fatto di ciò che chiamiamo ragione o
immaginazione.
Posso immaginare che cosa sarebbe la mia vita se non potessi disporre delle forme
dell’immaginazione perché ciò che nego (l’esserci di fatto dell’immaginazione) non è ciò che presuppongo (la sensatezza dell’immaginare e del concetto di immaginazione che è necessario perché
io possa asserire che nulla cade sotto di esso). All’immaginazione come possibilità reale che caratterizza di fatto la natura umana si devono contrapporre così le forme dell’immaginazione come possibilità ideali, come regole che appartengono in linea di principio all’universo del nostro linguaggio
e di cui dobbiamo avvalerci se fingiamo un mondo privo di capacità finzionali. Ora, rendersi conto
di questa distinzione di fondo significa anche comprendere che vi è un senso in cui il recitare, il narrare e, in generale, le forme immaginative non sono fatti: possiamo parlarne infatti non come di accadimenti che appartengono al nostro mondo e che ci determinano realmente, ma come forme di cui
disponiamo per dire e per immaginare quello che diciamo e ci rappresentiamo. In questo senso non
sono eventi, ma sono invece possibilità ideali che appartengono allo spazio logico del linguaggio.
Ci “sono” – se ci sono – non come un fatto, ma come una possibilità che determina lo spazio entro
cui si danno per noi i fatti – reali o immaginari che siano. In questo senso, l’immaginazione non è
una sorta di artiglio che ci serva per sopravvivere, ma è una delle forme della sensatezza cui pos10
Wittgenstein (1999), § 559.
156
�Due domande sulla natura dell’immaginazione
siamo accedere.
Su questo punto è bene indugiare un poco, perché qui fatti e possibilità si intrecciano in un nodo
che non è facile districare con chiarezza. Muoviamo allora, innanzitutto, da un esempio. Leggiamo
l’incipit di un romanzo. I Promessi sposi iniziano pressappoco così: raccontano di un curato che se
ne torna a casa, una sera, seguendo una stradicciola di montagna. Ha fatto una piccola passeggiata:
è il 7 novembre del 1628. In fondo alla strada si imbatterà in una brutta sorpresa che segnerà il suo
futuro e determinerà lo sviluppo ulteriore del racconto. Forse, se non conoscessimo così bene questo
romanzo e se ci limitassimo a leggere queste poche righe, potremmo intenderle come se ci parlassero di un fatto reale, accaduto vicino a Lecco, molti anni fa, proprio come Manzoni sembra del resto
suggerire nell’Introduzione che apre il suo romanzo.
Possiamo leggerlo così, ma possiamo anche immaginare un contesto che ci costringa a leggere
l’inizio di questa finzione letteraria come se si trattasse di un resoconto, vero o falso che sia: potremmo appartenere ad una cultura che non sa che cosa siano i romanzi e che non perde tempo a
immaginare vicende fittizie e a raccontare favole. O ancora: potremmo appartenere ad una forma di
umanità incapace di comprendere che cosa sia un romanzo, per una ragione qualsiasi. Nell’uno e
nell’altro caso quel testo dovrebbe essere letto così: come un resoconto fattuale, della cui veridicità
sarebbe opportuno accertarsi. Chi lo leggesse così, dovrebbe chiedersi se Renzo Tramaglino e Lucia
Mondella sono davvero esistiti e se è accaduto loro quello che la storia narra. Dovrebbe leggerlo insomma attribuendo alla storia un significato molto diverso da quello che le attribuiamo noi che abbiamo imparato fin da piccoli il gioco della narrazione finzionale. Certo, se non avessimo imparato
(o non avessimo potuto imparare) come si deve intendere un romanzo, saremmo anche noi costretti
a leggere quel libro come la cronaca di un fatto lontano, ma appunto: per noi le cose non stanno così
e questo ci consente di apprezzare una differenza che si gioca sul terreno del senso che attribuiamo
a ciò che leggiamo. Per noi, ora, questa differenza sussiste e ci parla di una possibilità ideale: quel
racconto si può intendere come una cronaca o come una finzione e se è una finzione, allora ha un
senso diverso da quello che gli spetterebbe se fosse una cronaca.
A partire di qui si comprende, io credo, quale sia la ragione che ci spinge a immergerci nelle pieghe di un’antropologia immaginaria che ci parla di lettori che non sanno abbandonare nemmeno per
un istante il terreno della realtà. Il senso di questa ipotesi è in fondo chiaro: ci mostra che se davvero esistesse una tribù di lettori così saldamente imprigionata nel reale da non essere in grado di
comprendere una fiaba, non per questo verrebbe meno la distinzione grammaticale che separa i resoconti dalle finzioni. Immaginare un mondo in cui le fiabe o i romanzi non abbiano diritto di cittadinanza non significa cancellare la differenza che le separa dai resoconti e non vuol dire nemmeno
negare che la finzione sia una possibilità ideale – una possibilità che non è tolta dal fatto che qualcuno non la sappia cogliere poiché non dipende nel suo esserci dal suo esser compresa. Così, se
davvero vi fosse una tribù che non sapesse leggere nel senso che le compete la vicenda di don Abbondio dovremmo da un lato prendere atto di un fatto empiricamente rilevante e, dall’altro, indicare
qual è la regola che traccia il discrimine tra una cronaca e una finzione. Questa regola potremmo
formularla così: non cercare per i nomi del tuo racconto un referente reale e accetta di svincolare la
tua narrazione da ogni riferimento a quello che accade di fatto nel mondo – fanne insomma una narrazione assoluta. Così, se per ipotesi esistesse una tribù di lettori che non sapesse costruire immaginativamente il personaggio di un curato, di nome don Abbondio, che ritorna a casa per una stradicciola di montagna, questo direbbe qualcosa soltanto sulla natura di quei lettori e non varrebbe affatto come una negazione effettiva di una possibilità ideale, esattamente come il fatto che nessuno sia
capace di moltiplicare tra loro numeri con un miliardo di cifre non nega che quelle operazioni abbiano in linea di principio un risultato11.
11
In un passo delle Ricerche filosofiche, Wittgenstein scrive così: «Le proposizioni ‘gli uomini credono che 2x2=4’
e ‘2x2=4’ non hanno il medesimo senso. La seconda è una proposizione matematica, mentre la prima – ammesso che
abbia un senso – può forse voler dire che gli uomini sono arrivati alla proposizione matematica. Queste due proposizioni hanno un impiego completamente differente» (Wittgenstein (1967), p. 296). Queste considerazioni, che sono strettamente connesse con quanto abbiamo detto, conducono nelle Ricerche filosofiche ad uno sviluppo che merita di essere
157
�Paolo Spinicci
Se ci si pone in questa prospettiva, le forme immaginative sono possibilità ideali – questo è il
punto. Eppure basta dire così perché qualcuno storca il naso. Parlare di possibilità ideali sembra infatti alludere ad un qualche cielo iperuranio in cui le forme della sensatezza siano idealmente anticipate e, per così dire, idealmente presenti al di là di ogni nostro pensarle – ma non è necessario che
sia così. In fondo, per tracciare la distinzione che ci interessa ci basta molto meno: è sufficiente riconoscere che il farsi avanti di un nuovo gioco linguistico non è soltanto un segno del fatto che ora
vi sono uomini che si comportano in un certo modo, ma è anche indice di una possibilità nuova che
entra di diritto a far parte delle forme che caratterizzano lo spazio logico nel quale si danno i nostri
pensieri. Una volta tracciata, la distinzione grammaticale tra narrazioni finzionali e cronache acquista il suo posto non come un fatto nel mondo, ma come una possibilità ideale in seno alla morfologia delle forme del significare: il suo esserci cessa di avere un significato meramente empirico e allude ad una possibilità logica che può essere percorsa o trascurata, ma che è comunque disponibile.
E se ci si pone in questa prospettiva l’intreccio tra possibilità ideali e considerazioni fattuali cui
avevamo dianzi alluso sembra in qualche modo comporsi. Non cerchiamo di disancorare lo spazio
logico in cui ci muoviamo dalle condizioni fattuali che lo rendono concretamente possibile e non
pretendiamo che sussista idealmente al di là delle condizioni reali che lo rendono fattualmente presente: rifiutiamo tuttavia di equiparare ciò che compete ai fatti con ciò che compete alla grammatica
e sosteniamo per questo che le forme che appartengono allo spazio logico delle nostre ragioni non
coincidono con i fatti che le rendono concretamente presenti.
Di qui, da queste considerazioni di carattere generale, è possibile tornare alla domanda che ci
eravamo dianzi posti. Su un punto ci era sembrato possibile fin da principio concordare:
l’immaginazione è un concetto che abbraccia una molteplicità di forme e di giochi linguistici che
appartengono alla nostra cultura e che poggiano su un insieme di capacità innate nell’uomo e condivise, con tutta probabilità, da molti altri animali. In questo senso, l’immaginazione non è affatto
necessaria: avrebbe potuto non esserci e ogni spiegazione delle cause per le quali raccontiamo, recitiamo o fantastichiamo ci riconduce ad una serie di fatti che avrebbero potuto essere differenti o non
essere affatto. La facoltà o le differenti facoltà su cui poggiano le forme di ciò che chiamiamo “immaginazione” appartengono al percorso fattuale della nostra storia evolutiva e avrebbero potuto
semplicemente non esserci: il nostro cervello non è un frutto necessario dell’evoluzione. E non è
nemmeno una condizione sufficiente della nostra cultura: una tribù che sia eguale alla nostra per ciò
che concerne l’insieme delle facoltà mentali potrebbe egualmente ignorare la prassi del raccontare
storie o del recitare, e non è affatto detto che il farsi avanti tra gli uomini della prassi narrativa abbia
coinciso con l’acquisizione di una qualche nuova facoltà. Riconoscere che la matrice biologica
dell’immaginazione è un prodotto casuale e che non è necessario che esista quel che di fatto esiste
non significa tuttavia negare che i giochi linguistici del raccontare, del recitare o del fantasticare
siano possibilità ideali, ed è così che ci si rivelano essere non appena ci disponiamo nella prospettiva interna – nella prospettiva della descrizione dei nostri giochi linguistici. In questo caso, l’esserci
delle forme dell’immaginazione è l’esserci di una serie di possibilità, e non di fatti: possiamo raccontare una storia e intenderla ora come un resoconto di un fatto, ora come una finzione, proprio
come possiamo intendere un gesto come imitazione di un altro o come sua messa in scena teatrale.
Possiamo farlo perché se ci disponiamo nello spazio dei nostri giochi linguistici – dei giochi linguistici di cui disponiamo – le forme dell’immaginazione non sono un accadimento di cui si debba
rendere conto, ma voci di una morfologia delle forme di senso della nostra esperienza.
Queste voci debbono essere descritte, e non spiegate nella loro genesi reale. Non dobbiamo anrammentato. Riconoscere che le verità matematiche sono indipendenti dal fatto che gli uomini le riconoscano non significa tuttavia negare che esse implichino un accordo sul loro uso. L’accordo definisce lo spazio della sensatezza ed è la
sua condizione: se non ci fosse un accordo completo nel nostro operare con i numeri, non potremmo nemmeno intendere le proposizioni matematiche nella loro peculiare indipendenza dal nostro averle raggiunte. Si veda a questo proposito
anche l’osservazione 241: «‘Così tu dici che è la concordanza tra gli uomini a decidere che cosa è vero e che cosa è falso!’. – Vero e falso è ciò che gli uomini dicono; e nel linguaggio gli uomini concordano. E questa non è una concordanza delle opinioni, ma delle forme di vita” (Wittgenstein (1967), § 241).
158
�Due domande sulla natura dell’immaginazione
dare oltre ad esse, se vogliamo coglierle per quello che innanzitutto sono: forme entro cui si definisce il senso di quello che pensiamo e esperiamo. Ed è qui che per la riflessione fenomenologica si
apre uno spazio di indagine. La fenomenologia non è una forma filosofica di indagine psicologica:
non spiega nulla e non cerca di comprendere la genesi reale delle nostre facoltà. Tutt’altro: la sua
prospettiva è del tutto interna alla sfera della nostra esperienza e non pretende di venire a capo delle
ragioni per le quali la nostra esperienza è così com’è. Queste ragioni sono di ordine fattuale e ci costringono ad andare al di là della nostra esperienza, per coglierla come un fatto tra gli altri. Ma se,
abbandonate le pretese del trascendentalismo, riconosciamo che il fatto dell’esperienza è insieme
l’orizzonte che circoscrive il nostro accesso alle cose nella loro indipendenza dall’io – se, in altri
termini, riconosciamo che è possibile una teoria modesta dell’esperienza che non pretenda di dimenticare che lo spazio logico in cui ci muoviamo è anche il frutto della nostra casuale natura, allora per la fenomenologia come disciplina descrittiva si apre lo spazio per un’applicazione possibile.
Bibliografia
Boyd B. (2010), On the Origin of Stories: Evolution, Cognition, and Fiction, Belknap, Cambridge
MA.
Condillac, E. Bonnot de (1970), Trattato delle sensazioni (1754), a cura di P. Salvucci, Laterza,
Roma Bari.
Currie G.-Ravenscroft J. (2002), Recreative Minds: Imagination in Philosophy and Psychology,
Oxford University Press, Oxford.
Gottschall, J. (2015), L’istinto di narrare, Bollati Boringhieri, Torino.
Husserl, E. (1968), Ricerche logiche, a cura di G. Piana, Il saggiatore, Milano.
Husserl, E. (2002), Idee per una fenomenologia pura e una filosofia fenomenologica, a cura di E.
Franzini e V. Costa, Einaudi, Torino.
McDowell, J. (1998), Meaning, Knowledge, & Reality, Harward University Press, Cambridge MA.
Piana, G. (1979), Elementi di una dottrina dell’esperienza, Il Saggiatore, Milano.
Piana, G. (2004), Sulla fantasticheria, http://www.filosofia.unimi.it/piana/index.php/filosofiadellimmaginazione/89-sulla-fantasticheria.
Wittgenstein, L. (1967), Ricerche filosofiche, a cura di M. Trinchero, Einaudi, Torino.
Wittgenstein, L. (1999), Della certezza, a cura di A. Gargani, Einaudi, Torino.
Abstract
The aim of this paper is to focus on a particular subject – imagination – in order to set limits and to
underscore the validity of a phenomenological understanding of our experience. Imagination is, first
of all, a general heading under which we comprehend a range of psychological faculties, whose
adaptive meaning (still poorly understood) deserve to be analyzed from a naturalistic point of view.
Under the same heading we are used to understand a variety of social and individual activities, of
playful gestures and utterances, which belong to the realm of meaning and which deserve to be
analyzed and clarified from a descriptive point of view. Phenomenology, as a description of the
meaning of our personal experience, has here its possible field of application.
Keywords: Imagination, Theory of Faculties, Phenomenology
159
�EMILIANO TRIZIO *
Il significato metafisico della teoria della conoscenza fenomenologica
1. Introduzione
Il rapporto tra fenomenologia e metafisica riveste un’importanza fondamentale per chiunque
intenda pervenire a una corretta comprensione dell’opera di Edmund Husserl, nonché del suo
significato per il dibattito filosofico contemporaneo. L’interesse verso questa tematica, per
quanto riscontrabile lungo tutto il secolo scorso, è rimasto a lungo sottotraccia, per poi riaffiorare
con forza in tempi relativamente recenti1. Non è improbabile che al suo rinnovamento abbiano
contribuito, da un lato, il raggiunto predominio delle nuove tematiche “metafisiche” nell’ambito
della filosofia analitica, e, dall’altro, l’affermarsi di una variegata coorte di nuove tendenze
realistiche presso molti ambienti continentali2. Così, alla questione più tradizionale vertente
sull’accusa rivolta ad Husserl da Heidegger prima3, e da Derrida poi, di aver riproposto una
versione tardiva della metafisica moderna della soggettività, si sono affiancate nuove discussioni
incentrate sulle questioni del realismo e sulla pretesa necessità di superare il correlazionismo
insito in tutta la tradizione fenomenologica. Questa evoluzione ha tuttavia favorito la tendenza,
in particolare nel mondo anglosassone, a considerare il rapporto tra fenomenologia e metafisica
in modo estrinseco, senza prima di tutto chiarire fino in fondo come esso vada inteso nei termini
propri al quadro teorico sviluppato da Husserl. Non è difficile immaginare quali possano essere i
rischi di tali operazioni. Il valore dell’opera dei grandi pensatori è legato essenzialmente alla loro
capacità di modificare i termini delle questioni filosofiche e le diverse rubriche disciplinari a cui
esse si presume appartengano. Ad opera di essi, i termini più comuni della riflessione filosofica
subiscono trasformazioni, a volte assai sottili, che impediscono di applicarvi griglie
ermeneutiche prefabbricate, definite sulla base di partizioni astratte della filosofia e dei suoi
problemi. In altri termini, il pensiero filosofico, quando è radicale come quello di Husserl, non si
lascia situare in sistemi di riferimento predefiniti, esterni a esso. Così, se il tema della relazione
tra l’idealismo trascendentale e la metafisica ha comprensibilmente dominato molte discussioni
recenti riguardanti il rapporto tra fenomenologia e metafisica, ciò è avvenuto senza che si
*
University of the West of England
1
Importanti riflessioni su questo tema si trovano già in Landgrebe (1949) e Kern (1964). Un’analisi della
questione della metafisica della presenza in relazione alla concezione husserliana del tempo si trova in Bernet
(1982). Per i contributi più recenti fondati su dettagliate analisi dei stesti husserliani, si vedano Ghigi (2002), e
(2007), Moran (2005), Bancalari (2010), Tengelyi (2014), e De Santis (2018).
2
Per una riflessione che connette la fenomenologia con le riflessioni metafisiche sulla coscienza di ambito
analitico, si veda Marbach (2010). Per una panoramica delle nuove posizioni realiste in ambito continentale, si veda,
per esempio, Gratton (2014).
3
Come nota Franco Volpi: “la metafisica ha raggiunto per lui il proprio compimento nell’essenza della tecnica
moderna, cioè nella costellazione epocale che determina il mondo contemporaneo. Con questa ipotesi Heidegger si è
contrapposto radicalmente a Husserl, per il quale la configurazione filosofico-scientifica del mondo moderno, con le
sue patologie, prima fra tutte la crisi delle scienze europee, non è la risultante dell’inveramento della metafisica
greca, bensì il tradimento dell’idea originaria della filosofia concepita come sapere universale e necessario di tutto
l’essere.” Volpi (1997), p. 169.
Bollettino Filosofico 33 (2018): 160-174
ISSN 1593 -7178 - 00030
E-ISSN 2035 -2670
DOI 10.6093/1593-7178/5914
�Il significato metafisico della teoria della conoscenza fenomenologica
chiarisse fino in fondo il ruolo che la metafisica ha svolto in modo del tutto consapevole ed
esplicito nello sviluppo intellettuale di Husserl.
Questo lavoro si inscrive nel tentativo che sto attuando da alcuni di anni di chiarire tali
questioni sulla scorta di un’interpretazione dell’opera di Husserl che riconosca al suo rapporto
con la metafisica il ruolo assolutamente centrale che le compete4. L’analisi si snoderà nel modo
seguente: nel § 2 si ricostruiranno i tratti fondamentali di un dibattito recente sul rapporto tra
fenomenologia e metafisica in cui si confrontano, da un lato, le interpretazioni che cercano di
svalutare tale rapporto (qui esemplificate dalla tesi di David Carr) e, dall’altro, quelle che
insistono sul nesso essenziale esistente tra queste due discipline (rappresentate dalle tesi di Dan
Zahavi). Nel § 3, si mostrerà che anche l’approccio di Dan Zahavi, per quanto più convincente di
quello di Carr, sottovaluta il valore del nesso esistente tra fenomenologia e metafisica, e si
criticherà la tesi che tale legame si manifesti soltanto dopo il passaggio dall’approccio delle
Ricerche Logiche a quello della fenomenologia trascendentale. Il paragrafo successivo (§ 4),
infine, permetterà d’introdurre altre considerazioni critiche sul modo in cui si tende a formulare
il rapporto tra fenomenologia trascendentale e metafisica, le quali verranno ulteriormente
sviluppate nelle conclusioni.
2. La questione della neutralità metafisica della fenomenologia
Il punto di partenza di quest’analisi sarà fornito dalle tesi di David Carr riguardanti il rapporto tra
fenomenologia e metafisica. Nel libro The paradox of subjectivity5, Carr propone di leggere Kant
e Husserl come rappresentanti di una “tradizione trascendentale” che costituirebbe un’alternativa
radicale alla metafisica moderna anziché un suo proseguimento. Lo scopo dichiarato di questa
interpretazione è di difendere tali autori, e in particolare Husserl, dalle critiche a essi rivolte in
primo luogo da Martin Heidegger. Come è noto, la cosiddetta svolta trascendentale, che
manifestò tutta la sua radicalità nella seconda sezione di Idee I (La considerazione
fenomenologica fondamentale) fu interpretata da molti tra gli stessi allievi di Husserl come una
deludente ricaduta in una forma enigmatica d’idealismo metafisico. La pietra dello scandalo è
costituita dalla tesi del carattere assoluto della coscienza trascendentale, espressa nella seguente
celebre formulazione nel § 49 di Idee I:
Dunque nessun essere reale, tale cioè che si rappresenti e si giustifichi coscienzialmente mediante
apparizioni, è necessario all’essere della coscienza stessa (nel senso amplissimo di corrente di
Erlebnisse). L’essere immanente è dunque indubitabilmente essere assoluto nel senso che per principio
nulla “re” indiget ad existendum. D’altra parte, il mondo della res trascendente è assolutamente relativo
[angewiesen] alla coscienza, non come logicamente immaginata, ma come attuale. 6
Simili affermazioni, che facevano tra l’altro riferimento (in modo per altro un po’ goffo) al gergo
cartesiano più classico, da parte del pensatore che nelle Ricerche Logiche aveva proclamato che
le questioni metafisiche sarebbero rimaste al di fuori dell’ambito delle ricerche fenomenologiche
in esse sviluppate, non potevano che suscitare reazioni contrastanti. In particolare, Heidegger
interpretò le tesi espresse in Idee I come prova che presupposti metafisici di ascendenza
4
Mi sia permesso di rimandare a Trizio (2016), (2017) e (2018) per i miei primi contributi in questa direzione.
Carr (1999). Per un approccio non troppo dissimile, ma che meriterebbe un’analisi a parte, si veda Crowell
(2001).
6
Husserl (1965), p. 107.
5
161
�Emiliano Trizio
cartesiana si annidano nel cuore del progetto filosofico husserliano, e questo con buona pace
della presunta messa tra parentesi di ogni tesi filosofica su cui esso si basa7.
Come si articola la difesa tentata da Carr contro l’accusa rivolta alla fenomenologia di
rappresentare l’ultima espressione della metafisica della soggettività? In sintesi, l’idea
fondamentale di Carr è che l’idealismo trascendentale non sia una tesi metafisica8, che il
soggetto trascendentale non debba essere interpretato in senso metafisico9, e che, in generale, la
filosofia trascendentale vada considerata come un metodo metafisicamente neutro10. L’errore
consisterebbe nel pensare che l’assoluto fenomenologico introdotto da Husserl nelle Idee, ma
anche, con accenti diversi, in molte altri testi, sia un soggetto sostanziale su cui si fondi l’essere
del mondo trascendente come un contenuto, o ancor peggio, come una sua creazione. Secondo
Carr (e, come avremo modo di ripetere, in questo almeno, a buon diritto) il soggetto
trascendentale di cui parla Husserl non sostiene l’essere come la sostanza sostiene i suoi modi, né
lo contiene realmente come se fosse una sua parte o componente, o un semplice contenuto
rappresentazionale, né lo crea e lo mantiene costantemente in essere a guisa di un soggetto divino
e in virtù di una qualsivoglia relazione causale11. Come si conciliano tutte queste affermazioni
con le enunciazioni più ardite dell’idealismo trascendentale di Husserl riguardo alla relatività del
mondo rispetto alla coscienza trascendentale? Carr è convinto che si possa dare una risposta a
questa domanda sulla base della distinzione tra fenomenologia e ontologia. L’ontologia formale
(cioè la scienza dell’oggetto concepito in vuota generalità) e le varie ontologie materiali che
Husserl ha affiancato a essa, e che riguardano la struttura a priori di determinati ambiti di realtà,
quali la natura materiale, il vivente, o l’insieme delle formazioni culturali, considerano il mondo
in ciò che vi è in esso in senso oggettivo, a parte rei. In altri termini, in esse, è il mondo come è
in sé a trovarsi posto in questione. La sospensione della tesi del mondo, per converso, e la
conseguente riduzione alla coscienza costituente pura avrebbero l’effetto di rindirizzare lo
sguardo teorico non tanto e non solo sull’esperienza cosciente, ma sull’essere oggetto (o,
presumibilmente, il poter diventare oggetto) del mondo e di tutti gli enti in esso contenuti. Detto
altrimenti, a una considerazione rivolta agli enti in sé e per sé, che è propria sia dei saperi
empirici, che delle varie ontologie aprioriche, si affiancherebbe una considerazione
trascendentale, cioè vertente su come tali enti diventino oggetti per un soggetto. Ora, su questa
base, Carr ritiene che si possa dare un’interpretazione non metafisica della tesi husserliana della
relatività dell’essere reale all’essere della coscienza.
What then is relative to or dependent on consciousness? Not the being of transcendent reality, but
merely its sense of being, including precisely its “intrinsic sense” of being transcendent. […] From the
phenomenological, as opposed to the ontological point of view, all regions of being are regions of
possible objects for consciousness, and it is in their capacity as objects, rather than simply as entities,
that they are considered. From this point of view beings and even regions of being are indeed, even
trivially, relative to or dependent on consciousness. To be an object is to be an object for consciousness,
to have meaning is to have meaning for a meaning bestowing intentional act.12
7
Heidegger (1979), p. 145.
Carr (1999), p. 114.
9
Ivi, p. 119.
10
Ivi, p. 102 e p. 111.
11
Queste affermazioni non sono nuove. Si veda, ad esempio, Gadamer (1994), pp. 62-65.
12
Ivi, p. 80.
8
162
�Il significato metafisico della teoria della conoscenza fenomenologica
Quando Husserl asserisce che la costituzione trascendentale permette di delucidare il senso
dell’essere (Seinsinn) di ogni categoria di oggetti, Carr sembra dire, egli si limiterebbe ad
affermare qualcosa non intorno all’essere stesso di tali oggetti, bensì soltanto al loro essere
oggetti, cioè all’avere un senso (o un significato) oggettivo per noi soggetti del conoscere. Tale
senso-per-noi sarebbe proprio dischiuso dalle analisi costitutive, le quali riguarderebbero,
appunto, la datità degli oggetti, la struttura invariante del loro modo di manifestarsi.
Alla luce di tale interpretazione, qual è lo statuto ontologico del soggetto trascendentale?
Ovviamente, come Carr giustamente afferma, la risposta alla domanda se la fenomenologia sia
una metafisica del soggetto dipende, in ultima analisi, da come essa intenda il soggetto
trascendentale13. Secondo questa interpretazione, laddove il soggetto empirico, in quanto realtà
immersa nel nesso causale e motivazionale del mondo, sarebbe una sostanza in senso
tradizionale14, il soggetto trascendentale sarebbe definito dall’intenzionalità soltanto, ossia non
sarebbe altro che una struttura non oggettiva che rende possibile la manifestazione di tutti gli
enti15. In ogni caso, esso non sarebbe né una sostanza in senso tradizionale, né una qualsivoglia
entità che contenga in sé il mondo in quanto rappresentazione.16 Le conclusioni di Carr sono
perentorie:
Both Kant and Husserl characterize their position as transcendental idealism, and both are concerned to
distinguish this position from realism and idealism in the usual sense. Realism and idealism are both
metaphysical theories about reality and its relation to the mind. The danger here is to think that
transcendental idealism is some third metaphysical position, perhaps somehow combining the other two.
Both Kant and Husserl have often been considered in this way, even by their most sympathetic
commentators. 17
In conclusione, la fenomenologia, secondo Carr, non prende posizione sulla controversia tra
idealismo e realismo, né prepara il terreno per una futura metafisica che dovrebbe incaricarsi di
farlo 18. Essa semplicemente non si occupa dell’essere del mondo, ma soltanto del senso che il
mondo ha per noi in quanto oggetto, senza precludere che esso posso essere altro o più di ciò che
è dato a noi19.
Certo, qualora la lettura proposta da Carr fosse condivisibile si potrebbe affermare in piena
tranquillità che Heidegger e tutti i pensatori che sulla sua scorta hanno creduto di poter liquidare
il pensiero di Husserl come un cascame metafisico della modernità, erano del tutto fuori strada.
Tuttavia, forza è riconoscere che lo Husserl di Carr, letto a partire da un’opposizione tra un punto
di vista oggettivo sul mondo e un punto di vista soggettivo, “nella prima persona”, come si ama
dire oggi, che sarebbe poi quello fenomenologico-trascendentale, assomiglia più a un filosofo
13
Ivi, p. 84.
Ivi, p. 91. Si tratta, anche in questo caso, di un’affermazione molto discutibile che però non sarà possibile
esaminare in questa sede.
15
«That is, as subject of its own intentionality, this subject can be seen as the source, not, of course, of the
existence of the world or the things in it, but of their meaning, and indeed their status as objects and as world for a
subject». Ivi, pp. 91-92.
16
Ivi, p. 96.
17
Ivi, p. 108.
18
Ivi, p. 102. In questo Zahavi sembra fraintendere la sua posizione, si veda Zahavi (2017), p. 61.
19
«Transcendental philosophy recognizes that the world may be more than, and other than, its appearance to us».
Carr (1999), p. 134.
14
163
�Emiliano Trizio
della mente come Thomas Nagel che al padre della fenomenologia20, e fin troppi aspetti del
pensiero di Husserl non si prestano a una tale lettura21.
Nel suo ultimo libro, Dan Zahavi22 ha criticato l’interpretazione di Carr in modo convincente.
Zahavi riconosce che qualunque discussione del rapporto tra fenomenologia e metafisica è
ostacolata dalla polisemia del termine metafisica, e dopo aver elencato un certo numero di
alternative tradizionali, dichiara di volersi limitare a considerare la metafisica nel senso di
un’indagine sullo statuto ontologico della realtà: «is reality mind-dependent or not, and if yes, in
what manner?»23. Da questo punto, la questione è declinata da Zahavi in mondo non dissimile da
come la intende Carr. Rispetto alla metafisica considerata in questo senso, la posizione di Zahavi
si può riassumere nel modo seguente. La fenomenologia, all’epoca delle Ricerche Logiche, vale
a dire quando essa è ancora definita come psicologia descrittiva, è improntata a una completa
neutralità metafisica. Non rientra, quindi, nella sua finalità pervenire a un chiarimento dello
statuto ontologico della realtà, benché essa possa avere ricadute critiche su tale problema, per
esempio escludendo una posizione come il fenomenalismo che pretende di risolvere gli oggetti
percepiti in costellazioni di dati sensoriali immanenti al soggetto24. Secondo Zahavi, a seguito
della svolta trascendentale, Husserl avrebbe mutato atteggiamento. In un breve paragrafo dal
titolo Metafisica e teoria della scienza25, Zahavi ricorda per sommi capi le considerazioni svolte
da Husserl nel § 21 del corso Einleitung in die Logik und Erkenntistheorie a proposito della
metafisica. Poiché il corso risale all’anno 1906/1907 e si situa quindi all’inizio della fase
trascendentale del pensiero di Husserl (cosa tra l’altro dimostrata dal fatto che esso contiene una
formulazione della riduzione fenomenologica), Zahavi ha ritenuto di poter vedere nelle
enunciazioni programmatiche in esso contenute il segno che il rapporto con la metafisica si era
modificato rispetto alla fase delle Ricerche Logiche. In particolare, Husserl vi stabilisce una
distinzione tra la metafisica formale o apriorica, cioè l’ontologia generale della realtà spaziotemporale, e la metafisica materiale o empirica, che si edificherebbe attraverso il lavoro di
delucidazione dei risultati delle scienze empiriche26. La parte a posteriori della metafisica,
chiamata anche scienza dell’essere in senso ultimo, che Husserl considera come la metafisica in
senso pregnante, presuppone sia l’elaborazione della metafisica formale che una teoria della
conoscenza sviluppata sul terreno fenomenologico. La soluzione dei problemi della teoria della
conoscenza che la fenomenologia rende possibile è quindi una precondizione necessaria per la
nascita di una vera metafisica scientifica. Ciò fa dire a Zahavi:
Why is this statement significant? Because whereas Husserl in Logische Untersuchungen considered
metaphysics to be something that is independent of and unrelated to phenomenology, he now explicitly
argues that it presupposes and requires a transcendental phenomenological clarification. To use a pair of
concepts employed by Husserl in the much later Encyclopedia Britannica article: whereas
transcendental phenomenology is first philosophy, metaphysics is second philosophy […]. Metaphysics
20
E del resto, Carr stesso istituisce un parallelo piuttosto ardito tra Husserl e l’autore di The View from Nowhere:
«written in the idiom of contemporary analytic philosophy (as opposed to Wittgenstein's cryptic-aphoristic style),
and addressed to its current practitioners, Nagel's book nevertheless raises most of the important issues surrounding
transcendental subjectivity and its relation to the empirical subject». Carr (1999), p. 131.
21
Ciò non significa non vi possano essere altre strategie per difendere Husserl dalle critiche di Heidegger. Si
veda, ad esempio, Majolino (2016).
22
Zahavi (2017).
23
Ivi, p. 65.
24
Ivi, p. 42.
25
Ivi, pp. 48-50.
26
Hua XXIV, pp. 99-102.
164
�Il significato metafisico della teoria della conoscenza fenomenologica
is the ‘proper science of reality’ (Hua Dok 3-VI/206); it is concerned not with ideal possibilities, but
with actuality, and is preceded and enabled by transcendental phenomenology qua eidetic science. But,
of course, to say that phenomenology might pave the way for a metaphysics is still different from saying
that phenomenology and phenomenological analyses are directly concerned with metaphysics. 27
Questo passaggio, il quale contiene importanti elementi su cui sarà necessario ritornare in
seguito, deve essere capito nel quadro della critica che Zahavi muove all’interpretazione di Carr
e ad altre che vanno nella stessa direzione. Il problema fondamentale è come interpretare la tesi
spesso ripetuta, e ribadita da Carr, che l’idealismo trascendentale di Husserl, essendo un
idealismo del “senso”, non avrebbe alcuna valenza metafisica a riguardo dell’essere stesso del
mondo. Zahavi fa giustamente notare come sia davvero difficile considerare la fenomenologia
come una disciplina metafisicamente neutra in un’accezione così radicale. Se le cose stessere
davvero così, ne seguirebbe che l’idealismo trascendentale sarebbe compatibile con qualunque
metafisica, «[…] including eliminativism, metaphysical realism, or subjective idealism»28.
Zahavi ha gioco facile a mostrare che l’idealismo trascendentale di Husserl è concepito per
fornire una risposta allo scetticismo globale e che la correlazione tra il soggetto trascendentale e
il mondo rende inimmaginabile che il mondo vero sia un altro rispetto a quello dato alla
coscienza29. Il senso d’essere del mondo, che per Carr si oppone allo statuto ontologico del
mondo, è invece il vero senso che l’essere del mondo ha in sé e per sé, non semplicemente in
quanto oggetto per noi. Ne consegue che qualunque realismo metafisico, secondo cui il mondo
esiste ed è determinato in sé indipendentemente dal soggetto, è incompatibile con l’idealismo
trascendentale30. Zahavi, dunque, riconosce che se è vero che la dipendenza dell’essere della
realtà trascendente dall’essere della coscienza trascendentale non va intesa secondo le categorie
classiche della metafisica, quale la relazione di una sostanza ai suoi modi, o di Dio alle sue
creazioni, per Husserl l’essere del mondo non è pensabile senza il soggetto trascendentale. E in
effetti, Zahavi cita diversi passi assai noti dell’opera di Husserl nei quali si asserisce che
l’esistenza stessa del mondo non è concepibile senza l’esistenza di fatto di un soggetto che lo
esperisca31, alla luce dei quali le interpretazioni “deflazioniste” alla Carr risultano assai difficili
da difendere. Zahavi conclude nel mondo seguente:
Phenomenology investigates not merely how different types of objects are meant, but also whether the
reality of these objects is mind-dependent or not. In its exploration of the phenomena, transcendental
phenomenology cannot permit itself to remain neutral or indifferent regarding the relation between
phenomena and reality. By having to take a stand in that relationship, phenomenology by necessity has
metaphysical implications. 32
Come si è detto, l’impostazione che Zahavi adotta è sostanzialmente corretta e le critiche che
muove a Carr e agli interpreti che cercano di minimizzare il significato ontologico della
fenomenologia sono del tutto condivisibili. Tuttavia, il suo resoconto del rapporto tra
fenomenologia e metafisica, nonché dell’evoluzione di tale rapporto a partire dalle Ricerche
27
Ivi, pp. 49-50.
Ivi, p. 64.
29
Ivi, pp. 70-71.
30
Ivi, p. 73.
31
Ivi, p. 71. Si veda, per esempio, Hua XXXVI, p. 78, p. 156, p. 119 e p. 121.
32
Ivi, p. 206.
28
165
�Emiliano Trizio
Logiche suscita, a sua volta, una serie d’interrogativi che è necessario prendere in
considerazione33.
Innanzitutto, come si è visto, Zahavi nella sua indagine sui rapporti tra fenomenologia e
metafisica non ha tratto il significato della parola metafisica dall’opera stessa di Husserl, bensì
ha scelto uno dei significati che sono stati tradizionalmente attribuiti a questo termine, ossia
quello secondo il quale la metafisica è la disciplina che si occupa dello statuto ontologico della
realtà in relazione alla mente e valuta diverse tesi su tale relazione, quali l’idealismo e il
realismo. Ciononostante, come si è detto, egli ha dato risalto al corso del 1906/1907
precisamente in quanto Husserl vi afferma che il compito della teoria fenomenologica della
conoscenza è di rendere possibile la nascita di una metafisica veramente scientifica, e ha visto in
ciò il segno che l’atteggiamento di Husserl nei confronti della metafisica era venuto a modificarsi
rispetto all’epoca delle Ricerche Logiche. Il problema è, però, che ciò che Husserl considera
come metafisica in senso autentico o pregnante in quel corso (e in molti altri testi) è la scienza
ultima della realtà di fatto, edificata a partire dai risultati delle scienze empiriche, e non la presa
di posizione sul problema della dipendenza della realtà dalla mente. Zahavi non riflette sulla
differenza tra questi due usi. Husserl chiama metafisica in senso autentico proprio la scienza
ultima della realtà di fatto, una scienza, cioè, i cui enunciati sono asserzioni su ciò che di fatto
esiste e non sulla verità o falsità del realismo e dell’idealismo. Riflettere sui diversi sensi in cui
Husserl utilizza il termine “metafisica” esige, tuttavia, che si risponda prima di tutto a una
domanda che riguarda l’evoluzione del pensiero di Husserl. Siamo davvero convinti che la
dipendenza della metafisica come scienza ultima della realtà di fatto dalla teoria della
conoscenza sia una novità nel pensiero di Husserl che emerge con la svolta trascendentale negli
anni seguenti alla pubblicazione delle Ricerche Logiche? Non è forse più probabile che tale
svolta abbia permesso di articolare un rapporto che era già in questione nelle opere precedenti di
Husserl?
3. Metafisica e teoria della conoscenza fenomenologica prima delle Ricerche Logiche
La situazione culturale e filosofica in cui Husserl si trova immerso fin dalla giovinezza è segnata
dallo sviluppo impetuoso della ricerca scientifica in tutti i campi del sapere. Verso la fine
dell’ottocento sembravano ormai lontani gli anni in cui l’idealismo tedesco aveva tentato di
rivaleggiare con le scienze empiriche sul loro stesso terreno, e buona parte degli sforzi della
filosofia del tempo avevano luogo in nome di un ritorno alla teoria della conoscenza di Kant o
seguivano l’una o l’altra delle varie tendenze positivistiche allora in voga. Questa certamente
appariva essere la situazione allo stesso Husserl, che osservava con preoccupazione la diffusa
condanna dell’idea stessa di metafisica, come si evince dalla parte pervenutaci della lezione
Erkenntnistheorie und Hauptpunkte der Metaphysik del 1898/1899, che ha un’importanza
fondamentale per ricostruire l’atteggiamento di Husserl verso la metafisica prima della
pubblicazione delle Ricerche Logiche34. Di fronte a questa generale sfiducia nella possibilità di
affrontare scientificamente gli interrogativi più alti che siano posti all’uomo, ossia quelli che
riguardano la natura ultima della realtà, Husserl reagisce vigorosamente riproponendo la
33
Zahavi aveva già sostenuto posizioni analoghe in una serie di pubblicazioni precedenti. Si veda Zahavi (2001),
(2002) e (2010). Si veda inoltre Zahavi, Boucher (2008), p. 505 in cui si afferma: «[…] Husserl, dans les Logische
Untersuchungen (lre ed.), pensait que la metaphysique est quelque chose d’independant de la phenomenologie et
qu’elle est sans lien avec elle».
34
Hua Mat III, p. 232.
166
�Il significato metafisico della teoria della conoscenza fenomenologica
necessità che il pensiero si misuri con tali problemi per assolvere ai massimi compiti che la
cultura occidentale aveva assegnato alla filosofia. Non è difficile riconoscere come, almeno fin
dagli anni novanta dell’Ottocento, le ambizioni filosofiche di Husserl avessero carattere
assolutamente universale, e questo nonostante le sue effettive ricerche si orientassero verso temi
spesso estremamente specifici, attinenti alla fondazione della matematica e della logica. Il
progetto filosofico di Husserl è fin dall’inizio caratterizzato da tre capisaldi che egli non
abbandonerà mai negli anni a venire: 1) le scienze positive già sviluppate e “mature” non vanno
rinnegate scetticamente, né sostituite con altre forme di sapere, 2) tuttavia, esse realizzano solo
incompletamente l’idea di scienza, o, in altri termini, esse soddisfano soltanto limitatamente un
genuino interesse teorico verso l’essere, 3) la filosofia è chiamata a superare l’incompletezza
della scienze e integrarle in un sapere più generale e più autenticamente razionale. Lungo tutta la
sua carriera filosofica, Husserl ha spesso dato sostanza a questi principi in forma leggermente
diversa, rinnovando sia il suo resoconto dell’incompletezza delle scienze, sia l’indicazione di
come porvi rimedio, senza che però questa ispirazione di fondo del suo pensiero si alterasse in
modo sostanziale. Per quanto riguarda il primo punto, è importante sottolineare che
l’incompletezza delle scienze consiste essenzialmente nel fatto che esse accettano acriticamente
una serie di presupposti, la cui lista, che pur subisce certe modificazioni sottili nel corso degli
anni, comprende però sempre i principi della logica e della matematica, l’esistenza del mondo e
la sua struttura generale che include lo spazio il tempo, e la causalità35. A queste assunzioni
generali non criticamente scrutinate dalle scienze, si deve poi aggiungere il fatto che le stesse
teorie empiriche che esse sviluppano ammettono interpretazioni diverse, in particolare per quanto
concerne l’ontologia a esse soggiacente. Anche queste ipotesi particolari andranno perciò chiarite
in vista di una razionalizzazione o “filosofizzazione” delle scienze. Ora, fin da prima delle
Ricerche Logiche, Husserl indica chiaramente che la metafisica ha il compito di occuparsi di
queste assunzioni e far sì che la forma di sapere così ottenuta possa dirsi davvero soddisfacente
dal punto di vista teorico36. Husserl non dice che la metafisica si esaurisce in questo sforzo
teorico, e tutto lascia pensare che già allora egli ritenesse che essa dovesse poi occuparsi anche di
questioni ancora più fondamentali, che riguardano l’esistenza di Dio, il senso della vita e della
storia e la possibilità della vita dopo la morte. Tuttavia, Husserl, che è persuaso che lo
scetticismo circa la possibilità della metafisica debba essere superato, preferisce procedere per
gradi e occuparsi in primo luogo di aspetti della metafisica che sono più prossimi al lavoro
teorico delle scienze positive.
Se la metafisica deve ambire a inglobare il sapere ancora imperfetto e unilaterale delle scienze
superandolo in una scienza autenticamente filosofica, essa lo può fare soltanto ricorrendo a una
disciplina più fondamentale che deve stare a monte sia delle scienze positive sia del loro
completamento metafisico: tale disciplina è la teoria della conoscenza. Negli scritti che
precedono la svolta trascendentale, il rapporto tra teoria della conoscenza e metafisica è oggetto
di continue riformulazioni e cambiamenti di terminologia e costituisce uno degli aspetti più
tormentati del suo percorso intellettuale37. Tuttavia è possibile rintracciare le tendenze di fondo
che sottendono a tale evoluzione e la rendono estremamente coerente. La teoria della
conoscenza, per Husserl, è in assoluta generalità la disciplina su cui tutta la filosofia deve
fondarsi. Essa deve servire allo scopo di delucidare la natura del conoscere in tutti i suoi ambiti,
35
Una formulazione di questo tipo risale già alla Logik Vorlesung 1896. Si veda Hua Mat I, p. 5.
Ibidem. In modo meno esplicito, questo approccio si può già ravvisare negli scritti sullo spazio del 1892-93. Si
veda, per esempio, Hua XXI, p. 265 e pp. 270-71.
37
Mi sia consentito di rimandare a Trizio (2017), pp. 43-63, per un’analisi di questa evoluzione.
36
167
�Emiliano Trizio
inclusi quelli della logica e della matematica, ma, storicamente, è motivata soprattutto dagli
enigmi riguardanti la conoscenza del mondo reale. Husserl si spinge fino ad affermare che la
teoria della conoscenza deve servire come strumento per l’edificazione della metafisica come
scienza:
Wir aber wollen eine Philosophie haben; wir wollen sie uns durch sorgsamste Analyse und Kritik
erarbeiten. Nach dem Prinzip, dass nur die vollste Klarheit und Deutlichkeit der Begriffe eine sichere
Erkenntnis ermöglicht, werden wir aller Verschwommenheit und Vieldeutigkeit von vornherein den
Krieg erklären. Bis zu den letzten absolut sicheren Fundamenten der Erkenntnis wollen wir graben, um
auf sie eine echte und zuverlässige Theorie des Wissens (zu bauen) und damit auch ein sicheres
Werkzeug metaphysischer Forschung zu gewinnen. 38
Di fatto, secondo Husserl, la storia della filosofia fornisce esempi di come diverse concezioni
della conoscenza abbiano l’effetto di produrre interpretazioni contrastanti dell’essere del mondo,
e, quindi, convinzioni metafisiche mutualmente esclusive quali l’idealismo, il fenomenalismo, il
realismo o il Kantismo39. A questo punto appare già in tutta la sua evidenza un fatto importante
per il dibattito ricostruito nel paragrafo precedente: Husserl stesso, fin dall’inizio della sua
carriera, utilizza il termine metafisica per indicare le dottrine che si occupano del rapporto tra la
coscienza e la realtà. La cosa ovviamente non sorprende affatto, essendo un tal uso conforme a
un’accezione del termine metafisica che è assai comune nella filosofia moderna. Più interessante
è che rintracciare un tal uso già nel primo periodo della riflessione husserliana permette di
seguire l’evoluzione di questa tematica fino alle fasi successive, quando la terminologia di
Husserl diventa meno perspicua in vista di un confronto con la tradizione filosofica.
Ritorniamo, però, al punto fondamentale: una diversa concezione della conoscenza determina
quale posizione metafisica si assume sul mondo, determina cioè l’interpretazione generale
dell’essere del mondo, e ciò senza che siano toccati i risultati particolari delle scienze, i quali, a
loro volta, subiranno i mutamenti di segno dettati dalla posizione metafisica prescelta. La teoria
fisica, per esempio, non sarà interpretata nello stesso modo da un realista, da un positivista o da
un kantiano, qualora pur si accordassero sul suo contenuto. Stanti così le cose, almeno quella
parte della metafisica che consiste nel fornire un’interpretazione dell’essere del mondo rispetto al
suo rapporto con la coscienza o il soggetto (le suddette convinzioni metafisiche) è così
strettamente legata alla teoria della conoscenza che Husserl tende persino a considerare le
opinioni fondamentali di quest’ultima come già appartenenti all’ambito della metafisica:
Daraus entspringen nicht bloß erkenntnistheoretische, sondern schon metaphysische Überzeugungen der
Art, wie wir sie in der Einleitung berührt haben, die Lehren des Bewusstseinsidealismus und
Positivismus, der alle Erkenntnis auf die subjektiven Phänomene einschränkt im Gegensatz zum
Realismus, der eine Erkenntnis von transzendenten Wirklichkeiten für möglich und für uns erreichbar
anerkennt. 40
Detto altrimenti, sviluppando una teoria della conoscenza del mondo reale o “esterno”, si prende
necessariamente anche posizione sulla forma generale del suo essere, cioè sul suo statuto
ontologico, per esprimersi nei termini più prossimi a noi (che sono quelli impiegati da Zahavi).
38
Mat III, p. 228.
Ivi, pp. 238-240.
40
Hua Mat III, p. 255.
39
168
�Il significato metafisico della teoria della conoscenza fenomenologica
Un altro elemento fondamentale che emerge con forza già nella lezione del 1898/1899 è la
dipendenza delle scienze empiriche da quello che Husserl chiama la comprensione prescientifica
del mondo [vorwissenschaftlische Weltauffassung 41] caratteristica dell’uomo naturale42, e che
rappresenta un’anticipazione di quello che Husserl chiamerà in seguito “l’atteggiamento
naturale”. Se le scienze positive abbisognano di un’indagine teorica altra rispetto ad esse perché i
loro risultati possano ricevere un’interpretazione ultima, ciò è dovuto essenzialmente alla loro
dipendenza strutturale dalla concezione generale del mondo che sta alla base della vita
prescientifica. Nessuno, durante lo svolgersi della vita naturale, dubita che esista il mondo, che
esso si estenda nello spazio e nel tempo, che esso contenga oggetti materiali connessi da
relazioni causali, ma anche altre menti etc. Le scienze, nel loro procedere metodico, modificano
certo a poco a poco la nostra concezione del mondo, ma non mettono mai in discussione questo
schema di base. Pertanto, se la metafisica deve completare le scienze superando la loro
accettazione acritica della concezione naturale del mondo, e se essa può farlo soltanto
addossandosi alla teoria della conoscenza, sarà necessario che la teoria della conoscenza si
astenga dal fare alcuna assunzione di carattere metafisico e, in particolare, si astenga
dall’assumere come valida tale precomprensione del mondo. Così, si capisce perché Husserl
mostri d’interpretare fin da principio in modo particolarmente radicale il carattere fondante della
teoria della conoscenza. Egli, infatti, ne esige la totale assenza di presupposti metafisici: il
conoscere in quanto tale non deve essere tematizzato in relazione a presupposti che riguardano la
struttura della realtà. Per chi sa leggere, tale richiesta anticipa precisamente la sospensione
dell’atteggiamento naturale che sarà richiesta dalla fenomenologia trascendentale. Inoltre, essa è
anche alla base delle analisi di “psicologia descrittiva” che si trovano nelle Ricerche Logiche.
Quanto visto finora ci permette di criticare la tesi di Zahavi, secondo cui la svolta
trascendentale di Husserl avrebbe comportato il passaggio da una fenomenologia senza rapporto
con la metafisica a una fenomenologia avente anche delle ripercussioni metafisiche. In realtà,
come si appena visto, già negli anni precedenti alle Ricerche Logiche, Husserl era pervenuto alle
conclusioni seguenti: 1) il fine ultimo dell’attività filosofica consiste nell’addivenire a una
conoscenza scientifica della realtà che includa, secondo modalità ovviamente da decidersi in
seguito, tutte le questioni più fondamentali su cui il pensiero metafisico si è interrogato; 2) fra di
esse vi è il problema dell’interpretazione dell’essere della realtà sulla base di quelle posizioni
metafisiche che la situano rispetto al soggetto; 3) tale interpretazione dell’essere della realtà si
decide sul terreno della teoria della conoscenza, la quale deve essere svolta secondo il principio
dell’assenza di presupposti metafisici; 4) la teoria della conoscenza è a sua volta assorbita
dall’analisi dei vissuti di coscienza, ossia della fenomenologia. Pertanto, quando Husserl,
all’inizio delle Ricerche Logiche, proclama che il problema stesso dell’esistenza del mondo, in
quanto metafisico, deve restare estraneo all’ambito d’indagine prescelto, egli vuole soltanto
mettere in chiaro che l’ipotesi dell’esistenza del mondo riceverà il suo senso, la sua
interpretazione correttamente vagliata, soltanto a partire da una teoria della conoscenza
sviluppata sul terreno di una psicologia descrittiva scevra da presupposti metafisici. Che una tale
psicologia descrittiva priva di presupposti metafisici sia concepibile è ciò che Husserl
riconoscerà ben presto come assurdo (nel 1903 per l’esattezza), quando egli stesso ricuserà con
forza l’idea che una dottrina dell’essenza dei vissuti di coscienza concepiti come appartenenti a
un soggetto psicologico possa essere il terreno legittimo su cui assolvere ai compiti della teoria
della conoscenza.
41
42
Ivi, p. 251.
Ivi, p. 241.
169
�Emiliano Trizio
4. Teoria fenomenologica della conoscenza e senso dell’essere
L’insistenza sul nesso tra teoria della conoscenza e metafisica che riscontriamo nei testi
husserliani degli anni precedenti alla pubblicazione delle Ricerche Logiche non autorizza a
pensare che Husserl attribuisse senz’altro alla teoria della conoscenza il compito di scegliere tra
le dottrine metafisiche classiche quali il realismo e l’idealismo. Neppure i testi più giovanili
lasciano intendere chiaramente che le cose stiano così, sebbene non ci sia alcuna esplicita
affermazione in senso contrario. Husserl, seguendo una strategia espositiva volta a mostrare non
soltanto che le scienze positive sono incomplete, ma anche che nessun progresso compiuto sul
loro terreno di ricerca può redimerle da tale incompletezza, pare piuttosto evocare l’esistenza
d’interpretazioni metafisiche contrapposte dell’essere del mondo, quali il realismo e l’idealismo,
al fine di convincere il lettore della necessità di una ricerca che faccia proprio quanto di
filosoficamente cogente tali posizioni si sforzavano di caratterizzare. Si tratta di mostrare
l’esistenza di una lacuna piuttosto che elencare tutti i possibili materiali che potrebbero colmarla.
Ciò che è fuor di dubbio, ad ogni modo, è che mentre si consuma il passaggio verso la
fenomenologia trascendentale (così come anche negli anni seguenti), Husserl considera tutte le
posizioni metafisiche classiche sul rapporto tra coscienza e mondo come letteralmente insensate.
Sottolinearlo è importante per comprendere in che senso la fenomenologia trascendentale erediti,
per coì dire, la funzione metafisica della teoria della conoscenza quale Husserl la concepiva già
prima delle Ricerche Logiche, senza però che essa s’impegni nello stesso gioco che aveva
caratterizzato la metafisica moderna fino a Kant incluso. A questo proposito, un testo del 1905
(Urteilstheorie Vorlesung 190543) contiene delle indicazioni estremamente preziose. In esso
Husserl introduce una serie di definizioni estremamente chiare, le quali, per quanto non siano
destinate ad avere fortuna nelle sue opere seguenti, gettano luce su una sorta di ponte nascosto
che congiunge la prima fase del pensiero di Husserl a quella propriamente trascendentale.
Husserl vi introduce una nozione di metafisica formale che non combacia con quella
presentata soltanto un anno dopo, nelle lezioni del 1905/1906 (e già menzionata al § 3):
Die reine Logik und Erkenntnistheorie ist, so könnten wir geradezu sagen, formale Metaphysik, sofern
sie unter Abstraktion von den Besonderheiten, in denen sich Sein in den bestimmten Wissenschaften
darstellt, die zur Idee des Seins überhaupt gehörigen Formen und Gesetzmäßigkeiten erforscht und
dabei den letzten Sinn des Seins und der zugehörigen Korrelationen zu Bedeutung und Denken zur
Klarheit bringt. Die materiale Metaphysik aber stellt aufgrund der Erkenntnistheorie fest, was nun
faktisch ist und wie es ist; sie fragt nicht bloß, was zum Sein überhaupt und als solchem wesentlich ist,
sondern als was das de facto Seiende nach den jeweiligen Ergebnissen der bestimmten
Seinswissenschaften zu gelten hat.44
Ist Metaphysik die Wissenschaft von dem real Seienden im wahren und letzten Sinn, so ist die
Erkenntnistheorie die Vorbedingung der Metaphysik. Die Erkenntnistheorie ist formale
Seinswissenschaft, sofern sie vom Sein, wie es sich faktisch in der Seinsforschung der bestimmten
Wissenschaften darstellt, absieht und das Sein überhaupt seinem wesentlichen Sinn gemäß erforscht.45
La metafisica formale o dottrina formale dell’essere si occupa di determinare in assoluta
generalità i caratteri dell’essere reale. Ad essa appartiene la logica formale in quanto mathesis
43
Hua Mat V.
Ivi, pp. 29-30.
45
Ivi, p. 41.
44
170
�Il significato metafisico della teoria della conoscenza fenomenologica
universalis, poiché questa stabilisce leggi valide per ogni oggetto possibile e a priori rispetto a
qualunque scienza particolare dell’essere; ma ad essa appartiene anche la teoria della
conoscenza, in quanto essa determina il senso d’essere della realtà, di nuovo in assoluta
generalità. Se si considera che la teoria della conoscenza è fondata su quella che Husserl qui
chiama “fenomenologia della conoscenza”46, si evince che Husserl, nel 1905, giunge a
considerare la fenomenologia come il terreno d’indagine di problemi appartenenti a un ambito
che egli stesso chiama “metafisica formale”. Questo fatto indica che Husserl, ora, vede con
maggior chiarezza che non si tratta di scegliere tra le posizioni metafisiche classiche, bensì di
sostituire tutte le interpretazioni errate dell’essere che esse proponevano con lo studio del senso
dell’essere della realtà così come esso si annuncia nelle sintesi coscienziali. Nelle opere più
tarde, quale la Crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Husserl spiegherà
in dettaglio come la totalità delle posizioni metafisiche moderne fossero influenzate da pregiudizi
oggettivisti che rendevano impossibile una corretta comprensione dell’essere del mondo. La
stessa nozione di sostanza appartiene, in quanto “sostruzione” metafisica47, al novero delle
nozioni oggettivistiche cha vanno abbandonate. Pertanto, si comprende bene che l’assoluto
fenomenologico delle Idee non sia una sostanza e che il suo rapporto con il mondo non possa
essere capito alla luce di nozioni metafisiche classiche: la fenomenologia fa giustizia di quel tipo
di concetti. Essa, attraverso la teoria della costituzione, rende conto di come l’essere di ogni
categoria di oggetti si costituisca nella coscienza trascendentale; descrive cosa voglia dire essere
per tali oggetti, cioè che senso abbia il loro essere48.
Ciò che ha reso difficile riconoscere che la fenomenologia trascendentale (e prima di essa la
“psicologia descrittiva” delle Ricerche Logiche) aveva lo scopo di occupare lo spazio tematico di
quella parte della metafisica classica che si era interrogata sullo statuto ontologico del mondo,
ridefinendola appropriatamente e superandone le aporie, è proprio il fatto che Husserl smise
subito di descrivere la teoria fenomenologica della conoscenza come metafisica formale, e, dopo
qualche esitazione, confinò l’uso del termine metafisica alla metafisica empirica o materiale, cioè
alle scienze di fatto fondate fenomenologicamente e, sempre più spesso negli anni ancora
successivi, alla riflessione sul Dio, sul senso del mondo, della vita e della morte49.
5. Conclusioni
I tentativi à la Carr di svalutare le valenze metafisiche della fenomenologia vanno incontro alle
difficoltà che sono state sottolineate da Zahavi. L’interpretazione di Zahavi mostra tuttavia il
fianco a due critiche. La prima è stata esplicitamente indicata nel § 3, mentre la seconda attende
ancora di essere formulata.
In primo luogo, come si è visto nel § 3, non si può affermare che vi sia una cesura netta tra
una fenomenologia pre-trascendentale che sarebbe senza rapporto con la metafisica (intesa come
46
Ivi, p. 42.
Per questa nozione, si veda Hua VII, p. 35.
48
La polemica contra la metafisica ingenua basata su “sostruzioni” è costante nell’opera di Husserl. Si veda, a
titolo di esempio, come Husserl cerchi di liberare la psicologia dall’uso di tali sostruzioni e di renderla una scienza
autentica, basata sull’esperienza (Hua IX, p. 193). Più in generale, le ricostruzioni della storia della filosofia
moderna che si trovano nel primo volume di Filosofia Prima (Hua VII) e nella seconda sezione della Crisi,
denunciano precisamente il modo in cui la via per la formulazione di un razionalismo rigoroso sia stata sbarrata, da
Cartesio in poi, proprio dalle dottrine metafisiche di stampo oggettivistico. Nel § 64 delle Meditazioni Cartesiane
poi, si trova la celebre affermazione secondo cui la fenomenologia si oppone soltanto alla metafisica ingenua che
opera con assurde cose in sé, ma non alla metafisica in generale (Hua I, p. 182).
49
Si veda Bernet, Kern, Marbach, (1992), pp. 296-299.
47
171
�Emiliano Trizio
indagine sullo statuto ontologico del mondo) e una fenomenologia trascendentale che invece
avrebbe ricadute metafisiche. Fin da prima delle Ricerche Logiche, Husserl riconosceva che
l’interpretazione dell’essere del mondo era determinata dalla teoria della conoscenza, la quale
doveva essere sviluppata sul terreno dell’analisi descrittiva dei vissuti di coscienza, cioè sul
terreno della fenomenologia. Inoltre, egli affermava espressamente che la teoria della conoscenza
doveva servire come strumento anche per svolgere questo ruolo “interpretativo”. Certo, il
rapporto tra fenomenologia e metafisica non rimase immutato col passaggio all’approccio
trascendentale. Soltanto allorché Husserl comprese a fondo il significato della costituzione del
mondo nella soggettività trascendentale, si aprì la possibilità di liberarsi, in nome dell’idealismo
trascendentale, di tutte le posizioni metafisiche classiche. Fino a quel momento, il rapporto tra la
fenomenologia e tali posizioni metafisiche, per quanto importanti ne fossero l’esistenza e il
significato, restava essenzialmente allo stadio programmatico.
In secondo luogo, sulla scorta delle analisi fin qui svolte, appare legittimo dubitare che sia
possibile, come fa Zahavi, valutare il rapporto tra fenomenologia e metafisica definendo
astrattamente quest’ultima come l’indagine volta a stabilire se la realtà “dipende dalla mente o
meno”. Questa formulazione, se presa alla lettera, si adatta certo a descrivere, per esempio, la
differenza tra la filosofia di Locke e quella di Berkeley, e, quando si sia avuto cura di
rimpiazzare la parola “mente” con la parola “coscienza”, essa può anche corrispondere alle
considerazioni che Husserl svolgeva nella fase iniziale del suo pensiero. Tuttavia, essa non può
essere semplicemente applicata alla fenomenologia trascendentale, precisamente perché la
coscienza trascendentale non è una mente da cui il mondo dipenderebbe, ma l’assoluto in cui il
mondo si costituisce in quanto unità di senso. Neppure è possibile, come fa Zahavi, affermare
che la fenomenologia trascendentale si occupi di capire se la realtà degli oggetti sia indipendente
dalla mente o no; perché ogni oggetto non è altro che un’unità di senso nella coscienza
trascendentale e, come tale, non potrebbe esistere senza quest’ultima.
Tutto ciò può essere inteso più chiaramente sulla base delle considerazioni seguenti. Se, da un
lato, l’interpretazione deflazionista di Carr si trova ancor più a mal partito di fronte alle
affermazioni di Husserl che sono state riportate nel § 4, secondo le quali la teoria della
conoscenza fenomenologica basata sull’analisi dei vissuti di coscienza è essa stessa una parte
delle metafisica formale, non bisogna però dimenticare che proprio questa presa d’atto
consentiva alla fenomenologia di affrancarsi dal linguaggio della metafisica moderna dominato
dai termini contrapposti di mente e mondo. Husserl si rese conto che alle interpretazioni erronee
dell’essere del mondo basate su nozioni oggettiviste quali quelle di sostanza mentale o materiale,
o quale l’idea di una mente definita come una sfera interna contrapposta a un mondo esterno, si
deve sostituire una filosofia autenticamente trascendentale, anti-oggettivista, che descrive il
senso dell’essere del mondo sulla base di categorie puramente fenomenologiche come
l’immanenza e la trascendenza. Certo, contro le conclusioni di Carr, l’idealismo trascendentale
assomiglia per un verso all’idealismo metafisico classico, perché afferma che il mondo non
potrebbe esistere senza coscienza, e per un altro, al realismo, perché, come Husserl amava
ripetere, non sottrae nulla alla realtà oggettiva del mondo; ma sarebbe errato considerarlo come
una semplice variante delle posizioni metafisiche del passato.
Probabilmente, considerazioni di questo tipo stanno alla base della decisione da parte di
Husserl di lasciar cadere l’uso del termine “metafisica” in relazione alla teoria fenomenologica
della conoscenza. Come è noto, e come si è già avuto modo di ricordare, Husserl conservò
ancora per molti anni l’uso del termine “metafisica” per il completamento filosofico delle
scienze di fatto, cioè per scienze che, a differenza della fenomenologia, non si occupano di pure
172
�Il significato metafisico della teoria della conoscenza fenomenologica
possibilità d’essere; ma questo senso non è quello scelto da Zahavi nei suoi lavori, e una sua
disanima esaustiva richiederebbe ulteriori analisi. In conclusione, ritroviamo l’idea che ha
guidato questo lavoro fin dall’inizio, e cioè che un pensiero quale quello di Husserl merita la
nostra attenzione più per il modo in cui trasforma le categorie filosofiche classiche, che per come
si presta a essere descritto grazie a esse.
Bibliografia
Husserl, E. Gesammelte Werke.
Hua, I (1973), Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge, Martinus Nijoff, L’Aia.
Hua, III/1 (1976), Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen
Philosophie (Erstes Buch), Martinus Nijhoff, L’Aia, trad. it. a cura di E. Filippini, Einaudi,
Torino.
Hua, VI (1954), Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale
Phänomenologie: Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie, Martinus
Nijhoff, L’Aia.
Hua, VII (1956), Erste Philosophie (1923-1924). Erster Teil: Kritische Ideengeschichte,
Martinus Nijhoff, L’Aia.
Hua, IX (1968), Phänomenologische Psychologie, Martinus Nijhoff, L’Aia.
Hua, XXI (1983), Studien zur Arithmetik und Geometrie (1886-1901), Martinus Nijhoff,
L’Aia.
Hua, XXIV (1984), Einleitung in die Logik und Erkenntnistheorie. Vorlesungen (1906-1907),
Martinus Nijhoff, L’Aia.
Hua, XXXVI (2003), Transzendentaler Idealismus: Texte aus dem Nachlass (1908-1921),
Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
Hua, Mat I (2001), Logik Vorlesung (1896), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
Hua, Mat III (2001), Allgemeine Erkenntnistheorie (1902-1903), Kluwer Academic
Publishers, Dordrecht.
Hua, Mat V (2002), Urteilstheorie Vorlesung (1905), Kluwer Academic Publishers,
Dordrecht.
Bancalari, S. (2010), “Eidos versus intersoggetività: una prospettiva husserliana
sull’impossibile”, Archivio di Filosofia, vol. 78, n. 1, pp. 229-238.
Bernet, R. (1982), “Is the Present Ever Present? Phenomenology and the Metaphysics of
Presence”, Research in Phenomenology, vol. 12, pp. 85-112.
Bernet, R.-Kern, I.-Marbach, E. (1992), Edmund Husserl, trad. it. a cura di C. La Rocca, Il
Mulino, Bologna.
Carr, D. (1999), The Paradox of Subjectivity. The Self in the Transcendental Tradition, Oxford
University Press, Oxford.
Crowell, S. (2001), Husserl, Heidegger and the Space of Meaning, Northwestern University
Press, Evaston.
De Santis, D. (2018), “‘Metaphysische Ergebnisse’: Phenomenology and Metaphysics in
Edmund Husserl’s Cartesianische Meditationes (§60). Attempt at Commentary”, Husserl
Studies, vol. 34, n. 1, pp. 63-83.
Gadamer, H.-G. (1994), Il movimento fenomenologico, trad. it. a cura di C. Senigaglia, Laterza,
Roma-Bari.
Ghigi, N. (2002), “La problematica della metafisica nella fenomenologia di Husserl”, Rivista di
Filosofia Neo-Scolastica, vol. 94, n. 3, pp. 425-439.
173
�Emiliano Trizio
Ghigi, N. (2007), La metafisica in Edmund Husserl, Franco Angeli, Milano.
Gratton, P. (2014), Speculative Realism, Bloomsbury, Londra e New York.
Heidegger, M. (1979), Prolegomena zur Geschichte der Zeitsbegriff, Klostermann, Frankfurt
a.M.
Kern, I. (1964), Husserl und Kant, Martinus Nijhoff, L’Aia.
Landgrebe, L. (1949), “Phenomenology and Metaphysics”, Philosophy and Phenomenological
Research, vol. 10, n. 2, pp. 197-205.
Majolino, C. (2016), “Until the End of the World: Eidetic Variation and Absolute Being of
Consciousness – A Reconsideration”, Research in Phenomenology, vol. 46, n. 2, pp. 157-183.
Marbach, E. (2010), “Is There a Metaphysics of Consciousness Without a Phenomenology of
Consciousness? Some Thoughts Derived from Husserl’s Philosophical Phenomenology”,
Royal Institute of Philosophy Supplement, vol. 67, pp. 141-154.
Moran, D. (2005), Edmund Husserl: Founder of Phenomenology, Polity Press, Cambridge.
Tengelyi, L. (2014), Welt und Unendlichkeit, Verlag Karl Alber, Freiburg/München.
Trizio, E. (2016), “What is the Crisis of Western Sciences?”, Husserl Studies, vol. 32, n. 3, pp.
191-211.
Trizio, E. (2017), “Husserl’s Early Concept of Metaphysics as the Ultimate Science of Reality”,
Phainomenon, vol. 26, pp. 37-68.
Trizio, E. (2018), “The Telos of Consciousness and the Telos of World History”,
Humana.Mente, in corso di pubblicazione.
Volpi, F. (1997), La metafisica rimossa, in AA.VV, Metafisica il mondo nascosto, Laterza,
Roma-Bari, pp. 167-196.
Zahavi, D. (2001), “À propos de la neutralité métaphysique des Recherches logiques”, Revue
Philosophique de Louvain, vol. 99, n. 4, pp. 715-736.
Zahavi, D. (2002), “Transcendental Subjectivity and Metaphysics”, Husserl Studies, vol. 25, pp.
103-116.
Zahavi, D. (2010), Husserl and the ‘Absolute’, in Ierna, C.-Jacobs, H.-Mattens, F. (Eds.),
Philosophy, Phenomenology, Sciences, Springer, Dordrecht, pp. 71-92.
Zahavi, D. (2017), Husserl’s Legacy, Oxford University Press, Oxford.
Zahavi, D.-Boucher, D. (2008), “Phénoménologie et Métaphysique”, Les Etudes philosophiques,
vol. 4, pp. 499-517.
Abstract
Recently, a number of publications (e.g. Tengelyi 2014, Zahavi 2017) have renewed the interest
for the relation between phenomenology and metaphysics. This issue appears crucial both for
understanding Husserl’s thought per se, and for a systematic appraisal of its relations with postHusserlian phenomenology as well as with contemporary analytic debates about metaphysics. In
this paper, I will argue that, contrary to what Zahavi and other have claimed, metaphysical
interests played an essential role even before the Logical Investigations and that, by
acknowledging it, we can better appreciate the metaphysical implications of Husserl’s later
transcendental idealism. This conclusion will rest on 1) a careful investigation of Husserl’s own
different notions of metaphysics and 2) an analysis of his views about the relations between
metaphysics and the theory of knowledge.
Keywords: Phenomenology, Metaphysics, Theory of Knowledge, Husserl, Transcendental
Idealism
174
��ANGELA ALES BELLO*
Il valore teoretico della fenomenologia “classica” di Edmund Husserl ed Edith Stein
e il suo contributo alla fondazione delle scienze umane
1. La teoresi fenomenologica
È opportuno chiarire il senso dell’aggettivo “classico” che ho aggiunto al termine fenomenologia.
Lo uso riferendomi a due prospettive d’indagine: la prima riguarda lo sviluppo interno della scuola
fenomenologica e il secondo il rapporto della fenomenologia con la filosofia che è definita
“classica”, la più importante corrente di pensiero che, dalla speculazione nata nell'antica Grecia,
attraversa la storia della filosofia occidentale.
Da ciò deriva una domanda fondamentale: che tipo di filosofia è la fenomenologia? La storia di
coloro che dichiarano di condividere questo stile di pensiero dimostra che è in gioco il senso stesso
della filosofia e per noi occidentali tale disciplina si è configurata - una volta per tutte? – con i
pensatori greci. Si vedrà anche che chi vuole rompere con la tradizione per affrontare le questioni in
modo nuovo, alla fine torna sempre a fare i conti con il passato.
Il bilancio critico sulla fenomenologia non è rivolto, perciò, soltanto a ciò che avviene ed è
avvenuto all’interno di questa corrente di pensiero, ma apre una questione più ampia. Infatti, lo
stesso fondatore della scuola ha posto in primo piano tale problema lungo tutto l’arco della sua
indagine. L’analisi dei “fenomeni” si presenta indubbiamente come una novità rispetto alla storia
della filosofia occidentale, già in Husserl e ancora più fortemente in quello che egli riteneva in un
primo momento che dovesse essere il suo continuatore, Heidegger. Aderenza ai fenomeni (Husserl),
aderenza alla vita (Heidegger), queste le parole d’ordine dei due pensatori all’inizio della loro
riflessione; tuttavia, mentre Husserl coglie, da questo punto di vista, l’insufficienza della
speculazione occidentale, la sua mancanza di radicalità, ma non la rinnega pur criticandola,
Heidegger porta alle estreme conseguenze la critica alla speculazione precedente, seguendo sempre
più esplicitamente in questo atteggiamento le orme di Nietzsche. Ma il nichilismo, che appare lo
sbocco di questa seconda presa di posizione e che, in verità, non si trova ancora affermato nel
pensiero di Heidegger, non conduce alla negazione della filosofia stessa? E questa è veramente una
novità? Non era già implicito nella Sofistica? Siamo risospinti inevitabilmente alla filosofia greca
dalla quale non possiamo liberarci, nonostante tutti gli sforzi, a meno che non rinunciamo ad
affrontare, come diceva Husserl «le questioni ultime e somme» e ci accontentiamo di dedicarci a
coltivare piccoli campi del sapere, che, nonostante la loro importanza, sono sempre limitati.
Forse l’esigenza di andare alle questioni ultime e somme è il frutto di una grande illusione?
Dobbiamo porci, però, ancora una domanda: come ci viene in mente di occuparci di tali questioni?
Da dove nasce tale esigenza? Che cosa c’è in noi che ci spinge?
Si è detto “noi”; allora forse è proprio da lì che dobbiamo cominciare e accettare il detto di
Eraclito: «Ho indagato me stesso» (Fr.101 DK). Possiamo ignorare questo inizio per immergerci
subito nel mare di qualcosa che non siamo noi? La vita, come diceva il primo Heidegger, il quale,
poi, per comprenderla è costretto a risalire al tema dell’esistenza, ma non in generale, piuttosto ad
un’esistenza che è collocata storicamente qui e ora, il Dasein.
___________________________
*
Università Lateranense - Roma
Bollettino Filosofico 33 (2018): 176-184
ISSN 1593 -7178 - 00030
E-ISSN 2035 -2670
DOI 10.6093/1593-7178/5915
�Il valore teoretico della fenomenologia “classica” di Edmund Husserl ed Edith Stein
È sufficiente, però, guardare dal di fuori il Dasein? si chiedeva Edith Stein1; dobbiamo rimanere
fuori dalle mura del castello? Kafka ci insegna che l’angoscia è generata proprio dal non poter
entrare, tuttavia, c’è anche chi non vuole entrare e si preclude consapevolmente questa strada, ed è
costretto, poi, a gettarsi subito nel mare dell’Essere senza avere, una volta entrato nella sua
immensità, la possibilità di conoscerlo, questo mi sembra il caso di Heidegger. Fuori di metafora, si
può fare a meno di cercare di entrare dentro di noi, se siamo noi che cerchiamo?
Vorrei fare a questo punto l’elogio dell’analisi della soggettività, che attraversa la filosofia
occidentale, perché l’essere umano è l’unico essere che sia capace di conoscere se stesso, di essere
contemporaneamente soggetto e oggetto d’indagine, anche se questo appare un "paradosso", come
costatava Husserl2. Allora, accettiamo il paradosso e sfruttiamo le possibilità che ci offre: iniziamo
da noi stessi per uscire da noi ed immergerci consapevolmente nel mare della realtà,
conquistandone progressivamente porzioni limitate, ma sicure. D’altra parte, non siamo mai al di
fuori dell’abisso, sia quello che è in noi, sempre secondo il detto di Eraclito, citato a questo
proposito da Husserl3, sia quello che è fuori di noi la cui conoscenza ci spinge sempre a reiterare la
ricerca in un continuo immer wieder. Questo perché, come siamo piccoli in un universo fisico
immenso, così è inesauribile ciò che possiamo conoscere con le nostre capacità
intellettuali/spirituali che ci conducono anche a superare la fisicità e ad entrare nel regno del “tutto”.
In fondo, in termini filosofici “classici” siamo risospinti, se vogliamo razionalizzare tutto ciò,
alle questioni gnoseologiche: come conosco? A quelle antropologiche: attraverso la conoscenza di
me stesso, posso scoprire come sono fatto? A quelle metafisiche: perché mi pongo i problemi ultimi
e sommi, pur avendo coscienza della mia finitezza?
La fenomenologia classica, quella di Husserl, in realtà, si pone tali interrogativi con
un’interessante novità di approccio. La Stein lo segue per un tratto del suo cammino, ma, in seguito,
accetta esplicitamente di fare i conti con tutta la storia della filosofia occidentale e si accorge che
tali questioni sono state affrontate nel passato e che alcune risposte, pur nell’inevitabile parzialità
legata all’essere umano finito, sono convincenti, perché colgono il senso di alcuni aspetti della
realtà. In questo caso, il termine “classico” riguarda la ripresa della componente non solo critica, ma
anche costruttiva del pensiero occidentale, pensiero sempre oscillante fra i due momenti della
criticità e della costruttività, tra i quali raramente riesce ad assumere un atteggiamento equilibrato.
2. Come avviene la conoscenza?
Ritengo che la novità della fenomenologia di Husserl risieda nell’analisi di particolari fenomeni,
quelli relativi alle nostre esperienze vissute. L’incontro del matematico Husserl con la psicologia
durante la frequenza delle lezioni di Franz Brentano a Vienna negli anni 1884 e 1885 sposta il suo
interesse verso ciò che accade nell’interiorità umana; tuttavia, non si tratta solo di analizzare i
fenomeni psichici, come faceva il filosofo viennese, esaminandoli secondo la loro qualità e secondo
la loro legalità, ma di ricostruire una mappa della struttura conoscitiva umana entrando in un
territorio ancora inesplorato, quello degli Erlebnisse, cioè degli atti da noi vissuti, non senza aver
compiuto prima un rivolgimento fondamentale dall’atteggiamento puramente naturale a quello
squisitamente filosofico.
Tale cambiamento si realizza, com’è noto, attraverso l’epoché, come operazione preliminare alla
scoperta dell’essenza o del senso delle “cose” (Sachen) e fra queste, operando un rivolgimento
dall’esterno all’interno, anche ciò che noi viviamo, i nostri Erlebnisse, approssimativamente tradotti
in italiano con il termine “vissuti” (abbreviando l’espressione: “ciò che è da noi vissuto”) o
introducendo un neologismo mutuato dalle lingue iberiche “vivenze” (vivências), come suggeriva
Ortega Y Gasset.
1
Stein (1993).
Husserl (1986), § 53.
3
«I confini dell’anima vai e non li trovi, anche a percorrere tutte le strade: così profondo è il Logo che essa
comporta» (Fr. 45 DK).
2
177
�Angela Ales Bello
Le vivenze sono caratterizzate, come già sosteneva Brentano a proposito dei fenomeni psichici
riprendendo un’antica tradizione medievale, dall’intenzionalità e costituiscono insiemi omogenei
dal punto di vista della qualità; pertanto, possono essere raggruppati come riguardanti il corpo
(Leib) – ad esempio la percezione legata di volta in volta alle sensazioni di tipo tattile, visivo,
uditivo e così via – la psiche (Psyche) – costituita dagli impulsi, dalle tensioni, dalle reazioni – e lo
spirito (Geist) – caratterizzato dagli atti intellettuali e volontari specificamente umani. Ciò consente
di risolvere un doppio problema, quello gnoseologico e quello antropologico. Riguardo al primo,
Husserl rivisita il tema kantiano del trascendentale, costituito dalla struttura essenziale delle stesse
vivenze, che fanno capo all’Io preso della sua purezza e si specificano di volta in volta all’interno di
una singolarità umana. Riconosco la gioia dell’altro, afferma Edith Stein, cogliendolo attraverso la
vivenza dell’entropatia (Einfühlung) e riconoscendolo come simile a me, perché ci accomuna
l’essenza della gioia, ma non posso vivere il contenuto e le sfumature della sua gioia, tutto ciò
rimane assolutamente connesso con la sua singolarità; è vero che mi posso avvicinare a lui o a lei
con un atto di simpatia, che non è empatia, per comprendere meglio, ma non potrò mai vivere la sua
“gioia”.
La struttura trascendentale non si ferma a ciò che abbiamo sommariamente indicato, ma sia apre
a dimensioni di cui non abbiamo coscienza, che viviamo in modo unbewusst, inconscio, dice
Husserl. Dalle Idee per una fenomenologia pura e una filosofia fenomenologica (1913)4, passando
per le Lezioni sulla sintesi passiva (1925)5 si approda alle analisi ora contenute nel volume
Grenzprobleme der Phänomenologie6, pubblicato nel 2013, che raccoglie testi scritti husserliani dal
1908 al 1937, su temi, quali l’inconscio, appunto, l’istinto, la metafisica e l’etica. Come si può
notare, questo scavo in dimensioni profonde non si manifesta solo dagli anni Trenta – anche se i
testi più significati sono di quegli anni – ma è presente fin dagli inizi della ricerca di Husserl;
inoltre, egli procede dal “sottosuolo”, direbbe la Stein, ai vertici intellettuali delle questioni
metafisiche e delle questioni etiche. I curatori del volume, Rochus Sowa e Thomas Vongher,
scrivono nella loro Introduzione che in questi testi la sfera dell’impulso e dell’istinto è tenuta
presente da Husserl, accanto alla sfera della ragione anche riguardo alle questioni etico-religiose7,
cosa che, sulla base di questi manoscritti, da me in parte letti nell’Archivio di Lovanio, avevo
cercato di mostrare nella mia piccola antologia Husserl. Sul problema di Dio8 pubblicata nel 1985.
3. Antropologia fenomenologica e le scienze umane
L’ampiezza delle analisi husserliane consente di dare un fondamento all’antropologia filosofia
ricostruendo la mappa complessa dell’essere umano. Egli non avrebbe accettato il termine
“antropologia”, perché compromesso con l’impostazione positivista che intendeva l’antropologia
come scienza naturale9. Sono stati Max Scheler e Edith Stein che hanno dato ad esso una valenza
filosofica. La Stein nella sua fase fenomenologica contribuisce in modo determinante alla
delineazione dell’umano, seguendo le indicazioni del maestro. Ma già Husserl aveva proposto
quella che egli definiva semplicemente la sua fenomenologia come una base teorica per tutte le
discipline che si erano separate dal grande tronco della filosofia a partire dall’Età Moderna. Questo
impegno, che si potrebbe definire epistemologico, era al centro degli interessi di Husserl e della
Stein. Mentre ella era maggiormente interessata alle discipline umanistiche, il maestro spaziava
dalle cosiddette scienze dello spirito alla psicologia, alla storia, ma anche alla matematica, in
particolare alla geometria, alle scienze fisiche, come dimostrano le sue ultime conferenze, confluite
nella Crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale10.
4
Husserl (2002).
Husserl (2016).
6
Husserl (2013).
7
Ivi, p. LXXXVII.
8
Ales Bello (1985a).
9
Ales Bello (2015).
10
Ales Bello (1982).
5
178
�Il valore teoretico della fenomenologia “classica” di Edmund Husserl ed Edith Stein
Sappiamo, d’altra parte, che dopo Husserl, molte scienze si sono riferite alla fenomenologia. Uno
dei filoni più interessanti è rappresentato dalle ricerche nel campo della psicologia e della
psicopatologia che hanno consentito di elaborare una psicologia fenomenologica, ma soprattutto
una psicopatologia fenomenologica. In tutto ciò non è ora estraneo il contributo della Stein. Il
rapporto di Husserl con la psicologia è documentato in tutto l’arco della sua indagine, come ho
messo in evidenza nel mio libro Il senso dell’umano11. Egli, riferendosi al processo fenomenologico
di progressiva “riduzione trascendentale” che conduce alla soggettività, indica alcune “vie”. La
prima che egli percorre è quella che definisce “via cartesiana” condotta in riferimento al cogito di
Cartesio, dal quale, però, si distingue per diverse ragioni: l’ampliamento della sfera delle esperienze
vissute che comprendono dimensioni, quali quella psichica solo accennate in Cartesio, o il dubbio
sull’esistenza del mondo che è da Husserl sostituito con la messa tra parentesi, solo provvisoria,
dell’esistenza, perché egli sostiene che non è in nostro potere dubitare di essa12.
Tuttavia, non sono solo le cogitationes cartesiane ad aver sollecitato l’indagine sulle vivenze; al
contrario, come si è visto, sono proprio i fenomeni psichici ad aver indicato una via per entrare nella
soggettività e ciò è accettato da Husserl, quando con insistenza si riferisce ad una via attraverso la
psicologia. L’intento non è quello di giungere a elaborare una psicologia, ma di fornire a questa
nuova scienza una base teorica stabile. D’altra parte, il territorio analizzato è sempre quello della
soggettività umana. Dopo aver cercato già nel 1917 di proporre una psicologia razionale apriori che
avrebbe dovuto svolgere per la psicologia lo stesso ruolo che la geometria pura svolge per le scienze
della natura, nelle Conferenze di Amsterdam13 descrive il triplice compito di una psicologia
descrittiva che dovrebbe fare da ponte fra l’antropologia come scienza della natura e la biologia e la
vera e propria psicologia la quale, in primo luogo, cerca l’essenza dei fenomeni psichici, in secondo
luogo, elabora tipologie e, infine, analizza il rapporto fra la dimensione corporea e quella spirituale.
È quello che definisco il terzo momento di riflessione sulla psicologia che mi sembra più
significativo, perché l’accostamento fra fenomenologia e psicologia diventa sempre più stretto;
infatti, soprattutto nella Crisi delle scienze europee, citando solo l’opera più nota e non tutta una
serie di manoscritti in corso di pubblicazione, appare un risultato che Husserl stesso dichiara
“sorprendente”, cioè la straordinaria affinità, addirittura identificazione fra la psicologia “pura” e la
fenomenologia trascendentale. Tuttavia, è opportuno tenere conto di una sostanziale distinzione, nel
senso che, se lo psicologo – e Husserl assume per il momento questo ruolo – accetta l’analisi
fenomenologica delle “vivenze” come indispensabile per la sua indagine, diventa fenomenologo,
ma un fenomenologo che poi si lascia guidare da questo bagaglio teorico per la sua azione nel
mondo in relazione a singoli esseri umani e, Husserl aggiunge, anche agli animali.
In tale proposta teoretica egli era già stato affiancato dalla sua discepola Edith Stein, la quale non
solo trascrive un testo di Husserl sul rapporto psicologia e fenomenologia del 1917 14, ma nel 1922
in Psicologia e scienze dello spirito. Contributi per una fondazione filosofica15, procede ad una
dettagliata analisi della psiche. Il merito di Edith Stein è di aver reso disponibili le indagini
sull’empatia e sulla psiche in lavori unitari e ben organizzati; il procedimento analitico e i risultati
sono quelli già proposti da Husserl, ma egli li aveva lasciati dispersi in molti scritti privati o nelle
sue lezioni e, quindi, non facilmente consultabili, mentre i lavori della Stein mettono insieme in
modo organico il materiale, certamente anche da lei personalmente elaborato, e ciò rende
maggiormente fruibili i contenuti. Si pensi alla questione dell’empatia, di sicura ascendenza
husserliana,16 che ella propone nella sua dissertazione di dottorato, Il problema dell’empatia e le
analisi indubbiamente da lei ulteriormente approfondite sulla struttura essenziale dei fenomeni
psichici, cosa che mi ha consentito recentemente di partecipare all’Oxford Handbook of
11
Ales Bello (2016a).
Husserl (2002), vol. I, § 31.
13
Husserl (1988).
14
Stein (2014).
15
Stein (1998).
16
Salato (ed.) (2016).
12
179
�Angela Ales Bello
Phenomenological Psychopathology con un contributo su The Role of Psychology According to
Edith Stein17.
A questo proposito è opportuno notare che certamente esiste una scuola di psicologia
fenomenologica, che si è costituita con Husserl e subito dopo Husserl in Germania 18, ma ora è
fiorente a mio avviso soprattutto in Brasile, grazie all’opera di diffusione del pensiero di Husserl e
soprattutto della Stein che mi è stato possibile realizzare negli ultimi venti anni19. Tuttavia, è nel
campo della psicopatologia che la fenomenologia, questa volta quella husserliana, ha avuto il suo
sviluppo più significativo, grazie all’opera di Ludwig Binswanger20. Si sono costituite scuole in
Italia, in Francia, in Germania ed anche nel Continente americano. L’analisi dei processi che
strutturano l’esser umano sono un indispensabile presupposto per la comprensione di un mondo
“altro”, quello del depresso, del maniacale, dello psicotico, mondo da comprendere nella sua alterità
e da accogliere come un possibile mondo “come se”, ma sempre “umano”. In particolare, si può
ricordare l’opera e l’azione di alcuni nostri psicopatologi d’impostazione fenomenologica, quali,
Bruno Callieri, Lorenzo Calvi e Arnaldo Ballerini21.
Recentemente è diventato fecondo il dialogo con le altre proposte nel campo della psicopatologia
soprattutto quella freudiana e jungiana. D’altra parte, lo stesso Binswanger, il quale proveniva da
una formazione psicoanalitica, se ne discosta, perché ritiene più convincenti le analisi
fenomenologiche. Il nodo che rimane da sciogliere è quello concernente il valore delle dimensioni
profonde della psiche, certamente messe in evidenza di Freud attraverso il suo inconscio, ma non
considerato da Binswanger come determinante ogni atto umano e come causa dei processi
patologici.
Come si è accennato sopra – d’altra parte, era noto a chi aveva frequentato l’Archivio di Lovanio
–, il recente volume della Husserliana, che ora li contiene, Grenzprobleme der Phänomenologie,
consente a tutti coloro che vogliono approfondire questo aspetto della ricerca di Husserl, di
comprendere che cosa egli intendesse con il termine Unbewusstsein, cioè la non-coscienza. Husserl,
come si detto, ha iniziato la sua indagine dagli Erlebnisse di cui abbiamo coscienza movendo dalla
percezione, ma il suo lavoro di scavo ha raggiunto un territorio, quello delle sintesi passive,
riguardanti la costituzione delle cose fisiche, da cui siamo “affetti” e ancora i fenomeni
dell’associazione riproduttiva, quelli dell’attesa, della delusione, del dubbio, che hanno le loro
radici in una dimensione di cui non abbiamo immediatamente coscienza, ma che possiamo scoprire
e, quindi, portare a coscienza.
Nell’opera Grenzprobleme Husserl segue diverse piste: quella dello svolgimento temporale di
situazioni quali la nascita, la morte, l’essere desti e il dormire, quindi i fenomeni delle
sedimentazioni e del ridestamento, quella degli istinti e della loro dell’inibizione e continenza.
Infine, come ho accennato, le questioni metafisiche. Nei primi due percorsi si tratta di un doppio
passaggio da ciò che è inconscio alla coscienza e dalla coscienza all’inconscio, questo transito si
manifesta all’inizio e alla fine della vita umana, nelle fasi di veglia e di sonno e nei casi in cui
appare un impulso ed è represso, inibito. Quest’ultimo caso è quello che Husserl ritiene
maggiormente legato alla psicoanalisi di Freud, che egli cita espressamente nel suo studio
sull’istinto.22
Non solo il campo della psicologia, ma, com’è noto, anche in quello della sociologia movendo
da Alfred Schütz, si è costituita una scuola fenomenologica, grazie alle indagini di Husserl e di
alcune esponenti della sua scuola sui temi della comunità e della società, mi riferisco a Edith Stein e
17
Si tratta della Sezione dedicata alla Psicopatologia dell’Oxford Handbook Online 2018.
Una sintesi delle scuole più importanti si trova nel mio Ales Bello (2016a), Cap. I, § 5.
19
Mahfoud, Massimi (eds.) (2013), contiene diciassette saggi di psicologi brasiliani.
20
Ho dedicato il Cap. I, parte II di Ales Bello (2016a) a «I disturbi della psiche. La psicopatologia fenomenologica
di Ludwig Binswanger».
21
Si veda Ales Bello, Ballerini, Borgna, Calvi (2008). Una sezione del Centro Italiano di Ricerche
Fenomenologiche, che dirigo, è dedicata a “Fenomenologia e Psicopatologia”, con particolare riferimento alla scuola di
psicopatologia fenomenologica italiana rappresentata dai pensatori citati.
22
Husserl (2013), pp. 113, 126.
18
180
�Il valore teoretico della fenomenologia “classica” di Edmund Husserl ed Edith Stein
a Gerda Walther.23 Utilizzare le loro analisi da parte di chi s’interessa di sociologia sarebbe, a mio
avviso, molto proficuo, come lo è stato nel campo delle indagini sul senso delle associazioni umane
nelle loro configurazioni giuridiche; ciò accade nell’ambito della Filosofia del Diritto per opera di
Luisa Avitabile, che dirige il Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici
dell’Università “La Sapienza” di Roma.
4. Fenomenologia della religione e questione dell’Assoluto
Nel campo della fenomenologia della religione l’apporto di Husserl è stato riconosciuto da uno dei
suoi fondatori, Gerardus van der Leeuw, nel suo libro Fenomenologia della religione24, in cui egli
s’ispira alle analisi husserliane per applicare il metodo al “fenomeno” religioso, così com’è vissuto
dall’essere umano. Si tratta di un’indagine che non affronta immediatamente la questione di Dio,
piuttosto, il modo in cui noi umani ci poniamo in relazione a qualcosa d’Altro che cerchiamo come
un possibile riempimento di un’aspettativa, mai soddisfatta da ciò che è finito. E la questione, che
subito si pone, è quella che si riferisce alla nostra costituzione umana, in sostanza, la questione
antropologica; quest’ultima, com’è importante per la psicologia e per le scienze umane, così lo è per
la comprensione dell’esperienza religiosa. Ritengo che nella descrizione dell’essere umano, già
condotta da Husserl, la Stein abbia aggiunto un suo contributo fondamentale, domandandosi quale
sia il senso della nostra singolarità e dove rintracciare il momento identitario che ci accompagna per
tutta la vita.
Ella ha ci ha invitato a riflettere sul sentire la nostra permanenza nonostante il passare del tempo
e ciò ci rimanda, a suo avviso, ad un “nucleo” (Kern) che è la sede delle indicazioni profonde del
nostro cammino esistenziale. E tale nucleo è anche il centro della consapevolezza del nostro essere
finiti e se ci definiamo in tal modo, ciò significa che cogliamo anche che si dà qualcosa d’infinto,
misura della nostra finitezza. Ciò non è sostenuto espressamente di Husserl, ma egli accetta che
siamo consapevoli che «ci devono essere nella corrente assoluta della coscienza e nelle sue serie
infinite altri modi di annunciarsi delle trascendenze […] un annunciarsi di ordine intuitivo, al quale
il pensiero teoretico potrebbe adattarsi e seguendolo razionalmente rendere intellegibile la potenza
unitaria del supposto principio teologico».25
Questo testo husserliano si presta ad una duplice lettura di carattere filosofico-fenomenologico:
come analisi della presenza in noi dell’apertura al divino e come indagine teoretica sul principio
teologico. Si tratta in quest’ultimo caso del Dio dei filosofi, quindi di una sorta di “prova” teoretica
– anche se ciò è lontano dall’intenzione husserliana, infatti egli non vuole dimostrare che Dio esiste,
semplicemente sta descrivendo come si giunge al divino, anzi come sia necessario pervenire ad
esso.
Nella direzione dell’analisi della presenza in noi dell’apertura verso l’Altro, si può – e ho tentato
di farlo – utilizzare tutto ciò per elaborare una “fenomenologia della religione” che si pone nei
confronti della storia delle religioni, come in fondo ci suggerisce van der Leeuw, una domanda
radicale: perché tante religioni che sono sempre “religione”, che cosa dà l’unità a tale diversità?26
L’unità è da ricercarsi nell’umano e nella sua struttura antropologica, la pluralità nelle differenti
manifestazioni e configurazioni di tale esperienza che dicono del divino cose diverse, ma lo intendo
sempre come qualcosa che è potente e che «viene incontro sulla strada di ogni essere umano», come
dice van der Leeuw. Egli ammette anche che qualcosa può sbarrare tale strada ed evoca l’immagine
dell’angelo con la spada fiammeggiante, questo è l’atteggiamento di chi nega l’apertura verso
l’Altro e la conseguente esistenza dell’Altro. Il fatto, poi, che ci si rifugi in altre potenze, che si
assolutizzino di volta in volta altre esperienze, dimostra che, se ne sia consapevoli o no, l’apertura a
23
Stein, Walther (2014).
Van der Leeuw (2017).
25
Husserl (2002), I vol., p. 127.
26
A partire dalle analisi husserliane sul divino (The Divine in Husserl and Other Explorations) ho proposto una
fenomenologia della religione, che si allarga all’analisi delle religioni per comprenderne l’intima struttura, in Ales Bello
(2014).
24
181
�Angela Ales Bello
una Potenza è strutturale. Ma lo scambio fra la Potenza del divino e la Potenza di cose finite
assolutizzate non mette in crisi l’esistenza di un’apertura e l’esigenza dell’Assoluto.
All’assolutezza della Potenza, che è il punto d’arrivo dell’esperienza religiosa, corrisponde
l’assolutezza del “principio teologico”, quello che si può definire un “pensare” Dio parallelo al
“credere” in Dio. Dal punto di vista del “pensare”, ho ritracciato alcuni percorsi husserliani che
conducono a Dio sparsi nelle sue opere e spesso nei suoi manoscritti: la via “oggettiva”, che muove
dalla teleologia delle cose fisiche e morali, quella soggettiva, già indicata nelle “correnti di
coscienza”, quella intersoggettiva, che s’ispira alla monadologia leibniziana, quella “hyletica” che
muove dalla profondità della vita istintiva e impulsiva la quale rivela una sua peculiare teleologia
(in quest’ultimo caso siamo risospinti alla questione della dimensione in-conscia, cui si faceva
riferimento prima), infine quella etica, che muove dalla questione della presenza del bene e del
male27. Dietro a Husserl, e raramente egli si riferisce ad esse, si stagliano le grandi ombre dei
filosofi del passato: da Anselmo a Tommaso d’Aquino, da Leibinz a Kant e a Fichte.
In molti altri luoghi la questione di Dio è trattata da Husserl; in particolare, ho già fatto
riferimento ai testi contenuti nei Grenzprobleme. Si può citare in modo emblematico il testo Nr.19
Absolute Teleologie del 1934, nel quale molte delle sue argomentazioni su Dio sono riprese da un
punto di vista teoretico e pratico: qui si parla di assoluto Logos che è assoluta verità, come un polo
ideale, che non si esaurisce in un’idealità perché ad esso corrisponde una Realtà (Wirklichkeit), anzi
una Sopra-realtà (Überwirklichkeit) ed è caratterizzato dall’unum, verum, bonum che ricordano i
trascendentali medievali. Pertanto, si può osservare che il termine trascendentale, anche in Husserl
come in Stein, mantiene i legami sia con la filosofia moderna, in particolare quella kantiana, inteso
come struttura della soggettività, sia con la filosofia medievale che lo aveva declinato come legato
al tema dell’essere. Husserl non parla dell’essere, piuttosto si riferisce al Logos, definendolo come
“tutto l’essente vero”28 e facendo esplicito riferimento, nel testo in esame, alla filosofia platonica.
Le brevi e non esaustive incursioni in alcuni campi del sapere, in cui la fenomenologia ha dato e
sta dando il suo contributo, ne attestano la fecondità. E, lasciandosi guidare dal tema generale che
accomuna i saggi presenti in questo numero del Bollettino Filosofico, si è cercato di mostrare che
l’importanza teoretica della fenomenologia, che ho definito classica, consente di giustificare perché
si accetti l’impostazione fenomenologica da un punto di vista filosofico e come sia possibile
proseguire, seguendo le indicazioni metodologiche proposte da Husserl e dalla Stein. In questa
direzione si mostra perché si può stare “con” la fenomenologia.
Si è visto che la valenza teoretica della fenomenologia si esercita proficuamente soprattutto in
quei campi della ricerca che riguardano l’umano, grazie alle analisi antropologiche che
costituiscono un necessario fondamento per procedere ad indagare le specifiche produzioni
culturali. L’“oltre” della fenomenologia è, quindi, rappresentato dalla prosecuzione sia sul piano
squisitamente filosofico sia sul piano delle molteplici prospettive del sapere. L’inesauribilità della
ricerca impedisce che si rimanga staticamente ancorati ad un pensiero unico, ma ciò non vuol dire
che alcuni contributi che sono stati dati dai pensatori del passato non siano ancora convincenti per la
chiarificazione delle questioni che l’essere umano si pone ed alcuni lo sono più di altri proprio in
vista di una sempre più approfondita, anche se inesauribile, esplicitazione del “senso” della realtà.
Bibliografia
Ales Bello, A. (19822), Husserl e le scienze, La Goliardica Editrice, Roma.
Ales Bello, A. (1985a), Husserl. Sul problema di Dio, Studium, Roma.
Ales Bello, A. (1985b), Edmund Husserl. Pensare Dio, Credere in Dio, Edizioni del Messaggero di
Padova, Padova.
27
Ales Bello (1985b). Il libro è stato tradotto in lingua inglese (2016b), in spagnolo (2016c) e in portoghese
(2016d).
28
Husserl (2013), pp. 250-251.
182
�Il valore teoretico della fenomenologia “classica” di Edmund Husserl ed Edith Stein
Ales Bello, A. (2014), Il senso del sacro. Dall’arcaicità alla desacralizzazione, Castelvecchi,
Roma.
Ales Bello, A. (2015), I presupposti dell’idea di persona, in Ales Bello, A.; Zippel, N. (ed.),
Ripensando l’umano – In dialogo con Edith Stein, Castelvecchi, Roma, pp. 17-36.
Ales Bello, A. (2016a), Il senso dell’umano. Tra fenomenologia, psicologia e psicopatologia,
Castelvecchi, Roma.
Ales Bello, A. (2016b), The Divine in Husserl and Other Explorations, Springer, Dordrecht.
Ales Bello, A. (2016c), Edmund Husserl. Pensar Dios, creer en Dios, Editorial Biblios, Buenos
Aires.
Ales Bello, A. (2016d), Edmund Husserl. Pensar Deus, crer em Deus, Paulus, São Paulo.
Ales Bello, A.-Ballerini, A.-Borgna, E.-Calvi, L. (2008), Io e Tu – Fenomenologia dell’incontro, in
G. Di Petta (ed.), Omaggio al Prof. Bruno Callieri per il suo LXXXV anno, Edizioni
Universitarie Romane, Roma.
Husserl, E. (1986), La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, trad. it. a cura
di E. Filippini, il Saggiatore, Milano.
Husserl, E. (1988), Conferenze di Amsterdam: psicologia fenomenologica e fenomenologia
trascendentale, trad. it. a cura di P. Polizzi, Ila-Palma, Palermo.
Husserl, E. (2002), Idee per una fenomenologia pura e una filosofia fenomenologica, trad. it. a cura
di V. Costa, 2 voll., Nuova Edizione, Einaudi, Torino.
Husserl, E. (2013), Grenzprobleme der Phänomenologie. Analysen des Unbewusstseins und der
Instinkte. Metaphysik. Späte Ethik (1908-1937), hrsg. von R. Sowa und Th. Vongehr,
Husserliana, Bd. XLII, Springer, Dordrecht.
Husserl, E. (2016), Lezioni sulla sintesi passiva, trad. it. a cura di Vincenzo Costa, La Scuola,
Brescia.
Mahfoud, M.-Massimi, M. (eds.) (2013), Edith Stein e a Psicologia. Teoria e Pesquisa, Prefácio de
A. Ales Bello, Artesã, Belo Horizonte, MG, Brasil.
Salato, N. (ed.) (2016), L’Einfühlung fra Edmund Husserl e Edith Stein, in Id., Fenomenologia
dell’Einfühlung. Studi su Edith Stein (Le Forme del Discorso, 7), Diogene Edizioni,
Campobasso, pp. 17-33.
Stein, E. (1993), La filosofia esistenziale di Martin Heidegger, trad. it. a cura di A. M. Pezzella, in
Id., La ricerca della verità – dalla fenomenologia alla filosofia cristiana, a cura di A. Ales Bello,
Città Nuova, Roma, pp. 153-226.
Stein, E. (1998), Psicologia e scienze dello spirito. Contributi per una fondazione filosofica, trad. it.
a cura di A. M. Pezzella, Prefazione di A. Ales Bello, Città Nuova, Roma.
Stein, E. (2014), Edmund Husserl: Phänomenologie und Psychologie. Ausarbeitung von Edith Stein
in «Freiheit und Gnade» und weitere Beiträge zu Phänomenologie und Ontologie (1917-1937),
ESGA 9, Herder, Freiburg.
Stein, E.-Walther, G. (2014), Incontri possibili. Empatia, Telepatia, Comunità, Mistica, a cura di A.
Ales Bello, M. P. Pellegrino, Castelvecchi, Roma.
van der Leeuw, G. (2017), Fenomenologia della religione, trad. it. a cura di V. Vacca, Prefazione di
A. Di Nola, Bollati Boringhieri, Torino.
Abstract
The so-called “classical” phenomenology is the position of the founder of the phenomenological
movement, Edmund Husserl and of his faithful disciple Edith Stein. Other direct or indirect
disciples could also be included but, in my opinion, the most distinctive feature of the classical
position is the Husserlian analysis of the human subject as a starting point for the examination of
reality. In the first part of my paper I show that such an analysis was already done by the modern
philosophers, but Husserl was the one who was able to go to the “thing in itself”. What is at stakes
in the discussion is the meaning of philosophy itself, namely that kind of human research aiming at
183
�Angela Ales Bello
an understanding of what manifests itself to us and presses us to give an answer. In the second part
of my paper, I deal with the application of phenomenological analysis to the field of human
sciences, showing that Husserl’s and Stein’s intention was to supply with basic indications on the
structure of the human the researchers involved in field such as psychology, psychopathology,
sociology and religion.
Keywords: Classical phenomenology, Humanities, Phenomenological Philosophy, Subjectivity,
Theory of Knowledge
184
�DANIELE DE SANTIS*
Le conclusioni della filosofia del conoscere
Appunti sul programma “razionalista” di Husserl e Bontadini
1. Introduzione, ovvero: la “conclusione” a mo’ di inizio
La conclusione della filosofia del conoscere è il titolo di un noto volume che Guido Calogero diede
alle stampe nel 1938 e che ripropone alcuni tra i suoi più cruciali scritti sull’idealismo italiano (con
in aggiunta un’appendice dal titolo: Per una storia della logica). Come Calogero medesimo ebbe a
precisare nell’avvertenza che accompagna la raccolta: chiunque, leggendo il volume, «scoprisse qui
qualcosa come una crisi o una palinodia o una catastrofe», credendo così di trovare «nuovo indizio
di una sedicente “crisi dell’idealismo”», tale lettore «dimostrerebbe di aver letto, del libro, soltanto
il titolo, e di non avere di conseguenza capito nemmeno quello»1. Senza penetrare nel fitto tessuto
speculativo che si articola lungo i saggi raccolti nella prima metà del volume (in particolare nei
primi due: «Coscienza e volontà», «Gnoseologia e idealismo»), e sforzandoci con questo di ridurne
la tesi all’essenziale2, si potrebbe affermare – con una serie di battute sì fortemente icastiche ma per
questo tanto più in grado di afferrare il “nocciolo” profondo dell’argomentare calogeriano – che
l’idealismo gentiliano, avendo superato il problema gnoseologico per eccellenza, cioè «il binomio
del soggetto e dell’oggetto»3, ha posto fine alla «gnoseologia», cioè a tutta quella filosofia che –
identificando nella «conoscenza» il proprio nucleo problematico e pungolo speculativo – è filosofia
del conoscere sic et simpliciter. Risolto il dramma gnoseologico, la filosofia del conoscere può
dunque dirsi conclusa – nel duplice senso per cui qualcosa termina avendo per l’appunto concluso,
adempiendolo, il proprio compito. Che una tale «filosofia del conoscere» (la quale, come
espressione, assume il valore di vera e propria catacresi) si identifichi con quella che comunemente
si dice «storia della filosofia moderna» in tutta la sua estensione (tanto cronologica quanto
speculativa) è Calogero stesso a confermarlo, con ciò esprimendo quello che fu un vero e proprio
locus classicus dell’idealismo attuale:
L’attualismo ha potuto, così, agevolmente mostrare come il suo principio gnoseologico [«niente può mai
essermi dato che non sia dato a me»4] non sia che la più avanzata e coerente manifestazione di tutto il
soggettivismo moderno: come anzi l’intero sviluppo della filosofia dell’essere e del conoscere non sia
comprensibile se non nell’aspetto di un graduale progresso verso quell’assoluto soggettivismo, via via
liberantesi dalle innumerevoli forme dell’oggettivazione realistica, prima del mondo e poi dell’io.5
Nell’idealismo è superato «l’eterno dualismo implicito, con maggiore o minore consapevolezza, in
ogni dottrina gnoseologica» 6 . Non è necessario qui ripercorrere le molte difficili pagine che
Calogero scrive tentando di dimostrare come – aporeticamente – l’«eterno dualismo» tenda,
*
Università Carlo di Praga
1
Calogero (1938), p. xi.
Per una più ampia analisi, Visentin (2010), pp. 21-102. Si vedano in particolare le pp. 43-48.
3
Come scrive Calogero all’inizio di «Coscienza e volontà»: «Il problema della conoscenza non sembra possa porsi e
risolversi senza implicare, comunque, il binomio del soggetto e dell’oggetto: ma ciò vale solo finché non si consideri quel
più profondo soggetto, a cui ambedue quei termini sono presenti e che entrambi li svaluta. Quella suprema soggettività è
lo stesso pensiero che si pone il problema» (Calogero, 1938, p. 1).
4
Nelle parole dello stesso Gentile: «la realtà non è pensabile se non in relazione coll’attività pensante per cui è
pensabile» (Gentile, 2014, p. 77, Capitolo I: «La soggettività del reale»).
5
Calogero (1938), p. 26.
6
Ivi, p. 29.
2
Bollettino Filosofico 33 (2018): 185-207
ISSN 1593 -7178 - 00030
E-ISSN 2035 -2670
DOI 10.6093/1593-7178/5916
�Daniele De Santis
incessantemente, a riaffiorare anche dall’interno della cornice dell’attualismo 7. Lasciando a questo
punto che Calogero rappresenti, di queste pagine, lo sfondo tematico lontano - quel che ci preme
sottolineare è che fu proprio Gustavo Bontadini, il quale con l’idealismo attuale ebbe rapporti assai
complessi 8 , a fare uso sistematico di quell’espressione, “la conclusione della filosofia del
conoscere”, per caratterizzare il punto di partenza della sua personale riflessione metafisica. Come
scrive Bontadini:
un vero valore di risolvenza all’attualismo, se ci apparecchiamo a considerarlo serenamente, da storici e
non da polemisti impazienti, dobbiamo riconoscerlo. La risoluzione, voglio dire, del ciclo
gnoseologistico, che è poi il ciclo della filosofia moderna (se alla filosofia moderna si vuol riconoscere un
carattere unitario, al di sopra della dispersione dei motivi, di cui è stracarica), la risoluzione del problema
gnoseologico o critico, la conclusione, come disse Calogero, della filosofia del conoscere.9
Che la conclusione della filosofia del conoscere sia, o possa rappresentare, un “nuovo inizio” per la
“metafisica”, è tesi centrale e piuttosto nota della speculazione bontadiniana, che qui sarà bene
quindi riassumere solo con una serie di veloci battute10. Il “dramma” della filosofia moderna, vale a
dire di ogni filosofia del conoscere, non consta solo o semplicemente del dualismo di soggetto e
oggetto, ma dello sforzo, “drammatico”, che il primo compierebbe nel tentativo incessante di
raggiungere l’altro trascendendo costantemente se stesso. Il dramma sarebbe non tanto quello della
trascendenza, quanto piuttosto quello del trascendimento di se medesimo da parte del soggetto –
alle prese, esso, con una impossibile traversata, in tutto e per tutto analoga a quella drammatica
descritta in As I Lay Dying di William Faulkner. Il soggetto si trascende sì verso l’oggetto, ma
solamente come verso ciò che non gli appartiene e del quale non coglie che “rappresentazioni” –
l’oggetto, l’essere, sempre ritraendosi invece nel suo proprio “al di là”: The head of one mule
appears, its eyes wide; it looks back at us for an instant, making a sound almost human. The head
vanishes again11. L’attualismo supererebbe non semplicemente il dualismo di soggetto e oggetto,
quanto il suo “presupposto” – quello che Bontadini chiama «presupposto naturalistico» (vedremo in
che cosa questo consista): il soggetto scoprendosi di nuovo, al “termine” della filosofia del
conoscere, in contatto diretto con l’essere (non più mediato da “rappresentazioni” o “idee”). Questo
il motivo per cui Bontadini può parlare di uno «sfruttamento del risultato idealistico della filosofia
moderna per riaprire il problema di una metafisica dell’essere» 12 ; «la creatività idealistica del
pensiero», come lui stesso la chiama, non significa che «l’eliminazione della presupposizione
naturalistica» – l’idealismo rivelando così la sua identità con il realismo, cioè con la «semplice
affermazione della originaria intenzionalità ontologica del conoscere»: «Idealismo, adunque, e
realismo: coincidenza dei due. Idealismo, in quanto il pensiero non è meno dell’essere, ma, se fosse
lecito dire […] di più, cioè l’essere e la sua manifestazione. […] realismo perché codesto pensiero
[…] si riferisce immediatamente e formalmente all’essere»13.
7
Si veda in merito il bel volume di Zappoli (2011), in particolare le pp. 115-122 («Gnoseologia e idealismo»).
Per un’introduzione, limitata dal punto di vista speculativo ma utile in termini di riferimenti testuali, Cappuccio
(2015); per un serrato confronto sul piano teoretico, si veda Maschietti (2000).
9
Bontadini (1996b), p. 6.
10
«La tutela di questo risultato della speculazione moderna deve stare particolarmente a cuore proprio agli amici della
metafisica classica; appunto perché esso equivale ad intendere la conclusione della filosofia del conoscere come
riapertura della filosofia dell’essere (c.n.)», Bontadini (1971a), p. 93.
11
Faulkner (1990), p. 149.
12
Bontadini (1996b), p. 171.
13
Bontadini (1995), pp. 259-260. Volendo citare un passo gentiliano che possa supportare questa lezione
bontadiniana, si potrebbe pensare a questo: «Il quale soggetto aveva bisogno di uscire da sé per imbattersi nel positivo, ciò che poi non gli veniva fatto, - finché non fu consapevole del suo vero essere, che proiettava innanzi a sé, e fermava in
un’astratta realtà. Ma, acquistata che abbia la coscienza dell’intimità dell’essere a quello stesso atto con cui egli lo cerca,
lo spirito non vedrà più come si possa desiderare positività più certa e più salda di quella che ha in sé quando esso pensa e
si realizza» (Gentile, 2014, p. 171, «Teoria generale dello spirito come atto puro», Cap. VII, §12).
8
186
�Le conclusioni della filosofia del conoscere. Appunti sul programma “razionalista” di Husserl e Bontadini
Così tracciato, il percorso condurrebbe (seguendo la scansione dei titoli di alcune note raccolte di
scritti bontadiniani) dalla filosofia moderna alla sua “risoluzione” nell’idealismo attuale, il quale si
muterebbe, come spinto da interna esigenza, in problematicismo, per approdare poi alla metafisica.
E Husserl? Come e dove si situa il “padre della fenomenologia” all’interno della vicenda narrata
da Bontadini? Prima di rispondere a questa domanda, sarà bene avanzare una serie di osservazioni,
il cui scopo sarà di sgombrare il campo da alcuni possibili equivoci. Queste pagine non
presenteranno né una lettura “bontadiniana” (indifferentemente da ciò che una simile espressione
possa significare) di Husserl né un’interpretazione “husserliana”, o fenomenologica (nel senso di
Husserl), della teoresi di Bontadini. Molti sono i temi che – almeno a livello più superficiale, ma
non perciò meno importante, della consonanza terminologica – potrebbero avvicinare i due, o
almeno fornire il punto di attacco di uno studio comparativo: la questione della «fenomenologia»
come attestazione del “dato” nella sua «presenza» e quella dell’«intenzionalità»; l’espressione di
«unità dell’esperienza» (U.d.E.) la quale, cruciale per la lettura bontadiniana dell’atto puro di
Gentile 14 , si presenta tuttavia (almeno in quanto espressione: Einheit der Erfahrung) come di
provenienza kantiana15, ed è da Kant che Husserl stesso la riprende 16; la questione del fondamento e
14
Si veda Maschietti (1998). Per un’introduzione, Grion (2008), pp. 178-184 («Sull’U.d.E. come punto di partenza
del filosofare»); Vigna (2008), pp. 353-380. Vale la pena soffermarsi su questo aspetto per considerare la strategia
dell’esegesi bontadiniana dell’“atto” gentiliano. Punto cruciale della sua interpretazione è la separazione di ciò che
Bontadini considera la “verità gnoseologica dell’idealismo” (vale a dire il puro formalismo) da quella che è invece
considerata una sua tendenza “teologica” (identificata con la figura gentiliana dell’«autoconcetto»). Come è stato
osservato: «Da questa verità gnoseologica [il puro formalismo] l’idealismo ha però inferito un’errata conseguenza
ontologica, ovvero il potere creativo del pensiero non solo per quanto concerne la forma del conoscere, ma anche per
quanto riguarda la realtà ontica» (Grion, 2012, p. 113). Se abbiamo qui citato Grion (che rimanda esplicitamente al
capitolo XVI della Teoria generale) è perché egli ci sembra restituire molto fedelmente la posizione di Bontadini:
mantenere il formalismo assoluto, liberandolo da quel suo eccesso teologico (Grion stesso parla di «conseguenza»).
Quella che viene così presentata è non solo la lettura bontadiniana, ma la stessa argomentazione di Gentile (“dal
formalismo all’autoconcetto”). Se ci volgiamo alla Teoria generale non possiamo però non notare come il capitolo XVI
presenti, de facto, prima la nozione di autoconcetto (§2), il suo valore metafisico (§3), quindi il formalismo assoluto (§4).
La sequenza è diametralmente opposta a quella di Bontadini. Al di là dell’aspetto fattuale, Gentile stesso scrive che «la
nostra dottrina […] mette capo a due concetti, che si possono considerare l’uno il primo principio e l’altro l’ultimo
termine della dottrina stessa»; e se tale “primo principio” è proprio «il concetto come autoconcetto», il “formalismo
assoluto” è «la mèta a cui guarda tutta la nostra dottrina» (Gentile, 2014, pp. 292-294). In altre parole, il formalismo è
conseguenza della teoria del concetto come autoconcetto; la pura forma non è guadagnata “svuotando” il soggetto di ogni
“determinazione” specifica ma, al contrario, assumendo a pieno proprio la sua valenza tetica: «La materia è posta e
risoluta dalla forma». È cioè la teticità del pensiero (che Bontadini considera come una conseguenza) a garantirne il puro
formalismo (e non il contrario): ci sembra proprio questo quello che Gentile sostiene nel §11 («Formalismo assoluto») del
capitolo IV («Concretezza del logo astratto») del testo La logica del concreto (si veda Gentile, 2014, pp. 627-629),
dedicato alla nozione kantiana di “forma”. Indipendentemente dal valore che si vorrà riconoscere all’esegesi di Bontadini,
essa sembra comunque basarsi su di un vero e proprio hysteron proteron ermeneutico.
15
Siamo nel cuore della prima edizione della deduzione trascendentale delle categorie: «Die wirkliche Erfahrung,
welche aus der Apprehension, der Assoziation (der Reproduktion), endlich der Rekognition der Erscheinungen besteht,
enthält in der letzteren und höchsten (der bloß empirischen Elemente der Erfahrung) Begriffe, welche die formale Einheit
der Erfahrung, und mit ihr alle objektive Gültigkeit (Wahrheit) der empirischen Erkenntnis möglich machen» (A124125). Si vedano anche inoltre le occorrenze alle pagine A158/B197; A180/B222; A206/B251; A216/B263; A229/B282.
Per un interessante riferimento bontadiniano a Kant e l’«unità dell’esperienza», si veda Bontadini (1966), p. 414
(«L’impianto gnoseologistico della Critica della ragion pura»).
16
Il termine riveste un ruolo importante in Husserl (1974), pp. 226, 398, così come in Husserl (1939), pp. 36, 300,
415-416). Citiamo solamente questi due testi che – ipoteticamente – Bontadini potrebbe aver conosciuto. Qui ovviamente
non vogliamo affermare nessun rapporto derivativo, ma segnalare delle analogie che andrebbero scandagliate più
seriamente. In queste pagine non si tenterà nessuna “ricostruzione” su base storico-filologica di quello che potrebbe
essere stato il rapporto tra Husserl e Bontadini. Dobbiamo però osservare che se è vero che «Bontadini non si è infatti mai
occupato in modo sistematico di Husserl, per quanto capiti di trovare, soprattutto nei suoi testi più recenti, alcuni
riferimenti al padre della fenomenologia contemporanea», il motivo non può semplicemente consistere nel fatto che «Il
pensiero di Husserl verrà infatti introdotto in Italia quando Bontadini avrà già pubblicato i suoi testi più significativi dal
punto di vista della propria teoria della conoscenza» (Grion, 2012, p. 105). Il riferimento non può essere solmente alla
prima monografia pubblicata su Husserl da Sofia Vanni Rovighi nel 1939 o al testo su Il cogito di Cartesio e il cogito di
Husserl (1937); l’introduzione di Husserl in Italia, da parte di Antonio Banfi con due articoli usciti sulla Rivista di
187
�Daniele De Santis
dell’esito “metafisico” della filosofia concepita come “filosofia prima” (che per Bontadini è la
stessa metafisica, la quale invece per Husserl si distingue radicalmente dalla prote philosophia,
identificandosi piuttosto con la «filosofia ultima»17). Accanto, o al di là di queste che potrebbero
sembrare solamente delle consonanze, si trova quello che forse è il maggiore, e più evidente, punto
di contatto tra i due: le loro rispettive interpretazioni della “storia della filosofia moderna” da
Cartesio a Kant. Qualcuno lo ha già ricordato, seppur fugacemente: «la sua lettura [di Bontadini]
coincide, almeno in un punto radicale, proprio con la lettura husserliana: mi riferisco al punto in cui
viene rimproverata a Cartesio […] la presupposizione dualistica della struttura cognitiva
dell’umano; la primarietà del pensiero, che è la grande scoperta del pensiero moderno; la pretesa,
cioè, di potersi interrogare se mai vi sia un qualcosa al di là del pensiero» 18.
È a questa “storia”, e alle sue due interpretazioni, che il presente testo vuole prestare attenzione.
Il nostro intento, tuttavia, non è quello di “confrontare” sistematicamente l’interpretazione
husserliana e quella bontadiniana della “filosofia del conoscere”. Diciamolo fin da adesso: questo
saggio è e vuole essere su Husserl19 – e si servirà di Bontadini e della sua interpretazione della
storia della filosofia moderna (quindi di eventuali analogie e differenze) solamente per meglio
comprendere la posizione husserliana e le “coordinate speculative” delle quali Husserl si serve. Al
centro si situerà la nozione di ragione o, meglio, di razionalità – che Husserl, come cercheremo di
mostrare, concepisce secondo una duplice, irriducibile, accezione, che come tale gli fornisce la
chiave per leggere le “vicende” della filosofia moderna. Ciò che è in gioco, nell’eventuale confronto
tra Husserl e Bontadini, sarebbe l’esito conclusivo della filosofia moderna, dunque ciò verso cui
essa apre o aprirebbe.
Iniziamo allora da un breve resoconto di quello che Bontadini afferma di Husserl nei suoi scritti.
2. Husserl secondo Bontadini
I vari contesti nei quali Bontadini parla – più che discutere – o menziona la fenomenologia di
Husserl sono facilmente identificabili: “tematicamente”, egli ne parla quasi esclusivamente in
riferimento al problema dell’intenzionalità; dal punto di vista “storico-filosofico”, invece, Husserl
interviene molto spesso quale “sfondo” a partire dal quale discutere alcuni sviluppi problematicisti
del suo pensiero, come ad esempio l’esistenzialismo; più in generale, Husserl e la sua
fenomenologia vengono sovente posti in rapporto con l’idealismo attuale. Sarà bene affermare sin
da subito che, nonostante non si possa parlare di un’“interpretazione bontadiniana” di Husserl,
quello che il filosofo milanese ne dice ha carattere altamente sistematico. Sarà bene dunque partire
discutendo dell’aspetto “tematico” che tanto sta a cuore a Bontadini: la nozione di intenzionalità.
Se in Metafisica e deellenizzazione il nome di Husserl appare solamente in nota (nella quale si fa
riferimento al «carattere intenzionale del pensiero» come aspetto in grado di conciliare l’idealismo e
il realismo 20 ), in una delle sue Conversazioni di metafisica Bontadini ricorda l’esegesi di Sofia
Vanni Rovighi dell’intenzionalità husserliana come di un’«intenzionalità ontologica del conoscere»
in cui è «risolto, nel suo lineamento di base, il problema gnoseologico» 21 . Husserl, sostiene
filosofia, data 1923: «La tendenza logicistica nella filosofia tedesca contemporanea e le Ricerche Logiche di Edmund
Husserl» (pp. 115-133); «La fenomenologia pura di E. Husserl e l’autonomia ideale della sfera teoretica» (pp. 208-224).
Ambedue gli articoli furono poi incorporati nell’opus magnum di Banfi del 1926, cioè I principi di una teoria della
ragione, Cap. VI, sezione §5.3 (La fenomenologia pura di Husserl). Si veda l’accenno fatto a Banfi in Bontadini (1996c),
p. 178.
17
Husserl (1956), p. 385.
18
V. Melchiorre durante la serie degli interventi riportati in Vigna (2008), p. 16.
19
Nel senso che quel che ci interessa primariamente è la comprensione di un aspetto importante del pensiero
husserliano, vale a dire la duplice nozione di razionalità sulla quale si insisterà a tempo debito.
20
Bontadini (1996d), p. 51.
21
Bontadini (1971b), pp. 9-57: p. 16. Si vedano le pagine sull’intenzionalità che nel suo volume vi dedica Vanni
Rovighi (1939) pp. 61-85. Come lei stessa scrive, in una serie di passi che bene esemplificano le affermazioni
bontadiniane: «Se io considero dunque la conoscenza come complesso di fatti psichici, di qualità del soggetto, non vedrò
mai perché essa mi metta in relazione con un altro, con un oggetto. Ora la conoscenza sta proprio in questa relazione, in
questo aver presente un oggetto» (p. 67); «Quel che gli [Husserl] preme è chiarire il concetto di conoscenza, specialmente
188
�Le conclusioni della filosofia del conoscere. Appunti sul programma “razionalista” di Husserl e Bontadini
Bontadini, è colui «che ha, forse più di ogni altro, contribuito a mostrare che la soggettività è
l’organo dell’oggettività, il farsi manifesto della realtà, la rivelatezza originaria (come fu poi
chiamata)» 22 . Simili espressioni si trovano negli Appunti di filosofia, dove si parla di
«rivendicazione» dell’intenzionalità23, e di Husserl si afferma che, in quanto «grande apostolo [della
fenomenologia] dei nostri tempi», è stato in grado di rivendicarne il valore «antifenomenistico» 24.
Più in generale, tutta la «scuola fenomenologica» ha “ripristinato” «la retta concezione della
oggettività o intenzionalità della conoscenza»25.
È bene sottolineare, tuttavia, che se quello che si è appena posto in evidenza è il «risultato»
(parola di Bontadini medesimo) della riflessione husserliana - questo entra in contrasto con il
«processo» per mezzo del quale Husserl stesso vi perviene. Ne La funzione metodologica dell’Unità
dell’Esperienza, Bontadini lo afferma esplicitamente:
E quanto alla fenomenologia husserliana è da dire, in primo luogo, che essa mantiene ancora alcuni
atteggiamenti (come quello «riduttivistico») che sono giustificati da preoccupazioni, le quali si
imponevano mentre il problema della gnoseologia moderna era in via di soluzione, ma che debbono
cadere allorché tale soluzione è conseguita (e conseguita essa è certamente, per ciò che riguarda
l’essenziale, anche dalla scuola fenomenologica). Si tratta perciò sempre di un conflitto tra il processo e il
risultato.26
Questa citazione colloca molto chiaramente Husserl dal punto di vista della bontadiniana “esegesi”
della parabola della filosofia del conoscere, in particolare della sua conclusione. Husserl si situa –
se comprendiamo Bontadini – nella fase conclusiva della filosofia moderna, le cui preoccupazioni
(con la quale espressione Bontadini intende la presenza del “presupposto naturalistico”) ancora
agiscono e gravano, non già sul «risultato» conseguito da Husserl (l’“intenzionalità” come relazione
diretta con l’essere), quanto sul “come” del suo conseguimento. Husserl non si colloca né
semplicemente dentro la “filosofia del conoscere”, né completamente al suo esterno: egli si trova
sulla soglia, per così dire, ancora preso tra le sue maglie per quanto riguarda il metodo, già oltre
essa per quanto concerne il risultato. L’epoché husserliana (perché a questo si riferisce Bontadini
con «processo») «rappresenta anch’essa una semplice tappa, una delle ultime – addirittura l’ultima
– di quel processo storico»27. Ultima tappa, nella quale il «presupposto» fa sentire ancora il suo
gravoso peso speculativo:
Se qualcosa di discutibile, e anzi d’inaccettabile, è detto dallo Husserl intorno alla natura del dato, ciò
nasce dal fatto che questo pensatore è ancora mancipio del presupposto dualistico, come è troppo
chiaramente attestato dalla sua teoria della epoché o dalla sospensione del giudizio di esistenza, o di
quella che gli chiama, in diversi momenti del suo pensiero, riduzione, eidetica e fenomenologica. Non di
riduzione si deve parlare a proposito della unità dell’esperienza, che è poi la pura e assoluta
fenomenologia: o, se se ne vuole parlare, si dica che ciò, che è da ridurre, sono in massa, tutti i
presupposti: in testa a tutti, quello della dualità dell’essere e del pensiero, dell’esistenza e del dato, ossia,
proprio quel presupposto, che dà allo Husserl l’idea di una fenomenologia come riduzione. Anche lo
Husserl si muove, manifestamente, nel ciclo (moderno) della lotta contro il dualismo presupposto, grande
campione di questa lotta, ma succubo esso pure di quegli equivoci che nascevano dal trovarsi in tale
situazione eminentemente instabile.28
contro il positivismo psicologistico secondo il quale noi conosceremmo solo le nostre sensazioni e tutta la conoscenza
non sarebbe che un associarsi meccanico di sensazioni. No, noi non conosciamo sensazioni, ma cose per mezzo delle
sensazioni» (p. 66)
22
Bontadini (1971b), pp. 197-198 («Filosofia e religione nel pensiero di Parini»).
23
Bontadini (1996c), p. 60.
24
Ivi, p. 106.
25
Ivi, p. 124.
26
Bontadini (1971a), pp. 39-69: p. 58.
27
Ivi, p. 206 («Il processo di banalizzazione della filosofia contemporanea»).
28
Bontadini (1996a), pp. 233-319: pp. 277-278.
189
�Daniele De Santis
Chiaramente, il problema non è il metodo husserliano della epoché (che qui Bontadini non sembra
distinguere dalle due riduzioni, quella eidetica e quella trascendentale), ma ciò che, dall’interno del
pensiero dello stesso Husserl, la rende “necessaria”: il presupposto dualistico di essere e pensiero.
In altre parole, nella misura in cui Husserl, direbbe Bontadini, accetta come presupposto il
“dualismo” di essere e pensiero, deve introdurre uno strumento metodologico atto a disattivarlo: di
qui il bisogno dell’epoché29. Da questo “lato” (dal lato cioè del metodo motivato dal “presupposto”)
Husserl – sorta di Giano bifronte, «campione» e «succubo» – guarda ancora alla filosofia moderna,
che non è altro, come direbbe Calogero, che filosofia del conoscere sic et simpliciter, cioè del
“dualismo” di soggetto e oggetto. Tale, dunque, il volto moderno e “non contemporaneo” della sua
fenomenologia – causa di quegli «inceppamenti» che «si risentono ancora» nel suo pensiero, e la
completa liberazione dai quali sarebbe infatti stato il precipuo risultato della «generazione
seguente»30.
In tal senso, il suo pensiero «in Germania rappresenta un momento corrispondente all’attualismo.
È noto che questo autore attribuì a se stesso, a volta a volta, le qualifiche di realista e idealista» 31.
Ma che cosa significa, questo, esattamente?
L’idealismo, come risoluzione del gnoseologismo, è ancora figura gnoseologistica, e come tale va inteso e
valutato: toglie il velo che il gnoseologismo sovrapponeva all’essenza del filosofare, ma lascia ad altri di
fare emergere, o riemergere, tale essenza. […] Si dice - tra le tante cose che gli si dicono contro - che il
fatto che io debba giudicare di tutto col (mio) pensiero, non significa che il mio (pensiero) sia tutto.
Giusto: oltre al pensiero c’è anche la pastasciutta, ecc. Però se io di giudico, vuol dire che il pensiero è
tutto «intenzionalmente». Il termine non era idealistico, ma l’idealismo non voleva dire cosa diversa. Non
per niente Husserl, che cominciò come realista – e cioè contro l’idealismo psicologistico, quello per cui la
pastasciutta risulta una modalità della coscienza – finì come idealista, in senso trascendentale.32
Indipendentemente dalla possibilità di accettare la “traduzione” che Bontadini fa del linguaggio, più
husserliano, dell’intenzionalità, in quello attualistico del (mio) pensiero che pensa tutto, quel che ci
preme metter in evidenza è come la parabola personale del pensiero di Husserl attesti, o attesterebbe
secondo Bontadini, l’ambiguità strutturale della sua fenomenologia. Nato «realista» – accettando il
presupposto dualistico di essere e pensiero – egli sarebbe poi divenuto «idealista», riconoscendo, su
base metodologica, l’infondatezza di detto “presupposto”. Come ebbe ancora a osservare Bontadini:
«Questa identità, o coincidenza, dei due grandi e antichi avversari, il realismo e l’idealismo, è stata
affermata pure da questo grande teoreta, il cui itinerario mentale riproduce appunto, in qualche
modo, l’ultimo tratto del generale itinerario tracciato dallo gnoseologismo moderno» 33.
Il pensiero di Husserl acquista in tal modo valore metonimico: situandosi al termine della
“filosofia del conoscere”, Giano “bifronte” dotato di un volto “moderno” e di uno
“contemporaneo”, egli ne esprimerebbe, ripetendolo in se stesso, questo medesimo ultimo tratto.
Anche se Bontadini non si è mai dedicato sistematicamente allo studio del pensiero di Husserl34, è
29
Bontadini sostiene che il “presupposto dualistico” esercita «un’azione teoreticamente riduttiva» sul pensiero di
Husserl (ivi, p. 388).
30
Bontadini (1971a), p. 246.
31
Ivi, p. 271 («Per una filosofia neoclassica»).
32
Ivi, pp. 315-316.
33
Bontadini (1996c), p. 167. In merito si potrebbe citare un passo del testo per la voce «Phenomenology» scritto da
Husserl per l’Encyclopedia Britannica: «Nel lavoro sistematico della fenomenologia, che procede dalle datità intuitive
fino alle vette più astratte (zu den abstrakten Höhen), si risolvono da sé medesime, senza l’artificio di una dialettica
argomentativa e senza nessun vano sforzo verso il compromesso, le ambigue opposizioni, di lunga tradizione, delle
prospettive filosofiche: opposizioni come quella tra razionalismo (platonismo) ed empirismo, soggettivismo e
oggettivismo, idealismo e realismo, ontologismo e trascendentalismo, psicologismo e anti-psicologismo, positivismo e
metafisica, visione teologica e causale del mondo », Husserl (1962a), p. 253.
34
Nel senso di non aver mai dedicato nessuno studio sistematico al pensiero di Husserl, a differenza ad esempio di
quanto fatto da Sofia Vanni Rovighi. Bisogna comunque puntualizzare come quest’aspetto non entri in contrasto con
quanto si è affermato in precedenza: nonostante Bontadini non abbia mai scritto un’opera sistematica su Husserl,
limitandosi quindi ad accenni e affermazioni sparse, quel che egli ne dice ha, se ricostruito correttamente, carattere
190
�Le conclusioni della filosofia del conoscere. Appunti sul programma “razionalista” di Husserl e Bontadini
chiaro come una comprensione profonda dell’iter speculativo del padre della fenomenologia si
rivelerebbe assolutamente necessaria alla comprensione – non già della storia della filosofia
moderna tout court – ma del suo ultimo tratto, quello più propriamente “conclusivo”.
Chiudiamo questa prima parte riassumendo i punti salienti della lettura bontadiniana di Husserl.
• Husserl ha la sua posizione storico-filosofica al “termine” della filosofia moderna, o «filosofia
del conoscere», svolgendo in Germania lo stesso ruolo svolto in Italia dall’idealismo attuale di
Gentile.
• Questa sua posizione storico-filosofica si riflette all’interno dello sviluppo del suo stesso
pensiero, e si esprime, “teoreticamente”, in «un conflitto tra il processo e il risultato» – tra il
«risultato», cioè la nozione di intenzionalità ontologica del conoscere o di soggettività come organo
dell’oggettività, e il «processo», cioè la necessità, stante il presupposto naturalistico, di uno
strumento metodologico che sia in grado di “disattivare” la “dualità di essere e pensiero”, senza
però negarla del tutto.
• Tanto storicamente quanto teoreticamente Husserl è, per Bontadini, un vero e proprio Giano
dalla testa bifronte, realista e idealista insieme, pensatore ancora moderno e tuttavia già
contemporaneo.
Se questa la posizione di Husserl, sarà bene allora volgere lo sguardo all’interpretazione della
storia della filosofia moderna che Bontadini offre nei suoi scritti.
3. La “storia della filosofia moderna” secondo Bontadini
3.1. Il “valore” della storia della filosofia moderna
Nessuna disamina dell’interpretazione bontadiniana della storia della filosofia moderna può
esimersi da una considerazione della «valutazione» che Bontadini stesso fa della medesima in
rapporto, si dica pure di scarto, a quella della generazione di filosofi neo-scolastici immediatamente
precedente la sua, in particolare a quella che egli chiama la «valutazione analitica» di Francesco
Olgiati (ci stiamo con ciò riferendo al celebre scritto, del 1929, «Valutazione analitica e valutazione
dialettica della filosofia moderna»35). Bontadini apre il saggio presentando le linee fondamentali del
programma «storicista» del quale Olgiati si era fatto sostenitore: «Tale programma […] gli fu
suggerito precipuamente dalla necessità, da lui avvertita con particolare acutezza, di porre su nuove
basi la valutazione e la critica del pensiero moderno» 36 – “nuove”, come si affretta a precisare,
rispetto a quelle abituali dei filosofi neo-scolastici, che si accontentavano di «una semplice
contrapposizione di principi a principi», vale a dire dei principi della filosofia “vera” rispetto
all’“errore” rappresentato dalla filosofia moderna nella sua interezza.37 Senza dover qui ripercorrere
la ricostruzione che Bontadini fa dell’interpretazione di Olgiati della storia della filosofia “antica”
(greca e medievale), e dell’apice che essa raggiunse con il sistema tomistico, cerchiamo di capire
come, secondo Bontadini, si sia espressa quella necessità, da parte di Olgiati, di «ricercare il
significato o valore […] della filosofia moderna»38.
sistematico, cioè coerente e strutturato in modo specifico. Ringrazio l’anonimo reviewer per avermi spinto a questa
precisazione importante.
35
Ora raccolto in Bontadini (1995), pp. 221-237.
36
Ivi, p. 221.
37
«Col procedere quegli scolastici davano bensì il bando all’errore, ma lo sbandivano tanto da non esser poi in grado
di indicare il modo e la via secondo cui da quell’errore, chi vi si trovasse impigliato, potesse passare alla verità»
(ibidem.). Si pensi ad esempio, volendo richiamare un autore che ci porta sì ben al di là del quadro bontadiniano, ma che
nondimeno è in grado di esemplificarne al massimo l’affermazione, alle quattro fasi della filosofia delineate da Franz
Brentano nel suo Die Vier Phasen der Philosophie, nel quale Kant rappresenta una fase di estremo scetticismo rispetto a
Hume, e in cui la fase “dogmatica” che segue al criticismo raggiunge in Hegel il suo apice, e la cui speculazione è
definita die äußerste Entartung menschlichen Denkens, «la più manifesta degenerazione del pensiero umano» (Brentano,
1895, p. 28).
38
Bontadini (1995), p. 224.
191
�Daniele De Santis
Volendo definire un tale approccio, con ciò valutandolo nel suo significato complessivo, si
potrebbe chiamarlo “analitico”: «egli [Olgiati] non attribuisce un valore alla sintesi moderna come
tale, ma ad alcuni o ad uno dei suoi elementi». 39 Una chiara esemplificazione di tale tendenza
analitica da parte di Olgiati si può trovare nella prefazione alla prima edizione di La filosofia di
Enrico Bergson (che qui Bontadini non richiama) – nella quale la lettura del grande filosofo
francese è presentata con le seguenti parole (si capirà a breve perché abbiamo deciso di citare
proprio il presente passo):
Ponendomi poi dal punto di vista della Neoscolastica, e tenendo conto degli studi critici più notevoli e
specialmente dei lavori degli scrittori cattolici, ho mostrato gli errori e le contraddizioni di questa
filosofia nuova. Ma – sarà bene avvertirlo fin d’ora – io non ho potuto appagarmi d’una critica negativa
e demolitrice, poiché lo studioso di filosofia non deve essere mai un Attila, che non lascia crescere filo di
erba, dove si posa la zampa del suo cavallo; ma deve essere un medico, il quale esamina un organismo e
procura di distruggere i microbi dannosi ed i bacilli, per rendergli possibile un ulteriore sviluppo40.
L’accezione di “analitica” ben si attaglia all’analogia medica stabilita da Olgiati: la sua essendo una
“lettura” che «distrugge i microbi dannosi ed i bacilli, per render[e] possibile un ulteriore sviluppo».
Essa – continua Bontadini – «porta ad accettare e ad incorporare nella filosofia dal cui punto di
vista si muove la critica quella tesi cui si attribuisce un valore positivo»41 (una volta, quindi, che la
si sia liberata dai «microbi dannosi»). La critica “analitica” è dunque una critica che si muove per
così dire all’interno della storia della filosofia moderna, e dei singoli sistemi di pensiero da essa
criticati; ed è sempre dall’interno che essa analiticamente, vale a dire “chirurgicamente”, divide,
taglia e asporta, in tal modo salvando il salvabile. Al contrario, «la valutazione dialettica può anche
non accettare nulla di ciò che essa ha per obbietto, nulla dico, conclusivamente o definitivamente,
ma solo attribuirgli un valore di trapasso o di preparazione ideale ad una diversa sintesi, in cui
questa che si valuta viene annullata, ed in cui essa ritrova appunto il suo vero valore: valore
dialettico, pertanto»42. La lettura, o valutazione dialettica, si muove per così dire al di sopra (per
quanto possano valere simili “metafore” di natura spaziale) dei singoli sistemi, cercando di cogliere
il valore “complessivo”, sintetico per così dire, della storia della filosofia moderna in quanto tale e
in tutta la sua estensione.
Come scrive Bontadini: «Il risultato della valutazione analitica è che il pensiero moderno non
contraddice in tutto al pensiero tradizionale, e che, pertanto, la conciliazione e la valorizzazione del
primo dal punto di vista del secondo è possibile sotto qualche aspetto»; al contrario, «il risultato
della valutazione dialettica dovrebbe essere che il pensiero moderno, preso tutt’insieme nel suo
sviluppo (che è già tutta una dialettica) vuole essere risolto nel pensiero tradizionale, ed il valore da
attribuirgli sarebbe appunto questo, di reintrodurre in questo pensiero» 43 . Se la generazione
precedente quella di Olgiati valutò “negativamente” la totalità della storia del pensiero moderno, e
quella invece analitica inaugurata dal maestro di Bontadini si dispose ad accogliere alcuni dei suoi
guadagni speculativi, la valutazione dialettica può sì ancora, come la prima, non accettare “nulla”
(«può anche non accettare nulla» – sottolinea Bontadini) della parabola della filosofia moderna,
disponendosi tuttavia nei suoi confronti, questa volta come la valutazione analitica, con un
atteggiamento positivo (se essa può non accettarne nulla significa comunque, in ogni caso, che può
anche accoglierne qualcosa).
Cerchiamo di capire in che cosa consistano – o possano consistere – i singoli guadagni del
pensiero moderno così come il suo complessivo «valore di trapasso». Bontadini non potrebbe essere
più chiaro di così; si può parlare di un unico, grande guadagno:
39
Ivi, p. 225.
Olgiati (1922), p. xix.
41
Bontadini (1995), p. 225.
42
Ibidem.
43
Ivi, p. 226.
40
192
�Le conclusioni della filosofia del conoscere. Appunti sul programma “razionalista” di Husserl e Bontadini
Ora, quale può essere stato determinatamente il contributo dialettico del pensiero moderno alla verità
sovrastorica? […] la speculazione moderna ha segnato il punto di partenza della speculazione in generale,
e vorremmo anche esprimere l’opinione che designazione abbia un carattere definitivo. Questo punto di
partenza è poi il Cogito cartesiano, ma inteso come Cartesio non poteva intenderlo, ossia includendo tante
di quelle cose che Cartesio ancora lasciava fuori di esso; è l’esperienza possibile di Kant; è l’Esperienza
pura di alcuni filosofi contemporanei, ossia l’Unità attuale e reale del dato di ciò che è presente
(assolutamente; che la presenza sia per es. presenza a me è secondario, ossia è essa stessa una cosa
presente).44
Il “guadagno” del pensiero moderno consiste nel riconoscimento, e suo progressivo svolgimento,
del «punto di partenza» della speculazione – punto di partenza che Bontadini identifica con
l’U.d.E.45 E per quanto riguarda il superamento del cosiddetto “presupposto”, quella “dualità di
essere e pensiero” che proprio la storia della filosofia moderna avrebbe superato? Non si dovrebbe
parlare almeno di un “secondo” guadagno, magari già implicito nel “primo”, ma da esso comunque
distinto, ottenuto dalla speculazione moderna?
Sebbene non si possa parlare né di uno “sviluppo” né, più in generale, di un cambiamento di
vedute da parte di Bontadini per quanto concerne la valutazione complessiva del risultato della
storia della filosofia moderna, ci sembra comunque possibile parlare, entro determinati limiti, di uno
slittamento di accento da parte del filosofo milanese. In uno dei testi scritti per «L’Educatore
italiano» (ci stiamo riferendo a «Sfruttamento della lezione berkeleyana» 46 ), che data 1962, il
superamento del dualismo di essere e pensiero, o del cosiddetto presupposto naturalistico, è
accettato e quindi descritto come un importante guadagno («il guadagno “critico”») della
conclusione della filosofia moderna rispetto alla speculazione precedente. Dopo aver ricordato, con
un linguaggio caratteristico di questi anni, che la storia del pensiero moderno si è conclusa
riportando in auge (quasi si trattasse di mera “ripetizione”) la concezione ontologica del conoscere,
Bontadini si affretta a precisare:
Con una differenza però certo non trascurabile, differenza che rappresenta il guadagno «critico» proprio
della filosofia moderna: giacché nella filosofia antica – e medievale – la predetta concezione
dell’intenzionalità è accompagnata dalla posizione immediata – o presupposizione – dell’ordine naturale,
della res naturae, come d’un ordine che giace al di là dell’orizzonte intenzionale. Per effetto di questo
accompagnamento, di questo, potremmo dire, eccesso di appetito (moglie e botte!), la filosofia
«tradizionale» risultava dogmatica.47
C’è dunque un guadagno «critico» della filosofia moderna – cioè di critica della tradizione classica
o, almeno, di una sua «presupposizione»: la presupposizione (qui da intendere nel senso di:
accettazione acritica e mai discussa) di un ordine che, situandosi «al di là dell’orizzonte
intenzionale», di questo ne rappresenterebbe la base. Presupposizione contro presupposizione: la
prima appartiene al pensiero classico; mentre la seconda rappresenta il punto di avvio della parabola
moderna e lo snodo “critico”, nella sua “risoluzione” ultima, di quella prima. Se è così, allora, ci
sembra doversi smussare la nota polemica con la quale Bontadini si riferisce spesso al punto di
avvio del pensiero moderno, cioè a quella sua accettazione cieca di una presupposizione
naturalistica che ne avrebbe condizionato lo sviluppo. Che l’«ordine naturale» (= presupposizione
dogmatica della filosofia antica) non vada identificato con il presupposto naturalistico (=
presupposizione dogmatica della filosofia moderna) è chiaro, ma allora in cosa si differenzierebbero
nel loro essere “presupposizioni”?
44
Ivi, p. 232.
«L’Unità dell’Esperienza è l’unità che compete alla realtà sperimentata in quanto sperimentata. Si intende tutta la
realtà sperimentata, quindi si intende che l’unità è totalità» (Bontadini, 1979, p. 123); «Come si considera anche innanzi
[…] il primo nell’affermazione è l’essere (nella forma di un qualcosa attualmente presente). Questo essere viene
riconosciuto come l’essere che appare, cioè che è identico con l’apparire: si riconosce che esso è affermato perché e per
quanto appare. L’U.d.E. è, dunque, l’essere che appare; non l’essere come apparire» (p. 126).
46
Bontadini (1996c), pp. 135-139.
47
Ivi, p. 138.
45
193
�Daniele De Santis
Un’altra osservazione si impone come necessaria. Se «la conclusione della filosofia del
conoscere» consiste nella risoluzione della presupposizione propria della filosofia moderna
(l’alterità dell’essere al pensiero), il quale, tuttavia, si presenta a sua volta come risultato e
guadagno “critico” rispetto alla presupposizione antica, non avrebbe allora ragione l’idealismo
attuale nel sostenere che esso avrebbe “risolto” in sé, definitivamente, la “totalità della storia della
filosofia” 48 ? La situazione sembra farsi ancora più complessa se guardiamo al modo in cui «la
conclusione della filosofia del conoscere» è presenta in La deviazione metafisica all’inizio della
filosofia moderna.
Quello che ci sembra essere posto in discussione – sebbene non venga mai nominato – è proprio
il guadagno «critico» che il testo del 1962 riconosceva alla filosofia moderna e alla sua conclusione.
Il modo in cui Bontadini medesimo caratterizza, con parole sì scarne, ma in ogni caso alquanto
chiare, il pensiero moderno e la sua risoluzione, non ci sembra lasci alcun dubbio al riguardo. Tre
sono gli aspetti “caratterizzanti”: «Allora: 1) posto che la presupposizione naturalistica (il realismo
dualistico presupposto) sia responsabile (o almeno corresponsabile) della crisi e del rifiuto della
metafisica, 2) essa però rappresenta un disguido teoretico, precisamente o semplicemente perché è
un presupposto; 3) tale disguido viene corretto dalla stessa filosofia moderna, che pure da essa
prende l’abbrivio» 49 . Il risultato «critico», così lo chiamava il testo del 1962, ci sembra qui
corrispondere a (1), nella misura in cui l’alterità dell’essere al pensiero (presupposizione moderna)
intacca, criticandolo, il presupposto antico, e dogmatico, della posizione immediata dell’ordine
naturale. A ben vedere, tuttavia, i due testi (quello del 1962 e questo, pubblicato dieci anni più tardi)
presentano due “prospettive” diverse sullo stesso problema: lo scritto del 1962 pone l’accento
sull’immediatezza che caratterizza la “posizione” dell’ordine naturale, dunque sul fatto che ciò che
verrebbe “criticato”, dalla risoluzione del pensiero moderno, è proprio tale immediatezza. La
risoluzione dell’alterità dell’essere al pensiero rappresenta il guadagno «critico» rispetto alla
presupposizione antica (immediata questa, mediata quella prima). Al contrario, secondo il saggio
del 1972 sarebbe proprio la presupposizione moderna, cioè l’alterità dell’essere al pensiero, a
rappresentare la critica (parola dello stesso Bontadini) della presupposizione antica: mentre nel
1962 era la «conclusione» della filosofia del conoscere a risultare “critica” del presupposto antico,
qui è la stessa presupposizione moderna a essere detta “critica” di quella antica. Sebbene questo
sembri solamente – come avevamo suggerito più sopra – un leggero slittamento di accento, quasi
che a cambiare fosse soltanto lo sguardo, per così dire l’angolo di osservazione, non già l’“apporto”
teoretico-interpretativo, a risultarne in realtà alterato è il valore stesso che si viene tal modo
riconoscendo, non semplicemente alla «conclusione della filosofia del conoscere», bensì alla
“totalità” della sua storia. Se, infatti, l’alterità dell’essere al pensiero si profila come “critica” della
presupposizione antica, e se «la conclusione della filosofia del conoscere» è il superamento di tale
alterità, allora tutto il “valore” del pensiero moderno si risolve nella “critica della critica” o, meglio,
nell’“auto-critica” che il pensiero moderno fa di sé: essendo il suo “valore” solamente “negativo”,
non si può più parlare di un «guadagno “critico” proprio della filosofia moderna». Dunque l’idea,
suggerita dai punti (2) e (3), di una storia della filosofia moderna che sembra consistere,
correggendo il proprio «disguido», nell’annullamento di se stessa. Una sorta di Brünnhilde
wagneriana che, nella drammatica Götterdämmerung nella quale le fiamme tutto abbracciano e
divorano, si sacrifica - così che a bruciare sia anche l’«anello», con esso dissolvendosi la
48
Questa rappresentando la prospettiva che Bontadini intende esplicitamente rigettare: «Già da molti anni il
sottoscritto va proponendo una “interpretazione globale” della filosofia moderna. Nulla di pretenzioso (e sarebbe pretesa
non solo smodata, ma ridicola, se paragonata agli scarsissimi mezzi del proponente): giacché si tratta di una semplice
rettifica e compimento di una prospettiva che, tra due e una generazione fa, era corrente». Bontadini si sta ovviamente
riferendo all’interpretazione attualistica, che così presenta: «Nella prospettiva idealistico-immanentistica la conclusione
del ciclo gnoseologistico si realizzava come risoluzione critica di tutta la storia della filosofia nella tesi idealistica. Tutta
la storia della filosofia sarebbe stata gravata da quel disguido teoretico, che va sotto l’etichetta della trascendenza; questo
disguido è finalmente eliminato con la predetta conclusione», Bontadini (1996d), pp. 25-26.
49
Ivi, p. 27.
194
�Le conclusioni della filosofia del conoscere. Appunti sul programma “razionalista” di Husserl e Bontadini
«maledizione»: «Das Feuer, das mich verbrennt, rein’ge vom Fluche den Ring!» (R. Wagner, Die
Götterdämmerung, III, 3)50.
Si legga il presente passo, molto duro dal punto di vista delle concessioni fatte al pensiero
moderno:
Si scorge da questa puntualizzazione che la filosofia moderna […] è un ciclo che sopprima se stesso, che,
per così dire, si fa dimenticare, in quanto la sua conclusione è la eliminazione del suo stesso presupposto
di partenza. Il risultato positivo del ciclo stesso […] consiste nel lasciar depositare il corretto concetto
della struttura o dell’implesso originario, e precisamente della intenzionalità ontologica – non meno che
ontologica – del conoscere in generale. […] Lo gnoseologismo può allora considerarsi una malattia – nel
secolo scorso vi fu chi, riferendosi alla filosofia moderna, parlò di una «patologia della mente umana» –:
ma trattasi di malattia a esito fausto51.
Quel che si tratta di sottolineare è la somiglianza tra la terminologia impiegata qui da Bontadini
con quella della quella si servì Olgiati per caratterizzare la sua lettura, “analitica”, di Bergson. Se da
una parte Bontadini insiste, come del resto ha sempre fatto, sul “guadagno”, innegabile, della
filosofia moderna rispetto a quella antica, dall’altra il lessico dell’auto-eliminazione e dell’“autooblio” («è un ciclo che sopprima se stesso, che, per così dire, si fa dimenticare») sembra
inevitabilmente suggerire l’idea di qualcosa che, come di fatto ogni malattia, porta sì a rafforzare
l’organismo (una volta che la si sia superata con successo), ma che si sarebbe comunque potuta
evitare. Fuor di metafora medica, Bontadini sembra volere tenere insieme due tesi “inconciliabili”:
quella della necessità, storico-filosofica, del “guadagno” del ciclo moderno (la cui “necessità”
deriverebbe, stando al testo del 1962, dal dogmatismo e della presupposizione del ciclo antico, che
si trattava appunto di superare), e quella dell’inutilità del ciclo moderno in e per se stesso (malattia
sì a esito fausto, ma che, in quanto tale, sarebbe stato molto meglio evitare, evitando in tal modo i
travagli della lunga convalescenza).
Secondo il risultato, il passaggio dal ciclo “antico” a quello “moderno” – dunque la rimozione
della presupposizione dogmatica del primo per mezzo del secondo – era inevitabile (proprio nella
misura in cui il ciclo antico si basava, anch’esso, su di una presupposizione); al contrario, secondo il
modo di questo medesimo superamento, vale a dire la storia stessa del pensiero moderno con i suoi
interni e articolati travagli, esso sembra presentarsi di fatto con il “crisma” del superfluo,
dell’evitabile, se non addirittura con quello, più marcato, dell’inutile. Se il primo corno è in grado di
sancire la necessità storico-filosofica del ciclo moderno (= il dogmatismo antico andava superato),
il secondo corno lo rende, non solo superfluo, ma del tutto inspiegabile nella sua origine storicofilosofica.
Se è così, un’importante conseguenza sembra derivarne concernente la distinzione tra
“valutazione analitica” e “dialettica”. Sembra infatti che, distinguendo il ciclo moderno come tale
dal suo risultato (il come dal cosa), egli si stia mantenendo in tutto e per tutto fedele
all’impostazione dello scritto del 1929: «la valutazione dialettica può anche non accettare nulla di
ciò che essa ha per obbietto, nulla dico, conclusivamente o definitivamente, ma solo attribuirgli un
valore di trapasso o di preparazione ideale ad una diversa sintesi». Tuttavia, e qui la nostra
osservazione vuole farsi critica, la distinzione tra le due valutazioni può mantenersi solo a patto che
si accetti l’esistenza di cicli filosofici (“antico”, “moderno” e “contemporaneo”, secondo
Bontadini), dei quali si può non accettare nulla attribuendo loro (è il caso di quello moderno)
esclusivo valore di «trapasso». Ma non si potrebbe sostenere che rispetto alla storia della filosofia
(al di qua della sua possibile ripartizione in cicli) l’interpretazione bontadiniana sia in tutto e per
tutto riconducibile alla valutazione detta “analitica”? Bontadini non si sta comportando proprio
come «un medico, il quale esamina un organismo e procura di distruggere i microbi dannosi ed i
50
Troppo comodo, tuttavia, sarebbe personificare quel che si chiama “storia della filosofia moderna”, a essa
attribuendo quel volere che Wotan dovette negare a se medesimo, e del quale, invece, Brünnhilde rivendica tutta la
drammaticità.
51
Bontadini (1996d), p. 27.
195
�Daniele De Santis
bacilli, per rendergli possibile un ulteriore sviluppo»? Se Olgiati “valutava” analiticamente la storia
della filosofia moderna (di essa qualcosa accettando, altro invece scartando), Bontadini sembra
valutare anch’egli “analiticamente” la “storia della filosofia” – di questa qualcosa accettando (la
piena determinazione del punto di partenza della speculazione raggiunta dall’idealismo attuale),
altro scartando (lo sviluppo della presupposizione naturalistica all’inizio del ciclo moderno, nonché
della totalità del pensiero moderno considerato come tale e nel suo sviluppo unitario).
Se quella che si appena delineata, certamente in modo scarno ma tentando comunque di
coglierne l’essenziale, è la visione complessiva, o almeno alcuni suoi aspetti, dell’interpretazione
bontadiniana del “ciclo” della filosofia moderna, sarà bene adesso discutere della “dialettica” che –
con le sue due tendenze – di quello rappresenta la trama e l’ordito.
3.2. Il “presupposto” e la dialettica di “razionalismo” e “empirismo”
Che la «presupposizione» caratterizzante «la filosofia del conoscere» sia descrivibile nei termini di
un’«alterità» dell’essere al pensiero dovrebbe essere punto speculativo già acquisito in base a
quanto detto in precedenza, da essa derivando quella che Bontadini chiama «l’impresa
“teoreticistica”» della filosofia moderna: «Teoreticista, perché si tratta appunto della conquista
conoscitiva dell’essere»52.
Se tale è la natura del «presupposto» all’origine della filosofia moderna, questa si caratterizza per
il dualismo di due tendenze che - tra di esse intessendo rapporti assai complessi 53 - sono da
Bontadini designate con i termini di «razionalismo» ed «empirismo». In che cosa, dunque,
consisterebbe la loro differenza? In apertura di uno scritto su Bacone, subito dopo aver
puntualizzato «che la differenza tra i due indirizzi – razionalistico ed empiristico – non è così
radicale» come si potrebbe “ingenuamente” credere (intendendo con questo il loro comune
dipendere e derivare dal «presupposto»), Bontadini scrive che «mentre il razionalismo si impegna
nella comprensione del presupposto, e quindi attinge a una metafisica in cui il dualismo è implicato
e come dedotto […], l’empirismo si dedica specialmente alle conseguenze del dualismo» 54 .
Comprensione del presupposto, per quanto riguarda il cosiddetto «razionalismo»; conseguenze del
presupposto, per quanto concerne al contrario l’«empirismo».
Quel che in tal modo viene delineandosi, se non addirittura rivelandosi, è la cifra più profonda
della comprensione bontadiniana della «filosofia del conoscere», del suo stesso “sviluppo”, ergo
della sua «conclusione». Sviluppo e conclusione che, non in termini di un “unico” lineare processo
andrebbero concepiti, quanto piuttosto in quelli, molto meno semplici, di una duplice linea di
sviluppo. Che tali “linee”, per servirci ancora di quest’immagine, possano “concretizzarsi”,
“incarnarsi” in singoli nomi propri con i loro sistemi filosofici e di pensiero, è cosa di secondaria
importanza rispetto al fatto che attraverso questi stessi nomi, attraverso questi singoli sistemi
filosofici, dunque anche all’interno di ciascuno di essi individualmente presi, quel che così si
presenta è una specifica «comprensione del presupposto» o una specifica «conseguenza del
presupposto». Così delineata, la storia della «filosofia del conoscere» è la storia di queste due
diverse “tendenze” e del loro intrecciarsi – a volte unendosi, a volte separandosi; ne consegue che
«la conclusione della filosofia del conoscere», cioè la risoluzione o auto-risoluzione del
presupposto, corrisponde alla risoluzione o auto-risoluzione di ciò che punto appare con il volto
della più irrefragabile contra-dizione. Come scrive Bontadini:
il fatto che questi due denominatori – l’empirismo e il razionalismo – si siano, ad un certo momento, dato
l’addio, avviandosi in divergenti direzioni, è uno di quelli che contribuirono ad intorbidare e complicare
la linea di svolgimento dello gnoseologismo. (Nonostante fosse un fatto “necessario”). Lo gnoseologismo
aveva bisogno, in effetti, della compresenza e della dialettica di entrambe le componenti. Quando, con
52
Bontadini (1996c), p. 97.
Si veda la più ampia ricostruzione offerta da Grion (2008), pp. 65-108.
54
Bontadini (1966), pp. 78-79.
53
196
�Le conclusioni della filosofia del conoscere. Appunti sul programma “razionalista” di Husserl e Bontadini
Kant, si avvertirà la necessità di riparare all’inconveniente prodottosi, la riparazione costerà fatica
improba, e solleverà nuove oscurità, a causa delle molte aporie nel frattempo prodottesi.55
Caso paradigmatico di una simile dialettica è quello di Locke. Dopo aver puntualizzato che «mentre
egli riconosce di avere a sua disposizione solo delle rappresentazioni empiriche, dei dati sensoriali,
continua tuttavia a parlarci della realtà esterna corporea», il filosofo milanese osserva che «questa
contraddizione non è propriamente imputabile a lui, ma era una stretta in cui si cacciava, per così
dire, il pensiero stesso, a causa dei presupposti di partenza […]. Diguisaché a Locke spetta piuttosto
il merito di aver eseguito, per così dire, un ordine oggettivo, di aver portato avanti la dialettica dello
gnoseologismo».56 Aggiunge quindi Bontadini, ampliando lo spettro della propria diagnosi:
La contraddizione è, pertanto, proprio tra le due componenti, l’empiristica e la razionalistica; cosicché si
spiega come esse dovessero disgiungersi, nel corso storico. Ma nello stesso tempo […] si scorge anche
come esse non potessero disgiungersi! Giacché, come già si ebbe a considerare, la stessa dottrina del dato
empirico o del fenomeno è condizionata dal riferimento ad una cosa in sé, cioè alla sua causa
trascendente. Che l’oggetto immediato della nostra conoscenza sia costituito da idee, e non da cose, che le
qualità sensibili siano, come già avvertiva Hobbes, non obiecta, bensì sentientum phantasmata, questo
[…] dipende dal fatto, e soltanto dal fatto, che esse sono interpretate come derivanti, per influsso fisico,
dalla realtà esterna o cosa in sé.57
“Contra-dizione” 58 in quanto – stante il «presupposto» dell’alterità dell’essere al pensiero – dal
quale “deriva” (componente razionalistica) la dottrina del “dato” o del fenomeno (componente
empiristica), questa stessa dottrina non potrà, alla fine, che presentarsi come la negazione più
radicale di quello, cioè di quanto, in poche ma essenziali parole, la rende o renderebbe possibile.
Volendo descrivere e caratterizzare tale situazione in tutta la sua complessità, bisognerebbe allora
affermare che se, da un lato, la componente razionalistica legittima la posizione empiristica
(l’alterità dell’essere al pensiero de facto “conducendo” alla dottrina del fenomeno), dall’altro
questa medesima posizione empiristica non può, a sua volta, che legittimare la componente
razionalistica (il fenomeno rimandando alla cosa in sé come «causa trascendente»: phenomena bene
fundata), di questa rappresentandone, nello stesso tempo, dunque contraddittoriamente, la sua
implicita critica e più disastrosa rovina speculativa:
Se il capitale iniziale della nostra conoscenza è costituito da idee, nel senso lockeano del termine, o
fenomeni o dati subbiettivi, donde sappiamo noi dell’esistenza o dell’essenza della causa esterna delle
idee stesse? Cioè donde abbiamo notizia di questi corpi o di quella materia che, con la loro azione
meccanica, producono in noi le idee? Proprio dal punto di vista empiristico bisogna disporsi alla
negazione della causa esterna, della materia.59
Quel che in tal modo viene compiendosi è il “passaggio” da Locke a Berkeley, cioè dal
fenomenismo all’idealismo. Il percorso, delineato da Bontadini (e che qui non è possibile, né
tantomeno necessario, ripercorrere in tutte le sue interne scansioni), procede dal «realismo
dogmatico» al «fenomenismo», e da questo, infine, all’«idealismo» con la sua «auto-risoluzione»60.
55
Bontadini (1996c), pp. 130-134.
Ivi, p. 131.
57
Ibidem.
58
Sarebbe importante, se ve ne fosse il tempo, approfondire il ruolo giocato dalla «contraddizione» per caratterizzare
la cifra più intima della storia della filosofia moderna, ponendolo eventualmente in relazione con l’impiego, cruciale, che
Bontadini ne fa nell’analisi del fenomeno (“contraddittorio”) del «divenire» (tanto nella sua fase dilemmatica quanto in
quella più propriamente antinomica e del confronto con Severino). Bisognerebbe dunque interrogarsi sul valore di simile
“contraddizione”, qui elevata addirittura al rango di criterio interpretativo: si tratta di una contraddizione apparente? O di
una contraddizione reale? Se fosse soltanto “apparente”, quale sarebbe il più ampio orizzonte all’interno del quale essa si
rivelerebbe in quanto tale, cioè unicamente apparenza? Se, al contrario, si trattasse di una contraddizione reale, allora che
valora si starebbe riconoscendo a quella contraddizione che si chiama “filosofia moderna”?
59
Bontadini (1996c), p. 132.
60
Ivi, p. 134.
56
197
�Daniele De Santis
Il corso generale della via lunga è dato, in ischema, da queste quattro tappe: realismo metafisico
(Hobbes), fenomenismo (da Hobbes e Cartesio fino a Kant, col quale vengono teorizzate le condizioni
trascendentali del fenomenismo), idealismo (cioè negazione del matterism, grazie a quel momento di
inerzia, anticipa una formulazione, che doveva restare per qualche tempo isolata e paradossale),
risoluzione o autorisoluzione dell’idealismo nel realismo semplice, o nella coincidenza di idealismo e
realismo (l’idea, termine della conoscenza, è realtà ontologica, è non meno di realtà ontologica, non
mero fenomeno, giacché il significato stesso di realtà fenomenico è stato tolto di mezzo).61
Questa «parabola o dinastia dialettica», come la chiama anche il filosofo milanese, ci riconduce a
una posizione che, come già sappiamo in virtù delle nostre precedenti analisi, era quella propria
della filosofia «classica»; «posizione rappresentata appunto» – afferma qui Bontadini nel linguaggio
che è anche e soprattutto quello della sua comprensione di Husserl – dalla concezione della
«intenzionalità ontologica» dell’«umano conoscere»62. Siamo quindi giunti al punto dal quale la
nostra analisi aveva preso l’abbrivio: Husserl e la sua fenomenologia si situano nella fase
conclusiva di questa storia, di questa parabola della «filosofia del conoscere». “Giano” bifronte nel
cui pensiero residua ancora il presupposto, quindi anche e soprattutto la “dialettica” delle due
tendenze individuate da Bontadini, vale a dire l’intreccio irrisolvibile di “razionalismo” ed
“empirismo”63.
4. La “storia della filosofia moderna” secondo Husserl
4.1. Razionalità e razionalità
Che per Husserl, così come per Bontadini, la “storia della filosofia” moderna da Descartes a Kant si
caratterizzi per una incessante e aspra dialettica di “razionalismo” ed “empirismo”, è tesi sì facile da
enunciare, ma non altrettanto da comprendere in tutta la sua profondità: tale profondità derivando
da quella che si chiama “razionalità”, e che Husserl, come anticipato all’inizio di questo lavoro,
intende secondo una irriducibile “duplicità”. Da un lato c’è quel che Husserl chiama Vernunft,
Vernünftigkeit e vernünftig; si tratta della razionalità di tipo “trascendentale”, della razionalità del
Sinn o “senso”, come si potrebbe anche caratterizzarla, cioè di “qualcosa” nella misura in cui questo
sia assunto come correlato della Vernunft secondo una delle sue tre espressioni: quella
“conoscitiva” (erkennende Vernunft, il cui correlato è das Wahre), quella “assiologico-valutativa”
(wertende Vernunft, cui corrisponde das Schöne), e quella “etico-pratica” (praktische Vernunft, alla
quale corrisponde invece das Gute)64. Leggiamo il riferimento alla ragione gnoseologica nella terza
meditazione cartesiana:
Finora è stato indifferente che gli oggetti in questione fossero veramente essenti o non-essenti, vale a dire
possibili o impossibili. Questa distinzione non viene meno con la sospensione della decisione sull’essere
o il non-essere del mondo […]. Essa si presenta piuttosto come un tema universale della fenomenologia
nella misura in cui viene compresa nell’ambito della ragione e della non ragione (Vernunft und
Unvernunft) (da intendersi nel più ampio senso possibile) come correlati dell’essere e del non-essere. Per
mezzo dell’ἐποχή operiamo una riduzione alla pura intenzione (cogitatio) e a ciò che è inteso puramente
come inteso (Vermeintes rein als Vermeintes). I predicati essere e non-essere, quindi le loro variazioni
modali, si riferiscono a quest’ultimo, vale a dire non agli oggetti sic et simpliciter, ma al senso
oggettuale.65
61
Bontadini (1966), p. 187 («La parabola della filosofia moderna»).
Bontadini (1996c), p. 138.
63
Volendo impiegare di nuovo, precisandola, l’analogia tessile più sopra introdotta, si dovrebbe affermare che mentre
il passaggio dal realismo dogmatico all’idealismo e la sua auto-risoluzione costituisce la “trama” della storia della
filosofia moderna, la dialettica di “razionalismo” ed “empirismo” ne rappresenta piuttosto l’“ordito”.
64
Husserl (1956), p. 6. Si veda il testo 21 (Autonomie und Heteronomie in der theoretischen, der praktischen und der
religiösen Sphäre), di Husserl (2014), pp. 272-276.
65
Husserl (1973), p. 91.
62
198
�Le conclusioni della filosofia del conoscere. Appunti sul programma “razionalista” di Husserl e Bontadini
Sein, Möglich-Sein, Wahrscheinlich-Sein, Zweifelhaft-Sein, Nicht-Sein – l’opposizione, marcata da
indelebile contraddittorietà, dell’essere e del non-essere, si riferisce ora al correlato di “senso” di un
sistema di sintesi che possono sia confermarlo che smentirlo (secondo una scala continua di diverse
“gradazioni”)66. La “ragione”, tuttavia, intesa come Vernunft, dunque il suo dominio di “razionalità”
intensa in quanto Vernünftigkeit, è “a posteriori”, e tale rimarrà nella misura in cui non se ne
rivelino e indaghino le profonde strutture a priori: Alle Vernunft im Aposteriori hat ihre Prinzipien a
priori67, come ricorda Husserl stesso ai suoi studenti. È qui che si fa largo la seconda nozione di
razionalità, quella che der Meister, come usavano appellarlo i suoi allievi, chiama – impiegando
questa volta non il termine squisitamente tedesco, quanto invece quello di origine latina –
Rationalität: la “razionalità” a priori o “eidetica”, quella che, distinguendosi dalla razionalità del
Sinn, può bensì dirsi razionalità dello Sein, dell’essere68. Essa si esprime per mezzo delle «verità
razionali» o rationale Wahrheiten, la cui funzione, come leggi dell’essere (Seinsgesetze 69 ), è
definita nei termini di una «razionalizzazione dell’empirico», Rationalisierung des Empirischen70.
Ne consegue una serie di termini, come rational e Rationalismus: con quest’ultima, allora, dovrà
intendersi il razionalismo, non già del senso, bensì dell’essere e delle sue strutture a priori, e la cui
«scoperta» risalirebbe precipuamente a Platone71.
Parlando di «razionalismo», dunque della dialettica di razionalismo ed empirismo, Rationalismus
ed Empirismus, non si può che intendere la razionalità di tipo “eidetico”, quella ontologica. In tal
senso, allora, una simile dialettica avrebbe, quali suoi protagonisti, da un lato la «razionalità
dell’essere», e dall’altro quel che ad essa si opporrebbe: l’empirismo, sottolinea Husserl, si
66
Ivi, p. 93. Quella che dunque, tradizionalmente, si presenta come un’opposizione contraddittoria, escludente cioè
ogni possibile grado intermedio (l’essere escludendo il non-essere, e viceversa), muta, in regime di senso, in quella che,
ancora tradizionalmente, si chiama invece contrarietà.
67
Husserl (1984), p. 237. Questo non dovrebbe stupire qualora ci si ricordasse che per Husserl “trascendentale” è ogni
indagine che riguarda le correlazioni di senso di natura costitutiva tra la coscienza e il mondo: nella misura in cui queste
“correlazioni” non vengono indagate eideticamente da una specifica scienza a priori esse rimangono del tutto a posteriori,
cioè fattuali. Ovviamente qui non stiamo suggerendo che la fenomenologia, così come la intende Husserl, sia o possa
essere un’impresa a posteriori; essa è infatti concepita come una “scienza eidetica”, cioè a priori, della regione coscienza
e delle sue correlazioni di senso. Quel che ci preme sottolineare in questa sede è la necessità di distinguere i due momenti,
quello trascendentale (in sé non a priori) e quello eidetico-apriorico, corrispondenti alle due forme di razionalità.
68
Sebbene questa identificazione di “ontologico” ed “eidetico” possa apparire frettolosa, soprattutto al lettore delle
opere di Bontadini, l’identità è tutta di provenienza husserliana: in un senso ampio che qui non necessita di essere
approfondito, il termine eidos è utilizzato da Husserl, per lo meno a partire dal 1913, per designare la “datità” dell’a priori
o, meglio, la datità delle strutture “a priori” dell’essere secondo la sua distinzione in regioni, sub-regioni, generi e specie.
69
Husserl (2001), p. 11.
70
Husserl (1976), pp. 24-25. Come Husserl osserva verso la fine del testo sulla voce Phenomenology, con riferimento
alle varie scienze a priori e le loro corrispondenti ontologie: «In questa loro configurazione ingenua [vale a dire non
ancora fondata trascendentalmente], esse fungono da strumenti metodologici delle corrispondenti scienze ‘esatte’ di dati
di fatto; più precisamente: esse servono a razionalizzare (zu rationalisieren) il regno dei dati di fatto, a realizzare la
methexis alla necessità riconducendo il fattuale (das Faktische) alla struttura d’essenza di un possibile fatto del mondo in
generale», Husserl (1962a), p. 251. In generale, con “razionalizzazione dell’empirico” si intende l’opera specifica delle
“scienze a priori”, dette appunto “razionali”, come la geometria, la psicologia pura e la stessa fenomenologia (nella
misura in cui questa sia assunta in quanto scienza a priori), che “razionalizzano” l’empirico investigandone e stabilendone
le legalità a priori, quelle cioè assolutamente necessarie e universali. Si tratta di una razionalizzazione teoretica che può
anche essere intesa come “pratica”, nella misura in cui essa venga intesa come il “risultato” delle scienze a priori.
Ringrazio l’anomico reviewer del testo per aver sollevato questo punto di estrema importanza.
71
Husserl (2012), pp. 28-65. Che Husserl decida di ricorrere al termine di provenienza latina non dovrebbe stupire;
come scrive Tommaso nella Summa Theologiae (I, q. 84, a. 5): «Platone sostiene […] che le forme delle cose sussistano
per se stesse e distinte dalla materia; egli le chiama idee, e afferma che il nostro intelletto conosce tutte le cose per mezzo
della loro partecipazione […]. Agostino allora sostituisce le idee difese da Platone con le ragioni, che esistono nella
mente divina, di tutte le creature, e secondo le quali tutte le cose sono fatte e dunque conosciute dall’anima umana (Posuit
autem Plato […] formas rerum per se substistere a materia separatas, quas Ideas vocabat, per quorum partecipationem
dicebat intellectum nostrum omnia cognoscere, […] ideo Augustinus, in libro Octoginta trium Quest., posuit loco harum
idearum quas Plato ponebat, rationes omnium creaturarum in mente divina existere, secundum quas Omnia formantur, et
secundum quas etiam anima humana Omnia cognoscit)».
199
�Daniele De Santis
«oppone» (in Gegensatz) all’«apriorismo» come carattere più proprio di quella prima 72. Questo, per
lo meno, nella sua forma antica. Perché, come Husserl non manca di indicare, l’“empirismo
moderno” non è necessariamente «anti-razionalistico» (anti-rationalistisch) in questo particolare
senso: se esso, in effetti, in quanto positivismo, nega la possibilità di una conoscenza scientifica di
realtà trascendenti, dunque delle “idee”, e con queste – nella misura in cui siano assunte nel loro
essere trascendenti – la possibilità di una «conoscenza ideale a priori», questo empirismo moderno,
dicevamo, riconosce, non meno del suo antagonista, il valore innegabile della nuova scienza
matematica della natura. In questa sua «nuova forma», scrive Husserl, «l’empirismo ha in comune
con il razionalismo la fisica esatta»73.
Se tale è la situazione, allora arduo diventa mantenere l’idea stessa di una dialettica di
razionalismo ed empirismo: quale sarebbe la differenza se ambedue i protagonisti, nella misura in
cui accettano la fisica esatta, presentano un identico e indistinguibile volto razionalista? «L’origine
di questo scontro, e di questa specifica determinazione dell’opposizione tra i due partiti si trova
nella modalità nella quale i primi grandi razionalisti, innanzitutto Descartes, quindi in modo più
estremo Spinoza, si sono appropriati del modello della scienza matematica della natura» 74. Ecco che
comincia a delinearsi, seppur ancora in modo vago e confuso, il senso profondo della husserliana
dialettica di razionalismo ed empirismo (moderno). Volendo tratteggiarla con poche ma essenziali
parole, si potrebbe sostenere che essa rivela in verità il “volto” di una “duplice”, inestricabile,
dialettica e tensione - sì che a essere in gioco è quella “duplice” nozione di razionalità più sopra
discussa. Da un lato, detta dialettica:
(α) Si presenta come interna al «razionalismo» stesso, quindi alla nozione di razionalità ontologica
e dell’essere: tensione e dialettica tra una Rationalität, che si vorrebbe concepita sul solo
«modello», Vorbild, della scienza esatta della natura, e una Rationalität che – emergendo –
rivendica e ribadisce, contro quella prima, la sua specifica legittimità e irriducibilità ontologica.
Dall’altro si avrebbe non già una dialettica “endogena” (Rationalität vs Rationalität), quanto, per
così dire, una dialettica “esogena” – con ciò dovendosi intendere:
(β) L’emergere e l’affermarsi – di contro all’unica razionalità compresa come Rationalität, cioè di
una razionalità dell’essere – della Vernünftigkeit, vale a dire della razionalità del “senso”, e dei suoi,
specifici, correlati (verum, bonum et pulchrum). Ed è proprio all’emergere di questa seconda forma
di razionalità che, come vedremo, il cosiddetto «empirismo» contribuisce.
Molteplici, dunque, sono le forze che, come nell’oscuro e torbido Nibelheim, si agitano sotto le
due espressioni, apparentemente chiare, di «razionalismo» ed «empirismo».
Se in Bontadini la parabola della «filosofia moderna» si caratterizza tanto per una “dialettica” di
razionalismo ed empirismo quanto per il progressivo “risolversi” delle varie posizioni filosofiche, in
Husserl la dialettica è, analogamente a quella del filosofo milanese, duplice - proprio perché duplice
è la sua concezione della «razionalità»75.
72
Husserl (2012) p. 217.
Ivi, p. 234.
74
Ivi, p. 235.
75
Volendo individuare i principi di queste due forme di razionalità, si potrebbe sostenere che la Vernünftigkeit è retta
dal principio di unità, la quale è l’unità del senso come correlato di un sistema di sintesi: «È chiaro che la completezza
del mondo, nella sua relatività ai soggetti che esso, nello stesso tempo, include in sé come suoi oggetti, è possibile solo
nel divenire, o possibile solo come divenire assolutamente compiuto (vollkommenstes), che da parte sua è diretto (e come
tale ha senso solo nella direzione) verso un’assoluta completezza come sistema ideale di poli, e unificato, come
completezza assoluta, in quanto unum» (Husserl, 2014, p. 275). Al contrario, il principio della Rationalität è quello di
«identità» nella sua valenza ontologica, vale a dire determinante l’«identità» dell’ente. Ecco come Husserl descrive la
reazione socratica alla sofistica (la quale avrebbe condotto a Platone): «Come reazione, il ritorno socratico all’evidenza si
presenta come chiarimento, per mezzo di un esempio, dei campi di pure possibilità: una libera variazione che mantiene
l’identità del senso, l’identità dell’oggetto come sostrato della determinazione e che lascia vedere questa identità»,
Husserl (1962b), p. 280. Ancora più chiaro le Ideen… III: «La modalità ontologica di considerazione è, per così dire,
catastematica: essa considera le unità nella loro identità per studiarle in quanto tali e come un qualcosa di stabile (um
ihrer Identität willen als wie ein Festes). La considerazione fenomenologico-costitutiva considera l’unità nel flusso
(Einheit im Fluss), vale a dire come unità di un flusso costituente; essa segue i movimenti, i decorsi nei quali una tale
73
200
�Le conclusioni della filosofia del conoscere. Appunti sul programma “razionalista” di Husserl e Bontadini
4.2. La storia della filosofia moderna, ovvero: della “lotta” delle razionalità
Proprio come nel caso della nostra ricostruzione del quadro bontadiniano, non riusciremo, in queste
poche pagine, a ripercorrere dettagliamene la comprensione husserliana di quella che si dice «storia
della filosofia moderna» - limitandoci quindi a indicarne i tratti che si riveleranno essere essenziali.
Per quanto concerne poi la questione, assai spinosa, molto dibattuta e tuttavia, purtroppo, assai
poco compresa, della «crisi delle scienze europee», ci limitiamo qui a segnalare come essa si
presenti – a partire già dal §3 della Krisis – come una “crisi di razionalità” nel senso della
Vernünftigkeit. Come Husserl puntualizza: rispetto all’«idea della filosofia» intesa come «scienza
della totalità dell’ente», della quale le singole scienze non sarebbero, cartesianamente, che rami, il
«concetto positivistico di scienza» è un «concetto residuale» 76 , che ha abbandonato tutte le
questioni e le domande metafisiche, le «domande supreme e ultime»77. Queste – come sottolinea
ancora Husserl – si caratterizzano tutte, unitariamente, per il loro riguardare «i problemi della
ragione», della Vernunft nelle sue «formazioni particolari» (Sondergestalten): quella della
«conoscenza» (der wahren und echten, der vernünftigen Erkenntnis), quella della dimensione
«assiologica» (von der wahren und echten Wertung), e quella dell’«agire» pratico (das wahrhaft
gute Handeln)78. È in quanto «essere di ragione» (Vernunftwesen) che l’essere umano è problema
metafisico, vale a dire squisitamente filosofico, e, nella misura in cui sia la sua “storia” a essere in
questione (seine Geschichte in Frage), è del senso che ne va, cioè della ragione nella storia (so
handelt es sich um den “Sinn”, um die Vernunft in der Geschichte). La “crisi” delle scienze
europee, essendo in verità la crisi dell’idea della filosofia come «scienza della totalità dell’essente»,
è in prima battuta il frantumarsi della connessione essenziale (Wesensverbundenheit) di Vernunft
und Seiendem überhaupt: «Essa [Vernunft] è quello che dà il senso ultimo, vale a dire il loro
riferimento normativo, a tutto quel che è inteso come essente, a tutte le cose, i valori, gli scopi: a ciò
che, dagli inizi della filosofia, viene indicato dalla parola verità (verità in sé) e, correlativamente,
dal termine essente (ὄντως ὄν)»79. La crisi dell’“umanità europea” si rivela dunque, a scrutarla da
vicino, come la crisi della Vernunft stessa: «Il fatto che l’essere umano perda questa fede [nella
ragione] non significa altro che la perdita nella fede in “se stesso”, nel suo proprio essere».
Quella che viene dispiegandosi è la cifra più profonda della lettura husserliana della parabola
della storia della filosofia moderna: le necessità di ripercorrerne le vicissitudini rispondendo al
bisogno di rintracciare l’origine, le modalità, dunque l’estensione, della contemporanea «crisi» della
Vernunft. Come enfatizza Husserl, le «battaglie spirituali dell’umanità europea» non sono altro che
battaglie tra filosofie (Kämpfe der Philosophien), tra quelle scettiche, che più propriamente
andrebbero chiamate «non-filosofie» (Unphilosophien), e quelle invece autentiche, che si battono
«per condurre all’auto-comprensione la ragione latente (latente Vernunft zum Selbstverständnis zu
bringen)»80.
Il compito – quello che si annuncia all’inizio del percorso della Krisis – di una Besinnung sul
senso delle nuove scienze, in particolare della scienza esatta della natura, ha come obiettivo quello
di porre in evidenza la nuova nozione di «razionalità» che essa reca seco. Galilei, come Husserl non
manca di ripetere, più che un nome proprio, rappresenta un nuovo ideale di Rationalität che si
unità […] è correlato di identità. Questa considerazione è, in una certa misura, cinetica o “genetica”» (Husserl (1952), p.
129). Senza istituire nessun confronto, si potrebbe sostenere che i caratteri che Bontadini ascrive alla razionalità (unità,
finalismo, assolutezza), la fanno corrispondere alla Vernünftigkeit: «La razionalità deve essere, per assunto, distinta dalla
semplice intelligibilità: poiché, mentre questa importa soltanto che una certa realtà possa essere oggetto di intellezione
[…], la prima esige certe determinazioni specifiche della realtà stessa ad esclusione di altre, che pure possano essere
parimenti intelligibili. Le determinazioni del reale di cui si tratta testé - unità, finalismo, assolutezza - sono insieme
determinazioni della razionalità e dell’intelligibilità, ossia sono tali che senza di esse l’Essere non solo non sarebbe
razionale, ma neppure intelligibile», Bontadini (1979) pp. 19-20.
76
Husserl (1962b), p. 6.
77
Si veda De Santis (2018a).
78
Husserl (1962b), p. 7.
79
Ivi, pp. 10-11.
80
Husserl (1962b), p. 13.
201
�Daniele De Santis
impone all’alba della modernità: «La vecchia filosofia non raggiunse la vera idea della razionalità
[…]. Questo nuovo ideale fu possibile solo seguendo il modello della matematica, della scienza
della natura e della loro trasformazione (neugestalteten)» 81 . A mutare, con l’imporsi di questo
ideale, è tanto l’idea di mondo, compreso in quanto mondo razionale in sé, quanto, più in
profondità, la concezione medesima della filosofia, da questo momento in poi presentandosi con
una fisionomia more geometrico 82 . Descartes, come puntualizza Husserl, è colui che, dopo la
fondazione galileiana della nuova scienza della natura, concepisce sistematicamente la nuova idea
di una filosofia universale, quest’ultima delineandosi sulla base del nuovo senso del matematico,
del «razionalismo fisicalista»83. Ma Cartesio, e qui la dialettica di razionalismo ed empirismo fa la
sua prima apparizione, è anche e soprattutto colui che, con le sue Meditationes, ha avviato un modo
di pensare che avrebbe disvelato il carattere “controsenso” di un simile razionalismo 84: con questo
dovendosi intendere quel rivolgimento soggettivo (Umsturz) che, attraverso le tappe del pensiero
inglese (Locke, Berkeley, Hume), avrebbe condotto a Kant e a quella filosofia trascendentale, della
quale la fenomenologia husserliana non rappresenta che la Endform, la «forma finale» e
definitiva85.
Cartesio è colui dal quale la duplice dialettica più sopra delineata prende l’abbrivio: ché
Descartes è colui che elabora il nuovo ideale della razionalità filosofica sulla base del Vorbild della
Rationalität galileiana; ma Descartes è anche colui nel cui pensiero la Vernunftskritik ha la sua
origine. Dialettica e lotta, adunque, tra la Rationalität, vale a dire la razionalità dell’“essere”
concepita sul modello della scienza esatta della natura, e la Vernünftigkeit, la razionalità del senso.
La filosofia post-cartesiana si presenta, quindi, non tanto come una «lotta contro la ragione» (come
direbbe Carlo Antoni86), con questo dovendosi intendere la lotta di una ragione contro un’altra,
quanto, piuttosto, come una lotta tra molteplici forme di razionalità – in primis tra la Vernünftigkeit
e la Rationalität. Ma se si afferma, come fa Husserl, che la filosofia autentica è sempre
Rationalismus, e che quindi l’abbandono di un razionalismo concepito sul modello della scienza
esatta della natura, detto anche «ingenuo», non può condurre all’abbandono di ogni razionalismo,87
allora si sta anche riconoscendo che la “storia della filosofia moderna” presenta il volto di una lotta
delle razionalità: quella tra la Vernünftigkeit e la Rationalität, e quella tra quest’ultima (ingenua) e
un’altra Rationalität (che si direbbe autentica).
Cominciamo a chiederci, allora, come, e in che senso, Descartes, che avrebbe assunto la
razionalità matematica a modello di razionalità filosofica, sia anche colui nella cui riflessione la
Vernunftskritik affonda le sue profonde radici. Senza poter qui ripercorrere le molte, e assai difficili,
pagine dedicate a questo tema da Husserl, limitiamoci a osservare come l’influenza del
razionalismo galileiano abbia come effetto la riduzione del soggetto a animus: «Descartes, qui, non
è già anticipatamente dominato dalla certezza galileiana di un mondo di corpi universale e
assolutamente puro, con la distinzione tra quel che è esperibile in modo puramente sensibile e quel
che, nel suo essere matematico, è affare del puro pensiero?»88. Rispetto a un mondo di puri corpi,
81
Ivi, p. 66.
Che il riferimento, piuttosto esplicito, sia a Spinoza, non dovrebbe stupire. Come Husserl puntualizza nel §11,
l’Ethica è «la prima ontologia universale»: «All’inizio cartesiano, egli è sin dal principio, naturalmente, del tutto
convinto che non soltanto la natura, ma la totalità dell’essere in generale debba essere un sistema razionale unitario»
(Husserl, 1962b, pp. 65-66).
83
Ivi, p. 75.
84
Ivi, p. 76.
85
Ivi, pp. 85-86. A pagina 70 si parla ad esempio del “trascendentalismo” come di una nuova forma di scientificità.
86
Si veda Antoni (1942), il cui progetto è descritto come una «ricerca delle origini dello storicismo, che vuol chiarire
come, quando e perché lo spirito tedesco si è volto contro la raison, contro la ragione matematica cartesiana, ed ha
cercato di sostituirla con una nuova ragione storica» (p. iii).
87
Husserl (1962b), pp. 200-201. Si veda anche p. 14: «Siamo adesso certi che il razionalismo del 18° secolo, e il
modo in cui esso vuole ottenere la pretesa stabilità del fondamento dell’umanità europea, era un’ingenuità. Ma
l’abbandono di un simile razionalismo ingenuo e, considerato nelle sue conseguenze, controsenso, significa anche
l’abbandono del senso αutentico del razionalismo?»
88
Ivi, p. 81.
82
202
�Le conclusioni della filosofia del conoscere. Appunti sul programma “razionalista” di Husserl e Bontadini
l’anima si presenta come un “residuo”, cioè un «elemento complementare» (Ergänzungsstück), che
alle stesse leggi dovrebbe sottostare: «L’anima è un qualcosa di reale in sé chiuso come un
corpo»89. Si delinea, immediatamente, a partire da queste prime battute, la lotta di una razionalità
(quella matematica della fisica galileiana del puro mondo dei corpi) con un’altra, la quale, propria
della sfera soggettiva, si direbbe comunque Rationalität90. È questa solo la prima delle due lotte,
quella cioè che si è detta “endogena” (α): la lotta che scaturisce da una razionalità dell’essere che, a
seguito della matematizzazione galileiana della natura, pretende estendere il proprio dominio oltre
di sé. Rationalität contro Rationalität. Ne consegue l’idea di una «sensibilità» che rimanda a un
«essente in sé», rispetto al quale essa può sì «errare», ma nei confronti del quale è sempre possibile
indicare una «via» razionale per coglierlo nella sua – specifica – in-seità. Ridotto a «elemento
complementare» del mondo dei corpi, e da esso separato come un “in sé”, l’ego vi si lega per mezzo
di una relazione concepita in termini di Schlüssen: «Quest’ingenuità - quasi inestirpabile - ha potuto
far sì che per secoli quasi nessuno abbia esaminato l’“ovvietà” dei passaggi [deduttivi] (Schlüssen)
dall’ego, e dalla sua vita cogitativa, verso un “fuori”, e ha fatto anche sì che, rispetto a questa sfera
d’essere egologica, non ci si sia mai chiesti se un “fuori” possa, in generale, aver senso»91. Come
osserva Husserl, introducendo la lotta “esogena” (β):
Sotto questa forma equivoca, nonostante la sovrapposizione dell’io psichico all’ego, nonostante la
confusione di immanenza psicologica e di immanenza egologica, dell’evidenza della percezione
«interna», o «auto-percezione» psicologica, e dell’auto-percezione egologica, le «Meditazioni» di
Descartes esercitarono un grande influsso storico ed agiscono ancora oggi. Descartes medesimo crede di
poter realmente dimostrare, attraverso passaggi conclusivi (auf dem Wege von Schlüssen) verso ciò che
trascende quello che è propriamente psichico, il dualismo delle sostanze finite (…). In tal modo, egli
ritiene di poter risolvere un problema che, per il suo atteggiamento contraddittorio, è importante e che
ritorna, sotto un’altra forma, anche in Kant: il problema di come le mie formazioni razionali, prodotte
nella mia ragione (wie die in meiner Vernunft erzeugeten Vernunftgebilde), (…) possano pretendere a una
validità oggettivamente «vera», a una validità metafisicamente trascendente. Ciò che l’epoca moderna
chiama teoria dell’intelletto o della ragione (Vernunft) in senso pregnante: critica della ragione
(Vernunftkritik), problematica trascendentale, ha le sue radici di senso nelle meditazioni cartesiane.92
Se – bontadinianamente – si vorrà cogliere in questo passaggio il riconoscimento, da parte di
Husserl, del problema del «presupposto», sarà bene allora precisare come ciò avvenga nel quadro,
dilacerante, delle due razionalità. Perché quello che Bontadini chiama il «presupposto» si delinea,
da una parte, come conseguenza dell’imporsi della Rationalität galileiana come «modello»
(Vorbild) di razionalità tout court; dall’altra, derivando da questa prima la dicotomia di res cogitans
ed extensa, il problema del presupposto si presenta sotto le mentite spoglie della Vernunftskritik,
vale a dire della critica della “ragione trascendentale” e dell’aspirazione, nutrita dalle sue stesse
formazioni, a esibire «una validità oggettivamente “vera”». In altre parole: se, dal punto di vista di
Bontadini, è la stessa Vernunftskritik a esplicitare il «presupposto» nella sua natura “problematica”,
in tal modo assumendo le fattezze del compito della risoluzione dell’alterità dell’essere al pensiero,
quest’ultima, in verità, è questione che rimanda all’aspra, e più profonda, dialettica di Rationalität e
Vernünftigkeit 93 . La quale si presenta, in prima battuta, come dialettica di «razionalismo» ed
«empirismo».
89
Ivi, p. 87.
Corrispondente, nel quadro statico delle Ideen… I, alla dualità delle due macro-regioni, quella della “pura
coscienza” e quella del “mondo”, in quanto due distinti domini ontologici, dunque soggetti a distinte leggi dell’essere.
91
Husserl (1962b), p. 82. Si noti come sia proprio qui che, secondo Husserl, ha la sua origine la cosiddetta «teoria
della conoscenza», intensa come dottrina della conoscenza che possa «trascendere» metafisicamente l’ego (ivi, p. 85).
92
Ivi, p. 83.
93
Come si è scritto con riferimento all’origine della comprensione bontadiniana del presupposto: «L’essere “esterno”
alla conoscenza è la natura quale veniva dipingendo la nuova meccanica, e sempre in consonanza con tale meccanica, la
natura veniva intesa come capace di esercitare sui nostri organi di senso delle azioni fisiche, nelle quali consiste l’origine
delle sensazioni» (Bontadini, 1996, pp. xiv-xv). Simile interpretazione è stata riproposta di recente, insistendo sul
«terreno indiscusso da cui muove l’intera ricerca scientifica» quale sfondo a partire dal quale si delineerebbe il carattere
90
203
�Daniele De Santis
La sequenza, quella che da Descartes, passando per Locke, conduce prima a Berkeley e poi a
Hume, si potrebbe delineare secondo il seguente “ritmo”. Se con il «sensualismo» di Locke, la
cartesiana res extensa è dichiarata, come trascendenza, inconoscibile, la totalità del mondo
materiale viene ridotto a un complesso di «dati di sensazione» da Berkeley, per poi compiersi, detta
riduzione, con Hume e la sua dissoluzione e del mondo materiale e di quello egologico. Se, con
riferimento a Berkeley, Husserl puntualizza, in generale, che «Il fondamento rimane il sensualismo
e l’apparente ovvietà che l’unico terreno indubitabile della conoscenza sia l’auto-esperienza e il suo
regno di dati immanenti» 94 , Hume «procede fino in fondo in questa direzione» (In diesen
Richtungen geht Hume bis ans Ende): «Tutte le categorie dell’oggettività, quelle scientifiche e prescientifiche per mezzo delle quali tanto la vita scientifica, quanto quella pre-scientifica, pensa un
mondo oggettivo, extra-psichico, sono finzioni»95.
Hume rappresenta dunque, di questa fase di radicalizzazione del discorso empirista che si
oppone e reagisce a quello razionalista, la «fine» (…bis ans Ende). La «fine» del discorso empirista
perché ne porta fino alle estreme conseguenze il presupposto, o l’ovvietà, come dice anche Husserl,
secondo cui «l’unico terreno indubitabile della conoscenza sia l’auto-esperienza e il suo regno di
dati immanenti»; ma anche, nello stesso tempo, la «fine» del discorso razionalista che quel
presupposto, od «ovvietà», aveva infatti determinato, modellando l’animus sulla base del corpus96.
Sembra ripresentarsi qui la bontadiniana “contraddizione” di razionalismo ed empirismo: l’uno
nutrendo l’altro, e viceversa, così facendo, tuttavia, minando se stesso (§3.2). A guardarla da vicino,
però, la situazione rivela un volto più articolato: se, da un lato, la radicalizzazione del discorso
«empirista» deriva dalla determinazione, «razionalista», dell’animus come elemento complementare
del mondo dei corpi, dunque dall’ovvietà di cui sopra – cosicché l’intero processo può essere
caratterizzato come un’“auto-dissoluzione” del «razionalismo» – dall’altro è necessario notare come
una tale dissoluzione colpisca sì la «razionalità» del mondo dei corpi e della loro pretesa
trascendenza (che viene a essere ricondotta, se non quando ridotta, a un insieme di dati immanenti),
niente affatto, tuttavia, la concezione dell’ego nei termini – psicologici – dell’animus (la quale,
come Husserl ripete, affligge ancora Kant97). Come egli osserva:
Questa linea di sviluppo [Locke, Berkeley, Hume] è particolarmente significativa perché rappresenta una
parte del percorso storico lungo il quale il trascendentalismo falsificato in senso psicologico da Descartes
«naturalistico» della più generale «alterità» dell’essere al pensiero: «Lo scienziato guarda infatti al mondo come ciò che è
strutturalmente altro da lui, come oggetto da indagare e, per questo, come realtà da ridurre alle sue componenti
misurabili» (Grion, 2008, p. 83). Come lo stesso autore scrive: «Lo gnoseologismo moderno mostra una certa sudditanza
nei confronti del sapere scientifico capace, a differenza della speculazione tardo-scolastica, di costruirsi come un sapere
efficace e incrementale. La filosofia moderna finisce dunque per svolgere un ruolo quasi di supporto rispetto al pensiero
scientifico, quanto meno nella misura in cui non si struttura come analisi critica di quanto la scienza assume
dogmaticamente, bensì come serrata rigorizzazione dei presupposti essenziali di quest’ultima», (Grion, 2012, p. 94).
Dobbiamo confessare tuttavia che, così presentata e delineata, questa “tesi” non riusciamo a ritrovarla direttamente in
nessuno degli scritti bontadiniani. Ora, che il pensiero moderno mostri una certa “sudditanza” nei confronti del sapere
scientifico, potrà essere vero; tuttavia, posta in questo modo, la tesi avrà valore “storico” (riferendosi a tale o tal altro
pensiero, vale a dire pensatore), giammai tuttavia “filosofico” strictu sensu: ché allora essa dovrebbe interrogare quel
pensiero medesimo che una tale sudditanza avrebbe autorizzata e capire come, e perché, esso si sarebbe in tal modo fatto
determinare. Come si è osservato in tutt’altro contesto e con riferimento a tutt’altri pensatori: «il ricorso alla storia
funziona come un alibi quando non si capisca, o non si voglia capire, che, se ha costituito una condizione e imposto
limiti, è al pensiero tuttavia che li ha imposti, sì che è in questo che deve cercarsi la ragione per la quale, se li ha subiti, li
ha subiti in quella determinata forma, che è la sua, inconfondibile» (Sasso, 2012, p. 18).
94
Husserl (1962b), p. 89.
95
Ibidem. Su questo punto, si veda De Santis (2018b).
96
«In questa prima forma di naturalismo, in base alla presunta esperienza l’anima è una sfera circoscritta e reale di
dati psichici, nell’unità chiusa di uno spazio di coscienza. L’ingenua equivalenza delle datità dell’esperienza psicologica e
di quelle dell’esperienza corporea conduce alla loro reificazione. […] le funzioni psichiche diventano delle analogie delle
forze fisiche, titoli per qualità meramente causali dell’anima» (Husserl, 1962b, p. 234).
97
Si veda ad esempio il lungo capoverso conclusivo del §31 (Kant und die Unzulänglichkeit der damaligen
Psychologie. Die Undurchsichtigkeit des Unterschiedes von transzendentaler Subjektivität und Seele).
204
�Le conclusioni della filosofia del conoscere. Appunti sul programma “razionalista” di Husserl e Bontadini
[…], dispiegando tutte le sue conseguenze, cerca di prendere coscienza della sua insostenibilità, e di
giungere in tal modo a un trascendentalismo più genuino e cosciente del suo vero senso.98
Se si volesse invece presentare questa linea di sviluppo nei termini della “lotta delle razionalità”, si
dovrebbe allora sostenere che quel che accade è che la Rationalität (galileiana), estendendosi oltre
se stessa, determinando quindi l’ego come animus, «elemento complementare» del mondo dei
corpi, di conseguenza stabilendo la suddetta «ovvietà» («l’unico terreno indubitabile della
conoscenza [è] l’auto-esperienza e il suo regno di dati immanenti»), fa sorgere il problema di come
«l’ego realizzi la conoscenza oggettiva nell’intenzionalità della sua ragione (attraverso atti di
ragione (Vernunft (durch Vernunftakte))» 99 ; ecco dunque che la Vernünftigkeit, esprimendo sé
stessa per mezzo della reazione dell’empirismo, conduce alla fine (…bis ans Ende) quest’ultimo e
anche quella Rationalität che, nella dicotomia di res cogitans ed extensa, aveva stabilito questa
come un «in sé». Persistendo, tuttavia, gli effetti della Rationalität (galileiana) nella determinazione
dell’animus, errerebbe colui che tentasse di interpretare questa «fine» come un passaggio
dall’essere al senso (vale a dire dalla Rationalität alla Vernünftigkeit). In Kant, infatti, non solo
quegli “effetti” si fanno ancora percepire in quanto tali, ma l’obiettivo della kantiana critica della
ragione consiste nell’esplicitazione del duplice «fungere» della Vernunft – che di quella Rationalität
vuole ristabilire, sì, la legittimità, stabilendone con questo anche i limiti: «La ragione ha un duplice
modo di fungere e di mostrarsi. Il primo modo è quello del suo auto-dispiegamento sistematico,
dell’auto-rivelazione nella libera e pura matematizzazione, del farsi delle scienze puramente
matematiche. […] Il secondo modo è quello del costante e segreto fungere della ragione […]. Il suo
risultato oggettivo è il mondo degli oggetti sensibili-intuitivi»100.
La storia della filosofia trascendentale, che da Kant conduce fino a Husserl, e che qui non
possiamo ricostruire in tutte le sue molteplici sfumature, e interne articolazioni, è sì una storia della
continua e progressiva liberazione della sfera del trascendentale dal pregiudizio naturalistico
(Vernünftigkeit vs Rationalität), ma anche, nello stesso tempo, dell’individuazione delle leggi
specifiche dello psichico (Seinsgesetze), che come un qualcosa di reale nello stesso senso della
«natura corporea», o come suo «elemento complementare», mai andrebbe concepito (Rationalität
vs Rationalität). Che questo, agli occhi di Husserl, non sarebbe stato possibile che grazie alla sua
fenomenologia (la quale avrebbe chiarito la differenza tra la “regione” mondo e quella coscienza,
dell’uno e dell’altra legittimando la legalità ontologica, cioè la rispettiva razionalità dell’essere), è
tesi che va qui sì menzionata, non già tuttavia, non volendo noi abusare ulteriormente della pazienza
del lettore, sviluppata.
5. Osservazioni finali: Husserl, «sorprendentemente»
Sbaglierebbe chiunque non vedesse, nelle precedenti pagine, che un tentativo, necessariamente
goffo, di “confrontare” Bontandini, Husserl e le loro rispettive “interpretazioni” della “storia della
filosofia moderna”. Se il nostro obiettivo è stato infatti, per quanto riguarda il primo, di metterne in
risalto la comprensione della posizione husserliana, del secondo volevamo esplicitarne la duplice
nozione di “razionalità”. La domanda sulla possibilità di leggere Husserl, come Bontadini di fatto
pretende, come un Giano bifronte, non ha, e non può avere, risposta facile. Se egli è infatti tale, per
il filosofo milanese, alla luce della scansione tra una filosofia “classica”, una filosofia “moderna” e
una filosofia “contemporanea”, indugiando la sua speculazione sulla soglia che dalla seconda
conduce alla terza, lo stesso si potrebbe sostenere se la si scorgesse a partire dalla sua stessa
prospettiva. La ragione, però, sarebbe in questo caso differente: se egli è tanto moderno quanto
contemporaneo (nel senso di Bontadini) è perché la tensione di gnoseologismo e metafisica, tradotta
nella dicotomia di razionalità dell’essere e razionalità del senso, convivendo nella “lotta delle
razionalità” propria della modernità, si ritrova in Husserl medesimo e nella sua fenomenologia
98
Husserl (1962b), p. 86.
Ivi, p. 85.
100
Ivi, p. 97.
99
205
�Daniele De Santis
trascendentale. Nessun lineare passaggio dalla filosofia classica a quella moderna e poi, per mezzo
dell’auto-risoluzione di quest’ultima, a una filosofia neo-classica in grado, finalmente, di riaprire “il
problema dell’essere”: perché il problema dell’essere, compreso da Husserl nei termini di una lotta
tra Rationalitäten, è inestricabilmente legato a quello della razionalità del senso, a sua volta
compreso come lotta tra Rationalität e Vernünftigkeit. Non un “essere” che andrebbe, alla fine,
recuperato, quasi si facesse necessario, come fu nel caso di Orlando, invocare Astolfo, per
riprenderlo, «come un liquor suttile e molle», racchiuso nell’ampolla sulla quale sarebbe scritto:
“Senno dell’essere” (il riferimento è a Orlando furioso, XXXIV).
Non dovrebbe stupirci, allora, lo stupore con il quale Bontadini, in un appunto di filosofia del
1961, registra il rinnovato interesse per il pensiero husserliano in Germania:
In Italia c’è stata una corrente filosofica, o, se si preferisce, un filosofo, che più di ogni altro s’è accostato
alla formulazione di quell’idealismo semplice e paradigmatico, cui noi facciamo riferimento. Si tratta di
Giovanni Gentile e dell’attualismo. Altrove lo stesso valore - sempre sotto una certa approssimazione deve essere attribuito ad altri esponenti della filosofia precontemporanea (ossia del momento conclusivo
della filosofia moderna). Per esempio, in Germania, a Edmund Husserl (sul quale ora sta
sorprendentemente rifluendo un larghissimo interesse).101
Non dovrebbe stupirci, il suo stupore, perché ne conosciamo l’origine: pensatore
precontemporaneo, Husserl – nel quadro di una filosofia contemporanea non più dominata dal
problema gnoseologico – non dovrebbe, in teoria, suscitare interesse alcuno; il suo destino, di oblio,
dovendosi accumunare a quello che travolse l’idealismo attuale di Gentile. Se però così non è stato,
se, «sorprendentemente», il pensiero husserliano sopravvive alla «conclusione della filosofia del
conoscere», è perché esso è in grado di proporre a partire da sé il programma di una
“razionalizzazione” dell’essere in tutti i suoi molteplici ambiti ontologici, in tal modo approdando a
una rifondazione della metafisica102.
Bibliografia
Antoni, C. (1942), La lotta contro la ragione, Sansoni, Firenze.
Bontadini, G. (1966), Studi di filosofia moderna, La Scuola Editrice, Brescia.
Bontadini, G. (1971), Conversazioni di metafisica. Due Volumi, Vita e Pensiero, Milano.
Bontadini, G. (1979), Saggio di una metafisica dell’esperienza, Vita e Pensiero, Milano.
Bontadini, G. (1995), Studi sull’idealismo, Vita e Pensiero, Milano.
Bontadini, G. (1996a), Dall’attualismo al problematicismo, Vita e Pensiero, Milano.
Bontadini, G. (1996b), Dal problematicismo alla metafisica, Vita e Pensiero, Milano.
Bontadini, G. (1996c), Appunti di filosofia, Vita e Pensiero, Milano.
Bontadini, G. (1996d), Metafisica e deellenizzazione, Vita e Pensiero, Milano.
Bontadini, G. (1996e), Studi di filosofia moderna, Vita e Pensiero, Milano.
Brentano, F. (1895), Die Vier Phasen der Philosophie und ihr augenblicklicher Stand, Verlag der
Cotta’schen Buchhandlung, Stuttgart.
Calogero, G. (1938), La conclusione della filosofia del conoscere, Le Monnier, Firenze.
Cappuccio, A. M. (2015), Gustavo Bontadini tra gli idealisti, Rubbettino, Soveria Mannelli.
De Santis, D. (2018a), “‘Metaphysische Ergebnisse’. Phenomenology and Metaphysics in Edmund
Husserl’s Cartesianische Meditationen (§60). Attempt at Commentary”, Husserl Studies, vol. 34,
n. 1, pp. 63-83.
De Santis, D. (2018b), Synthesis and Identity. Husserl on Kant’s Contribution to the History of
Philosophy, in I. Apostolescu-C. Serban (eds.), Husserl, Kant and Transcendental
Phenomenology, De Gruyter, Berlin (di prossima pubblicazione).
101
Bontadini (1996c), p. 151 («Dall’idealismo al problematicismo»).
Su questo aspetto, sul quale non possiamo soffermarci, e sul quale molta confusione ancora domina, si veda Trizio
(2017).
102
206
�Le conclusioni della filosofia del conoscere. Appunti sul programma “razionalista” di Husserl e Bontadini
Faulkner, W. (1990), As I Lay Dying, Vintage International, New York.
Gentile, G. (2014) L’attualismo, Bompiani, Milano.
Grion, L. (2008), La vita come problema metafisico. Riflessioni sul pensiero di Gustavo Bontadini,
Vita e Pensiero, Milano.
Grion, L. (2012), Gustavo Bontadini, Lateran University Press, Roma.
Husserl, E. (1939), Erfahrung und Urteil, Academia, Prag.
Husserl, E. (1952), Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie.
Drittes Buch: Die Phänomenologie und die Fundamente der Wissenschaften, M. Nijhoff, Den
Haag.
Husserl, E. (1956), Erste Philosophie (1923-1924), M. Nijhoff, Den Haag.
Husserl, E. (1962a), Phänomenologische Psychologie, M. Nijhoff, Den Haag.
Husserl, E. (1962b), Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale
Phänomenologie, M. Nijhoff, Den Haag.
Husserl, E. (1973), Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge, M. Nijhoff, Den Haag.
Husserl, E. (1974), Formale und transzendentale Logik, M. Nijhoff, Den Haag.
Husserl, E. (1976), Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie.
Erstes Buch: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie, M. Nijhoff, Den Haag.
Husserl, E. (1984), Einleitung in die Logik und Erkenntnistheorie. Vorlesungen 1906/07, Kluwer
Academic Publisher, Dordrecht.
Husserl, E. (2001), Allgemeine Erkenntnistheorie 1902/03, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht.
Husserl, E. (2012), Einleitung in die Philosophie. Vorlesungen 1916-1920, Springer, Dordrecht.
Husserl, E. (2014), Grenzprobleme der Phänomenologie. Analysen des Unbewusstseins und der
Instinkte. Metaphysik. Späte Ethik, Springer, Dordrecht.
Maschietti, S. (1998), “L’esperienza e i suoi fondamenti metafisici nel pensiero di Gustavo
Bontadini”, Annali dell’Istituto italiano per gli studi filosofici, pp. 544-632.
Maschietti, S. (2000), “Sull’interpretazione bontadiniana dell’idealismo attuale”, La Cultura, vol. 3,
pp. 415-471.
Olgiati, F. (1922), La filosofia di Enrico Bergson, Fratelli Bicocca, Torino.
Sasso, G. (2012), La voce dei ricordi, Bibliopolis, Napoli.
Trizio, E. (2017), “Husserl’s Early Concept of Metaphysics As the Ultimate Science of Reality”,
Phainomenon, vol. 26, pp. 37-68.
Vanni Rovighi, S. (1939), La filosofia di Edmund Husserl, Vita e Pensiero, Milano.
Vigna, C. (a cura di) (2008), Bontadini e la metafisica, Vita e Pensiero, Milano.
Visentin, M. (2010), Il neoparmenidismo italiano II. Dal neoidealismo al neoparmenidismo,
Bibliopolis, Napoli.
Zappoli, S. (2011), Guido Calogero (1923-1942), Edizioni della Normale, Pisa.
Abstract
The present paper wants to offer neither a Husserlian reading of Gustavo Bontadini, nor a
“Bontadinian” interpretation of Husserl’s transcendental phenomenology. My aim is more
circumscribed, and yet systematic: it consists in providing an examination of both Husserl’s and
Bontadini’s interpretation of the history of modern philosophy from Descartes to Kant, in order to
bring to the fore analogies and differences between the two. As I will show, Husserl’s reading of the
history of modern philosophy is based on a twofold notion of rationality, or, rather, he distinguishes,
quite accurately, two concepts of rationality - whose struggle animates and characterizes, from
within, the philosophical trajectory of modernity.
Keywords: Bontadini G., Calogero G., Husserl E., Idealism, Phenomenology, Rationality
207
�EDUARDO GONZÁLEZ DI PIERRO*
Patočka y Henry. A-subjetividad y Fenomenología material:
dos modalidades de realismo fenomenológico
Introducción
El presente escrito pretende ser un estudio comparativo – preliminar, sin duda – entre Patočka y
Henry, donde sus respectivas propuestas pueden desembocar en un realismo fenomenológico que,
pese a lo que pudiera pensarse e interpretarse, no está alejado de la matriz husserliana originaria,
pues no se trata de un realismo como el de los primeros discípulos de Gotinga, sino lo que se ha
dado en llamar actualmente “realismo trascendental” como expresión del momento del aparecer en
tanto momento central del proyecto fenomenológico iniciado por Husserl. Las propuestas que
hemos elegido son, para el caso de Patočka, su “fenomenología a-subjetiva”, y, para el caso de
Henry, su “fenomenología material”.
Debemos, por tanto, iniciar brevemente con la aclaración preliminar, que en la conclusión será
ampliada, de qué entendemos aquí por “realismo fenomenológico”1. Lo primero que diremos es que
no se trata de ese tipo de realismo que suele adscribirse a la mayor parte de los primeros
fenomenólogos del así llamado “Círculo de Gotinga”, aunque las referencias a ellos se vuelven casi
inevitables. Se trata, más bien, de entender que la fenomenología husserliana se coloca en un punto
en que se trasciende la polémica realismo-idealismo, aunque ésta se reedite de vez en vez en el
transcurrir de todo el movimiento fenomenológico. Lo que aquí sostenemos es la tesis de que el
llamado “giro trascendental” de Husserl no es un retorno al idealismo clásico en ningún sentido,
como de hecho lo interpretaron precisamente los fenomenólogos de Gotinga, o bien en el sentido en
que, en diferentes contextos y desarrollos, fue entendido por algunos importantes epígonos de la
fenomenología, entre otros, por ejemplo, Paul Ricoeur o, más recientemente, Jean-Luc Marion.
Este trabajo se divide en cuatro breves apartados, además de esta introducción. El primero se
refiere a una reconstrucción e interpretación del contenido del parágrafo 55 de Ideas I de Edmund
Husserl, como paradigmático de la posición husserliana respecto de lo que él mismo denomina
equívocamente “idealismo trascendental”, pero que no es un idealismo de corte kantiano-fichteano.
El segundo está consagrado a la conocida formulación de una “fenomenología a-subjetiva” en Jan
Patočka, en relación justamente con los contenidos husserlianos mostrados en el apartado anterior.
*
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
1
Nos adherimos a la concepción de un “realismo fenomenológico” en la línea de Angela Ales Bello, la connotada
especialista en la fenomenología de Husserl, así como de Edith Stein; Ales Bello construye la noción de “realismo
trascendental” como la auténtica caracterización de lo que, equívocamente, Husserl acuñara en su momento como
“idealismo trascendental”; se trata aquí, por un lado, de revertir de una vez por todas las interpretaciones tradicionales,
iniciadas entre otros por pensadores de la talla de Paul Ricoeur, en el sentido de considerar la posición de Husserl como
un retorno a un idealismo subjetivo como el del idealismo clásico alemán – como por otro lado consideraron la mayoría
de los primeros discípulos del “Círculo de Gotinga” – y, por otro, de establecer un debate con lo que actualmente se
conoce como “nuevo realismo” o “realismo especulativo”, principalmente en la vertiente italiana, capitaneada por
Maurizio Ferraris. Véase, al respecto, Ales Bello (2013); y Shahid y Cortellesi (2015).
Bollettino Filosofico 33 (2018): 208-216
ISSN 1593 -7178 - 00030
E-ISSN 2035 -2670
DOI 10.6093/1593-7178/5944
�Patočka y Henry. A-subjetividad y fenomenología material
El tercero se refiere a la exposición sintética de la “fenomenología material” de Michel Henry,
relacionada con el mismo texto husserliano del inicio. El cuarto apartado muestra unas breves
conclusiones en las que se pretende establecer un paralelismo entre las propuestas de Henry y
Patočka como modalidades de lo que podemos denominar “realismo trascendental” y que no
representarían una “superación” o “corrección” de la concepción de Husserl, sino más bien su
desarrollo radical.
1. El punto de partida: el parágrafo 55 de Ideas I
Me parece importante partir de las consideraciones que se desprenden del importante parágrafo 55
del primer volumen de Ideas, porque ilustran el núcleo de la verdadera posición de Husserl respecto
del problema central que desarrollarán, entre otros, tanto Jan Patočka como Michel Henry, y que es
el propósito central de esta comunicación.
En principio, Husserl enuncia que las unidades reales son “unidades de sentido”. Esto, a su vez,
nos remite, necesariamente a una instancia que es la que suministra el sentido, y tal instancia no
puede ser otra que la conciencia. El problema es que no es posible absolutizar la realidad
emparejándola con la totalidad del ser, de ahí la palmaria afirmación de Husserl, fuerte en su
formulación: «Una realidad absoluta es exactamente lo mismo que un cuadrado redondo»2. Por
supuesto que Husserl es el primero en ser consciente de los problemas y objeciones que puede
implicar su tesis, que se desarrolla desde el principio de esta sección, e inmediatamente replica,
anticipando posibles cuestionamientos: «A quien en vista de nuestras discusiones objete que esto
significaría convertir todo mundo en ilusión subjetiva y echarse en los brazos de un “idealismo
berkeleyano” sólo podemos replicarle que no ha captado el sentido de estas discusiones»3. Luego,
Husserl enfatiza que no se trata de una negación de “lo real”, sino de un rechazo a una
interpretación de tal esfera que implica contradicción. Después de un despliegue de argumentación
lógica, Husserl concluye diciendo que «Éste [el contrasentido] sólo brota cuando se filosofa y,
buscando una razón última sobre el sentido del mundo, no se nota en modo alguno que el mundo
mismo tiene todo su ser como un cierto ‘sentido’ que presupone la conciencia absoluta como campo
del dar sentido»4.
Hacia la parte final, Husserl previene a quien pueda extrañarse o incluso escandalizarse con la
afirmación de que el mundo natural se constituye en la conciencia absoluta de que no lo haga,
prometiendo – como de hecho lo hará – que más adelante esclarecerá ciertos huecos o detalles que
en este momento pueden quedar pendientes, y señalando, para concluir, que lo que le interesa es,
preliminarmente, dar cuenta de lo que significa realmente una “conciencia trascendentalmente pura”
y, sobre todo, el hacer ver con claridad que la reducción fenomenológica es posible y que pensar
que «después de su ejecución queda la conciencia absoluta o trascendentalmente pura como un
residuo al que seguir atribuyendo realidad, es un contrasentido»5.
2
Husserl, E., Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. Libro primero:
Introducción general a la fenomenología pura, refundición de la traducción de J. Gaos de Antonio Zirión, UNAMIIF/Fondo de Cultura Económica, México, (2013), p. 204.
3
Ivi, p. 205.
4
Ibidem.
5
Ibidem.
209
�Eduardo González di Pierro
2. Patočka: la fenomenología a-subjetiva como Realismo
Como sabemos, el filósofo checo Jan Patočka se encuentra entre los más importantes y lúcidos
continuadores de la fenomenología husserliana, en inevitable relación de crítica y pretendida
superación, pero siempre argumentando y fundamentando cuidadosamente su interpretación y
posición acerca de Husserl. Se trata de un pensador que centró la atención en el aspecto, por así
llamarlo aún, objetivo de la fenomenología husserliana, pero da una explicación interesante respecto
del polo subjetivo de la misma, en el sentido de una reformulación de lo que él considera el
proyecto fenomenológico desde su momento fundacional en Las investigaciones lógicas. Ha
generado equívocos el hecho de que la fenomenología patočkiana haya sido denominada
“fenomenología a-subjetiva”, llegando incluso a pensarse, temerariamente, que el filósofo checo se
inserta nuevamente en el filón de la llamada “fenomenología realista” del círculo gotinguense; nada
más alejado de la verdad, como podemos constatar en varios pasajes en que Patočka interpreta y
comenta la fenomenología de Husserl. Me centraré sólo en algunas consideraciones que se
encuentran en su texto Platón y Europa, así como en su Introducción a la fenomenología.
La crítica que Patočka le mueve a Husserl, ayuda al mismo tiempo al esclarecimiento de las
consideraciones trascendentales vertidas en los primeros parágrafos de Ideas I, y confluye en el
núcleo de las conclusiones del parágrafo 55 que, como señalamos al principio, es fundamental como
base de las consideraciones que aquí queremos mostrar. Y es que, para el pensador checo,
paradójicamente, la formulación husserliana que presenta a la fenomenología como cierta doctrina
de la subjetividad, aun siendo trascendental, no es radical6 , al menos no como según Patočka
debería ser. Y es que, según él, lo importante es destacar el aspecto de la aparición como
fundamental y fundante de la fenomenología husserliana. Algo aparece a alguien, y esta estructura,
de acuerdo con Patočka es típica y necesaria para toda objetividad. «Y esta regularidad es
justamente la manera en que los objetos se dibujan progresivamente y se construyen en relación con
la subjetividad, o sea, aquello que Husserl llama constitución»7. Es decir, el aparecer debe surgir
ante la conciencia de manera pura, sin un sustrato, por así llamarlo, “real”; la afirmación de Patočka
es, efectivamente, radical: «El fundamento último y más profundo de la explicación filosófica, la
respuesta última a la pregunta de la filosofía, no puede ser ningún ente. La estructura del aparecer
ha de basarse sobre sí misma»8. Nosotros, por nuestra parte, podemos decir que cuando se dice
“ningún ente”, se refiere a que no puede ser ni la objetividad en sentido puramente empírico, pero
tampoco la subjetividad – ésta última también es un ente.
Ahora bien, lo anterior implica el que la propia subjetividad ha de mostrarse bajo la forma de una
aparición. Pero veamos lo que dice el propio Patočka del aparecer en este sentido, aun en su
radicalidad: «Esto no significa de ninguna manera que sea posible un aparecer que no aparezca a
nadie» 9 . La fenomenología es ciencia del aparecer y, en cuanto tal, siguiendo a Patočka, el
problema se asienta en el equívoco del fenómeno mismo que se da por sí y en sí, y que consiste en
el hecho de que el fenómeno excede al puro presente y nos suministra siempre más que el presente.
La argumentación de Patočka es como sigue: “El fenómeno me da la cosa, y la cosa no entra en el
presente, la cosa es algo más. El fenómeno, justo en tanto fenómeno del ente, no es el ente en cuanto
tal. Es verdad que el fenómeno pretende ser éste, aquí y ahora, la cosa presente, pero se trata de una
6
Patočka (1998 2), p. 69.
Ibidem.
8
Ibidem.
9
Ivi, p. 70.
7
210
�Patočka y Henry. A-subjetividad y fenomenología material
pretensión que es necesario comprobar. ¿Cómo se comprueba? Con otros fenómenos del mismo
tipo”10.
Ya señalamos hace un momento que la denominada “fenomenología a-subjetiva” de Patočka, no
es, como algunos han querido ver de manera completamente errónea, una reformulación de la así
llamada “fenomenología realista” de algunos de los primeros discípulos de Gotinga. Patočka
subraya que la esfera fenoménica está regulada por leyes propias que son muy distintas de las leyes
tanto de la mente como del objeto empírico, por lo que el ámbito fenoménico es más profundo que
el ámbito psíquico y físico, pues la esencia de la esfera fenoménica radica en el manifestar las cosas
tal como éstas se dan. En palabras del propio Patočka: «La legalidad o, si queremos, la estructura
del aparecer, es completamente independiente de la estructura de las cosas que son; no se puede
deducir la manifestación en cuanto tal ni de las estructuras objetivas, ni de las estructuras
psíquicas»11. Esta última afirmación refuerza nuestra convicción de la profunda comprensión por
parte del “Sócrates de Praga” respecto de la estructura fenomenológica de la relación noesis-noema,
en la que él simplemente privilegia el aparecer como esencia del fenómeno y este aparecer se sitúa
en el ámbito de correlación absolutamente necesaria entre el polo noético y el polo noemático y no
en alguno de los dos.
Lo que Patočka enfatiza es lo que, a su modo de ver, constituye la fidelidad al principio
metodológico de la fenomenología, a saber, la descripción rigurosa de lo que aparece, sin nada que
lo “contamine”, por así decir; y para el filósofo checo, toda referencia a la subjetividad representa
un obstáculo para comprender la realidad que la fenomenología misma pretende describir, de tal
manera que desplaza la idea de la fenomenología como “ciencia de la subjetividad trascendental” a
una “ciencia del aparecer en cuanto tal” y se instaura como una investigación sobre las estructuras
que soportan esta dimensión del aparecer. No se trata de una cuestión puramente metodológica,
aunque desde luego lo es, sobre todo como punto de partida necesario. Es importante enfatizar que
la subjetividad trascendental husserliana no se encuentra tematizada más que en correlación
persistente e inseparable de lo real, del mundo, por lo que, aun aceptando que la dimensión
trascendental se remita al ámbito subjetivo, esto no significa de ninguna manera que la
“objetividad” de lo real esté subordinada o se vea socavada por la conciencia pura.
De este modo, la advocación “a-subjetiva” de la fenomenología construida por Patočka,
representa, a sus ojos, una muestra de fidelidad al propio Husserl, pues sería el cumplimiento
original de su voluntad en el momento fundacional de la propia fenomenología. Escribe Patočka:
«[…] lo que Husserl proponía como novum frente a la tradición filosófica […], eso justamente es lo
que hace falta estudiar, es el ámbito en el que el fenómeno, el aparecerse de las cosas, se encuentra
en su casa» 12. Y explica el sentido de su crítica en los siguientes términos: «Nuestra crítica es
precisamente crítica en nombre de la misma fenomenología, en nombre del principio filosófico
husserliano y de su principio de todos los principios: que el fundamento de todo conocimiento, por
razones obvias contra las que nada se puede objetar, siempre es la experiencia, la intuición
experiencial, y que de esa experiencia se deben deducir todos los argumentos que podamos producir
posteriormente»13.
10
Ibidem.
Ivi, p. 60.
12
Patočka (2005), p. 104.
13
Ivi, p. 105.
11
211
�Eduardo González di Pierro
Así, la fenomenología a-subjetiva no tiene el significado de una fenomenología “sin sujeto”; es
el resultado de una radicalización – que no una negación, como a veces se ha querido pensar – de la
epojé husserliana que Patočka lleva a cabo en su programa de repristinación de lo que él considera
el cometido fenomenológico original. La subjetividad no es negada, como lo señala Patočka: «No
queda afectada [por la crítica] a autoseguridad del cogito, es decir, que ego cogito es algo
garantizado por sí mismo y que dubito ergo sum es una evidencia absoluta»14. Lo que sucede es que
el sujeto está sometido al aparecer mismo; el aparecer lo precede necesariamente. Patočka no niega
que las cosas se aparezcan a una subjetividad, pero llama la atención que esta subjetividad, a su vez,
aparece ella misma, como las demás cosas. Los análisis de Husserl acerca de la subjetividad, son
considerados como importantes y válidos a los ojos de Patočka, pero deben ser sometidas a
indagaciones de mayor profundidad, es decir, dentro de una perspectiva que no sea solamente
gnoseológica, sino ontológica; efectivamente, como se ha tratado de mostrar, es la “estructura
ontológica” presidida por el ser-en-la-aparición, la condición de posibilidad de la conciencia, y no al
revés. Es por ello, que podemos denominar esta perspectiva de Patočka como modalidad de
realismo trascendental.
3. Henry: la fenomenología material como realismo trascendental
La principal crítica que Henry le dirige a Husserl en general a lo largo de su obra, pero
principalmente en l’Essence de la manifestation y sobre todo en Phenomenologie materielle, es,
paradójicamente, no ser “suficientemente trascendental”. Y es que, en cierto sentido, lo que
encontramos en la fenomenología de Henry es, justamente, una radicalización del pensamiento
husserliano, más que una superación o una pretendida inversión o corrección como la que sí se dio
en otros epígonos; al igual que para otro caso paradigmático, me refiero al gran filósofo checo Jan
Patočka, Henry parece descender a estratos aún más hondos que el del aparecer, es decir, hacia las
condiciones mismas de posibilidad de ese aparecer, lo que, de acuerdo con él mismo, significaría
una auténtica fenomenología trascendental. En Henry no se trata únicamente de identificar la
Gegebenheit como dación originaria ante la conciencia, sino de dar cuenta de la naturaleza última
del darse mismo de ésta. No podemos realizar un desarrollo mayor sobre esto por exceder a los
propósitos de este trabajo, pero es importante tomarlo en consideración como horizonte sobre el
cual Henry desarrollará su pensamiento de madurez. Baste para ello, la siguiente cita, significativa
porque puede servirnos no sólo como ilustración de cuanto hemos dicho hasta aquí, sino como
enlace al importante tratamiento de la dimensión corporal en Henry en Encarnación. Escribe el
pensador francés en Fenomenología Material: «Así, la fenomenología husserliana no conoce, en
lugar de la Impresión, más que su ser constituida, su ser ofrecida a la intencionalidad o a una protointencionalidad. Es cuando se le enfrenta con su objeto propio que la fenomenología hylética cae en
una fenomenología de la constitución, y es entonces que los grandes problemas del cuerpo, del ego,
etc. se reducen a ‘problemas constitutivos’, como puede verse en Ideen II»15.
Ahora bien, para Henry, el cometido fenomenológico radica en centrar su reflexión no tanto
sobre los fenómenos, sino sobre la fenomenalidad, lo que equivale a decir que la principal
preocupación fenomenológica se desplaza de lo fenoménico como tal a su modo de aparecer. Como
señala Henry: “no lo que aparece, sino el aparecer” 16 . La afirmación, de clarísimos ecos
14
Ivi, p. 106.
Henry (2001), p. 83.
16
Ivi, p. 62.
15
212
�Patočka y Henry. A-subjetividad y fenomenología material
patočkianos, es asumida como la tarea principal de la fenomenología material, es decir, la
radicalización de la fenomenología que el propio Henry denomina como “clásica”. De aquello que
no aparece, nada podemos saber, y por eso el aparecer es el fundamento de lo que aparece. La
pregunta central es, entonces, ¿qué es este aparecer en sí mismo, y qué aparece en él? El aparecer
auto-aparece, y esto, de acuerdo con la interpretación henryana es un sentir que se dirige a sí, un
sentir-se, pero un sentir-se de la Vida, de donde se desprende la conocida noción de auto-afección
que es, en última instancia, una auto-revelación. Una revelación que carece de objeto, que es
entendida como la manifestación en su poder mismo de manifestarse, sin que exista un depositario
que lo reciba. No es un manifestarse-a, que exigiría un complemento, sino un puro manifestarse o
de un revelarse-para, lo que, a los ojos de Henry, es una forma de filosofía de la trascendencia y,
según él, Husserl cae en esta perspectiva todavía, porque la estructura de la fenomenalidad en
Husserl es consecuencia de su concepto de intencionalidad como un algo que está frente-a otra cosa
y que le es, por tanto, trascendente, por mucho que se esfuerce en enfatizar que tal trascendencia se
da siempre quoad nos y por tanto estaría en un plano de inmanencia; para Henry, de cualquier
modo, hay un primado de la trascendencia, aunque no se trate de la trascendencia in se o absoluta:
«Digamos simplemente aquí […] que la fenomenología material tal como yo la concibo, es
resultado de esta reducción radical de toda trascendencia»17.
Podemos decir que en Henry, como en Patočka, también se formula una suerte de filosofía asubjetiva; pero en Henry esta a-subjetividad se da por una radicalización de la subjetividad, la
radicalización de la inmanencia de la subjetividad, que a su vez genera precisamente la idea de que
la vida no es otra cosa que una afectividad trascendental, porque se refiere únicamente a sí misma y
nada más. Es decir, lo que en Patočka denominamos como “fenomenología a-subjetiva”, en Henry
la llamamos “fenomenología no-intencional”. En palabras del propio Henry: «es la fenomenología
clásica la que choca contra la imposibilidad de producir un conocimiento teórico de la subjetividad
absoluta, llevando así ella misma la prueba de que la vida trascendental se sustrae a toda
aproximación intencional […]»18.
De acuerdo con Henry, la gran aportación husserliana fue la de haber teorizado una vía
metodológica, así como haber identificado una cuestión que es esencial a la filosofía: el aparecer,
como la manera en que los fenómenos se dan. Hay dos elementos principales que caracterizarían
este modo de entender a la fenomenología: en primer lugar, que el propio aparecer se vea
reformulado para que el movimiento fenomenológico se renueve a su vez; en segundo lugar, como
ya se mencionó líneas arriba, la radicalización de la reducción fenomenológica, que significa
identificar la constitución típica de la materialidad fenomenológica.
La fenomenología fundada por Husserl gira alrededor del eje de la idea de intencionalidad;
parece ser por lo menos problemático, pensar de manera distinta; sin embargo, Michel Henry acepta
el reto de formular una fenomenología no-intencional. La problematicidad de la fenomenología ha
de confrontarse con la forma en que el aparecer mismo se manifiesta, y Henry enfatiza cómo en
Husserl se da toda manifestación como donación originaria pero confiada a la intencionalidad. Al
interior de esta estructura, el aparecer se distingue claramente de aquello que aparece, y bajo el
dominio de la intencionalidad se sucumbe también al dominio de la re-presentación, lo cual es
claramente anti-fenomenológico a los ojos de Henry porque el auto-aparecer del aparecer como tal
17
18
Ivi, pp. 68-69.
Ivi, p. 64.
213
�Eduardo González di Pierro
se desvanece. Será pues, entonces, necesario, desmarcarse de la intencionalidad, para llegar al
momento de la “donación pura” del aparecer como auto-aparecer.
Para ello, será necesario llevar a cabo una reducción radical, diferente de la que Husserl propone
inauguralmente para poder eliminar la dimensión intencional y permitir, así, que el auto-aparecer
emerja en su pureza, aterrizando precisamente en la noción henryana de Vida; es ésta la que permite
al fenómeno desplegarse en su sentido prístino y originario, porque es ella la única que puede autoexperimentarse; es la condición de posibilidad para la inteligibilidad de la realidad antes de
cualquier subjetividad que se precie de ser el último residuo; a la subjetividad intencional le
precede, de cualquier manera, la Vida como auto-afección; esta “fenomenología de la vida” tiene
como operación central una reducción radicalizada que permite llegar realmente al último sustrato
del horizonte de sentido que no es, de ninguna manera, la intencionalidad de la conciencia, sino la
estructura misma del aparecer dentro de la cual, pero ya en un momento ulterior, podría edificarse la
vida intencional.
4. Breve conclusión
De esta manera, podemos darnos cuenta de cómo las propuestas de Patočka y Henry pueden muy
bien considerarse expresión de una fenomenología no-egológica, para decirlo en palabras de Aron
Gurwitsch. Y esta fenomenología no-egológica es interpretada aquí como lo que podemos llamar,
en el debate actual, “realismo fenomenológico”, tal como lo presentamos en la introducción de este
trabajo. Se trata, más que de una “inversión de la fenomenología”, de una “radicalización” de la
misma, donde se privilegia el momento del aparecer como fundante tanto de lo que aparece como
de “a quién aparece”. Nos encontramos en el corazón de la fenomenología husserliana a través de
dos de sus más lúcidas interpretaciones y desarrollos.
El “realismo fenomenológico” que podemos encontrar tanto en la a-subjetividad de Patočka,
como en la no-intencionalidad de Henry, reedita el problema de la relación entre fenomenología y
ontología, o bien de la fenomenología como ontología, porque la cuestión del sentido de las cosas
en tanto fenómenos, abre y mantiene abierta la concepción de que la fenomenología es, desde su
origen husserliano, una forma de realismo, y que quienes la han concebido como un “idealismo” lo
han hecho bajo una lectura estandarizada de las obras de Husserl, principalmente Ideas I, con poca
profundidad y escasa confrontación con la totalidad de la obra husserliana como un proyecto
integral en línea de continuidad.
Respecto de Patočka, encontramos que la fenomenología a-subjetiva se funda principalmente en
la crítica a la idea de reducción: «Ni la reducción fenomenológica, que pone un sujeto absoluto y
trascendental, ni la psicología puramente eidética […], son caminos transitables filosóficamente»19.
La a-subjetividad no niega al sujeto trascendental, pero lo subordina al aparecer, porque incluso el
sujeto, digámoslo así, por trascendental que sea, aparece; su consistencia ontológica emerge de una
anterioridad que no es subjetiva, pero trascendental de acuerdo con el sentido fenomenológico del
término. En palabras de Patočka, «el proceso de mostrarse en cuanto tal es el tema de la
fenomenología»20.
Para Henry, la crítica a la reducción está igualmente presente, pero, como vimos someramente,
es una crítica que no consiste en la superación de esta operación, sino en su radicalización. Esta
radicalización permite la disolución de la intencionalidad que, a los ojos del filósofo francés, impide
19
20
Patočka (2005), p. 106.
Ivi, p. 107.
214
�Patočka y Henry. A-subjetividad y fenomenología material
la captación de la manifestación misma, que es el cometido fenomenológico central, tal como, en
otros términos, se vio expresado en la última cita del filósofo checo que hicimos líneas arriba.
Ninguno de los dos fenomenólogos excluyen, como algunos piensan, a la subjetividad del interés
fenomenológico. Lo que hacen es anteponer la condición de posibilidad misma de tal subjetividad:
Patočka, en la estructura misma del aparecer; Henry, en la esencia de la manifestación que es la
Vida como auto-afección originaria que condiciona al contenido de lo que aparece, incluida la
subjetividad.
Pero en ambos filósofos podemos aplicar la lectura de una formulación “realista” de la
fenomenología husserliana, enfatizando lo que está fuera y antes del sujeto trascendental, y que
sería la realidad misma, no aquella que está constituida por una objetividad material o empírica,
cósica, sino la que se constituye por una hyle que, como ya en Husserl, instaura una materialidad
“ampliada”, por así decir, y que testimonia cómo ya, desde un inicio, el fundador de la
fenomenología tiene en el horizonte de su proyecto el carácter no-intencional, no ignora la nointencionalidad, y ahí radica para él el sentido originario de las cosas, sentido que se completa –
pero no se crea – por un sujeto que está inexorablemente sometido a y precedido por el aparecer
(Patočka), o bien, por la manifestación misma (Henry).
Bibliografìa
Ales Bello, A. (2013), Il senso delle cose. Per un realismo fenomenologico, Castelvecchi, Roma.
Costa, V. (2007), Il cerchio e l’ellisse. Husserl e il darsi delle cose, Rubbettino, Soveria Mannelli.
Costa, V. (2009), Husserl, Carocci, Roma.
Costa, V. (2014), Il movimento fenomenologico, La Scuola, Milano.
Henry, M. (2001), Fenomenologia materiale, Guerini e associati, Milano.
Husserl, E. (2007), Filosofia prima. Teoria della riduzione fenomenologica, Rubbettino, Soveria
Mannelli.
Husserl, E. (2013), Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. Libro
primero: Introducción general a la fenomenología pura, refundición de la traducción de J. Gaos
de Antonio Zirión, UNAM-IIF/Fondo de Cultura Económica, México.
Patočka, J. (19982) Platone e l’Europa, Vita e Pensiero, Milano.
Patočka, J. (2005), Introducción a la fenomenología, trad. de Juan Sánchez, rev. de Iván Ortega,
Herder, Barcelona.
Shahid, M.-Cortellesi, B. (a cura di) (2015), La sfida del realismo trascendentale. Intorno ad una
proposta di Angela Ales Bello. Qulture Edizioni, Roma.
Abstract
As is well-known, the Czech philosopher Jan Patočka is one of the most important and
sharp continuers of Husserl phenomenology: in an inevitable critical relationship he aims at
overcoming Husserl’s perspective, always accurately taking into account the Master’s
thought. Patočka has always focalized his attention on the so to say objective aspect of
Husserl’s phenomenology. However, he presents an interesting explanation of the
subjective one through a reformulation of the phenomenological project in the moment of
its foundation in Logical Investigations. It has caused several misunderstandings, thus
Patočka’s phenomenology has been defined an “asubjective phenomenology”, leading to
the inclusion of Patočka among the so-called “realist phenomenology” of the Göttingen
Circle. This is totally incorrect, as we can see in several passages, in which Patočka
215
�Eduardo González di Pierro
interprets and comments Husserl’s phenomenology. The article only examines some
considerations in Plato and Europe and in Patočka’s Introduction to Husserl’s
Phenomenology. Patočka’s criticism to Husserl allows at the same time to clarify the
transcendental considerations expressed in the first paragraphs of Ideas I, that converge in
the core of the conclusions of the point 55 of the work. Here we can see that Husserl’s
supposed “transcendental idealism” is not a return to a form of German classical idealism,
but it is rather a peculiar form of “realism” different from the way it has interpreted by the
first followers of Husserl.
Keywords: Phenomenology, A-Subjective Phenomenology, Husserl, Patočka
216
�ROSSELLA FABBRICHESI*
Come la fenomenologia diventò faneroscopia:
il progetto di Peirce di una “Filosofia Suprema”
Voglio brevemente ricordare, nei suoi tratti essenziali, il percorso che condusse Peirce dalla logica
alla semiotica, e di qui alla fenomenologia, scienza che, negli ultimi anni della sua produzione, egli
preferì denominare “faneroscopia” (da phaneron, ciò che è evidente, palese, ciò che si manifesta in
piena luce). Già negli anni ‘60 del XIX secolo l’autore identificò logica e semiotica, affermando che
la logica si interessava del riferimento dei simboli ai loro oggetti, i quali, nella loro natura
concettuale, erano a loro volta simboli o segni. Questo è un principio-base della semiotica
peirceana: ogni segno rinvia ad un altro segno in una catena relazionale infinita che verrà
denominata “semiosi illimitata”, nella quale il segno si riferisce ad un oggetto per un terzo elemento
mediatore, l’Interpretante, che intende l’uno in vece dell’altro, che dice che «qualcun altro dice la
stessa cosa che egli stesso dice»1.
Come si può evincere, la relazione semiotica è una relazione triadica sostenuta da una precisa
griglia categoriale. Le categorie nell’opera di Peirce mutano segno e denominazione2, ma si
attestano negli anni della maturità con il nome di Primità, Secondità e Terzità [Firstness,
Secondness, Thirdness]. La prima designa la qualità del feeling nella sua immediatezza percettiva,
senza riferimento a null’altro – un semplice e irrelato carattere positivo, puramente possibile,
autosufficiente, destinato ad essere falsato da ogni descrizione; la seconda indica invece l’elemento
relazionale o reattivo, il rapporto che pone diadicamente una contro l’altra due qualità – il bruto hic
et nunc dell’accadere dei fatti, la loro cieca opposizione e persistenza di contro a tutto il resto.
Infine, la terza categoria qualificherà la mediazione interpretativa che collega un Primo e un
Secondo. Cioè la semanticità del pensiero, la normatività degli abiti di risposta, la luce illuminante
dei riconoscimenti. Essa sola è general, legge e a pieno titolo rappresentazione. Solo per essa
Primità e Secondità hanno un senso. Primi e Secondi sono rintracciabili solo nei Terzi, che per altro
non potrebbero sussistere se non mediando l’astratta irrazionalità dei Primi e la bruta fattualità dei
Secondi, nelle forme di una generale intellegibilità.
Sulla base categoriale Peirce costruisce la propria intera architettura concettuale, ordinando nel
1902 la classificazione delle scienze. Qui la filosofia è distinta in tre regioni: fenomenologia,
scienza normativa (cioè estetica, etica, logica) e metafisica. Come abbiamo visto, la fenomenologia
ha una priorità formale su ogni altra prospettiva filosofica, fin dagli scritti giovanili (dove per altro
non compariva con questo nome). Essa «accerta e studia i tipi di elementi universali presenti nel
fenomeno, intendendo per fenomeno tutto ciò che è presente alla mente in qualsiasi senso» (CP
1.186). Essa resta principalmente «dottrina delle categorie, il cui ufficio è quello di districare
l’aggrovigliata matassa di tutto ciò che in qualsiasi senso si manifesta e di riordinarlo in forme
distinte; o in altre parole di far sì che il primo compito nel quale deve impegnarsi la filosofia sia
l’analisi definitiva di ogni esperienza. È un compito particolarmente difficoltoso, forse e il più
difficile di tutti» (CP 1.280). Questa analisi delle categorie è da considerarsi fondativa di ogni
indagine propriamente filosofica essendo per Peirce la filosofia “scienza d’osservazione” e
*
Università degli Studi di Milano
1
Cito, com’è d’uso, da Peirce (1931-35), con la sigla CP, facendo riferimento al volume e al numero del
paragrafo. In questo caso CP 1.553.
2
Cfr. Peirce (1992).
Bollettino Filosofico 33 (2018):217-225
ISSN 1593 -7178 - 00030
E-ISSN 2035 -2670
DOI 10.6093/1593-7178/5919
�Rossella Fabbrichesi
necessitando dunque di un processo preliminare attraverso il quale si chiarisca quali siano gli
elementi dell’esperienza che si manifestano «ogni ora e ogni minuto alla nostra osservazione, sia
che ci troviamo occupati in serie investigazioni, sia che siamo soggetti alle più strane vicissitudini
dell’esperienza o che stiamo ascoltando con aria sognante i racconti di Scheherazade»3. Si può
agevolmente notare come la definizione di fenomenologia in Peirce sia centrata sull’idea di
esperienza e non coinvolga alcun riferimento ad una coscienza intenzionale o anche solo
psicologica; come inoltre sia fondamentale il rinvio all’attività di pura osservazione (con una sorta
di anticipazione del wittgensteiniano “Non pensare, osserva”).
Anzitutto dobbiamo osservare e descrivere semioticamente, dunque; e la descrizione sarà resa
possibile dall’uso delle tre categorie fenomenologiche che abbiamo prima analizzato. Uso che, si
badi bene, passa sempre attraverso una forma di interpretazione: è grazie alla mediazione delle
Terzità, cioè di precise operazioni ermeneutiche, che io posso riferirmi, infatti, ad una Primità e una
Secondità, le quali sono esperibili, ma mai coglibili nella loro purezza e dunque mai perfettamente
travasabili nel linguaggio. Le categorie, che in Peirce nascevano come funzioni concettuali di
unificazione della molteplicità sensibile (nello scritto giovanile e immensamente influente On a
New List of Categories4), divengono poi pure forme relazionali rintracciabili nel modo di darsi degli
eventi dell’esperienza5. Dobbiamo osservare bene il fenomeno e dire quali siano le caratteristiche
che in esso non mancano mai. La fenomenologia non ha perciò nulla a che fare con la psicologia6,
né con qualche statuto trascendentale. L’esperienza cui rinvia Peirce è molto simile invece
all’esperienza pura dell’amico James, piano di immanenza in cui fluiscono gli eventi della vita, «un
puro that che non è ancora nessuna cosa [what] definita, anche se pronto per essere ogni genere di
cosa»7.
Con una differenza importante. Anzitutto, il puro that per Peirce non sarebbe altro che il piano
del puro First; secondariamente, questo piano andrebbe visto come sempre solcato da precisi what
interpretativi.
Come si può definire l’esperienza su cui si basa tale filosofia? [...] Esperienza può solo significare l’intero
risultato cognitivo del vivere, e include le interpretazioni tanto quanto il contenuto dei sensi. Ancor di più le
prime, dato che il contenuto dei sensi è un ipotetico qualcosa che non possiamo mai cogliere come tale,
libero da un’attività interpretativa.8
Nel manoscritto del 1899 da cui è tratto questo passaggio, egli definisce High Philosophy la
fenomenologia e, infine, angosciato dall’urgenza di instaurare un’etica della terminologia, inventa
un nuovo nome per questa disciplina che gli sta così a cuore e che vuole differenziare da una parte
dalla fenomenologia hegeliana e husserliana (per quel poco che ne sapeva), dall’altra,
dall’empirismo radicale jamesiano, con il quale aveva certo più affinità. La definisce così
Faneroscopia (da phaneron).
Faneroscopia è la descrizione del phaneron, e per phaneron intendo la totalità collettiva di tutto ciò che è in
ogni modo o senso presente alla mente, indipendentemente dal fatto che corrisponda o meno a qualcosa di
reale. Se mi chiedete presente quando e a quale mente, vi dirò che lascio queste questioni senza risposta.9
3
Peirce (2008), p. 447.
Peirce (1992), pp. 14-27.
5
Mi permetto di rimandare per un approfondimento a Fabbrichesi (1993).
6
Cfr. CP 8.295, 1.285. In questo senso Peirce mostra di non apprezzare particolarmente la fenomenologia di
Husserl, cfr. 4.7.
7
James (2009), p. 50. Ho trattato più estesamente questo tema in Fabbrichesi (2015).
8
Peirce (1992), p. 75.
9
CP 1.284.
4
218
�Come la fenomenologia diventò faneroscopia
Nell’interesse di quella esattezza terminologica senza la quale nessuno studio può divenir scientifico,
propongo il termine phaneron per denotare qualsiasi cosa possa presentarsi alla mente in qualsiasi senso
[…] Risulterà chiaro da quanto si è detto che la faneroscopia non si porrà il problema di chiedersi fino a
che punto i phaneron da essa studiati corrispondano a qualcosa di reale. Essa si astiene religiosamente da
qualsiasi speculazione sulla relazione tra le sue categorie ed eventi di ordine fisiologico, cerebrale, o altro
[…] semplicemente scruta con attenzione le apparenze immediate, cercando di unire ad un’estrema
precisione la più ampia generalizzazione possibile.10
Ogni phaneron è costituito da alcuni elementi indecomponibili, modellati sulla struttura delle
valenze chimiche e presenti in ogni genere d’esperienza. Peirce è talmente convinto dell’esito delle
sue riflessioni da dedicare a tale sviluppo della propria teoria pagine e pagine dei manoscritti. Di
nuovo: Primità, Secondità, Terzità, «inestricabilmente mescolati insieme» (CP 1.287) in modo che
nessuno di loro possa essere isolato, eppure ognuno differenziato dagli altri come un tono, una
vibrazione di diversa intensità del flusso della vita. Ciò che appare si rivela fenomeno d’esperienza
nel particolare colore assegnatole da una delle tre categorie. Potremmo dire, secondo
un’interpretazione che viene suffragata anche da Rosensohn11: vi è un unico fenomeno
d’esperienza, declinato secondo diverse sfumature faneroscopiche. Quando si parla di faneroscopia
(senza dimenticare che Peirce naviga tra l’una e l’altra definizione e utilizza anche in tarda età il
vocabolo Fenomenologia) si assiste però, a mio modo di vedere, anche a qualcosa di maggiormente
connotato a livello teorico: se abbiamo detto che quella di Peirce è una fenomenologia puramente
esperienziale depurata da ogni pre-giudizio e incrostazione che non sia puramente osservazionale,
«la rarissima capacità di vedere ciò che si ha di fronte, così com’esso si presenta, scevro di ogni
interpretazione, non alterato da circostanze alle quali si è permesso senza motivo di modificare la
situazione»12, se abbiamo notato questo aspetto – che certamente lo avvicina alla fenomenologia
husserliana – quando il nostro autore passa allo stadio della Filosofia Suprema e vira verso le analisi
faneroscopiche il suo obiettivo si perfeziona e raggiunge altri scopi. L’indagine faneroscopica
rimane fortemente ancorata al piano categoriale – perché fenomenologia e faneroscopia sono
declinazioni di una stessa categoriologia – e riguarda l’«intero risultato cognitivo del vivere»13.
Come abbiamo visto, per i suoi intendimenti l’illusione avrà ugual portata della percezione diretta, e
la sua indagine contemplerà sia le interpretazioni che i contenuti dei sensi, anzi in primo luogo
proprio le interpretazioni, le Thirdnesses, poiché sono queste che parlano di “contenuti dei sensi”.
La Filosofia Suprema è dunque Filosofia dell’Esperienza, intendendo per esperienza l’intreccio di
Qualità, Reazione e Interpretazione, che, ricordiamolo, sono elementi indecomponibili di ciò che si
manifesta in piena luce all’osservazione: i colori, i feelings, le asprezze, gli scontri che qualificano il
mondo della vita, ma anche il riconoscimento e il discorso che sempre li accompagna. Fatti e
interpretazioni, interpretazioni e fatti. Come voleva Goethe: «La cosa più elevata sarebbe:
comprendere che tutto ciò che è fattuale è già teoria. L'azzurro del cielo ci rivela la legge
fondamentale della cromatica. Non si cerchi nulla dietro ai fenomeni: essi sono già la teoria»14.
Se il metodo ha dunque fortissime affinità con quello fenomenologico tradizionalmente inteso,
Peirce ci tiene però a rimarcare che gli eventi della vita osservati sono comunque sempre
immediatamente interpretati e tradotti in segni, poiché dal circolo della semiosi è impossibile uscire,
se non transitando attraverso le esperienze non dicibili e non pensabili della Primità e Secondità. Ma
queste non si danno se non nella Terzità segnica, e nel momento in cui accedono ad essa già sono
travisate («una volta toccate già svaniscono» CP 1.358). L’interpretazione, poi, il “risultato
10
Peirce (1992), p. 140.
Rosensohn (1974), p. 78.
12
Peirce (2008), p. 448.
13
Peirce (1992), p. 75.
14
Goethe (1983), p. 163.
11
219
�Rossella Fabbrichesi
cognitivo del vivere”, non è a sua volta una pura interpretazione, un detto o un pensato, ma un abito
di risposta, un “saper fare” che si evidenzia e si rafforza nella pratica (secondo i dettami della regola
pragmatica15). Nessuna centralità psicologica, o trascendentale, nessuna primazia coscienziale. Ciò
che si dà come pura apparenza “alla mente” non può che darsi come segno che si indirizza ad un
certo Interpretante. E tale Interpretante è un abito di risposta pragmatico. Nella semiotica
pragmatista di Peirce è il segno col suo Interpretante a occupare la scena (cioè la terzità che
incessantemente interpreta primità e secondità emergenti), non certo la coscienza con i suoi
contenuti noematici.
Rinvio ad altri lavori maggiormente approfonditi e competenti16 per ulteriori osservazioni più
congruenti sulla distanza o la prossimità tra Husserl e Peirce. Vorrei però sottolineare brevemente la
differente natura dei loro progetti fenomenologici, centrando l’attenzione solo su pochi elementi. i)
Proporrò i lineamenti del pensiero anti-intuizionista (anti-cartesiano) del giovane Peirce, che
espunge la coscienza, o meglio l’autocoscienza, dalla prospettiva privilegiata che le assegna la
tradizione moderna e contemporanea; ii) cercherò di dimostrare come la centralità dell’evidenza
husserliana si assesti su di un piano completamente diverso, e in gran parte opposto, a quello
dell’inferenza cui fa continuamente riferimento Peirce, fondando la propria semiotica; iii) infine,
mostrerò come Peirce pensasse ad una fenomenologia di impianto triadico, segnico e interpretativo
che poco sembra avere a che fare con l’“andare alle cose stesse” della fenomenologia classica.
Ognuno di questi principi è radicato nella proposta filosofica che Peirce costruì fin dagli anni
giovanili. Negli scritti cosiddetti “anticartesiani”, un gruppo di saggi redatti per il Journal of
Speculative Philosophy nel 1868, Peirce abbatte con poche, lucide considerazioni, alcune
‘superstizioni’ che in filosofia hanno tenuto banco fin da tempi antichissimi. Qui l’autore presenta
un sistema compiuto, in cui vengono demoliti i tradizionali concetti di interiorità, introspezione,
intuizione immediata e immagine mentale e si perviene a gettare le fondamenta della semiotica.
Semiotica che va intesa, più che come una disciplina tecnica e specialistica, come un
“idealrealismo”, com’egli soleva dire, cioè come una proposta filosofica analoga ad una sorta di
‘terza via’ tra idealismo e empirismo. Il tentativo appare ampiamente riuscito, benché sia stato
ignorato e negletto dai suoi contemporanei – come Royce ebbe a scrivere – e, tutto sommato, anche
dai posteri.
i) Nel primo e nel secondo saggio, Questioni riguardo a certe pretese facoltà umane e Alcune
conseguenze di quattro incapacità17, Peirce sostiene con energia che noi non abbiamo alcuna
capacità di introspezione, ma ogni nostra conoscenza del mondo interno è derivata, tramite un
ragionamento ipotetico, dalla nostra conoscenza dei fatti esterni. «Non abbiamo una facoltà intuitiva
di distinguere diversi modi soggettivi di coscienza»18 e quando un uomo dice a se stesso di essere
arrabbiato è probabile che ben prima le sue ire si siano scaricate sul caffè troppo bollente, sulla
moglie petulante, che la rabbia venga cioè inferita da varie condizioni esterne percepite come
potenzialmente dannose e che sia «un segno del ritorno a sé il dire “sono arrabbiato”»19. Peirce fa a
questo proposito l’esempio lampante del bambino che inizia parlando di se stesso in terza persona,
per arrivare a percepire l’esistenza di un Io personale solo nel momento in cui questo Io si rivela
fallibile e in errore: se la stufa lo scotta, egli si scopre soggetto a quest’affezione e ignorante a tal
punto da non aver previsto la bruciatura. «Così diventa consapevole dell’ignoranza ed è necessario
supporre un io al quale questa ignoranza possa inerire»20. L’ignoranza è in qualche modo sopperita
15
Cfr. Peirce (2008), pp. 205-227 e CP 5.486.
Ad esempio Luisi (2017).
17
Peirce (2008), pp. 83-144.
18
Ivi, p. 99.
19
Ibidem.
20
Ibidem.
16
220
�Come la fenomenologia diventò faneroscopia
dalla testimonianza degli altri, che avvertono il bambino di star lontano dalla stufa. Ma non sempre
agli avvertimenti si dà ascolto: per aver valore, vanno verificati, allora ci si potrà poi affidare ad essi
con tutta tranquillità. Fallibilità personale e testimonianza comunitaria sono dunque per Peirce
all’origine dell’autocoscienza, che è in sé un fenomeno del tutto derivato. L’anticartesianesimo
dell’autore è qui perfettamente evidente.
L’autocoscienza non è dunque un dato immediato, non si palesa con evidenza quando mi
raccolgo su me stesso, ma si raggiunge per inferenza, attraverso un ragionamento complesso e tutto
sommato molto poco intuitivo. E paradossalmente, aggiungerei io, l’identità emerge quando viene
violata per la prima volta: essa mi qualifica come soggetto in quanto sono oggetto di certe affezioni
e di certe incapacità; nasce, in conclusione, come contraccolpo all’incontro con l’altro, come
‘difesa’ rispetto all’irruzione di un “esterno” che, appunto, testimonia un “interno” che gli resiste.
Qualcosa del genere, pur in tutt’altro contesto, pensava Nietzsche.
Peirce è fautore, dunque, di una concezione “privativa” del Sé, come scrive Colapietro21, certo
molto lontana da quella di stampo moderno e contemporaneo, un Sé che si rivela fin da questi primi
anni come un effetto simbolico e non come una causa generativa di conoscenza propria e degli altri.
A poco a poco, spiega Peirce, noi dimentichiamo i passaggi che hanno condotto alla formazione di
un certo sapere e facciamo fatica a liberarci dell’idea che “Io” esisto e che la conoscenza dell’io sia
la prima certezza. Se mai vogliamo dunque ancora parlare di autocoscienza, dovremmo parlarne
come di un’invenzione, non come di una scoperta operata dallo sguardo acuto di chi indaga.
«Io so che io (non solamente l’Io) esisto», scrive significativamente l’autore all’inizio del primo
saggio 22. Là dove qualcosa mi resiste, mi invade, mi ferisce, io percepisco una passività essenziale
che identifico come interiorità. Peirce finisce per concepire la coscienza come un luogo costruito
sulla base di prove ed errori, come – potremmo dire – una mera soglia di fallibilità, sempre sull’orlo
della catastrofe del senso. L’autogoverno, se mai arriva, arriva al termine del “dramma
dell’autocorrezione”23. È questa una mossa fondamentale di Peirce: la coscienza, lungi dall’essere
un luogo di identità costitutiva e attività fungente, è una forma vuota, concava, che trova riflessività
solo quando è contusa, che si scolpisce per sottrazione. Quando l’errore viene percepito come mio
errore ecco che riconosco quel sé che viene offeso come me stesso. Ma questo Io interiore sorge
come un evento flebile, vacillante, tutt’altro che immediatamente evidente e originario.
Un’emergenza che si staglia sulla soglia dell’irruzione di un’alterità.
L’autocoscienza si instaura, in definitiva, in virtù dell’azione parallela di molti complessi
processi inferenziali, che ci conducono dai segni “esterni” alle operazioni “interne”, e, ancora, dalle
comunicazioni “esteriori” alle emozioni “interiori”.
ii) Eccoci così giunti al secondo punto che Peirce mette in risalto: noi non abbiamo alcuna
capacità intuitiva, ma ogni nostra concezione è determinata logicamente da concezioni precedenti.
La certezza dell’intuizione e del carattere autoevidente di alcune nozioni è frutto solo di un
atavismo, di una lunghissima consuetudine, cui ci siamo familiarizzati a tal punto da considerarla
radicata ontologicamente. Le premesse cadono nell’irrilevanza e davanti ai nostri occhi resta solo il
brillio della conclusione. Un segno è segno solo per un altro segno ed è arduo dire dove verrebbe a
contatto con le prime impressioni; la conoscenza si configura come un illimitato processo di
rimando relazionale tra elementi che si danno solo all’interno di quei rapporti, senza un punto
iniziale né uno terminale24. I saggi che seguiranno nei successivi dieci anni saranno così dedicati
allo studio dei principi guida dell’inferenza e della costituzione degli abiti di risposta conseguenti.
21
Colapietro (2005), pp. 45-68.
Peirce (2008), p. 93.
23
Colapietro (2005), p. 47.
24
Peirce (2008), p. 104.
22
221
�Rossella Fabbrichesi
Per conoscere bisogna avere già conosciuto (lo ripeterà Heidegger, evidenziando le manifeste
analogie tra circolo ermeneutico e semiosi illimitata – ma questa è un’altra storia….). Una cosa è
avere un’intuizione, nota Peirce, e un’altra è rendersi conto intuitivamente di aver avuto
un’intuizione. Il principio dell’inferenza domina sovrano. E dato che la capacità di rinviare ad altro
è la caratteristica prima dei segni, possiamo ben arrivare ad affermare che ogni pensiero è un segno
e che non possiamo pensare senza segni, cioè che il pensiero si svolge come un processo in cui ogni
cognizione deve essere interpretata da un’altra, ad infinitum. È questo, come dicevamo, il principio
della semiosi infinita peirceana, che, impostata in questi scritti, verrà poi costantemente riaffermato
come principio cardine delle sue analisi.
La conoscenza non è fatta di stati, succedentisi gli uni agli altri e costruiti come grossi
contenitori di idee che rispecchino degli analoghi stati esterni: la conoscenza si svolge come un
continuum (“a flow”) e un continuum fatto non di cose, ma di segni, essi stessi definibili come
continuità in actu. Il ragionamento, pensa Peirce, non dovrebbe formare una catena, che non è più
forte del più debole dei suoi anelli, ma un filo le cui fibre possono essere assai sottili, a condizione
che siano sufficientemente numerose e strettamente connesse.
L’inferenza logica non è dunque in grado di produrre un singolo stato mentale, e di produrlo in
un modo isolabile, concluso, separabile dagli altri stati. Ogni inferenza si dà solo come infinito
processo di transizione, anzi come un processo continuo, cioè mai realmente iniziato con un primo,
ma sempre gradualmente, infinitesimalmente iniziante: «un infinito processo di cominciamento»25
che permane variando e non giunge mai ad un termine reale, singolare e discreto. Il vero problema
della teoria del ragionare è allora valutare la natura di questo passaggio transizionale. Per Peirce la
conoscenza non è composta come una successione di stati discreti, che si inanellano l’uno all’altro
in una sequenza lineare, partendo da un primum auto-evidente; la conoscenza si svolge come a
living process, a flow, un continuum assolutamente privo di parti ultime, cioè di parti discrete, ma
composto di puri segni, cioè di continui rinvii. I significati non sono degli stati, tanto meno degli
stati di coscienza; non stanno, piuttosto stanno per, cioè transitano indirizzandosi altrove.
«Che significa risolvere ogni supposta intuizione in un’inferenza? Significa risolvere l’universo
dei “fatti” in un universo di “segni”»26. Claudio Paolucci nota, con molte ragioni, che la semiotica
di Peirce ha un elemento decisamente innovativo rispetto a gran parte della tradizione gnoseologica
precedente. Essa ci insegna infatti che un segno può presentare un oggetto solamente attraverso la
mediazione di un’altra rappresentazione che lo ripresenti sotto un altro rispetto,
ciò che si fa presente alla coscienza può farsi presente solo ripresentandosi attraverso representamen. Un
representamen può cioè presentare un oggetto e farlo emergere così in quanto fenomeno, solamente
ripresentandolo attraverso un segno interpretante, che in sé possiede un’essenza costitutivamente discorsiva
(esso “dice”). Ogni presentazione passa sempre attraverso ripresentazioni interpretanti.27
Non importa che Peirce negli scritti faneroscopici sottolinei la necessità di concentrarsi sulla
presentazione apparentemente immediata alla mente, in qualsiasi ora o giorno della nostra vita, di
una espressione dell’esistenza, poiché tale presentazione, quando bussa ai cancelli del pensiero,
viene immediatamente agguantata dagli ingranaggi dei segni ed è dunque sempre rinviata,
diversamente rappresentata, rivista, reduplicata. Si ricordi: le nozioni di Primo e Secondo sono così
tenere che «toccarle vuol dire distruggerle» (CP 1.36).
iii) Veniamo allora alla tematica attinente alla configurazione di una disciplina semiotica. È forse
qui interessante ricordare come Husserl fosse tra i primi, nel corso dell’800, del tutto
25
Ivi, p. 211.
Sini (1972) p. 147.
27
Paolucci (2010), p. 194.
26
222
�Come la fenomenologia diventò faneroscopia
indipendentemente da Peirce, a ipotizzare la fondazione di una scienza, denominata “semiotica”,
capace di ispirare uno studio logico dei segni e un tentativo di classificazione delle categorie
semiotiche28. Lo studio del segno come rimando, o struttura triadica di riferimento – alla maniera
stoica e poi peirceana (non saussuriana) – è e resterà, per le ragioni che diremo, molto lontano dagli
interessi husserliani. Però, come indicherà lo stesso Jakobson, le Ricerche Logiche potrebbero
essere lette, soprattutto per quanto riguarda il secondo volume, come un compiuto trattato di
semiotica generale29. Non è il solo a pensarla in questo modo30.
Innegabilmente però, anche se qui viene considerato un certo parallelismo tra pensiero e
linguaggio, la fenomenologia dei significati logici, in quanto vissuti del pensiero o del giudizio, va
distinta da una fenomenologia delle forme del linguaggio, che è considerata non sempre adeguata a
quei vissuti, manifestandosi di fatto ad un gradino “derivato” e di minor intensità a livello
apprensivo. L’interesse di Husserl è piuttosto centrato intorno agli atti intenzionali della coscienza e
ai significati logici ad essi correlati. L’espressione va abitata dal senso e il senso nasce sempre e
solo in virtù dell’intenzionalità: la gran parte dei segni indicativi, ad esempio, non è sostenuta da
tale espressività.
La funzione espressiva e comunicativa non sembra dunque avere una centralità particolare nel
corpus delle riflessioni husserliane, checché ne pensasse Jakobson, poiché
al di là del Leib c’è ancora la Seele […] Nella sua intimità la Seele, la coscienza intenzionale, intuisce
direttamente se stessa e i suoi significati: li intuisce in carne ed ossa, cioè come anche dice Husserl, nella
loro “verità”, nella verità di un’intuizione evidente, totalmente “riempita” e “adeguata”.31
Il senso appartiene in modo solo derivato al corredo semiotico, che a sua volta non coincide del
tutto con il pensiero, ma ne è uno strumento, certo importante, ma non sempre essenziale; è un
doppio, il cui prototipo rimane assolutamente originario e dominante. L’evidenza, l’intuizione, la
visione d’essenza non possono avere a che fare con il segno in quanto rimando, poiché, appunto,
non hanno bisogno d’altro per fondarsi in un complesso gioco di rimandi espressivi, ma vengono
apprese grazie alla luminosità “offerente” dell’atto di coscienza. In parole ancora più radicali – e
forse frettolose – il segno per Husserl è un banale strumento, una cosa fra le altre, molto distante
dalla primazia dell’atto di pensiero. Non diversamente penserà Heidegger, come testimoniano i
paragrafi 16 e 17 della Prima Parte di Essere e tempo.
L’approdo alla tematica semiotica invece, come abbiamo visto, è centrale nella filosofia di
Peirce: è a partire dalla rielaborazione delle concettualità operative del rinvio semiotico che Peirce
reinterpreta i fatti (bruti Secondi che vengono colti sempre e solo come significati), le verità
(costituite nel long run delle interpretazioni pubblicamente condivise), l’uomo stesso (un’ “essenza
vitrea” che ha di nuovo le qualità dei segni, anzi dei segni esterni che usa), e infine l’universo nel
suo complesso (una rete di segni in perpetuo divenire evolutivo). Per Peirce “andare alle cose
stesse” avrebbe solo il senso di “andare ai segni stessi”, cioè non smettere mai di interpretare,
rinviando, mediando, costruendo corpi semiotici sempre più estesi.
28
Husserl (1970).
Jakobson (1978).
30
Rimando per questi approfondimenti, a Spiegelberg (1956), Dougherty (1980), Rosensohn (1974) e Sini
(1982).
31
Sini (1982), p. 18.
29
223
�Rossella Fabbrichesi
Bibliografia
Calcaterra, R. M. (a cura di) (2005), Semiotica e fenomenologia del Sé, Aragno, Torino.
Colapietro, V. (2005), L’altro come Sé e il Sé come Altro, in Calcaterra, R. M. (a cura di), Semiotica
e fenomenologia del Sé, Aragno, Torino, pp. 45-68.
Dougherty, C. (1980), “The Common Root of Husserl’s and Peirce’s Phenomenologies”, The
Monist, vol. 63.
Fabbrichesi, R. (1993) Introduzione a Peirce, Laterza, Roma-Bari.
Fabbrichesi, R. (2015) “Esiste la coscienza? Le tesi inattuali di Peirce e James a confronto con la
filosofia novecentesca”, in Filosofia del linguaggio, semiotica e filosofia della mente. A partire
da C.S. Peirce nei cento anni dalla morte, numero speciale SFL, a cura di P. Leonardi e C.
Paolucci, Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio.
Goethe, J.W. von (1983), La metamorfosi delle piante e altri scritti sulla scienza della natura, a cura
di Stefano Zecchi, Ugo Guanda Editore, Parma.
Husserl, E. (1970), Zur Logik der Zeichen (Semiotik), in Husserliana, XII, Nijhoff, Den Haag, trad.
it e introduzione a cura di C. Di Martino, Semiotica, Spirali, Milano 1984.
Jakobson, R. (1978), Lo sviluppo della semiotica, Bompiani, Milano.
James, W. (2009), Saggi di empirismo radicale, a cura di S. Franzese, Quodlibet, Macerata.
Luisi, M. (2017), Peirce e la fenomenologia, Rubbettino, Soveria Mannelli.
Paolucci, C. (2010), Strutturalismo e interpretazione, Bompiani, Milano.
Peirce, C.S. (1931-35), Collected Papers, a cura di C. Hartshorne e P. Weiss, Cambridge Scholars
Press, Cambridge (Mass.), Vol. I-VI.
Peirce, C.S. (1992), Categorie, a cura di R. Fabbrichesi, Laterza, Roma-Bari.
Peirce, C.S. (2008), Scritti scelti, a cura di G. Maddalena, UTET, Torino.
Ransdell, J.
(1989), Is Peirce a Phenomenologist?, original French version in Études
Phénoménologiques, vol. 9-10, pp. 51-75, consultato in inglese il giorno 20 aprile 2018 alla
pagina http://www.iupui.edu/~arisbe/menu/library/aboutcsp/ransdell/PHENOM.HTM.
Rosensohn, W. (1974), The Phenomenology of Charles S. Peirce, B. R. Grüner, Amsterdam.
Sini, C. (1972), Il pragmatismo americano, Laterza, Bari.
Sini, C. (1982), Il problema del segno in Husserl e in Peirce, in Id., Kinesis. Saggio di
interpretazione, Spirali, Milano, pp. 13-29.
Spiegelberg, H. (1956), “Husserl’s and Peirce’s Phenomenologies: Coincidence and Interaction?”,
Philosophy and Phenomenological Research, vol. 17, n. 2, pp. 164-185.
Abstract
Charles Sanders Peirce (1839-1914) worked in the latest years of the XIX century on a
classification of sciences that included phenomenology, beside metaphysics and normative
sciences. He wanted these triadically distinct in esthetics, ethics and logic. This vision of
phenomenology is clearly different from Husserl’s. Nonetheless, there are some analogies.
First of all, the idea that phenomenology has to deal with what is present to the mind in any
moment and in any sense. For Peirce this presence is triadically said: as Firstness,
Secondness and Thirdness. It is the presence of an experience, plus its interpretation. It is a
Third, that is, a signification, that bridges the divide between a First and a Second, the pure
quality and the pure given of the experience itself. This leads us to underline the
differences between the two phenomenologies. It is not by chance that Peirce begins, in the
first years of the new century, to call it “phaneroscopy”, from the greek word “phaneron”
and to appeal to an “High Philosophy” as its fulfillment. If Husserl’s theory is grounded on
the principle of evidence, Peirce opposes to it the force of inference; if Husserl appeals to
intuition, Peirce denies it any legitimacy, referring to triadic relations of signs (semiosis) as
224
�Come la fenomenologia diventò faneroscopia
the leading-principle of reasoning and certainty. The beginning of our philosophical
experience is not the pure and undoubtable apprehension of the thing itself, but the sign
relation that mediates between a sign, an object and its Interpretant. This relation is
eminently fallible and dynamically ever-changing.
Keywords: High Philosophy, Husserl, Peirce, Phaneroscopy, Phenomenology
225
�SANDRO GORGONE*
Per una nuova fenomenologia della natura.
La filosofia delle atmosfere di Gernot Böhme
Che grande fu
poterti chiamare Natura –
ultima, ultime letture
in chiave di natura,
su ciò che fu detto natura
e di cui sparì il nome
natura che poté aver nome e nomi
che fu folla di nomi in un sol nome
che non era nome
(A. Zanzotto, Dirti “natura”)
L’essenza della natura deve esprimersi
simbolicamente; è necessario un
nuovo mondo di simboli, e anzitutto
l’intero simbolismo del corpo, non
soltanto il simbolismo della bocca, del
volto, della parola, ma anche la totale
mimica della danza.
(F. Nietzsche, La nascita della tragedia)
1. L’onnipresente natura e il suo fenomeno
In una conferenza tenuta nel 1990 dal titolo Caratteri della natura dal punto di vista della moderna
scienza della natura, Gernot Böhme esprime il ruolo decisivo che nella nostra società riveste la
natura sotto il profilo sociale, economico e politico evidenziando come domini, da molteplici
prospettive, un generale appellarsi alla natura che sembra quasi valere come compensazione del
carattere sempre più artificiale delle nostre vite:
Tutti parlano della natura. La natura è probabilmente oggigiorno la questione più discussa, richiamata e
tematizzata […]. La natura come immagine cattura i nostri sguardi ed è in grado di suscitare fiducia nella
qualità. La natura, poi, come esperienza vissuta è l’offerta fondamentale del turismo. Come spazio libero
essa soddisfa le esigenze del tempo libero dei consumatori. La natura è ancora una rappresentazione guida
per la conduzione delle nostre vite: alimentazione naturale, cosmetica naturale, materie prime naturali per
oggetti d’uso e vestiti, sono considerati senza dubbio i migliori. Infine la natura rappresenta ancora il più
vasto campo della ricerca umana e la scienza della natura è, sotto molti punti vista, la scienza modello per
tutto il sapere1.
Ma proprio questo onnipresente e pervicace appellarsi alla natura, che si realizza primariamente
come esigenza estetica2, cela secondo Böhme una profonda e radicale rimozione della natura,
un’irrevocabile svalutazione del suo valore normativo e della sua funzione di orientamento
*
Università degli Studi di Messina
1
Böhme (1992), p. 56. Tutte le traduzioni dai testi di Böhme non disponibili in lingua italiana sono mie.
Böhme ritiene che «il bisogno di natura si articola principalmente come bisogno estetico» (ivi, p. 146) e che
l’onnipresenza della natura si realizza principalmente come onnipresenza di “ornamento naturale” (cfr. ivi, pp. 146150).
2
Bollettino Filosofico 33 (2018): 226-238
ISSN 1593 -7178 - 00030
E-ISSN 2035 -2670
DOI 10.6093/1593-7178/5920
�Per una nuova fenomenologia della natura. La filosofia delle atmosfere di Gernot Böhme
assiologico. Il fatto che ci appelliamo così spesso ed in modo chiaramente ideologico e quasi
ossessivo alla natura (basti pensare all’enorme rilevanza economica, scientifica, sociale e morale del
prefisso “bio-”) non significa forse che altre rappresentazioni ed altri valori non “naturali”
informano e guidano il nostro agire?
Tuttavia, a causa della sempre più estesa crisi ecologica, alla natura viene surrettiziamente
attribuito quel carattere di principio ordinante e assiologicamente positivo che essa possedeva un
tempo sulla base di un fondamento teologico-metafisico. Ma, una volta venuto meno quel
fondamento metafisico, come si può giustificare l’identificazione tra bene ed ordine naturale che
oggi sembra di nuovo valere come presupposto più o meno esplicito delle svariate risposte alla crisi
ecologica e delle molteplici impostazioni di etica ambientale 3? La rappresentazione tradizionale
della natura come ordine dato e normativo è, infatti, ormai priva di consistenza dal momento che «la
natura che ci circonda è evidentemente un prodotto storico e sociale e l’uomo è un essere tanto
naturale quanto culturale, cioè è destinato a configurare attivamente il suo ambiente e se stesso»4.
Per poter riscoprire la natura nei suoi propri caratteri e mettere in luce la reciprocità del suo
rapporto con l’uomo è necessario, pertanto, secondo Böhme, delineare una filosofia della natura
nella forma di una nuova fenomenologia della natura non riducibile all’approccio tipicamente
riduzionistico delle scienze della natura. Nella prefazione programmatica al volume collettaneo
Fenomenologia della natura a cura di Gernot Böhme e Gregor Schiemann, si afferma che tale
nuova considerazione fenomenologica della natura individua una modalità conoscitiva che mira ad
un «sapere della natura attraverso la manifestazione e la salvaguardia della sua datità sensibile. […]
Una fenomenologia della natura è un’elaborazione sistematica dell’accesso sensibile alla natura, per
cui l’oggetto natura si costituisce non correlativamente ad un soggetto trascendentale ma in
relazione all’uomo nella sua esistenza corporea [leiblich]»5. Nella misura in cui si comprende
l’estetica originariamente come scienza dell’esperienza sensibile, tale approccio fenomenologico
possiede uno spiccato carattere estetico.
Non si tratta, tuttavia, per Böhme primariamente di fondare una nuova estetica naturale, ma di
individuare un “nuovo” approccio fenomenologico nei confronti della natura. A tale scopo egli si
richiama esplicitamente alla Nuova Fenomenologia elaborata a partire dagli anni ottanta da
Hermann Schmitz6. La “novità” di questa impostazione dipende dalla convinzione che il fenomeno
della natura non sia stato trattato dalla fenomenologia tradizionale se non come ambito
esemplificativo rispetto all’analisi della Lebenswelt. Ciò, secondo Böhme, dipende necessariamente
dalla considerazione husserliana dei fenomeni come datità della coscienza e dalla funzione
principale di fondazione trascendentale delle scienze che la fenomenologia, ridotta sempre più
chiaramente ad un’analisi della coscienza, dovrebbe esplicare. Al contrario, invece, la Nuova
Fenomenologia di Schmitz si pone programmaticamente come “completamento dell’esperienza
della scienza della natura”7. Il suo punto di partenza non è più la coscienza ma il fenomeno della
corporeità umana e, corrispondentemente, si modifica anche il concetto di fenomeno inteso da
Schmitz come la “datità nel sentire corporeo” [im leiblichen Spüren Gegebene] che contiene in sé
riflessivamente sempre anche un riferimento al “sentirsi” della coscienza. Come ha
sistematicamente mostrato Merleau-Ponty8, lo spazio corporeo [leiblicher Raum] non ammette un
“fuori”. Ciò costituisce un notevole ostacolo all’elaborazione di una fenomenologia della natura
3
Per un’introduzione alle diverse prospettive di etica ambientale odierne con particolare attenzione alla loro
fondazione critica ed assiologica cfr. Ott (2010) ed in ambito italiano Andreozzi (2012).
4
Böhme (1992), p. 58.
5
Böhme, G., Schiemann (1997), pp. 8; 10. L’aggettivo leiblich e il sostantivo Leib verranno qui di seguito tradotti
semplicemente con “corporeo” e “corpo” mentre verrà esplicitamente segnalato l’utilizzo dei termini körperlich e
Körper.
6
Schmitz (1964-1980; 1980; 2003). In traduzione italiana è disponibile soltanto Schmitz (2011).
7
Schmitz (1980), p. 44.
8
Cfr. Merleau-Ponty (2003a, 2003b). «Il mondo percepito […] è l’insieme delle vie del mio corpo» (Merleau-Ponty,
2003b, p. 259).
227
�Sandro Gorgone
che, invece, sembra presupporre tale esteriorità nel senso della indisponibilità ed estraneità della
natura, sia essa la natura esterna all’uomo, sia quella propria del corpo umano, il corpo come la
“nostra natura”9.
Le analisi fenomenologiche di Schmitz riguardano da un lato l’esperienza corporea relativa ai
caratteri del mondo della vita [lebensweltliche Züge], in particolare i suoi tratti “creaturali” e le sue
funzioni vitali quali la respirazione, la fame, la sete, il sonno, la sessualità, e dall’altro gli spazi
“esterni”, i processi e gli eventi naturali che Schmitz chiama “semi-cose” [Halbdinge]. Secondo
Böhme, tuttavia, l’analisi di tali fenomeni, se pure realizza un’auspicabile estensione del campo di
indagine tradizionale della fenomenologia, è condotta da Schmitz a partire dal tradizionale concetto
di natura carico dei pregiudizi e delle stratificazioni ermeneutiche della sua lunga storia filosofica
secondo cui, in assenza di uno specifico concetto fenomenologico 10, “natura” indica
prevalentemente in senso hegeliano l’ambito dello Spirito estraniato da sé, dell’esteriorità, del nonIo. Tuttavia è nella stessa fenomenologia di Schmitz che si incontra la possibilità di esperire il
nostro corpo, e non soltanto la sua esteriorità, come natura; si tratta della determinazione del
fenomeno corporeo attraverso l’espressione di “körperlicher Leib” con cui Schmitz indica la
duplicità di esperienza estraniante ed appropriante della nostra esistenza corporea, ovvero la
tensione di matrice husserliana tra essere-corpo [Leibsein] ed avere un corpo [Leibhaben] che
ricorre, peraltro, anche nel concetto di “eccentricità” introdotto dall’antropologia filosofica di
Helmuth Plessner. Tale duplicità rimanda ad una costante oscillazione tra la consapevolezza che il
corpo che io sento come mio, mi appartenga effettivamente e mi costituisca, e la consapevolezza,
per molti versi opposta e suscettibile di una declinazione psicopatologica, che il corpo sia una cosa
del mondo e che si ponga rispetto all’io come qualcosa di estraneo e di indipendente. L’accordo
polemico tra esteriorità ed interiorità, tra estraneo e proprio, che è intrinseco al concetto schmitziano
di körperlicher Leib, si porrebbe, dunque, come il campo di indagine privilegiato per una nuova
fenomenologia della natura che voglia tematizzare il corpo come natura.
2. Il corpo: la nostra natura
Una nuova fenomenologia della natura è, dunque, possibile solo a partire da una rinnovata
comprensione del corpo che ne riscopra la centralità nell’ambito del Sé 11: il corpo, come soprattutto
la fenomenologia francese ha ampiamente mostrato12, diviene, dunque, il caso paradigmatico della
natura dell’uomo13. Il rapporto con la natura è al contempo rapporto con se stessi e, viceversa, la
considerazione dei fenomeni naturali presuppone l’esperienza della propria corporeità, così che va
superato il concetto trascendentale di natura come ambito di oggettivazione e normatività. Secondo
tale prospettiva, il corpo umano in quanto natura sarebbe qualcosa di oggettivo e di “esteriore”.
Tale concezione, che si dispiega in modo evidente nell’antropologia di Kant, costituendo il
presupposto della sua morale dell’autonomia del soggetto dalla necessità naturale, si ritrova in tutta
la tradizione umanistica e filosofica della modernità: l’uomo rivendica la propria posizione
9
«Anche la propria natura si presenta come qualcosa di indisponibile al soggetto. Essa è pur tuttavia la mia, in
quanto io sono ineludibilmente riguardato [betroffen] da essa e addirittura nella mia esistenza qui ed ora mi esperisco
come dipendente da essa» (Böhme, G., 1997a, p. 13).
10
«Non è ancora disponibile un concetto fenomenologico di natura» (Böhme, G., 1997b, p. 135).
11
Quasi scontato è il riferimento alle celebri affermazioni nietzscheane sul corpo come “grande ragione” e come
“fenomeno più ricco” ed alla sua veemente critica alle istanze religiose, morali e filosofiche che nella tradizione
occidentale hanno represso la corporeità cercando di fondare il Sé esclusivamente sulle facoltà intellettuali e razionali o
sulla sfera psichica dell’uomo.
12
Cfr. soprattutto il concetto di carne di Maurice Merleau-Ponty (2003b) e quello di incarnazione di Michel Henry
(2001). Cfr. anche B. Waldenfels (2000).
13
Böhme, dunque, non fa derivare il concetto di natura dell’uomo dall’idea tradizionale di natura come datità
normativa o dalla sua crisi attuale nel senso di una naturalizzazione o di una costruzione biotecnologica, ma, seguendo
l’approccio fenomenologico che pone al centro il fenomeno del corpo, intende sviluppare il problema della natura
umana a partire dal suo corporeo essere-nel-mondo: cfr. Böhme (2002b). Per una ricostruzione del dibattito sulla
“natura umana” in relazione all’avvento delle biotecnologie cfr. Weiss (2005).
228
�Per una nuova fenomenologia della natura. La filosofia delle atmosfere di Gernot Böhme
ontologica nel superamento della sua condizione e condizionatezza naturale attraverso
l’affermazione delle sue differenze specifiche dall’animalità naturale (ragione, linguaggio, anima,
spirito, riflessione, ecc.). Al contempo anche i metodi delle scienze naturali hanno considerato il
corpo come natura attraverso la sua integrale oggettivazione anatomica, funzionale, psicologica ed
infine genetica e biochimica, per cui il corpo, anche se non più ridotto a mera struttura anatomicofunzionale [Körper], diviene sempre corpo oggettivato. Secondo questa prospettiva, dunque, la
definizione del corpo come “natura che noi stessi siamo”, che ripetutamente ricorre nei testi di
Böhme, sembra essere paradossale, dal momento che la naturalità contraddice ogni modalità
fenomenica del Selbstsein. Per accedere ad una rinnovata “naturalizzazione” del corpo, appare,
pertanto, necessario un mutamento di prospettiva, una nuova visione e concettualizzazione della
natura che la sottragga alla sfera di matrice hegeliana della esteriorizzazione ed oggettivazione.
Il modo di sentire il proprio corpo, tipico dell’epoca in cui la natura è sempre più oggettivata e
manipolata artificialmente dalle tecno-scienze, si esprime emblematicamente, secondo Böhme, in
una caratteristica Stimmung del nostro tempo: la Betroffenheit, l’essere riguardati, colpiti da
qualcosa, ma anche, secondo il significato proprio del sostantivo tedesco – lo sconcerto, lo stupore,
il turbamento nei confronti di una serie di fenomeni sempre più diffusi nelle nostre società (effetti
dell’inquinamento, allergie, disturbi dell’umore, malattie psicosomatiche, ecc.) che generano una
sempre maggiore inquietudine e che soltanto attraverso un complesso processo di elaborazione
collettiva confluiscono nell’emergere di una vera e propria coscienza ecologica. Tale Betroffenheit
implica una certa dose di riflessività e di coinvolgimento del soggetto che lo colloca in una
posizione intermedia tra l’io della consapevolezza e l’io divenuto oggetto di riflessione. Nella
Betroffenheit di cui si fa esperienza nella propria corporeità come natura, è inscritta anche una certa
esperienza della natura che mi è esterna, della cosiddetta natura materiale che non si presenta più
come l’ambito oggettuale del non-io e del per-sé ma come “natura per me”14.
La comprensione scientifica sempre più stringente dei meccanismi fisiologici e la sempre più
raffinata capacità diagnostica, insieme con gli straordinari sviluppi della medicina genetica e delle
biotecnologie hanno, tuttavia, minato profondamente la naturalità della Betroffenheit corporea15; i
processi emancipativi della persona hanno introdotto una complessa dialettica tra essere un corpo
ed avere un corpo in modo tale che la costituzione del Sé avviene per lo più al di là e spesso contro
la corporeità stessa, come mostra emblematicamente il dibattito su identità di genere e identità
sessuale16. Si tratta di un pervasivo processo di estraneazione dalla propria natura e di crescente
aritificializzazione di tutte le sfere vitali per cui si smarrisce progressivamente il modo in cui
l’essere corpo coincideva, attraverso l’esperienza della Betroffenheit, con l’essere natura.
All’emergere del soggetto moderno come istanza di autonomia ed autofondazione corrisponde –
come l’epoché cartesiana inaugurale del moderno testimonia inequivocabilmente – il divenire
strumento, veicolo e perfino zavorra del corpo. L’alienazione della corporeità che si realizza nella
divaricazione tra il corpo e il soggetto autonomo, tra uomo interiore e uomo esteriore, è, tuttavia,
secondo Böhme, il risultato di un faticoso processo evasivo che solo a prezzo di enormi sforzi può
essere mantenuto, dal momento che l’affermazione dell’«istanza autonoma dell’io è il prodotto
della fuga dalla Betroffenheit e può essere in ogni momento rimessa in questione»17.
14
In questa prospettiva di una natura significante che possa essere la dimora dell’uomo, Böhme analizza
ripetutamente come modello storico la dottrina aristotelica dei quattro elementi: «I quattro elementi vennero pensati [da
Aristotele] in relazione ad un essere che è esso stesso natura. Le quattro qualità, che caratterizzano gli elementi – caldo,
freddo, umido, secco – caratterizzano al contempo i bisogni dell’essere vivente: la fame è bisogno di caldo e secco, la
sete bisogno di caldo e umido» (Böhme 1992, p. 85). Per una più ampia trattazione della teoria dei quattro elementi e
del suo significato iconologico e simbolico cfr. Böhme, G., Böhme, H. (1996).
15
Böhme si confronta con le sfide etico-filosofiche poste della medicina dei trapianti, dalla chirurgia estetica e dalle
tecniche di manipolazione genetica in Böhme (2017), pp. 143-199.
16
Cfr. ivi, pp. 302-325.
17
Böhme (1992), p. 88.
229
�Sandro Gorgone
Nella modernità si smarrisce la consapevolezza di essere corporalmente [leiblich] natura18. Il
sapere scientifico, anche nelle sue attuali formulazioni meno riduzionistiche, quali ad esempio
quella olistica19, presenta la comprensione della nostra naturalità non nella modalità del Selbstsein
ma nella prospettiva in cui noi stessi possiamo essere tematizzati e trattati come “natura oggettiva”
[gegenständliche Natur].
Böhme indica come antidoto contro tali nuove forme di alienazione, di strumentalizzazione e
rimozione del Sé corporeo che si celano dietro le gloriose conquiste dell’emancipazione del
soggetto, la riscoperta e la valorizzazione del “senso proprio” [Eigensinn] e del “senso comune”
[Gemeinsinn] di ascendenza aristotelica20. L’utilizzo di questo concetto tipicamente olistico,
potrebbe aiutare a riconoscere e rispettare l’autonomia e la spontaneità [Selbsttätigkeit] del corpo
come Sé, ovvero della natura del corpo-proprio; tuttavia l’introduzione dello Eigensinn non va a
configurare un rinnovato meccanicismo, trasposto ad un livello olistico, nel senso di una necessità
automatica della sfera psicosomatica. Non si tratta di abbandonarsi all’automaticità meccanica della
natura del nostro corpo, ma di esercitare, in senso aristotelico, nei confronti della molteplicità
sensoriale della Betroffenheit una aisthésis koiné, ovvero una percezione comune rispetto alla quale
i fenomeni molteplici non sono percepiti accidentalmente ma per sé. Estendendo le riflessioni di
Böhme, potremmo affermare che, così come, secondo lo Stagirita, la pluralità dei sensi speciali per
la percezione dei sensibili comuni ha come fine quello di agevolare il riconoscimento dei koinà
stessi21, la molteplicità degli approcci aisthesiologici consente di cogliere la pluralità e polivocità
del Sé corporeo che invece sfugge ad ogni approccio dualistico e riduzionistico.
Che il corpo venga esperito come natura indica che esso viene esperito come qualcosa che non si
può sottomettere alla nostra signoria e non può diventare materia di processi di soggettivazione, ma
che fronteggia e perfino sabota la nostra volontà, invadendo con le proprie “ragioni” gli spazi
razionalmente controllati dall’io. Essere natura nel proprio corpo rappresenta, dunque,
analogamente all’assunzione heideggeriana di responsabilità nei confronti del fondamento che mai
si può possedere, un difficile compito [Auf-gabe]: si tratta di trasformare la donazione [Gabe]
fenomenica della Betroffenheit corporea in autoprogetto [Selbstentwurf] esistenziale. Va inoltre
sottolineato che la modalità ontologica inerente all’essere natura del corpo non è più quella della
sostanzialità o della presenza, ma, secondo la prospettiva heideggeriana, quella transitiva del
“lasciar essere” e dell’avvenire, analogamente a quanto Michel Henry intende con l’espressione on
existe son corps22. La tensione tra Sé e natura si rivela essere in ogni situazione esistenziale non più
un’insanabile contraddizione ma il principale compito che caratterizza il nostro soggiorno mortale e
terrestre, il compimento esistenziale del nostro ethos: «Essere corpo è al contempo un dato e un
compito»23. Tale compito esistenziale consiste nel realizzare il proprio Sé in modo da lasciare
emergere il proprio essere natura. La propria “natura” non è più, dunque, soltanto, secondo le
diverse prospettive etico-teologiche, un dato da accettare o un dono da consacrare, ma il compito
fondamentale della nostra esistenza corporea, attraverso quella che Foucault ha chiamato la “cura di
sé”:
La tensione tra natura e Sé, in cui si gioca l’esistenza corporea, ammette principalmente due modalità di
risoluzione: la prima è quella più comune, cioè che il soggetto agente secondo le sue possibilità domina,
18
Così Weiss commenta questo processo di denaturalizzazione dell’uomo: «Con l’avvento delle biotecnologie –
cioè con l’avvento delle possibilità manipolative aperte da farmacologia, riproduzione assistita, medicina dei trapianti e,
prima fra tutte, la genetica – viene meno l’aspetto naturale dell’essere umano, inteso come punto di partenza dato e
limite di fatto dell’automanipolazione dell’uomo, e con esso il concetto stesso di “natura”, sia in senso normativo che
nell’accezione di essenza» (Weiss 2005, pp. 220-221).
19
Per un’introduzione in prospettiva analitica all’approccio olistico del sapere cfr. Dell’Utri (2002). Per i rapporti tra
la fenomenologia della natura di Böhme e la prospettiva olistica cfr. Kluwe (2003).
20
Böhme (2013), p. 96.
21
Aristotele, De anima, Γ 1, 425b 5-10.
22
Henry (2001).
23
Böhme (2017), p. 69.
230
�Per una nuova fenomenologia della natura. La filosofia delle atmosfere di Gernot Böhme
liquida o rimuove la natura. Questa sarebbe – per dirla con Heidegger – la modalità carente dell’esserecorpo. Nella modalità autentica dell’essere-corpo si tratterebbe di sviluppare l’essere-sé in modo che esso
ammetta il proprio essere-natura. La propria natura diviene allora il tema della cura di sé [Selbstsorge]24.
3. Ritorno alla natura
Le considerazioni di Böhme sullo statuto ontologico della natura si legano, dunque, strettamente al
corpo inteso come natura, dal momento che proprio nella odierna gestione del corpo soprattutto
attraverso la biomedicina e le biotecnologie protesiche e genetiche, emerge tutta la portata della
riproducibilità tecnica della natura25. Decisiva conseguenza di tale riproducibilità tecnica – e non
sua causa – è la sempre più diffusa rivalorizzazione della natura come elemento centrale delle più
disparate prassi esistenziali26.
La natura non ci interpella più come ciò che è dato [das Gegebene], ma, attraverso la crescente
potenza della tecnica, come ciò che è fatto o è fattibile 27: «La natura è ciò che è possibile attraverso
la produzione»28. È questa la metamorfosi ultima del concetto di natura che si pone alla fine della
lunga tradizione di matrice aristotelica secondo cui la natura costituisce, invece, l’opposto della
produzione. La natura perde, così, la sua determinazione dialettica attraverso gli ambiti che
tradizionalmente le si opponevano (tecnica, cultura, civiltà) e viene progressivamente concepita
come un prodotto culturale, come mostra emblematicamente la storia della costituzione estetica
dell’idea di paesaggio; essa diviene “natura socialmente costituita” 29, “natura umana”30. L’affinarsi
della capacità tecnica di riproduzione della natura ed in particolare la possibilità di una
manipolazione e riproduzione tecnica dei processi biologici di riproduzione della vita, suggellano il
divenire contingente della natura umana; di conseguenza viene definitivamente accantonata la
pretesa di derivare dalla natura un qualunque tipo di orientamento morale e di normatività sociale,
giuridica e politica.
Tuttavia, così come attraverso l’esperienza delle avanguardie artistiche del Novecento, al di là
del declino dell’aura dell’opera d’arte causata della sua riproducibilità tecnica, è nata una nuova
forma d’arte sconfessando la profezia hegeliana della “morte dell’arte” nell’epoca moderna, anche
la natura potrebbe – almeno è questa l’opinione di Böhme – analogamente “rinascere” nell’epoca
della sua riproducibilità tecnica.
Se, da un lato, tramonta ogni pretesa di considerare la natura come un elemento orientativo per la
nostra cultura europea-occidentale, dall’altro essa riacquista un ruolo rilevante in quanto ambito
ontologicamente indeterminato ma vitale dell’esistenza umana: con la sua cultura e i suoi mezzi
tecnici, l’uomo inizia di nuovo a rappresentarsi e comprendersi come appartenente alla natura – in
primo luogo alla sua natura corporea – e corrispondentemente la natura non viene più interpretata
24
Ivi, p. 70. Böhme riprende l’idea foucaultiana di “cura di sé” nel senso di una dietetica dell’essere corporeo e la
inserisce nella sua teoria della corporeità come compito in Böhme (2017), pp. 345-359.
25
Richiamandosi al celebre saggio benjaminiano sulla riproducibilità tecnica dell’arte, Böhme analizza le
conseguenze filosofiche ed antropologiche della crescente riproducibilità tecnica della natura: Böhme (1992), p. 107123. Come Benjamin ritrova la causa del declino dell’aura dell’opera d’arte nella sua riproducibilità tecnica, così
Böhme individua nella crescente potenza naturomimetica della tecnica la causa del declino dell’aura della natura: cfr.
Böhme (1992), p. 118.
26
Cfr. Böhme (1992), p. 113. La rinnovata rilevanza che assume oggi la natura come rappresentazione culturale
fondamentale (natura come valore per il tempo libero, come elemento fondamentale dell’estetica delle merci, come
rappresentazione degli obiettivi politici, come predicato di qualità per ogni cosa) è per Böhme un sintomo della sua
ineluttabile decadenza assiologica.
27
In questa direzione si muove l’interpretazione heideggeriana del reale nell’età del dominio della tecnica che il
filosofo di Meßkirch chiama età della macchinazione [Machenschaft] intendendo con questo termine la «capacità di fare
ed estinguere l’ente, dal momento che in essa si determina già l’essentità dell’ente abbandonato dall’essere […]»
(Heidegger, 1997. p. 16).
28
Böhme (1992), p. 115.
29
Cfr. Böhme-Schramm (1985).
30
Cfr. Böhme (2002a), pp. 25-28.
231
�Sandro Gorgone
come datità esteriore ma, al di là e forse al di qua di una lunga tradizione lessicale, come il nome di
una totalità indeterminata e diffusa in modo simile a come essa veniva concepita dai presocratici
attraverso il concetto di apeiron31. Secondo Böhme, «ciò apre la possibilità di una nuova filosofia
della natura come filosofia prima ma preclude, allo stesso tempo, la possibilità di derivare dal
concetto di natura anche norme morali» 32.
Come Böhme afferma nel suo libro emblematicamente intitolato Die Natur vor uns33, la
trasformazione rivoluzionaria della concezione della natura che si attua in senso anti- o
postmoderno e che coincide con il fenomeno planetario della globalizzazione economica e sociale,
consiste precisamente nel fatto che essa non si presenta più come qualcosa che è dietro di noi, come
qualcosa di superato dal progresso scientifico e dalla formazione sociale e civile dell’individuo. La
natura non sta dietro di noi nemmeno nel senso di uno stato incontaminato e quasi paradisiaco che
poi sia andato perduto a causa della civiltà ed a cui si dovrebbe fare ritorno, secondo la prospettiva
del pensiero naturalistico di cui Jean-Jacques Rousseau è certamente l’esponente più celebre 34. La
natura sta, piuttosto, davanti a noi, nel senso che essa pone all’umanità contemporanea una sfida
decisiva. In una prospettiva propriamente etico-politica, il compito che ci pone la natura nel nostro
tempo è quello di una «produzione [Herstellung] della natura, nel senso di uno stato naturale che si
possa chiamare umano, ovvero che in un prevedibile futuro consenta un’esistenza degna
dell’uomo»35.
La natura, nel suo duplice senso di natura esteriore e di natura corporea che noi stessi siamo, sta
di fronte a noi, secondo Böhme, anche perché essa è di nuovo, se pure in un modo completamente
diverso da quello tipico della tradizionale filosofia della natura, un topos fondamentale per
l’autocomprensione dell’uomo. Il dibattito sulla “morte della natura” che si ritrova soprattutto
nell’opera di Ulrich Beck e nella connessa categoria di seconda modernità36, attraverso la
descrizione della trasformazione antropogenica della natura a livello globale indica in modo
evidente il declino della concezione tradizionale di natura come datità ed ambito di regolarità
normativa. Tuttavia, a causa della crisi ambientale, «la meditazione della propria naturalità, ancora
di più, la sua riabilitazione nell’autocomprensione umana, diviene un compito ineludibile» 37.
Il ruolo della natura come fondamento portante e presupposto dato è messo radicalmente in
questione dalla prassi tecnica e medica e l’uomo non è più disposto a riconoscere qualcosa di dato
come dimostra in modo emblematico l’esempio più volte discusso da Böhme della nascita
programmata38. La fiducia nell’autonomia e spontaneità della natura esteriore così come della
propria natura39, ossia del proprio corpo vivente, è andata completamente perduta40. Di fronte a
questo tragico venir meno della natura come orizzonte di riferimento orientativo e come
fondamento portante – in cui si acutizza e si approfondisce l’annuncio nietzscheano della morte di
Dio – Böhme si pone la domanda capitale sui possibili presupposti di una rinnovata interpretazione
dell’essenza dell’umano: «La revoca dello stato naturale determina l’essere umano oggi ed in futuro
in modo definitivo? In base a cosa deve orientarsi l’uomo alla luce di questo evento?»41.
31
Cfr. Böhme (1992), p. 123.
Ivi, p. 123.
33
Böhme (2002a).
34
Böhme sottolinea, tuttavia, come l’utilizzo che fa Rousseau del concetto di stato di natura sia comprensibile
esclusivamente a partire dal suo intento di una critica della società: cfr. Böhme (2002a), pp. 10-11.
35
Böhme (2002a), p. 10.
36
Cfr. Beck (2000).
37
Böhme (2002a), pp. 47-48.
38
Böhme (1992), pp. 94-104 e (2017), pp. 326-342.
39
Per l’uomo moderno nessun ordine è più rintracciabile nella natura o come natura e ciò dipende, almeno in parte
dal fatto che la manifestazione più evidente della natura, l’ecosistema della terra, non è più qualcosa di determinato
soltanto da se stesso ma è sempre più co-determinato dall’attività storica dell’uomo.
40
«Le tecniche di controllo e regolamentazione dei propri atti di vita, la moderna dietetica servono, in parte, a
compensare tale perdita di fiducia, in parte, però, ne sono esse stesse la causa» (Böhme, G., 1992, p. 91).
41
Böhme (2002a), p. 91.
32
232
�Per una nuova fenomenologia della natura. La filosofia delle atmosfere di Gernot Böhme
Mi sembra che si possa provare a rispondere a questa domanda capitale posta da Böhme
riprendendo il tema centrale delle sue opere più recenti, quello delle atmosfere, in particolar modo
l’atmosfera della naturalità, la cui trattazione ha lo scopo di superare la tradizionale
contrapposizione tra natura e arte, natura e tecnica. È lo stesso Böhme, peraltro, a ribadire che
l’esigenza di un “ritorno alla natura” non viene meno con il declino del concetto tradizionale di
natura, ma si concentra soprattutto sulla natura corporea dell’essere umano: il sintomo più evidente
di questa nuova comprensione dell’uomo come natura è «il sempre più ampio consenso sul fatto che
la dignità dell’uomo si collochi non più primariamente nell’essere-persona o nella sua razionalità
ma proprio nella sua corporeità. Contro torture, manipolazioni genetiche, medicina riproduttiva,
eutanasia e morte tecnicamente assistita la natura che noi stessi siamo, il corpo, si rivela per
l’appunto l’ambito in cui va salvaguardata la dignità umana»42.
4. Il gesto della naturalezza
Anche se la natura, quella esteriore e quella corporea dell’uomo, ha perso per l’uomo odierno la sua
portata ontologica ed assiologia, resta, tuttavia, quella che potremmo chiamare la sua potenza di
irradiazione43 che si pone come una fonte di senso irrinunciabile e necessaria per
l’autocomprensione esistenziale dell’uomo. Alcuni caratteri di questa potenza di irradiazione si
possono evincere dalla trattazione böhmiana del “gesto della naturalezza” 44 che si ritroverebbe
soprattutto nelle forme riprodotte della natura attraverso i gesti delle arti “naturali” in grado di
evocare la potenza irradiante della natura. Le forme riprodotte della natura, infatti, mostrano la
naturalezza come un’atmosfera, un fluido «che contraddice la loro esistenza cosale, ossia la loro
artisticità stessa»45. La percezione del gesto della naturalezza possiede sempre un carattere
riflessivo, come Böhme ricava dalla teoria dell’espressione di Ludwig Klages 46. L’espressione,
infatti, secondo Klages, implica una partecipazione attuativa [Mitvollzug] del soggetto che la
percepisce: «Il carattere espressivo di un movimento – scrive Böhme a tal proposito – viene
compreso nella virtualità della partecipazione attuativa. Ciò significa che la percezione
dell’espressione poggia su un’intima parentela del percipiente con il percepito» 47. Estendendo
questo pensiero di Klages, Böhme può, dunque, affermare che la percezione della naturalezza è
sempre anche la percezione della nostra propria naturalezza48.
La naturalezza come atmosfera fondamentale rimanda, poi, a due caratteri principali che Böhme
deriva ancora dal pensiero di Klages: la vitalità (che Klages collega all’imprevedibilità del moto
proprio degli animali e soprattutto alla crescita delle forme vegetali) e la partnership. Il “gesto della
naturalezza” consisterebbe, dunque, nel fatto che le forme naturali nel loro sviluppo autonomo
manifestano la dinamica propria della vita, il cui ritmo e le cui modalità espressive risuonano con
l’essere vivente che le osserva. Il secondo carattere della naturalezza, partnership, indica invece
l’accordarsi reciproco tra elementi di una stessa serie naturale; di tale carattere “naturale” sono
esempi affascinanti e sorprendenti il cadere armonico dei fiocchi di neve, il crescere simmetrico
della chioma di un albero e il volo sincronico degli stormi d’uccelli. Lo sviluppo di queste forme
non è determinato soltanto dall’adattamento all’ambiente esterno ma indica forme di autopoiesi
all’interno dell’intero processo di crescita. Lo specifico carattere “naturale” di questi movimenti di
crescita, maggiormente evidente nella crescita delle forme vegetali, che Klages caratterizza come
“danze della vita”, consiste nel fatto che essi non formano mai un ordine compiuto, ma sempre un
“ordine in divenire”; tale ordine non determina necessariamente tutti i movimenti dei singoli
42
Ivi, pp. 91-92.
Ernst Jünger ha a lungo meditato sul carattere irradiante dei fenomeni naturali delineando una sorta di
“fenomenologia irraggiante”: su questa prospettiva della sua opera cfr. Gorgone (2016).
44
Cfr. Böhme (1992), pp. 141-159.
45
Böhme (1992), p. 152.
46
Cfr. Klages (2015).
47
Böhme (1992), p. 154.
48
Ibidem.
43
233
�Sandro Gorgone
elementi, così che il movimento del tutto si mostra sempre come l’insieme dei movimenti dei
singoli elementi. È proprio questa intima molteplicità dinamica, insieme con la loro multiformità
irriducibile ad un unico paradigma morfologico, a caratterizzare il gesto della naturalezza.
Ma per comprendere la complessità di questo concetto di naturalezza, che Böhme analizza
soprattutto dalla prospettiva di una nuova estetica della natura, dobbiamo ora rivolgerci
direttamente al cuore della fenomenologia della natura böhmiana, ossia alla teoria delle atmosfere.
5. La natura delle atmosfere
Le atmosfere come portatrici spaziali di Stimmungen49 costituiscono per Böhme il medium
fenomenologico tra l’essere-nel-mondo corporeo e le specifiche qualità dell’ambiente esterno.
L’uomo si trova costantemente in una determinata situazione percettiva che impronta in modo
decisivo il suo rapporto con il mondo. Le percezioni sono, infatti, primariamente tracce della
“presenza corporea”50, ossia tracce di una certa atmosfera; il percepire è sempre un “percepire
sensibile” a cui appartiene essenzialmente il momento della corporeità. Nell’ambito del suo
progetto di rifondazione dell’estetica come teoria generale della percezione a partire dal concetto di
atmosfera, Böhme afferma: «Alla percezione appartiene l’essere affettivamente toccati
[Betroffenheit] da ciò che si percepisce, appartiene la realtà delle immagini, appartiene la
corporeità. Percepire è in fondo il modo in cui si è corporalmente presso qualcosa o presso qualcuno
o come ci si trova nelle sue vicinanze. L’oggetto primario della percezione sono le atmosfere» 51.
La percezione non si rivolge, dunque, direttamente alle cose ma si orienta verso ciò che di esse
avvertiamo, verso le loro irradiazioni, ossia, appunto, verso le atmosfere 52. Le atmosfere che si
irradiano dalle costellazioni spaziali e temporali, intonano sempre in una determinata maniera il
nostro essere-corporeo. La tradizionale divaricazione tra mondo soggettivo e mondo oggettivo
viene, dunque, completamente superata dalla complessa correlazione tra la qualità dell’ambiente e
la nostra situazione mondana [Weltbefindlichkeit]. Per sviluppare questo presupposto, Böhme segue
una diffusa opinione secondo cui dietro la crescente estetizzazione del reale sia all’opera un
processo di rimozione e dissoluzione dell’oggettività a favore della preminenza del carattere iconico
e teatrale del nostro rapporto con il mondo 53: «Noi oggi non percepiamo più oggetti ma soltanto
segnali»54. Ciò vale in primo luogo per la percezione della natura, così che la “natura delle
atmosfere” – laddove questo genitivo va inteso primariamente in senso oggettivo – costituisce
l’oggetto privilegiato di una nuova estetica della natura nel senso di una fenomenologia corporea
della natura.
Ma che cosa intende propriamente Böhme con il concetto di atmosfera che contiene in sé un
irriducibile grado di vaghezza ed i cui confini semantici sembrerebbero essere difficilmente
definibili? L’uso comune di questo termine ci induce, infatti, ad affermare che l’atmosfera indica
49
Preferisco non tradurre questo termine tedesco la cui estensione semantica si sovrappone a quella di atmosfera; le
più comuni traduzioni italiane (stato d’animo, umore, tonalità emotiva, ecc.) darebbero adito ad interpretazioni di tipo
soggettivistico e psicologistico che Böhme intenzionalmente intende evitare in quanto troppo unilaterali: le
Stimmungen, così come le atmosfere, si pongono, infatti in una posizione ontologicamente mediana rispetto alla
contrapposizione tipicamente moderna tra soggetto e oggetto, tra interiorità ed esteriorità. Esse, piuttosto, vanno
ricollegate alla Befindlichkeit heideggeriana intesa come modalità ontologica originaria dell’esserci in cui di volta in
volta si dischiude il suo essere-nel-mondo. Come le atmosfere per Böhme, la Stimmung nel contesto dell’analitica
esistenziale di Essere e tempo è strettamente connessa con la costitutiva apertura dell’esserci al mondo: cfr. Heidegger
(2006), p. 395. Sulle Stimmungen nel pensiero di Heidegger, cfr. soprattutto Caputo (2001) e (2005).
50
Per Böhme la modalità percettiva fondamentale e onnicomprensiva è la “sensazione atmosferica della presenza”
(cfr. Böhme (2010), pp. 77-79.
51
Böhme (2013), pp. 47-48.
52
Già nell’etimologia del termine atmosfera (sfera dell’esalazione, dei vapori) è implicito un riferimento alla sua
essenza irraggiante.
53
«L’estetizzazione del reale è al contempo un processo di rimozione. Ci troviamo in un’epoca teatrale, in un nuovo
barocco» (Böhme 2013, p. 14).
54
Ivi, p. 17.
234
�Per una nuova fenomenologia della natura. La filosofia delle atmosfere di Gernot Böhme
qualcosa di «indeterminato, diffuso ma non indeterminato in relazione a quello che è il suo
carattere»55. Anche se disponiamo di un ricco ed articolato lessico per caratterizzare le atmosfere
(un’atmosfera può essere serena, melanconica, seducente, piacevole, invitante, erotica, ecc.) il loro
statuto ontologico resta incerto: «Non si sa esattamente se bisogna assegnarle all’ambito degli
oggetti o degli ambienti da cui esse scaturiscono o alla sfera dei soggetti che ne fanno esperienza» 56.
Inoltre, le atmosfere non possono essere esattamente localizzate: «non si sa esattamente dove siano.
Sembra che esse riempiano lo spazio con una tonalità emotiva un po’ come se fossero una
nebbia»57.
L’atmosfera non appartiene, dunque, né all’oggetto né al soggetto ma è una sorta di co-presenza;
con un’espressione di Hermann Schmitz che abbiamo già richiamato, l’atmosfera sarebbe una
“semi-cose” [Halb-Ding] al di qua della contrapposizione soggetto-oggetto. Solo a posteriori le
atmosfere si differenziano nel polo soggettivo ed in quello oggettivo della relazione e si stabiliscono
nella struttura duale tipica della gnoseologia moderna. Con questo concetto Schmitz vuole indicare
da un lato l’autonomia di questi particolari fenomeni nei confronti dell’io che ne fa esperienza e
dall’altro il loro carattere cosale che si manifesta in primo luogo nel fatto che esse posseggono
differenti sfumature e che possono essere esperite da diverse prospettive58.
Le atmosfere come “semi-cose” rappresentano, dunque, un ambito fenomenico che si estende
oltre il campo di ricerca delle scienze della natura59; per la loro costitutiva effettualità ed attualità
esse costituiscono, inoltre, la modalità pura della fenomenicità: «Le semi-cose […] sono tutto ciò
che sono esclusivamente nella pura attualità. […] Le semi-cose sono fenomeni puri, ossia apparenze
che esistono solo fintanto che appaiono e non apparenze di qualcosa» 60.
Il vento, la notte, il freddo o la tempesta, in quanto esempi di “semi-cose” naturali che Böhme
riprende dalle analisi schmitziane, possono essere considerati oggetti della scienza della natura ma
soltanto a costo di perdere il loro carattere semi-cosale che si manifesta sempre relativamente al
corpo umano: «I fenomeni che vengono caratterizzati come semi-cose, sono esperiti in quanto tali
solo attraverso la presenza corporea e cioè attraverso il loro intervenire nell’economia corporea,
ovvero attraverso il loro concorrere a tale economia»61.
Secondo Böhme si può individuare nella distanza che inerisce ad ogni manifestazione di
un’atmosfera un carattere fondamentale dell’atmosferico 62; in quella distanza che necessariamente
deve essere contenuta nell’esperienza – ovvero nella constatazione corporea – di questi fenomeni.
Anche per tale caratterizzazione dell’atmosferico Böhme si richiama, dunque, al concetto
bejaminiano di aura ed alla “apparizione di una distanza” che in essa sarebbe essenzialmente
contenuta. Egli collega esplicitamente il concetto di atmosferico con quello di aura rintracciando
55
Böhme (2013), p. 22.
Ibidem.
57
Ibidem. «L’atmosfera è […] uno spazio con una sua tonalità emozionale, ossia ciò che qui ci suggerisce una certa
impressione, è una disposizione d’animo. […] [Le atmosfere] sono delle disposizioni d’animo indefinitamente estese
nello spazio (quasi-oggettive)» (Böhme 2010, p. 84). Böhme attribuisce alle atmosfere anche un carattere di totalità nel
senso di una “totalità diffusa”: cfr. Böhme (2013), pp. 102-103.
58
Cfr. Schmitz (2016). Nella stessa prospettiva fenomenologica delle atmosfere inaugurata da Schmitz già nei primi
volumi del suo System der Philosophie (cfr. in particolare Der Gefühlsraum in Schmitz 1964-1980, III, 2), si muovono
anche le ricerche sull’estetica delle atmosfere e sui sentimenti come atmosfere di Tonino Griffero (cfr. soprattutto
Griffero 2013 e 2017) che così esprime l’intento della sua atmosferologia: «L’atmosferologia e l’ontologia quasi-cosale
procedono dunque a un’ambiziosa decosalizzazione senza necessariamente popolare, come vuole la fisica, il mondo
intero di onde, ma più semplicemente aiutando a mantenere sufficientemente aperto l’orizzonte filosofico: fosse anche
solo per preservare le quasi-cose dalla furia riduzionista» (Griffero 2013, p. 26).
59
Cfr. Böhme (1997b), p. 147.
60
Böhme (2010), p. 103.
61
Böhme (1997b), p. 143.
62
Böhme pone una differenza, che resta a mio avviso problematica, tra atmosfera e atmosferico riservando
propriamente a quest’ultimo il carattere ontologico semi-cosale: cfr. Böhme (1997b), pp. 144-147; (2010), pp. 99-115;
(2013), pp. 137-140.
56
235
�Sandro Gorgone
anche in quest’ultima un carattere quasi-cosale: l’aura sarebbe, come l’atmosfera, un «involucro
vuoto e privo di caratteri della presenza dell’atmosfera»63.
La teoria dell’atmosferico presuppone, dunque, un decisivo mutamento della tradizionale
concezione filosofica della cosa come sostanza dotata di qualità accidentali o materia formata.
Forma e qualità di una cosa dovrebbero piuttosto «essere comprese come estasi o meglio restrizioni
o articolazioni del presentarsi [das Heraustreten] di una cosa»64. L’estaticità della cosa va intesa,
però, non soltanto nel senso fenomenologico dell’apparire fenomenico, ma come fonte
dell’irraggiamento spaziale che è all’origine dell’effondersi delle atmosfere. Tale spazio di
irraggiamento non ha qualità fisico-oggettive ma si identifica con lo spazio della Betroffenheit
corporea. Le cose, in particolar modo le cose naturali, possiedono un determinato potenziale
espressivo [Ausdruckpotential], un’espressività fisiognomica65 che fa della loro presenza un
medium per la Betroffenheit corporea del soggetto; così una costellazione strutturata di cose naturali
e di prodotti antropici – un paesaggio 66 – genera, nella sua dimensione proprio-corporea, una
determinata atmosfera.
Grazie a questa ontologia delle atmosfere, che consente di individuare un livello mediano tra
soggettività e oggettività, Böhme può sviluppare una vera e propria fisiognomica della natura nel
senso di un’analisi dei suo caratteri atmosferici irraggianti: così come la fisiognomica dell’uomo
intende rintracciare a partire da determinati tratti somatici i suo caratteri interiori, così la
fenomenologia fisiognomica della natura considera i tratti naturali esteriori al fine di scoprire i suoi
caratteri interiori utilizzando una modalità di conoscenza che non tende a spiegare in modo
riduzionistico i fenomeni ma a comprenderli nella loro complessità unitaria e ad interpretarli alla
luce di una struttura di senso e di rimandi analogici e simbolici 67. A partire da Aristotele, tali
caratteri interiori della natura68 sono stati evidenziati soprattutto attraverso il suo processo di
personificazione che Böhme interpreta come antecedente dell’interpretazione fenomenologicofisiognomica della natura attraverso la tematizzazione Betroffenheit corporea69.
Tali caratteri nominano un’impressione unitaria della natura colta intuitivamente e la formulano
in modo fisiognomico. Esse, dunque, differiscono dalle affermazioni delle scienze naturali, anche se
possono ricoprire un ruolo euristico per la scienza in quanto rappresentano indicazioni di ciò che va
ricercato nella natura e di ciò che da essa ci si può aspettare.
I caratteri unitari della natura, che si esprimono sempre in una determinata “lingua della natura”,
possono, infine aiutare a ripensare le configurazioni ecologiche e la correlazione dei loro elementi,
consentendo così di sviluppare in senso filosofico, ma anche sociale e politico, la questione
ecologica al di là dei calcoli tecnici ed economici relativi ai problemi della sostenibilità e della
tutela ambientale70.
63
Böhme (2013), p. 26.
Böhme (1989), p. 52. Böhme interpreta le estasi come “forme espressive” delle cose in Böhme (2013), p. 108.
Cfr. anche Böhme (2010), pp. 193-210 in cui Böhme definisce le estasi come “espressioni della presenza” di una cosa
(ivi, p. 195).
65
«La dimensione dell’espressione è dunque una struttura fondamentale di ogni cosa naturale» (Böhme 1989, p. 53).
Riferimenti essenziali per la formulazione di questa determinazione fisiognomica della cosa di Böhme sono il Klages
dei Fondamenti della scienza dell’espressione (Klages 2015) e la teoria dell’espressività delle forme naturali, la
cosiddetta teoria della signatura rerum presente sia in Paracelso che in Jakob Böhme che Böhme analizza in Böhme
(1989), pp. 121-138.
66
Sul paesaggio come modalità emblematica di espressione delle atmosfere cfr. Böhme (2013), pp. 212-222.
67
Sul rapporto tra fisiognomica e atmosfere cfr. Böhme (2010), pp. 155-174 e (2013), pp. 202-212 in cui Böhme
afferma che «il riconoscere fisiognomicamente è primariamente un percepire un’atmosfera» (ivi, p. 206).
68
Per Aristotele tali caratteri erano principalmente individuati nei seguenti principi: “la natura non fa nulla invano”
e “la natura tende sempre al meglio”.
69
Cfr. Böhme (1992), p. 63.
70
A partire dalla fondazione atmosferologica e fisiognomica della fenomenologia della natura, Böhme può delineare
la prospettiva di una nuova estetica naturale ecologica: Böhme (1989), pp. 92-95. Sul carattere ecologico del pensiero di
Böhme cfr. Chandler (2011).
64
236
�Per una nuova fenomenologia della natura. La filosofia delle atmosfere di Gernot Böhme
Al fondo della nuova prospettiva estetico-ecologica delineata da Böhme si colloca, dunque, il
concetto di atmosfera attraverso cui è possibile interpretare la sfera di relazioni reciproche tra le
costellazioni di elementi naturali ed antropici. Presupposto di questa che, richiamandoci
all’esperienza presocratica della natura, possiamo definire una “fisiologia atmosferologica”, è
l’ontologia semi-cosale secondo cui le cose non si comprendo più come entità spazialmente e
temporalmente delimitate, che possono interagire con il loro ambiente attraverso scambi materiali
ed energetici, ma, invece, come luoghi di espressività e di stratificazione storico-esistenziale e
simbolica, fonti di irraggiamento ed ambiti relazionali in cui si realizza il compito originario
dell’ecologia intesa come sapere della dimora dell’uomo sulla terra, del suo soggiornare
corporalmente e culturalmente nella natura.
Bibliografia
Aristotele (1979), L’anima, trad. it. a cura di G. Movia, Loffredo, Napoli.
Andreozzi, M. (ed.) (2012), Etiche dell’ambiente. Voci e prospettive, LED, Milano.
Beck, U. (2000), La società del rischio: verso una seconda modernità, trad. it. a cura di W.
Privitera, Carocci, Roma.
Böhme, G. (1989), Für eine ökologische Naturästhetik, Suhrkamp, Frankfurt a.M.
Böhme, G. (1992), Natürlich Natur. Über Natur im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit,
Suhrkamp, Frankfurt a.M.
Böhme, G. (1997a), Phänomenologie der Natur – ein Projekt, in Böhme, G.-Schiemann, G. (Eds.)
Phänomenologie der Natur, Suhrkamp, Frankfurt a.M., pp. 11-43.
Böhme, G. (1997b), Die Phänomenologie von Hermann Schmitz als Phänomenologie der Natur?,
in Böhme, G.-Schiemann, G. (Eds.) Phänomenologie der Natur, Suhrkamp, Frankfurt a.M., pp.
133-148.
Böhme, G. (2002a), Die Natur vor uns. Die Naturphilosophie in pragmatischer Hinsicht, Die Graue
Edition, Kusterdingen.
Böhme, G. (2002b), Über die Natur des Menschen, in A. Barkhaus-A. Fleig (Eds.), Grenzverläufe,
Fink, München 2002, pp. 233-247.
Böhme, G. (2010), Atmosfere, estasi, messe in scena. L’estetica come teoria generale della
percezione, Marinotti, Milano.
Böhme, G. (2013), Atmosphäre. Essays zur neuen Ästhetik, Suhrkamp, Frankfurt a.M.
Böhme, G. (2017), Leibsein als Aufgabe. Leibphilosophie in pragmatischer Hinsicht, Die Graue
Edition, Kusterdingen.
Böhme, G.-Böhme, H. (1996), Feuer, Wasser, Erde, Luft. Eine Kulturgeschichte der Elemente,
Beck, München.
Böhme, G.-Schiemann, G. (Eds.) (1997), Phänomenologie der Natur, Suhrkamp, Frankfurt a.M.
Böhme, G.-Schramm, E. (Eds.) (1985), Soziale Naturwissenschaft: Wege zu einer Erweiterung der
Ökologie, Fischer, Frankfurt a.M.
Caputo, A. (2005), Heidegger e le tonalità emotive fondamentali, 1929-1946, Franco Angeli,
Milano.
Caputo, A. (2001), Pensiero e affettività: Heidegger e le Stimmungen, 1889-1928, Franco Angeli,
Milano.
Chandler, T. (2011), Reading Atmospheres: The Ecocritical Potential of Gernot Böhme’s Aesthetic
Theory of Nature, Oxford University Press, Oxford.
Dell’Utri, M. (2002), Olismo, Quodlibet, Macerata.
Gorgone S. (2016), Strahlungen und Annährungen, Attempto, Tübenigen.
Griffero, T. (2013), Quasi-cose. La realtà dei sentimenti, Bruno Mondadori, Milano-Torino.
Griffero, T. (2017), Atmosferologia. Estetica degli spazi emozionali, Mimesis, Milano-Udine.
Heidegger, M. (2006), Essere e tempo, trad. it. a cura di A. Marini, Mondadori, Milano.
Heidegger, M. (1997), Besinnung, in Gesamtausgabe, vol. 66, Klostermann, Frankfurt a.M.
237
�Sandro Gorgone
Henry, M. (2001), Incarnazione: una filosofia della carne, trad. it. a cura di G. Sansonetti, SEI,
Torino.
Klages, L. (2015), Espressione e creatività, trad. it. a cura di D. Di Maio, Marinotti, Milano.
Kluwe, S. (2003), Naturphilosophie und Holismus bei Gernot Böhme und Michael Esfeld, Mohr
Siebeck, Heidelberg.
Merleau-Ponty, M. (2003a), Fenomenologia della percezione, trad. it. a cura di A. Bonomi,
Bompiani, Milano.
Merleau-Ponty, M. (2003b), Il visibile e l’invisibile, trad. it. a cura di A. Bonomi, Bompiani,
Milano.
Ott, K. (2010), Umweltethik zur Einführung, Junius, Hamburg.
Schmitz, H. (1964-1980), System der Philosophie, Bd. I-V, Bouvier, Bonn.
Schmitz, H. (1980), Neue Phänomenologie, Bouvier, Bonn.
Schmitz, H. (2003), Was ist Neue Phänomenologie?, Koch, Rostock.
Schmitz, H. (2011), Nuova fenomenologia. Un’introduzione, trad. it. a cura di T. Griffero,
Marinotti, Milano.
Schmitz, H. (2016), Atmosphären, Alber, Freiburg/München.
Waldenfels, B. (2000), Das leibliche Selbst. Vorlesungen zur Phänomenologie des Leibes,
Suhrkamp, Frankfurt a.M.
Weiss, M.G. (2005), “La dissoluzione della natura umana. Il potenziale critico delle biotecnologie
tra emancipazione ed essenzialismo”, Annali di studi religiosi, vol. 6, pp. 219-249.
Abstract
The paper aims to interpret the proposal of the German philosopher Gernot Böhme of a new
phenomenology of nature in the sense of an integration of the classical Husserlian phenomenology
which, according to Böhme, had neglected the phenomenon of nature thus becoming a pure analysis
of consciousness with a strong transcendental character. The starting point is the New
Phenomenology of Hermann Schmitz, who affirms that phenomenon is a “giveness in bodily
tracks”. Böhme emphasizes the concrete human bodily experience in the natural environment with
the practical (ethical and ecological) purpose to show that humans are a part of nature. To this
purpose, he goes back to the Aristotelian conception of nature and to Goethe's theory of colours.
The way in which Nature influences our own feeling of being-there (Befindlichkeit) is named by
Böhme atmosphere. In its peculiar ontological quality (the atmospheres are “quasi-things” and place
themselves in an intermediate sphere between subject and object), the atmosphere is the new
phenomenological core of the conceiving of nature. Böhme interprets the atmospheres as irradiation
and evocation of spaces, things and human beings, bodily resonances of living physical,
architectonical and natural environments that we can perceive through particular aesthesiological
experiences. The physiognomic and expressive power of natural atmospheres, that Böhme finds
especially in landscapes, represents the most peculiar character of his phenomenology of
atmosphere.
Keywords: Phenomenology, Nature, Body, Thingness, Atmospheres, Naturalness, Return to Nature
238
�LUCA GUIDETTI*
La logica non-aristotelica da un punto di vista fenomenologico.
Gotthard Günther e Oskar Becker
1. La fenomenologia della logica formale
Una delle più importanti eredità della filosofia kantiana, trapassate prima nel neokantismo
ottocentesco e poi nella fenomenologia, è il contrasto tra logica formale e logica trascendentale.
Come nota Heinrich Scholz, per Kant la logica formale è identificata con la logica tradizionale
risalente ad Aristotele, in cui l’uso di simboli al posto di espressioni linguistiche serve a rendere
univoco il discorso1. Ma a parte la difficoltà di accomunare la logica aristotelica alla logica
tradizionale, il cui uso copulativo della frase è estraneo ad Aristotele, la sovrapposizione kantiana
intende la logica classica (aristotelico-tradizionale) come una logica formale allargata in cui risulta
oscurato il ruolo svolto dalla “logistica”, cioè dalla tradizione formale del “calcolo logico
matematizzato” risalente a Leibniz2. Questo complesso intreccio è fonte di numerosi equivoci che
toccano da un lato la “logica trascendentale”, inclusa nell’ampio e confuso spettro delle logiche
non-formali (gnoseologia, metodologia, teoria delle categorie) e dall’altro la stessa logistica che,
come logica formale in senso stretto (“formalistica”), finisce per ridursi a un linguaggio simbolico
astratto, sorretto da regole sintattiche del tutto separate da qualsiasi contenuto semantico 3.
Da un punto di vista fenomenologico, che Husserl sviluppa nella Prima sezione di Logica
formale e trascendentale (1929)4, il primo compito è quello di chiarire il ruolo svolto dalla logica
formale – e in particolare della logistica – all’interno di una più ampia teoria dell’esperienza non
pregiudicata in un determinato senso categoriale (come teoria della conoscenza, psicologia,
fisiologia del pensiero o, in generale, come ontologia), al fine di far emergere il significato che la
logica trascendentale fenomenologica assume rispetto alla logica trascendentale kantiana 5. Tale
chiarimento riguarda due questioni, vale a dire: a) il senso e i limiti delle strutture di calcolo che
configurano le “forme” della logica; b) le funzioni di queste forme rispetto alle strutture oggettuali
dell’esperienza, cioè alle specifiche determinazioni semantiche in cui l’esperienza si delinea e
assume rilevanza fenomenologica.
Per ciò che attiene alla simbologia e al calcolo logico, Husserl nota come esso, in quanto pura
dottrina delle forme (morfologia) o «sistema di tutte le forme possibili» 6, non abbia nulla a che
vedere con processi di astrazione o di derivazione da contenuti predefiniti (di pensiero, di strutture
percettive, di oggetti ecc.). Ogni dipendenza delle forme logiche in tal senso ricade nella “fallacia
naturalistica” di attribuzione, quale si rinviene, ad esempio, nelle forme pure dell’intuizione o nelle
forme categoriali kantiane. È infatti ovvio che se spazio, tempo e concetti avessero delle “forme”
come loro “proprietà”, anche le regole del calcolo logico dovrebbero essere “dedotte” dalle loro
strutture semantiche; in tal modo, non solo la logica trascendentale occuperebbe tutto il terreno
della logica formale, ma non sarebbe possibile riservare a quest’ultima la proprietà di regolare la
correttezza del ragionamento (la “verità formale”), poiché un contenuto semantico può sempre
*
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
1
Cfr. Scholz (1983), p. 11.
Cfr. Scholz (1961), pp. 175 ss.
3
Cfr. Scholz (1983), pp. 65 ss.
4
Cfr. Husserl (1966), §§ 12-54, pp. 59-181.
5
Cfr. Bachelard (1957), Parte II, Cap. 6; Heffernan (1989), pp. 3 ss.
6
Cfr. Husserl (1966), §§ 13-14, pp. 61-65.
2
Bollettino Filosofico 33 (2018): 239-254
ISSN 1593 -7178 - 00030
E-ISSN 2035 -2670
DOI 10.6093/1593-7178/5921
�Luca Guidetti
variare indipendentemente dalla forma in cui si esprime 7. Dunque, per garantire la correttezza del
calcolo, le forme logiche non devono esprimere nulla, ma solo esibire le “regole” – potenzialmente
illimitate – che determinano la formazione e la connessione dei segni.
Ora, quest’autonomia della logica e dei rispettivi procedimenti di calcolo non deve portare a
confondere il superamento del naturalismo – a cui anche la fenomenologia aspira – con la
ricusazione dal più vasto ambito del “logico” del problema del “significato” delle forme logiche.
Tale problema è infatti per Husserl connaturato alla stessa emergenza delle strutture simboliche che
si ritrovano in tutti i possibili sistemi logici e dipende dalla “bilateralità operativa”, sia empirica sia
trascendentale, che sta a fondamento della morfologia pura8. Per quanto riguarda l’operatività
empirica e le correlative strutture di senso, essa sorge in seguito all’“applicazione” delle forme
logiche e delle regole di calcolo a determinati ambiti oggettuali “materiali”. Così, ad esempio, la
regola formale della somma aritmetica dice che due unità di una certa quantità di liquido, aggiunte
ad altre due, danno quattro unità, ma non interviene sui contenuti particolari degli oggetti a cui tale
regola viene applicata, essendo in alcuni casi possibile (come nell’unione di certe sostanze
chimiche) che il “risultato effettivo” di tale somma sia uguale a tre sole unità, senza per questo
condurre a una modifica retroattiva delle regole formali del calcolo 9. Poiché nella sua pura forma
ogni segno può avere qualsiasi significato, il problema del “significato conoscitivo” degli oggetti
logico-formali e delle loro regole sintattiche non si pone se, in senso “fenomenologico-descrittivo”,
l’ambito formale del calcolo e quello funzionale della sua applicazione vengono mantenuti distinti
per quanto riguarda la loro “natura essenziale”, ma si presenta quando si richiede una
“giustificazione” della loro corrispondenza sulla base delle esigenze di restrizione della morfologia
logica a determinati contesti operativi dell’esperienza 10. In quanto semplice “mezzo di
designazione”, il calcolo logico, come pura “morfologia sintattica”, non solo non può essere fondato
su qualche struttura ontologica o conoscitiva preventivamente assunta, ma non è in grado di
decidere riguardo alla propria “adeguatezza” in riferimento a un certo ambito fenomenico. Per tale
ragione, nessun significato che emerge da un’operatività empirica può condizionare in senso
naturalistico le strutture logiche.
D’altra parte, questa necessaria distinzione tra forma e contenuto non impedisce che, dal punto di
vista trascendentale, una struttura logica possa derivare da, o viceversa condizionare, una certa
“configurazione dell’esperienza”, aggiudicandosi, per un bisogno di senso connesso alla “genesi”
della stessa morfologia logica, quelle funzioni semantiche che “non” appartengono alla sua natura
formale e nei confronti delle quali essa rivendica la sua indipendenza “essenziale” 11.
Quest’operatività trascendentale si connette per Husserl all’idea stessa di una logica pura come
mathesis universalis o sistema delle molteplicità indefinite al cui interno si situano, come casi
particolari, le tradizionali strutture logiche e la stessa matematica 12. È infatti evidente come
l’indefinitezza di tale molteplicità, che si esprime come un’“operazione d’iterazione” in virtù della
quale ogni forma si origina continuamente da un’altra, debba ammettere per principio la coesistenza
di forme sintatticamente inconciliabili, in quanto non limitabili ai tradizionali principi d’identità,
non-contraddizione e terzo escluso 13. Anche tali forme “non-classiche” sono dunque incluse nello
schema empirico-trascendentale della bilateralità operativa, ma, non essendo conformi alla “logica
della conseguenza” o “apofantica” di matrice aristotelica, fondata sul principio di noncontraddizione (che per Husserl rappresenta il secondo livello di formalità), esse lasciano aperta la
questione della loro applicazione a contesti empirici che “rifiutano” tale principio.
7
Cfr. Scholz (1961), pp. 178-179.
Cfr. Husserl (1966), § 8, pp. 40-43.
9
Cfr. Pap (1967), pp. 131-132.
10
Cfr. Melandri (1960), p. 90.
11
Cfr. Husserl (1995), §§ 99 ss., pp. 313 ss.; Derrida (1992), pp. 201 ss.
12
Cfr. Husserl (1966), §§ 23-24, pp. 88-95.
13
Cfr. ivi, §§ 74-75, pp. 233-236; van Atten (2017), p. 283.
8
240
�La logica non-aristotelica da un punto di vista fenomenologico. Gotthard Günther e Oskar Becker
Secondo Gotthard Günther, si tratta precisamente di verificare la legittimità di una logica della
conseguenza anche rispetto a tali contesti, cercando correlativamente di chiarire quali strutture
assumano per essi rilievo all’interno della pura combinatoria formale14. Inoltre, l’estensione della
logica della conseguenza a contesti non-classici offre le basi per una “logica della verità” che superi
il principio di non contraddizione e, in tal modo, realizzi l’esigenza fatta valere dalla
Wahrheitslehre husserliana secondo cui l’ontologia formale, che corrisponde alla “possibilità”
dell’esperienza, deve valere come «schema trascendentale della verità in generale», non
necessariamente coincidente con la nozione classica di coerenza formale 15. Di riflesso, ciò consente
di comprendere la semantica relativa ai contesti empirici ammessi dalla logica tradizionale,
gettando luce sulla loro stessa nozione di “verità”. Accanto alla meccanica simbolica del calcolo –
ad esempio di tipo “sillogistico” – quest’“attivazione” ontologico-semantica delle forme logiche,
per la quale la descrizione deve lasciar posto alla costituzione trascendentale, si ritrova già a partire
dalla logica “bivalente” classica, risalente ad Aristotele ma assunta come dogma inconcusso nella
logica formale contemporanea. Da qui, la necessità di ricondurre tale logica alle sue funzioni
originarie, allo scopo di rivelare la sottaciuta metabasis che, da neutrale “mezzo” calcolistico, l’ha
trasformata in “causa” o in “effetto” di ben determinate configurazioni della realtà16.
2. Günther: l’identità nella riflessione e i “valori di posizione”
Com’è noto, Aristotele sostiene a più riprese che il principio di non contraddizione è il più sicuro di
tutti, quello su cui si basa ogni determinazione degli oggetti e ogni possibilità di garantire
l’univocità del discorso17. In realtà – nota Günther riprendendo a tal riguardo alcune osservazioni
svolte da Jan Łukasiewicz – esso si basa su un principio ancor più fondamentale che,
“implicitamente”, Aristotele considera come “ultimo” e che corrisponde alla sua teoria della
sostanza, vale a dire il principio d’identità18. Da questo punto di vista, se si considera il concetto
d’identità che si è sviluppato nella metafisica classica, appare subito chiaro come la dicotomia tra
una nozione “ontologico-metafisica” e una invece “logico-linguistica” non costituisca una vera
alternativa. Poiché l’identità è inseparabile dai criteri con cui la si pone, è evidente che la forma di
tali criteri si rifletterà in qualche modo sul loro oggetto; d’altra parte, non bisogna ricadere
nell’errore opposto di ritenere che tali criteri siano la “causa” del loro oggetto e del suo
“significato”. Per chiarire questo problema – fonte d’innumerevoli fraintendimenti – si può portare
come esempio il rapporto tra il principio d’identità (A è A) e il principio di non-contraddizione (non
[A e non-A]). Per un certo aspetto, se si assume il principio di non-contraddizione nella
formulazione di Leibniz (“A non è non-A”)19, il principio d’identità potrebbe essere inteso come la
sua determinazione “positiva”, cioè come l’“inversione di senso” della contraddizione attraverso la
negazione. Così però l’identità apparirebbe inutile, rivelandosi come la mera tautologia per cui ogni
cosa è uguale a se stessa20. Ciò spiega anche la ragione per cui, tradizionalmente, non l’identità, ma
la non-contraddizione abbia rappresentato il principio più fondamentale e in sé “evidente”.
Ora, questo modo di considerare il rapporto tra i due principi, per cui un’affermazione
(l’identità) è “sinonima” della negazione della sua negazione (cioè della negazione della
contraddizione), è in contrasto con il fatto, attestabile già a livello formale, che una “molteplicità” o
14
Cfr. Günther (1976a), pp. 14 ss.
Benché, infatti, Husserl intenda il terzo livello della formalità o “dottrina della verità” come restrizione della
“dottrina della conseguenza” fondata sulla non-contraddizione classica, dal punto di vista trascendentale il principio
messo in opera da questo terzo livello significa solo che «qualunque sia o possa essere il nostro concetto di verità, esso
deve sempre consentirci di regolare la nostra scelta delle forme in modo tale che vengano a evidenziarsi solo quelle che
sono suscettibili di ricevere un contenuto conforme, cioè un valore di verità», Melandri (1960), p. 90.
16
Cfr. Günther (1976a), p. 22.
17
Cfr. Aristotele (1978), IV, 6, 1011 b 13-14, p. 315.
18
Cfr. Günther (1991)3, pp. XI ss.; Łukasiewicz (2003), p. 45.
19
Cfr. Leibniz (1988), § 31, p. 288; Łukasiewicz (2003), p. 45; Höfler (1890), p. 135.
20
Cfr. Ueberweg (1882), p. 232.
15
241
�Luca Guidetti
un “prodotto logico” tra più giudizi, che ritroviamo nella contraddizione, non possano essere intesi
come sinonimi di una forma, come l’identità, che non implica invece alcuna molteplicità; al
massimo le due forme, identità e non-contraddizione, si possono rendere “equivalenti” attraverso la
“ridefinizione” dei termini che le compongono21. Nella fattispecie, si può rendere equivalente
l’affermazione dell’identità con la sua doppia negazione, come avviene nella formulazione
leibniziana. Ma allora l’“equivalenza” – cioè la corrispondenza che si può istituire tra la posizione
positiva di un oggetto e la negazione della sua posizione negativa – non ha lo “stesso” significato
della “sinonimia”. Infatti, da un certo tipo di equivalenza deriva una certa sinonimia, ma da una
sinonimia, cioè da un’identità di significato, non deve necessariamente derivare un certo tipo di
equivalenza. Sia la definizione sia l’equivalenza sono infatti solo “regole di trasformazione” che
attingono a contesti predicativi già prestabiliti, contesti in cui emergono quei “significati” che essi
non possono “rappresentare”. Non c’è dunque bisogno di contrapporre l’ambito logico-formale a
quello ontologico-contenutistico, poiché già a livello logico si rivela l’irriducibilità del contenuto
significativo a una semplice corrispondenza di forme 22.
Seguendo l’argomentazione di Günther, la vera dicotomia non si dà tra il piano ontologico e il
piano logico dell’identità, ma tra la sua accezione “semplice” (AA) o “elementare” (A=A) e quella
“funzionale” o “contesturale”23. Entrambe le accezioni configurano infatti una ben determinata
corrispondenza tra logica “e” ontologia dell’identità. Nella fattispecie, la concezione classica
dell’identità, risalente ad Aristotele, si presenta come “elementare”, in quanto esprime la forma
“estensionale” dell’identificazione (l’identificazione denominativa) che considera l’individuo come
un oggetto isolato, atomico e in ultima istanza assoluto24. Il difetto principale di tale concezione non
si trova nel suo assolutismo, ma nell’elementarismo che l’accompagna. Qui la sostanza, o il
soggetto identico, non sono mai ontologicamente differenziabili. Ciò che rende uguali fra di loro le
sostanze, in quanto realtà per sé stanti (res quae nulla alia re indigent ad subsistendum), è infatti la
“forma della sostanzialità”. Così, in un’identità elementare tutte le relazioni devono essere esterne,
inclusa quella del soggetto con gli “altri” soggetti e persino con il suo mondo. Ma se il mondo
appartiene al soggetto come una sua proprietà esterna, allora esso non serve a qualificarlo nella sua
sostanzialità e l’insieme delle sue determinazioni relazionali esterne – inclusi lo spazio e il tempo –
risulta da ultimo accidentale25.
Inoltre, il principio d’identità elementare non si limita alla sola “legge d’identità” per cui, dato un
qualsiasi A, vale sempre e necessariamente la relazione total-riflessiva A=A, ma implica quel più
complesso stato di cose per cui, dato un qualsiasi individuo A e un qualsiasi predicato P, dei due
enunciati complementari “x è P” e “x non è P” uno dev’esser vero e l’altro falso (tertium non
datur)26. In altre parole, “la legge di terzo escluso definisce implicitamente che cosa si debba
intendere con ‘individuo’ sulla base dell’identità elementare”. Qui un individuo è tutto ciò che
risolve una tautologia predicativa del tipo (x)(Px ¬Px), realizzando necessariamente PA oppure
¬PA. Ora, se si desse il caso che A non è in grado di decidere l’alternativa Px ¬Px, ciò vorrebbe
dire che A non è un individuo neppure nell’accezione puramente logica. In apparenza questo
requisito pare ovvio, cioè universalmente soddisfacibile. Ma non è così. Già a livello puramente
formale-estensionale ci sono oggetti – ad esempio oggetti matematici, come √2 – che non
soddisfano tale richiesta. Se un tale oggetto esiste, esso non è né pari né dispari; quindi non può
essere qualcosa che rientra nella ratio dell’identità elementare e del correlativo principio del terzo
escluso27. Inoltre, sempre a livello formale la proprietà “riflessiva”, che qualifica l’identità, si riduce
21
Cfr. Łukasiewicz (2003), p. 46.
Cfr. Günther (1991)3, p. XIII.
23
Cfr. Günther (1979), pp. 287 ss.
24
Cfr. Günther (1991)3, p. XVII.
25
Cfr. Günther (1976b), p. 4.
26
Cfr. Günther (1991)3, p. 15.
27
Cfr. Łukasiewicz (2003), pp. 109 ss.
22
242
�La logica non-aristotelica da un punto di vista fenomenologico. Gotthard Günther e Oskar Becker
a quella “simmetrica”, cioè alla semplice possibilità di convertire la “posizione” del soggetto
nell’uguaglianza. In questo modo le diverse posizioni del soggetto, essendo perfettamente
permutabili, risultano indifferenti. Ciò si collega alla funzione denominativa del termine che sta per
il soggetto, cioè l’io o la cosa; esso non ha alcun significato perché, nell’indifferenza della
posizione, può avere tutti i significati possibili28.
L’identità classica esprime quindi “l’equivalenza della sostituzione” sulla base di un processo di
significazione già attuato. Se, ad esempio, il significato dell’io è il suo oggetto – cioè quella cosa,
sostanza o essenza che designiamo come “io” – ciò vale per qualsiasi altro segno che indichi l’io, ed
è una conseguenza diretta dell’elementarità e dell’isolamento dell’identità. Solo partendo da
quest’indifferenza è possibile la generalizzazione dello schema soggetto-oggetto: poiché ogni
pensiero – nota Günther – deve avere un oggetto, possiamo generalizzare, dicendo che un “soggetto
in generale” ha sempre qualcosa come un “oggetto in generale” 29. L’identità immediata dell’essere
è quindi la conversa dell’identità simmetrica della riflessione che, assumendo come riferimento o
“significato” il soggetto assoluto o “trascendentale”, inibisce per principio ogni possibilità di
cogliere la “differenza”. A tal riguardo, Günther si connette alle Ricerche filosofiche di
Wittgenstein: se le proprietà degli enti dipendono da relazioni “interne” tra il segno e l’oggetto,
allora esse non possono mai essere rilevate come appartenenti a un “determinato” oggetto30.
Poiché la logica classica, monopolare e bivalente, è strettamente legata a una concezione
elementaristica, atomistica e puntuale dell’essere, una logica trans-classica comporta anche una
diversa concezione dell’identità ontologica, cioè una «nuova immagine metafisica del mondo», una
concezione «non teoretico-identitaria»31. Ora, per Günther il compito di tradurre in forme logiche
tale immagine non può spettare a una semplice estensione del calcolo logico nel senso della
polivalenza o della “paraconsistenza”, poiché queste si limitano a moltiplicare a matrice i valori di
verità su una base bivalente, lasciando inalterato il problema del “significato” come corrispondenza
a un oggetto puntualmente inteso nella sua identità assoluta e indifferenziata32. Se l’essenza
dell’essere è riferimento a sé, allora l’altro, il diverso, è del tutto escluso. L’errore di fondo consiste
nel trascurare il fatto che l’identità inversa della “riflessione”, che sembra contenuta nella perfetta
uguaglianza A=A, non può essere intesa mediante le tradizionale categorie ontologiche 33.
Secondo Günther, solo l’idealismo classico tedesco, in particolare con Fichte e Hegel, è stato in
grado di tematizzare adeguatamente questa difficoltà, offrendo elementi per una sua soluzione 34.
Richiamandosi alle ricerche svolte alcuni anni prima da Max Bense sulla concezione hegeliana
della negazione come “successione di disgiunzioni”35, Günther osserva come né l’idealismo logico
neokantiano, in cui si pone il problema dell’inoggettivabilità dello psichico e di una sua
ricostruzione attraverso le forme delle oggettivazioni, né il successivo logicismo russelliano, con la
sua teoria metalinguistica dei “tipi”, presentino nuove prospettive rispetto alla tradizionale tesi
teoretico-identitaria, ma anzi ripropongano da capo il “paradosso” della reiterazione all’infinito
dell’autocoscienza, che cercano di evitare con opportune clausole di sbarramento come il divieto di
tematizzare (o di porre come argomento) una funzione. Ma che ne è del modo in cui comprendiamo
la nostra comprensione dell’essere? È possibile una logica che includa questa modalità della
riflessione?36 Si tratta di render conto dell’“equivocità” della nozione di oggetto, che non significa
28
Cfr. Günther (1991) 3, p. 15.
Cfr. ivi, pp. 23-24, 97.
30
Cfr. Wittgenstein (1983), §§ 265-266, pp. 124-125. Si veda anche Wittgenstein (1975), pp. 42-43.
31
Cfr. Günther (1991)3, p. XIV.
32
Cfr. ivi, p. XIII.
33
Cfr. ivi, pp. XV-XVI.
34
Günther (1991)3, pp. XV e XVIII, si riferisce in particolare a I fatti della coscienza di Fichte e ai primi tre capitoli
del secondo libro della Scienza della logica di Hegel sulla Dottrina dell’essenza. Cfr. Fichte (2007), Hegel (1984),
Günther (1978)2, pp. 6 e 204-209; Esposito (2011), pp. 188-189.
35
Cfr. Bense (1949) e (1950-51). Si veda, a tal proposito, Günther (1991)3, pp. 20, 244, 314-329, 393 n. 35.
36
Cfr. Günther (1991)3, p. XV.
29
243
�Luca Guidetti
solo l’“ente” che trascende il pensiero, ma anche il “processo” di riflessione che viene pensato
nell’atto di porre la trascendenza oggettuale. Qui emerge il problema, del tutto qualitativo e
intensionale, del “senso” e della struttura di “validità” del discorso logico: si tratta di capire se, in
una teoria formale della riflessione, una rappresentazione logico-simbolica – inevitabilmente
estensionale del punto di vista tecnico – possa rendere il senso intensionale-concettuale degli
oggetti che vengono pensati37. Nella logica hegeliana, questa possibilità si presenta nel momento in
cui alla tradizionale negazione proposizionale, che permette di passare “in blocco” da P(x) a nonP(x), si sostituisce la negazione riferita all’effettivo contenuto concettuale (inhaltslogische
Negation), vale a dire una negazione articolata sia riguardo al senso (non-P), sia al riferimento
(non-x). Di conseguenza, non-P(x) significa la disgiunzione della negazione del predicato e
dell’oggetto, cioè non-P(x) P(non-x)38.
Ed è a questo punto che prende corpo il concetto di “identità di funzione”. Ma cosa significa, per
Günther, “funzione”? Non dobbiamo intendere la funzione nel senso cassireriano, cioè come
semplice variazione dei valori in una serie, né in senso matematico, come relazione che lega un
oggetto a un altro in un predefinito contesto operazionale 39. Questi tipi di funzioni d’identità non
risolvono infatti il problema della “qualificazione” degli oggetti, ma spostano semplicemente il
criterio di determinazione dalle relazioni interne, assolute e intraoggettive, alle relazioni esterne,
assumendo che vi sia un unico terreno, comune e condiviso, entro cui i rapporti prendono forma.
L’“identità di funzione” è invece ciò che si mostra in seguito all’“attivazione” di una certa
“posizione” dell’oggetto rispetto al soggetto40. La base logica dell’identità si rivela dunque, fin dalle
sue origini, operativamente condizionata.
Seguendo la logica hegeliana dell’essenza, Günther nota come nella relazione soggetto-oggetto
non si dia solo la possibilità di pensare un “soggetto soggettivo” (l’“io”), ma anche un “soggetto
oggettivo” (il “tu”), la cui differenza non può essere espressa dai i tradizionali funtori logici (non, e,
o, se-allora), in quanto costanti riferite, “volta per volta”, solo al soggetto egologico o all’oggetto
trascendente41. Nella logica classica non c’è modo, ad esempio, di esprimere la differenza tra “io ‘e’
gli oggetti” e “tu ‘e’ gli oggetti”42, mentre la logica hegeliana, distribuendo la negazione anche sul
riferimento, consentirebbe – “se avesse a disposizione i mezzi logico-formali adeguati” –
d’includere nella sua matrice l’alternativa tra l’ego e l’alter-ego. Infatti, il tu e l’io, esprimendo
“posizioni” diverse rispetto agli oggetti intenzionati, sono diversi anche tra di loro, sebbene possano
risultare, per certi aspetti, uguali o equivalenti. D’altra parte, questa differenza non appare se,
accanto al logos monotematico, si ricorre all’intuizione come pura “posizionalità” dell’oggetto. A
questo riguardo, Hegel osserva che l’identità, così come viene tradizionalmente espressa attraverso
l’uguaglianza (A=A), è solo una «legge dell’intelletto astratto», poiché la forma della proposizione
«promette una distinzione tra soggetto e predicato», ma il suo significato posizionalmente assoluto
«non mantiene ciò che la sua forma promette»43.
Günther riconosce come nell’empirismo logico e in una parte del tardo neokantismo (ad esempio
in Nicolai Hartmann) vi sia il tentativo di affermare l’origine intersoggettiva dell’identità e della
rispettiva nozione di verità; ma poiché per essi l’oggetto appare sempre nella posizione assoluta in
cui si fa portatore della “sua” verità, l’accordo che lega le posizioni dei soggetti
nell’intersoggettività è già stabilito “a priori” come vincolante per “ogni” soggetto44. Così,
l’intersoggettività neopositivistica non è altro che la riproposizione, sul piano dell’“esperienza
comune”, della nozione di “coscienza in generale”. Siano infatti S’ e S’’ due soggetti, e O il loro
37
Cfr. ivi, p. XVII.
Cfr. Bense (1949), p. 229.
39
Cfr. Cassirer (1999), pp. 257-258.
40
Cfr. Günther (1976c), pp. 214-218; Esposito (2011), pp. 196-200.
41
Cfr. Günther (1991)3, pp. 93 ss.
42
Cfr. ivi, p. XVIII.
43
Hegel (2004), § 115, p. 312.
44
Cfr. Günther (1991)3, p. 214.
38
244
�La logica non-aristotelica da un punto di vista fenomenologico. Gotthard Günther e Oskar Becker
oggetto comune. Il modo in cui tale oggetto si presenta come “vero”, cioè il suo valere per tutti i
soggetti, determina inoltre che tutti i soggetti siano uguali tra di loro 45:
S’
O
S’’
Il limite di questo schema classico è che il piano bidimensionale della raffigurazione collassa in una
realtà lineare o unidimensionale, e su una linea non vi è la possibilità di determinare le “differenti”
posizioni dei punti, a meno di non indicare l’inizio o la fine assoluta della linea. Un simile
paradosso si presenta in tutti i dualismi fondati sulla teoria classica dell’identità, come l’opposizione
tra idealismo e realismo o tra spiritualismo e materialismo. Se la negazione inverte
simmetricamente l’affermazione entro la “stessa” dimensione lineare, l’affermazione può essere
considerata come negazione della sua negazione, sicché non vi è modo di distinguerle dal punto di
vista del contenuto semantico. Ma la conseguenza più importante dell’inversione simmetrica è che,
dove affermazione e la negazione possono assumere l’una il posto dell’altra, il principio d’identità
finisce per dipendere dalla definizione ultima del “giudizio vero”, come quel giudizio che
attribuisce a un dato oggetto l’attributo che esso possiede 46. In tal caso la riflessione risulta sempre
equivoca, poiché alla disgiunzione inclusiva si sostituisce la “congiunzione lineare” degli attributi
“veri” che rendono impossibile stabilire se l’oggetto del discorso sia “positivo” o “negativo” 47. Se
alla negazione si può sostituire l’affermazione con un semplice cambiamento di segno, risulta
evidentemente impossibile pensare un oggetto che contenga predicati contraddittori. Infatti, dal
momento che lo spazio dell’affermazione viene inteso come pieno e positivo, anche la negazione
rientra, per conversione simmetrica, in questo stesso spazio e, come tale, non comporta alcun
residuo o “differenza” dell’essere. Nella logica classica, la negazione non introduce la differenza,
ma occupa lo stesso spazio logico dell’essere e dell’affermazione; perciò, ammettere la
contraddizione significa concedere la possibilità di uno spazio logico “inconcepibile” in cui ogni
oggetto, essendo “qualsiasi” oggetto, non è mai individuabile. Ecco perché – nota Hegel – senza la
riflessione che non fonde le cose in un sol senso, ma le articola in base a diverse posizioni, “essere”
e “nulla” risultano equivalenti dal punto di vista logico 48. Tale equivalenza è legata alla figura del
pensiero astratto, a cui la logica hegeliana sostituisce il “pensiero concreto” come quella forma in
cui l’identità non appare più monotematica, ma è (almeno) “doppiamente tematica”49. Infatti, nella
sua duplice struttura tale pensiero non ha solo se stesso come oggetto di possibile riflessione, ma
anche l’altro uomo e le cose, cioè il “non-identico”.
45
Cfr. ivi, pp. 11, 65 e 86.
Cfr. Łukasiewicz (2003), pp. 51-54.
47
Osserva a tal riguardo Wittgenstein (1983, § 216, p. 113): «Nel dire che “una cosa è identica a se stessa” […] è
come se immaginassimo di mettere la cosa nella sua propria forma e vedessimo che conviene ad essa. “Ogni cosa
conviene a se stessa”: così dicendo, guardiamo un oggetto e immaginiamo che lo spazio occupato dall’oggetto sia
vuoto, e che l’oggetto vi entri esattamente, come una macchia “conviene” al suo contorno bianco. Ma la cosa avrebbe
esattamente quest’aspetto se invece della macchia ci fosse stato un buco e la macchia ci entrasse perfettamente. Con
l’espressione “conviene” non si descrive semplicemente l’immagine della macchia. Non si descrive semplicemente
questa situazione».
48
Cfr. Hegel (1984), vol. I, p. 59 e vol. II, p. 441: «Il cominciamento contiene l’uno e l’altro, l’essere e il nulla; è
l’unità dell’essere con il nulla […]. L’essere è non essere nell’essenza. La sua nullità in sé è la natura negativa
dell’essenza stessa».
49
Cfr. Günther (1991)3, pp. 16 e 28; Günther (1978)2, pp. 204 ss. Si vera anche, a tal riguardo, Klagenfurt (2016),
pp. 52-53.
46
245
�Luca Guidetti
Se l’identità astratta è analitica, l’identità concreta – nota Günther sulla scorta delle osservazioni
hegeliane – è al contrario sempre “sintetica”50. Il pensiero astratto è rappresentativo, raffigurativo,
mentre il pensiero concreto è relazionale. Poiché il pensiero concreto è “di un” soggetto (e non
“del” soggetto in generale) la cui identità non è sostanza ma relazione 51, il soggetto, l’oggetto e la
negazione possono avere un significato non univoco senza generare contraddizioni insanabili. Tale
relazionalità impedisce inoltre che alla coscienza in generale si opponga diametralmente, come
condizione di senso, la coscienza “solipsistica”. Si tratta solo di due casi-limite all’interno della
medesima figura lineare, e pertanto coincidenti: per entrambe, l’affermazione equivale sempre alla
negazione, sicché in ognuna di esse la seconda riempie tutto lo spazio della prima (rispettivamente,
per totalizzazione o per singolarizzazione), senza un “luogo” in cui collocare la differenza. Ora –
conclude Günther – la logica hegeliana (e in generale la logica dell’idealismo speculativo) sarebbe
giunta a tali conclusioni non solo se avesse avuto la disponibilità di un appropriato formalismo, ma
soprattutto se fosse stata in grado portare a compimento la struttura “disgiuntiva” che è alla base del
suo sistema, ponendo esplicitamente a fianco dell’orto-soggettività dell’“io” la para-soggettività del
“tu” e dell’“altro” soggetto (la “riflessione in sé ‘o’ nell’altro”). Il suo limite consiste invece
nell’aver dato risalto alla forma “congiuntiva” della relazione riflessiva (la “riflessione in sé ‘e’
nell’altro”) che finisce per risolversi nell’affermazione di una “soggettività infinita” 52.
Ammettendo la molteplicità “disgiunta” dei soggetti, scompare anche l’assoluta oggettività ed
elementarità degli oggetti. Tale molteplicità, insieme alla rottura del carattere univoco della
negazione, determina una trasformazione dello schema lineare e bivalente (diadicomonodimensionale) in uno autenticamente polivalente (triadico o poli-adico)53:
S’
O
S’’
Qui due soggetti (due “io”) non sono mai logicamente equivalenti, poiché le “posizioni” del
soggetto pensante e del soggetto pensato non coincidono. Infatti S’ e S’’, non essendo la
moltiplicazione reiterata del medesimo soggetto, appartengono a “due classi” diverse. Quando si
tematizza l’altro soggetto, non si tematizza semplicemente un altro io (S’ S’’), ma si traccia uno
spazio complesso S’ (S’’ O), in cui il secondo soggetto, che è ora un “tu”, è in relazione con
gli oggetti del suo proprio mondo. Ciò dipende dall’introduzione di una “seconda negazione”, ossia
di un senso diverso della negazione in virtù del quale il non-io non si riferisce semplicemente alle
cose, ma anche all’altro soggetto come al “tu”. Il tu, infatti, non si può assegnare né al soggetto né
all’oggetto sebbene, nel senso della complementarità, si possa aggiudicare a entrambi. Solo in tale
“sintesi disgiuntiva” è possibile ammettere, accanto alla negazione esclusiva, una negazione
inclusiva e quindi, accanto al terzo escluso, una forma relazionale che contempli il “terzo incluso”.
La figura complessiva della relazione, da lineare e unidimensionale, diventa pertanto “circolare” o
pluridimensionale54.
50
Cfr. Hegel (1984), vol. II, p. 463.
Cfr. Hegel (2002), p. 167: «Io è solo l’identità del rapporto di me stesso come soggetto a me come oggetto» (trad.
modificata).
52
Cfr. Günther (1991)3, pp. 314-329.
53
Cfr. ivi, pp. 98, 101.
54
Cfr. ivi, p. 111.
51
246
�La logica non-aristotelica da un punto di vista fenomenologico. Gotthard Günther e Oskar Becker
Qui una componente oggettiva, che comprende una parte dell’oggettività cosale e del tu, trova
continuazione in due componenti soggettive, una delle quali è condivisa dall’oggettività
intenzionale e dall’io, mentre l’altra è comune all’io e al tu. È chiaro che per rendere coerente
questa figura circolare occorre che l’espressione “soggettività” (e quindi “identità”) abbia un
“duplice senso”, riferito una volta all’io e un’altra al tu. Da ciò l’errore di fondo della logica
classica, vale a dire l’assunzione che l’opposizione tra io e cosa corrisponda a quella tra soggetto e
oggetto55. Ma la “cosa” non coincide con l’ambito della componente oggettiva e, d’altra parte, l’io e
il tu non esauriscono l’ambito della soggettività; infatti, la cosa è il risultato della composizione tra
l’oggettività e la soggettività egologica, il tu dell’oggettività e della soggettività dell’altro, e l’io
della soggettività egologica e della soggettività estranea (del tu). Si noti come in questa circolarità
relazionale “le asserzioni d’identità abbiano sempre valori logici diversi”: l’identità tra soggetto e
oggetto può essere alternativamente intesa come identità della prima o della seconda soggettività,
ma non di entrambe al tempo stesso e, soprattutto, non nel medesimo “luogo”. Ciò dipende dal fatto
che al soggetto come al “tu” appartiene una ben distinta «grandezza metafisica»56.
Perciò, conclude Günther, la realtà può essere adeguatamente intesa solo se si assume che il tema
“essere” sia solo “una” componente, accanto a cui deve porsi l’altra componente soggettiva e
sdoppiata, riguardante il senso, che possiamo indicare come componente “meontica”, cioè relativa
al non-essere. “La realtà ha una componente meontica che non costituisce affatto una sua
‘diminuzione’ metafisica, ma un arricchimento del suo ‘senso’”57. Poiché la differenza meontica
della soggettività in io e tu comporta l’assunzione di due distinti “valori di posizione”, l’ambito del
tu non è direttamente raffigurabile il quello dell’io e, viceversa, l’ambito dell’io non è riconducibile
a quello del tu58. Si tratta di una “relazione non-simmetrica” che, nel negare la simmetria, non
implica un’asimmetria inclusiva: ciò dipende dal “senso dell’attivazione” della struttura
“topologica” in cui si collocano le parti costitutive della relazione. All’identità come uguaglianza tra
termini si sostituisce, in ultima istanza, un’identità che si costituisce “funzionalmente”, cioè a
partire dal centro di uguaglianza o polo-zero della relazione tri- o n-polare59. Quest’identità
topologico-funzionale accoglie in pieno la sollecitazione fenomenologica secondo cui l’identità o
univocità di una funzione non è data solo dal suo concetto, ma in primo luogo dal suo “oggetto”,
ossia dai valori che ne soddisfano le condizioni poste concettualmente, non dal significato della
funzione preso a sé. Tutto ciò, inoltre, retroagisce sul principio atomistico dell’identità: se oggetto è
ogni cosa che può essere individuata come “relazionalmente” identica a se stessa, l’identità non può
essere altro che funzionale, poiché tale è anche l’atomicità.
3. Becker: la logica trans-classica tra compossibilità e connecessità
Mentre Günther, richiamandosi alla dottrina hegeliana della riflessione, sviluppa una critica della
logica classica che si fonda sul rifiuto della teoria dell’identità elementare, e in tal modo intravede
la possibilità di una “logica della conseguenza” che, partendo dalla morfologia pura, superi le
restrizioni imposte dal principio di “non-contraddizione”, Oskar Becker innesta l’intuizionismo
matematico sul tronco della fenomenologia trascendentale husserliana e, rifiutando il principio del
“terzo escluso” come criterio per la determinazione degli oggetti logico-matematici, sviluppa la
logica della conseguenza nel senso di una nuova “logica della verità”60. A tal scopo, la negazione
non viene più caratterizzata come un operatore vero-funzionale, ma come un operatore “modale”
che articola in senso “costruttivo” la determinazione ontologica dei sensi “intensionali” che
emergono dalle nozioni di “possibilità” e “necessità”.
55
Cfr. ivi, p. 112.
Cfr. ivi, p. 119.
57
Cfr. ivi, pp. 120-121.
58
Sulla logica güntheriana dei “valori di posizione”, cfr. Ort (2007), pp. 81 ss.
59
Per la figura dell’identità come centro di relazioni n-polari (cioè di ordine >2), cfr. Melandri (1974), p. 112.
60
Cfr. Becker (1927), p. 509.
56
247
�Luca Guidetti
Già nella sua prima e più importante opera del periodo giovanile su Esistenza matematica61,
Becker – che aveva conosciuto l’intuizionismo di Jan Brouwer soprattutto attraverso i lavori di
Hermann Weyl e Dietrich Mahnke62 – pone al centro dell’indagine fenomenologica il problema del
rapporto tra gli oggetti apparentemente “ideali”, come quelli che caratterizzano la conoscenza
matematica (numeri, funzioni ecc.), e la costituzione soggettiva dei significati che ad essi si
connettono, rilevando i limiti di una loro ricognizione “mentalistica” che Husserl sembrava invece
sostenere a livello della Filosofia dell’aritmetica (1891) e delle Ricerche logiche (1900-1901)63. Ma
ancora nei primi paragrafi di Logica formale e trascendentale – opera pubblicata due anni dopo
(1929) rispetto a Mathematische Existenz – Husserl legava la trattazione della logica della
conseguenza alla distinzione tra i “gradi di evidenza” dei giudizi relativi alla “pura apofantica
formale”, riservando un ruolo secondario alla questione della derivabilità e dimostrabilità degli enti
che compaiono nelle relazioni matematiche del calcolo, e quindi alle funzioni in esso svolte dalle
costanti e dai connettivi logici, in particolare dalla negazione 64.
In realtà, nella seconda parte dell’opera, in corrispondenza al passaggio dalla logica della
conseguenza alla logica della verità, Husserl pareva accogliere alcune sollecitazioni di Weyl e dello
stesso Becker65 in merito all’impossibilità di stabilire, sulla base di un mero riempimento formale
dei contenuti giudicativi, quali oggetti effettivamente si costituissero in corrispondenza agli atti del
giudizio. In particolare, Husserl sottolineava la modalità costruttiva «dell’infinità iterativa, che ha il
suo correlato soggettivo nel “si può sempre di nuovo”»66, collegando a ciò il problema
dell’evidenza dei principi logici non più in riferimento ad astratte strutture formali, ma ai concetti di
verità e falsità in quanto possibilità di «portare in generale ogni giudizio all’adeguazione»67. Poiché
ogni giudizio può assumere in sé «l’intenzione pratica rivolta alla verifica» e ogni verità «è pensata
come una decisione»68, ovvero «è comprensibile nella sua evidenza come un’operazione» 69, i
principi logici tradizionali possono essere validi solo sulla base di una “sfera unitaria di senso” che
non è loro compito stabilire, ma che viene affidata alle operazioni della soggettività costitutiva a
partire dalla possibilità, puramente grammaticale, dei «giudizi in generale» 70. Si tratta di un «apriori
sorprendente» che viene dato a ogni uomo e che consiste nel sapere che esistono percorsi e azioni di
pensiero «effettuabili ma mai effettuate»71. Se infatti la logica tradizionale si riferisce «a un mondo
reale pensato come già dato»72, al contrario per tutti quei giudizi che, sollevandosi «al di sopra della
[disgiunzione] della verità e della falsità», sono contenutisticamente “privi di senso”, «il terzo –
conclude Husserl – non è qui escluso»73.
L’accoglimento delle indicazioni provenienti, in generale, dalle formulazioni operative
dell’intuizionismo matematico si rende esplicito nella Terza Appendice a Logica formale e
trascendentale. Qui Husserl – menzionando a più riprese Becker e dedicando persino un intero
paragrafo (§ 4) ai suoi rilievi critici – avverte l’esigenza di concepire «l’intera logica della
conseguenza nel modo più ampio»74, vale a dire non circoscritta alla semplice non-contraddizione
formale. Quest’ultima infatti, insieme al principio del terzo escluso, non è in grado di rispondere
alle questioni relative alle implicazioni “effettive”, cioè al tema della “compatibilità” o
61
Cfr. Becker (1927).
Cfr. ivi, p. 444. Su ciò, si vedano anche Gethmann (2002), p. 111; Peckhaus (2005), pp. 245-278.
63
Cfr. Becker (1927), pp. 442-444.
64
Cfr. Husserl (1966), §§ 14-18, pp. 65-79.
65
Cfr. Gethmann (2002), p. 113.
66
Husserl (1966), § 74, p. 233.
67
Ivi, § 77, p. 238.
68
Ivi, § 79, p. 243.
69
Ivi, § 106, p. 346.
70
Ivi, § 90, p. 273.
71
Ivi, § 79, p. 244.
72
Ivi, § 92, p. 277.
73
Ivi, § 90, p. 274.
74
Ivi, Appendice terza, § 1, p. 405.
62
248
�La logica non-aristotelica da un punto di vista fenomenologico. Gotthard Günther e Oskar Becker
“incompatibilità” che sorge allorquando la derivazione logica e la necessità analitica si mostrano
come condizioni necessarie, ma non sufficienti, a determinare «la conseguenza nel senso
dell’unitarietà “in blocco” del conseguire temporale dei giudizi intesi in successione», tale da
condurre a un’«attuazione effettiva e autentica del giudizio»75. In questo senso, si trattava per
Husserl di eliminare, sulla scorta dei rilievi “semi-intuizionistici” beckeriani76, quei fraintendimenti
che possono generarsi in seguito all’accoglimento, all’interno dell’analitica pura, della mera
possibilità o impossibilità delle specifiche forme logiche. Infatti, nel caso dei giudizi che fondano le
verità effettive, si deve piuttosto parlare di una sussistenza composita di diverse istanze operative
che, come sistema della compossibilità o incompossibilità, racchiude nella propria legalità
essenziale anche il tema della “necessità congiunta” o connecessità 77. A tal proposito, si rivela del
tutto inutile la questione, impostata sulla falsariga dell’atomismo semantico presente nel concetto
dell’identità elementare, dell’adeguazione dei “singoli” significati giudicativi a qualche stato di
cose, dal momento che il principio di non contraddizione e del terzo escluso servono solo a riferirsi,
nel giudicare effettivo, a forme complesse, ovvero a “prodotti logici” di proposizioni o parti
proposizionali che ne attestino la reciproca compatibilità o incompatibilità. Solo il prodotto o
l’operazione complessiva – in termini intuizionistici, la determinazione di un’effettiva procedura di
decidibilità – può rivelare se ci troviamo di fronte a una tautologia, a una contraddizione o a una
semplice compatibilità non contraddittoria come fondamenti di una logica della verità 78.
Le osservazioni di Becker in merito al carattere operativo della logica della conseguenza come
base per una logica della verità troveranno un’adeguata sistemazione alcuni anni dopo Esistenza
matematica, in particolare nelle Ricerche sul calcolo modale (1952), in cui egli approfondisce la
nozione di compatibilità e incompatibilità a favore di un’interpretazione non classica dei connettivi
logici – in particolare della negazione – e dei principali operatori modali (possibilità e necessità) 79.
Dal momento infatti che la logica classica è vero-funzionale, cioè si riferisce ad oggetti attuali in cui
la verità o la falsità corrispondono all’esistenza o alla non-esistenza, essa non è in grado di render
conto del contenuto “concettuale” che si costituisce nel “conseguire” effettivo per oggetti “non
ancora” esistenti, vale a dire né del tutto esistenti, né non-esistenti80. Si tratta dunque di evidenziare
il significato “intensionale” dei connettivi logici partendo dai concetti nel cui senso non rientrano
solo gli oggetti attuali (reali), ma gli “oggetti possibili”. Ciò dipende dal fatto che la relazione tra
l’ambito estensionale della realtà oggettuale e quello intensionale della possibilità oggettuale è
“asimmetrica”: mentre infatti da una sfera di oggetti possibili può conseguire, attraverso un
procedimento di decisione, la delimitazione di una determinata sfera di oggetti reali, la reciproca
non vale, poiché dal concetto inerente a un insieme effettivo di oggetti non si può ricavare l’intero
“senso concettuale”, che riguarda anche l’insieme degli oggetti possibili. In tale prospettiva, il
valore di verità del concetto o della “classe caratterizzata” non corrisponde al valore dell’oggetto o
della classe denotata da un semplice procedimento di designazione e d’identità classico 81; al
massimo si potrebbe intendere la designazione classica come un “caso particolare” del
procedimento, cioè come quel caso in cui la decisione si conclude nella fissazione di un certo
oggetto, a condizione però di occultare il senso funzionale dell’identità a vantaggio di quello
esclusivamente “formale”. Per non ricadere in una simile fallacia riduzionistica – che, come
abbiamo visto, contravviene alla fondazione fenomenologica della logica come logica di
un’esperienza possibile –, alla negazione semplice della logica classica bisogna sostituire la
“negazione modale” che, connessa al problema fenomenologico del rapporto tra conseguenza e
verità, si presenta come una “negazione rafforzata”, in quanto non nega una semplice asserzione
75
Ibidem.
Cfr. Thiel (1995), p. 24; Gethmann (2002), p. 111.
77
Husserl (1966), Appendice terza, § 1, p. 407.
78
Ivi, Appendice terza, § 4, p. 415.
79
Cfr. Becker (1979), pp. 25-111.
80
Cfr. ivi, p. 73.
81
Cfr. ivi, pp. 73-74.
76
249
�Luca Guidetti
d’esistenza, ma un’asserzione della “possibilità” d’esistenza. «Se dunque – conclude Becker – si dà
fin dall’inizio all’asserzione di esistenza il senso dell’asserzione di possibilità, si elimina la
difficoltà relativa al tertium non datur»82, poiché questo non comparirà più tra oggetti reali, ma solo
tra oggetti possibili o impossibili (non-possibili) all’interno di un dato sistema decisionale 83. È
quindi la differenza nella “caratterizzazione” del sistema (il suo pieno “senso concettuale”) a
decidere della proprietà dell’oggetto, non una proprietà dell’oggetto, “inteso come un dato
assoluto”, a decidere della sua caratterizzazione 84.
Tuttavia, nota Becker, una semplice declinazione modale dell’ambito “logico” non è sufficiente
a rendere il significato concettuale della logica applicata all’esperienza giacché, se così fosse, tale
significato sarebbe già emerso a partire dalla logica modale aristotelica come fondamento di tutta la
logica classica. Così, mediante una discussione del problema delle modalità che prende spunto dalle
più recenti osservazioni svolte a tal riguardo da Nicolai Hartmann in merito alla distinzione tra
possibilità logica e possibilità reale 85, nonché alle categorie modali della “presenza” rintracciabili
nell’analitica esistenziale di Heidegger86, Becker pone al centro dell’attenzione il tema – a cui già
Husserl aveva accennato – della “possibilità condizionale”, ovvero della compossibilità come
«condizione limitativa del sussistere degli oggetti con altri oggetti o con un determinato sistema di
leggi»87. Tale introduzione del compossibile permette quindi d’integrare lo schema classico della
modalità (possibilità, realtà, necessità) con altri quattro modi (compossibilità, incompossibilità,
connecessità, non-connecessità), a cui si aggiunge il quinto modo della compossibilità disgiuntiva in
corrispondenza alla tradizionale nozione equivoca di “possibilità”, che può essere intesa come
possibilità indifferente (positiva o “potenzialità” d’essere, per cui anche il necessario deve “poter”
essere) oppure come possibilità disgiuntiva (positiva e negativa, congiunzione di possibilità e nonnecessità)88. Ora, dal momento che quest’estensione dello schema classico dipende dalla
considerazione di un “insieme di condizioni” preso volta per volta, non solo la compossibilità indica
la “compatibilità” rispetto a tali condizioni (e rafforza il compossibile rispetto al semplicemente
possibile, così come la negazione modale è rafforzata rispetto alla negazione classica), ma pone
anche al centro la questione della relazione tra le “condizioni” e gli “oggetti” che risultano dalla
loro applicazione operativa89. È infatti evidente che mentre la relazione di compossibilità tra gli
oggetti risultanti e l’insieme delle condizioni è senza dubbio simmetrica (se cioè p è compossibile
con l’insieme C, anche C è compossibile rispetto a p), non è al contrario simmetrica la rispettiva
relazione di connecessità. In altri termini, dato un sistema di condizioni in cui p è introdotto per
compossibilità, se tale sistema è in grado di fornire una procedura operativa che giunga
“effettivamente” a p, allora p è una conseguenza necessaria del sistema, cioè è “connecessario” con
esso. Tuttavia, non essendo “un” dato sistema una conseguenza necessaria che si debba sviluppare a
partire dall’esistenza di p, esso non è altrettanto connecessario con p. L’unica soluzione per ottenere
in questo caso una simmetria consisterebbe nel far coincidere il sistema delle condizioni con
l’oggetto stesso, originando un mondo chiuso o una sorta di metalinguaggio atomistico, in senso
“molecolare”, della realtà (una realtà “a mosaico”, fatta di punti complessi ma separati e
82
Ivi, p. 75.
Ciò si connette alla cosiddetta “Regola di Becker” secondo la definizione fornita da Churchman (1938). Tale
regola – volta a garantire la “finitezza” del sistema delle modalità – afferma infatti che dall’implicazione stretta tra p e q
segue l’implicazione stretta tra la “possibilità” di p e la “possibilità” di q. Cfr., a tal riguardo, Becker (1930) e Peckhaus
(2002), pp. 168-169.
84
Cfr. Becker (1979), pp. 76-77.
85
Cfr. ivi, pp. 78-79.
86
Cfr. ivi, pp. 93-97.
87
Ivi, p. 87.
88
Cfr. ivi, pp. 79-80, 92.
89
In tal senso, il tema beckeriano della compossibilità si collega alle attuali indagini sulle “logiche condizionali”,
volte a stabilire il significato “operativo” delle inferenze, ovvero il rapporto “effettivo” di consequenzialità delle
implicazioni; cfr. Pizzi (1987), pp. 97 ss.
83
250
�La logica non-aristotelica da un punto di vista fenomenologico. Gotthard Günther e Oskar Becker
inaccessibili) 90. Non volendosi consegnare alle difficoltà che emergono da tale immagine – in virtù
della quale risulterebbe d’altra parte impossibile anche solo parlare di “un mondo” –, Becker si
richiama alle osservazioni critiche che Heidegger muove nei confronti della tradizionale dottrina
delle modalità connessa alla metafisica classica. Secondo Heidegger, se il possibile come categoria
modale della “semplice presenza” delle cose è inferiore alla realtà e alla necessità, dal punto di vista
ontologico-esistenziale esso costituisce invece la determinazione più originaria e positiva, in quanto
contrassegna l’essenza stessa dell’esserci o della realtà umana. La legge di depotenziamento
modale, per cui il necessario implica il reale (il vero) e questo a sua volta implica il possibile, va
dunque per Heidegger rovesciata, poiché per l’esserci la possibilità è la sua realtà o verità
essenziale, vale a dire il “modo” più forte di tutti che supera la mera fatticità in vista dell’effettività
ontologica91.
Ora, questo rovesciamento, nota Becker, finisce per rendere equivoca la nozione modalizzata di
“verità” (e quindi lo stesso rapporto tra logica della conseguenza e logica della verità), poiché è
evidente che se da un lato la possibilità esistenziale implica la necessità come “effettività” del
progetto legato all’esserci (ciò che rende necessariamente sensate le condizioni dell’esistenza, vale
a dire la necessità che è inclusa nella possibilità ontologica), dall’altro essa è necessitata o
“costretta” dalla stessa “fatticità” dell’esserci, che non può sottrarsi al condizionamento di cose,
situazioni o leggi in cui esso si trova “gettato”92. Questa natura anfibia del “necessario” non può
trovare soluzione all’interno dei concetti esistenziali heideggeriani, in cui ogni termine relativo
all’esistenza funge, al tempo stesso, da segno di una relazione (la fatticità dell’esserci) e da
contenuto che la istituisce (la possibilità ontologico-esistenziale). Occorre dunque – conclude
Becker – introdurre una nuova specie di concetti “para-esistenziali” al cui centro non sta l’esserci
(Dasein), ma la “natura essenziale” (Dawesen), per la quale vale ciò che Aristotele chiamava il
“semplicemente necessario” (aplos anankaion), ossia la “schietta e univoca” necessità 93. Ma questa
necessità univoca, anziché denotare gli enti (e l’uomo stesso) nella loro singolarità irrelata, indica
solo la loro “presenza essenziale” (parousia, praesentia)94 che contiene proporzionalmente, in
composizione modulare, le contraddizioni che si danno quando la “forma” degli enti viene spezzata
attraverso negazioni diametrali e refrattarie ad ogni complementarità. In ultima istanza, la nozione
di “natura essenziale” permette di evitare quella soggettivizzazione dell’oggettivo che potrebbe
comparire non solo a margine del Dasein heideggeriano, ma anche nell’“insieme delle condizioni”
che – come abbiamo visto – si pone a fondamento della modalizzazione operativa dell’esperienza.
Infatti l’intuizionismo beckeriano non si richiama mai – come accade invece in Brouwer – a un atto
originario della “mente” che genera, in un autonomo senso costruttivo, gli enti della serie
matematica95, ma intende sempre la costruzione operativa in senso fenomenologico, cioè come
“correlazione” intenzionale, nel senso della “modalizzazione”, tra gli atti e le essenze oggettuali96.
Ora, la possibilità di tale correlazione è strettamente congiunta al fatto che la “natura” delle essenze
oggettuali contenga una dimensione “strutturale” in cui – in modo non dissimile dalle “posizioni di
valore” di Günther – la forma circoscrive un “campo” o “luogo” di possibili significazioni rispetto
alle quali i differenti insiemi di condizioni operano come funtori di accumulazione semantica,
dando volta per volta rilievo ontologico a un certo contenuto anziché a un altro 97. Si tratta, di nuovo,
90
Cfr. ivi, pp. 88-90.
Cfr. ivi, pp. 93-94.
92
Cfr. ivi, p. 95.
93
Cfr. ivi, p. 96. Cfr. altresì Becker (1995), p. 45: «Ogni ente che si trova nella natura essenziale (Dawesen), se
considerato dal punto di vista della modalità, si trova peraltro ad essere determinato in forza della sua pura e semplice
necessità, laddove – sul piano storico – la modalità decisiva è quella della possibilità» (trad. modificata). Su ciò, cfr.
Sattler (2011), pp. 173 ss.
94
Cfr. Becker (1995), p. 133; Pöggeler (1995), pp. 180-181.
95
Cfr. Brouwer (1983), pp. 29 ss.
96
Sul rapporto tra la semantica fenomenologica e la teoria della modalizzazione, cfr. Wiegand (1998), pp. 7 ss.
97
Cfr. Becker (1963), pp. 324-325; Pöggeler (2002), p. 24.
91
251
�Luca Guidetti
di una dinamica strutturale eminentemente topologica, ovvero di una “topologia delle modalità”98
che, insieme al superamento dell’essenzialismo e del coscienzialismo ingenui, consente a Becker di
portare alla luce il significato più profondo di ogni “logica” orientata in senso fenomenologico.
Bibliografia
Aristotele (1978), La metafisica, vol. I, trad. it. a cura di G. Reale, Loffredo, Napoli.
Bachelard, S. (1957), La Logique de Husserl. Étude sur Logique formelle et logique
transcendantale, Paris, PUF.
Becker, O. (1927), “Mathematische Existenz. Untersuchungen zur Logik und Ontologie
mathematischer Phänomene”, Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung,
vol. 8, pp. 439-809.
Becker, O. (1930), “Zur Logik der Modalitäten”, Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische
Forschung, vol. 11, pp. 497-548.
Becker, O. (1963), “Rezension zu: Gotthard Günther, Idee und Grundriß einer nicht-Aristotelischen
Logik, Bd. I: Die Idee und ihre philosophischen Voraussetzungen”, Hegel-Studien, vol. 2, pp.
322-325.
Becker, O. (1979), Logica modale, calcolo modale, trad. it. a cura di G. Franci, Faenza Editrice,
Faenza.
Becker, O. (1995), L’essere e la «praesentia», in Poggi, S.-Tomasello, P. (a cura di), Martin
Heidegger. Ontologia, fenomenologia, verità, LED, Milano, pp. 131-167.
Bense, M. (1949), “Theorie dialektischer Satzsysteme. Eine Untersuchung über die sogenannte
dialektische Methode”, Philosophische Studien, Bd. I, H. 2-4, pp. 202-233.
Bense, M. (1950-51), “Theorie dialektischer Satzsysteme. Eine Untersuchung über die sogenannte
dialektische Methode (Schluß)”, Philosophische Studien, Bd. 2, H. 1-2, pp. 153-167.
Brouwer, L.E.J. (1983), Lezioni sull’intuizionismo. Cambridge 1946-1951, trad. it. a cura di S.
Bernini, Boringhieri, Torino.
Cassirer, E. (1999), Sostanza e funzione. Ricerche sui problemi fondamentali della critica della
conoscenza, trad. it. a cura di E. Arnaud, con un’Introduzione di M. Ferrari, La Nuova Italia,
Firenze.
Churchman, C.W. (1938), “On Finite and Infinite Modal Systems”, The Journal of Symbolic Logic,
vol. 3, pp. 77-82.
Derrida, J. (1992), Il problema della genesi nella filosofia di Husserl, trad. it. a cura di V. Costa,
Jaca Book, Milano.
Esposito, E. (2011), Gotthard Günther tra idealismo e cibernetica, in Lanzillo, M.L.-Rodeschini, S.
(Eds.), Percorsi della dialettica nel Novecento. Da Lukács alla cibernetica, Carocci, Roma, pp.
185-205.
Fichte, J.G. (2007), I fatti della coscienza 1810/11, trad. it. a cura di M.V. D’Alfonso, Guerini e
Associati, Milano.
Gethmann, C.F. (2002), “Hermeneutische Phänomenologie und Logischer Intuitionismus. Zu O.
Beckers Mathematische Existenz”, in Gethmann-Siefert, A.-Mittelstrass, J. (Eds.), Die
Philosophie und die Wissenschaften. Zum Werk Oskar Beckers, Fink, München, pp. 109-128.
Günther, G. (1976a), Logistik und Transzendentallogik (1940-41), in Id., Beiträge zur Grundlegung
einer operationsfähigen Dialektik, Erster Band, Meiner, Hamburg, pp. 11-23.
98
Si tratta infatti di una topologia – ampliata rispetto alla logica proposizionale vero-funzionale non modalizzata –
in cui la possibilità corrisponde alla “chiusura” di un insieme (o, topologicamente, di un “intorno”), mentre alla
necessità corrisponde l’“interno”. Cfr., a tal riguardo, Tarski (1938), pp. 114 ss.; McKinsey (1941), p. 129; McKinsey,
Tarski (1944), pp. 143 ss. Poiché, dal punto di vista topologico, l’implicazione proposizionale corrisponde
all’“inclusione”, si potrà allora dire che un intorno è incluso nella sua chiusura (pPp), ma non che un intorno è incluso
nel suo interno (pNp). Per Becker, infatti, la necessità semplice della “natura essenziale” non è quella della sua
esistenza, ma della sua “forma” che “prende corpo sempre di nuovo”; cfr. Becker (1979), p. 97.
252
�La logica non-aristotelica da un punto di vista fenomenologico. Gotthard Günther e Oskar Becker
Günther, G. (1976b), Wahrheit, Wirklichkeit und Zeit, die transzendentalen Bedingungen einer
Metaphysik der Geschichte (1937), in Id., Beiträge zur Grundlegung einer operationsfähigen
Dialektik, Erster Band, Meiner, Hamburg, pp. 1-9.
Günther, G. (1976c), Das metaphysische Problem einer Formalisierung der transzendentaldialektischen Logik (1964), in Id., Beiträge zur Grundlegung einer operationsfähigen Dialektik,
Erster Band, Meiner, Hamburg, pp. 189-248.
Günther, G. (1978)2, Grundzüge einer neuen Theorie des Denkens in Hegels Logik, Meiner,
Hamburg.
Günther, G. (1979), Life as Poly-Contexturality, in Id., Beiträge zur Grundlegung einer
operationsfähigen Dialektik, Zweiter Band: Wirklichkeit als Poly-Kontexturalität, Meiner,
Hamburg, pp. 283-306.
Günther, G. (1991)3, Idee und Grundriß einer nicht-Aristotelischen Logik. Die Idee und ihre
philosophischen Voraussetzungen, Meiner, Hamburg (I ed. 1959).
Heffernan, G. (1989), Isagoge in die phanomenologische Apophantik. Eine Einführung in die
phänomenologische Urteilslogik durch die Auslegung des Textes der Formalen und
transzendentalen Logik von Edmund Husserl, Kluwer, Dordrecht.
Hegel, G.W.F. (1984), Scienza della logica, 2 voll., trad. it. a cura di A. Moni e C. Cesa, Laterza,
Roma-Bari.
Hegel, G.W.F. (2002), Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, Parte seconda: Filosofia
della natura, trad. it. a cura di V. Verra, UTET, Torino.
Hegel, G.W.F. (2004), Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, Parte prima: La scienza
della logica, trad. it. a cura di V. Verra, UTET, Torino.
Höfler, A. (1890), Logik, Tempsky, Wien.
Husserl, E. (1966), Logica formale e trascendentale. Saggio di critica della ragione logica, trad. it.
a cura di G.D. Neri, Laterza, Bari.
Husserl, E. (1995), Esperienza e giudizio. Ricerche sulla genealogia della logica, trad. it. a cura di
F. Costa, Bompiani, Milano.
Klagenfurt, K. (2016), Technologische Zivilisation und transklassische Logik. Eine Einführung in
die Technikphilosophie Gotthard Günthers, Metropolis-Verlag, Marburg.
Leibniz, G.W. (1988), I principi della filosofia o monadologia, in Id., Scritti filosofici, vol. I, trad.
it. a cura di D.O. Bianca, UTET, Torino.
Łukasiewicz, J. (2003), Del principio di contraddizione in Aristotele, trad. it. a cura di G.
Maszkowska, Quodlibet, Macerata.
McKinsey, J.C.C. (1941), “A Solution of the Decision Problem for the Lewis Systems S2 and S4,
with an Application to Topology”, The Journal of Symbolic Logic, vol. 6, n. 4, pp. 117-134.
McKinsey, J.C.C., Tarski, A. (1944), “The Algebra of Topology”, Annals of Mathematics, vol. 45,
n. 1, pp. 141-191.
Martin, G. (1969), “Oskar Beckers Untersuchungen über den Modalkalkül”, Kant-Studien, vol. 60,
n. 3, pp. 312-318.
Melandri, E. (1960), Logica e esperienza in Husserl, il Mulino, Bologna.
Melandri, E. (1974), L’analogia, la proporzione, la simmetria, ISEDI, Milano.
Ort, N. (2007), Reflexionslogische Semiotik. Zu einer nicht-klassischen und reflexionslogisch
erweiterten Semiotik im Ausgang von Gotthard Günther und Charles S. Peirce, Velbrück,
Weilerswist.
Pap, A. (1967), Introduzione alla filosofia della scienza, trad. it. a cura di G. Mucciarelli e A.
Roatti, il Mulino, Bologna.
Peckhaus, V. (2002), “Oskar Beckers Stellung in der Geschichte der Modallogik”, in GethmannSiefert, A.-Mittelstrass, J. (Eds.), Die Philosophie und die Wissenschaften. Zum Werk Oskar
Beckers, Fink, München, pp. 161-184.
Peckhaus, V. (Ed.) (2005), Oskar Becker und die Philosophie der Mathematik, Fink, München.
253
�Luca Guidetti
Pizzi, C. (1987), Dalla logica della rilevanza alla logica condizionale, Euroma/La Goliardica,
Roma.
Pöggeler, O. (1995), Fenomenologia ermeneutica e fenomenologia mantica, in Poggi, S.Tomasello, P. (a cura di), Martin Heidegger. Ontologia, fenomenologia, verità, LED, Milano,
pp. 169-225.
Pöggeler, O. (2002), Phänomenologie und philosophische Forschung bei Oskar Becker, in
Gethmann Siefert, A.-Mittelstrass, J. (Eds.), Die Philosophie und die Wissenschaften. Zum Werk
Oskar Beckers, Fink, München, pp. 13-26.
Sattler, J. (2011), Phänomenologie und Ontologie bei Oskar Becker, Dissertation, Fernuniversität
Hagen, Hagen.
Scholz, H. (1961), Mathesis universalis. Abhandlungen zur Philosophie als strenger Wissenschaft,
Schwabe & Co, Basel/Stuttgart.
Scholz, H. (1983), Storia della logica, trad. it. a cura di E. Melandri, Laterza, Roma-Bari.
Tarski, A. (1938), “Der Aussagenkalkül und die Topologie”, Fundamenta mathematicae, vol. 31,
pp. 103-134.
Thiel, C. (1995), Halbintuitionismus, in Mittelstrass, J. (Ed.), Enzyklopädie Philosophie und
Wissenschaftstheorie, vol. II, Metzler, Stuttgart/Weimar, pp. 23-24.
Ueberweg, F. (1882), System der Logik und Geschichte der logischen Lehren, Marcus, Bonn.
van Atten, M. (2017), Construction and Constitution in Mathematics, in Centrone, S. (Ed.), Essays
on Husserl’s Logic and Philosophy of Mathematics, Springer, Dordrecht, pp. 265-315.
Wiegand, O.K. (1998), Interpretationen der Modallogik. Ein Beitrag zur phanomenologischen
Wissenschaftstheorie, Kluwer, Dordrect/Boston/London.
Wittgenstein, L. (1975), Ludwig Wittgenstein e il Circolo di Vienna. Colloqui annotati da F.
Waismann, trad. it. a cura di S. de Waal, La Nuova Italia, Firenze.
Wittgenstein, L. (1983), Ricerche filosofiche, trad. it. a cura di M. Trinchero, Einaudi, Torino.
Abstract
At the beginning of the thirties of the Twentieth century – in conjunction with attempts to revise the
principles of classical logic developed by Łukasiewicz and Kleene – Gotthard Günther (1900-1984)
propounds a “new theory of thought” focused on criticism of the principle of bivalence through the
retreival of speculative reasons of Hegel’s Science of logic, in particular the chapters dedicated to
the Doctrine of the essence. In the Hegelian dialectical process of “reflection”, which goes beyond
the immediacy of being, Günther sees the philosophical presuppositions for overcoming the
classical motifs of thought (such as the undifferentiated identity of the logical object, the prohibition
of contradiction and the law of excluded third) in favor of an inclusion, within the logical structure,
of the multiplicity of subjects and the multivalence of cognitive relations, in which not only the ego
is the logical subject of judgment, but also the “thou” and the other. This non-Aristotelian logic, to
the extent that it opens to the intentional multiplicity of the essences, reveals singular points of
convergence with the intensional modal systems developed by Oskar Becker (1889-1964) in the
field of phenomenological thought. Taking a cue from the reflections on pure analytics performed
by Husserl in the last part of Formal and transcendental logic, Becker develops an expanded
system of the “logic of consequence” that overcomes the traditional “logic of non-contradiction”,
thus rooting the different logical forms – of which the “Aristotelian” is only a special case – in the
“essential nature” of man, whose thought, in its different intentional modalities, finds no limits in
the traditionally defined logical laws.
Keywords: Non-Aristotelian logic, Transcendental Logic, Modal Logic, Phenomenology,
Reflection, Identity
254
�FELICE MASI*
Prova e Ragione. Struttura e demarcazione dell’epistemologia della
VI Ricerca logica attraverso alcuni casi di studio
1. Domande
Si può dire che la prima epistemologia fenomenologica sia una forma di verificazionismo e che la
VI Ricerca logica abbia introdotto la percezione nello “spazio delle ragioni” 1? E si può dar credito
allo stesso Husserl, quando afferma, con sguardo retrospettivo nell’introduzione alla seconda
edizione della VI Ricerca logica, che essa costituisce un avviamento in direzione di una teoria della
ragione?
A ben guardare le due domande possono essere convertite nelle due parti di un medesimo
argomento: se l’epistemologia della VI Ricerca logica è inclusa in una teoria della ragione, allora
essa vi contribuisce predisponendo una soluzione verificazionista al problema della conoscenza e la
sua mossa centrale non potrebbe non essere quella di aver introdotto le percezioni nello “spazio
delle ragioni”.
Una recente versione di quest’argomento può trovarsi in Hopp2: assunto che a qualsiasi oggetto
corrisponde la possibilità ideale di essere esperito3, allora un’espressione – che per essere realmente
tale, ovvero perché abbia significato reale, deve riferirsi a un oggetto 4 – deve ammettere che
l’oggetto a cui si riferisce sia, almeno idealmente, esperibile. O detto altrimenti: un’espressione ha
significato se l’oggetto a cui si riferisce è esperibile, quindi un’espressione ha significato se è in
linea di principio riempibile.
2. Varietà di verificazionismo
Con semantica verificazionista non s’intende la lingua franca che la tradizione dell’empirismo ha
sin dai suoi inizi adoperato per delimitare descrittivamente gli enunciati empirici, ma una ben più
specifica semantica normativa di quegli enunciati che prescriva un criterio di significanza, ovvero
la semantica di una logica normativa della conoscenza che si distingueva dalla logica formale del
simbolismo grammaticale-matematico. Di essa si possono dare quanto meno quattro versioni:
*
Università degli Studi di Napoli Federico II
1
Benoist (2013), p. 160, p. 214. In riferimento alla sola intenzione categoriale, cfr. Sokolowski (2000),
pp. 94-95.
2
Hopp (2011), Hopp (2018). Già Smith, McIntyre (1982), p. 259, p. 267, avevano avanzato l’ipotesi di uno Husserl
verificazionista, confrontando però le sue opere più tarde (in cui emergono le nozioni di motivazione e di orizzonte, con
la logica modale carnapiana dei mondi possibili.
3
Smith (2003), p. 186. Cfr. Husserl (2005b), p. 490. Citerò da questa edizione – pur introducendo talvolta alcune
modifiche alla traduzione per omogeneità d’argomentazione –, quando la prima edizione è passata inalterata alla
seconda.
4
La specificazione di reale è necessaria: a) per non invalidare la definizione stessa di espressione, come segno
dotato di significato, il cui riempimento, anche solo possibile (positivo o negativo che sia), non è necessario, b) per non
far collassare la morfologia dei significati (o analitica pura) su quella dei giudizi. Difatti, solo in una teoria del giudizio
si può discriminare tra un significato reale e uno immaginario, valutando se le materie in specie, che compongono gli
oggetti complessi cui si riferisce un’espressione (ancora una volta in specie), siano compatibili (o no), e quindi se le
espressioni hanno (o no) la possibilità ideale d’essere riempite. Quanto detto potrebbe non valere per il verificazionismo
ideale, quando si lega a una sorta di minimale realismo metafisico. Cfr. Wright (2000), Engel (2006), p. 75.
Bollettino Filosofico 33 (2018): 255-275
ISSN 1593 -7178 - 00030
E-ISSN 2035 -2670
DOI 10.6093/1593-7178/5922
�Felice Masi
1)
Un enunciato ha significato se vi è la possibilità di trovarne una verifica di fatto, ovvero
quando questo non è logicamente contraddittorio (Schlick) 5;
2)
Un enunciato ha significato se vi è la possibilità di confermarlo, riducendolo (parzialmente o
completamente) alla classe dei predicati osservabili, ovvero se un osservatore è in grado, nelle
circostanze appropriate, di prendere una decisione in merito (Carnap)6;
3)
Un enunciato ha significato empirico (o cognitivo) se vi è «la possibilità logica di tipo
osservativo che, se attualmente realizzata, costituirebbe l’evidenza conclusiva per l’asserzione data»
(Hempel) 7;
4) Un enunciato ha significato se vi è la possibilità di comprendere (costruire) quale sia il modo
per darne prova (Dummett).
3. Sinossi della contro-argomentazione
Avendo provato così a dettare i termini generali della questione, la tesi che vorrei sostenere è che
a) l’epistemologia della VI Ricerca non è parte integrante di una teoria della ragione e, per ciò
stesso, non fa professione verificazionista,
b) ma che in essa la “chiarificazione fenomenologica della conoscenza” si delinea piuttosto
b.1) su una teoria della prova, ovvero di una teoria del riempimento come prova di
un’intenzione (sulla base di un’intuizione) e dei corrispondenti livelli di credenza come
altrettanti gradi di provabilità (con tutto ciò che questa si chiama dietro quanto alla nozione di
logica e teoria della conoscenza e ai loro rapporti reciproci);
b.2) e che tale teoria della prova è integrabile in un empirismo riflessivo, sul quale vengono
scaricate le operazioni di prova a cui non corrisponde una variazione di credenza.
La demarcazione proposta non è rigidamente temporale: Husserl chiude i conti con la prima
epistemologia fenomenologica a piccoli passi e a partire dalle questioni gravanti sul pensiero
indiretto, ossia sul riempimento incompleto, e quindi anche su ciò che – nel vocabolario delle
Ricerche logiche – era la funzione del signitivo nella conoscenza, cioè del non propriamente
riempibile, come ad esempio il riferimento al lato non-visto, che è essenziale alla conoscenza di un
oggetto intero, oppure al non-più-presente nell’espressione dell’unità della coscienza.
La contro-argomentazione, dopo essersi assicurata ad alcune brevi (e giocoforza dogmatiche)
definizioni e aver esposto la sua contro-tesi, si svolgerà su sei casi di studio, uno terminologico e
cinque teorici.
4. Definizioni.
1) La conoscenza concepita logicamente è quella “orientata alla verità” 8. Quest’orientamento ha
una precondizione (qualitativa) e una condizione (formale). In virtù della prima, tanto la sua
espressione quanto la sua eventuale intuizione devono essere posizionali, in modo che l’una possa
essere rafforzata (o indebolita) o confermata (o disconfermata) dall’altra9. In virtù della seconda,
essa deve rispettare la forma della logica come teoria delle molteplicità definite, così da riconoscere
che ogni singolo asserto è parte di un insieme col medesimo riferimento oggettuale e che occorre
ricondurlo all’insieme di cui partecipa, se si vogliono raggiungere due risultati: la messa in risalto
della medesimezza del riferimento oggettuale (che decide della forma dell’insieme e non della sua
estensione) e l’aumento di credibilità dell’asserto.
1.1) Dalla precondizione discende un impegno per la conoscenza: accettare la definizione logica
di verità (cfr. 2).
5
Schlick (1936), p. 83.
Carnap (1936-1937), p. 192, p. 195.
7
Hempel (1950), p. 45.
8
Hua, XXIV, p. 5.
9
Husserl (2005b), p. 367.
6
256
�Prova e Ragione. Struttura e demarcazione dell’epistemologia
della VI Ricerca logica attraverso alcuni casi di studio
1.2) Dalla condizione deriva che la conoscenza è a partire dal fondamento, ovvero dalla
necessità ideale della sua inclusione10.
2) Il concetto logico di verità è tale per cui «la parola “vero” si potrebbe sostituire con
“possibilità dell’evidenza”»11, ovvero con possibilità della conferma o possibilità della provabilità.
“La possibilità dell’evidenza” comprende due sottocondizioni connesse: la possibilità reale dei
significati unitariamente intesi nell’espressione e la possibilità d’identificazione dell’oggetto.
2.1) Se verità è “possibilità dell’evidenza”, allora evidenza non può essere “possibilità della
verità”, escludendo così una risoluzione epistemica della verità e la degenerazione dell’evidenza in
verosimiglianza.
2.2) il concetto logico di verità regge un controfattuale, che potrebbe renderla sì più
problematica, ma anche più utile: “può esser ‘vero’ solo ciò della cui evidenza si può dubitare”12.
3) L’intenzionalità conoscitiva è una relazione d’ordine e, per questo, è transitiva (ammette che
da una determinata espressione che intende un determinato oggetto, un’intuizione, sulla medesima
linea, tracciata o anticipata dall’intenzione, transiti in senso contrario), ma anche riflessiva (è
possibile che il riempimento esiga un’ulteriore espressione), e non simmetrica (ovvero i ruoli di
intenzione e intuizione, o di pensiero e percezione, non sono scambiabili) 13.
4) L’espressione percettiva è espressione dell’impegno conoscitivo contratto da un vissuto
intenzionale. La sua definizione è composta da un versante fansiologico e da uno semantico.
4.1) Il primo discende dalla correlazione interna all’apparire, tra l’apparenza di qualcosa e
qualcosa che appare14, così che nell’espressione l’apparenza di qualcosa è apparenza di qualcosa
che appare.
4.1.1) L’apparire di qualcosa che appare (ovvero l’espressione percettiva) non è la
comunicazione confessionale dell’aver o dell’aver avuto una percezione (“così m’appare”), né la
presunta assoluta evidenza interna di ciò che può essere appreso attraverso se stesso, che potrebbe
rendersi con “(io) sono apparso così” 15.
4.1.2) Nell’espressione percettiva si contrae un impegno con qualcosa (che appare) e su qualcosa
(l’apparenza, ovvero l’espressione stessa), affinché su questo possa esercitarsi, mediante prova, la
transizione tra intenzione e intuizione 16.
4.2) Il secondo deriva dal fatto che la percezione realizza la possibilità dell’intendere-questo, ma
non ne costituisce il significato, né una sua parte17.
4.2.1) L’espressione dipende dalla percezione, che ne costituisce il vincolo ossessivo, sin dalla
sua forma sintattica (l’uso del “questo”), ma è insensibile alla variabilità delle espressioni, stante
l’invarianza della scena percettiva, alla variabilità percettiva, mentre resta invariata l’espressione, e
alla variazione di momenti extra-essenziali, ma ancora in qualche modo percettivi, nell’invarianza
dell’espressione.
10
Husserl (2005a), p. 238.
Hua, Mat., II, p. 307.
12
Cfr. Patzig (1977), Bernet (1981).
13
Cfr. Melandri (1990), pp. 188-189.
14
Husserl (2005b), p. 142.
15
Chisholm (1966) p. 40, p. 50.
16
Perciò Husserl (2005b), p. 501, può affermare che «è controsenso dubitare che il decorso reale del mondo, il
mondo in sé nella sua connessione reale, possa entrare in contrasto con le forme del pensiero», cosa che non mette in
salvo nessuno dal fallimento del pensiero o dall’inadempienza della conoscenza o ancora dall’infalsificabilità della
menzogna (che bara appunto sulla posizionalità), ma almeno riesce a prescrivere una buona terapia – che però è anche
dura e difficile da seguire alla lettera, come Husserl stesso mostrerà – contro la favola della razionalità o irrazionalità
del mondo. Si badi che qui Husserl usa “controsenso” e non “senza senso” o “assurdo”, tenendo a mente che
esemplificazione del primo è “cerchio quadrato”, del secondo “verde è o”, del terzo l’errore o il falso. Il primo ha un
significato impossibile, il secondo non ha significato, il terzo enuncia un significato complesso che, alla prova
dell’intuizione, è risultato una diversificazione. Se esprimessi il contrasto tra “pensiero” e “corso reale del mondo”
intenderei così un significato impossibile, giacché avrei composto due specie materiali non unificabili, e lo stesso
avverrebbe se esprimessi il loro necessario accordo.
17
Husserl (2005b), p. 319.
11
257
�Felice Masi
4.2.2) L’espressione è l’esplicitazione di ciò che è implicitamente in comune, non solo alla serie
di momenti che compongono la percezione complessa di un medesimo oggetto, ma anche alle serie
immaginativa o signitiva, che ne possono derivare 18.
4.2.3) Quella dell’espressione percettiva è una definizione operativa, tale per cui se l’espressione
è un’esplicitazione le deve fare da correlato un’implicitazione, qualcosa che rispetto a essa è ciò che
si prende come implicito.
4.2.4) Il gioco di esplicitazione e implicitazione non coincide con l’esperimento dell’apertura
d’un cassetto, né con quello di un gatto in una scatola, né presenta alcuna insidia di circolarità,
perché non vien toccata la rigida divisione del lavoro tra le due.
4.3) La definizione fansiologico-semantica di espressione percettiva avvia a risoluzione l’enigma
dell’autò tò phaìnesthai – «il più mirabile di tutti i fenomeni» – con cui Hobbes19 aveva inaugurato
l’empirismo moderno;
5) Perché un vissuto sia conoscitivo deve presentare all’analisi descrittiva alcuni elementi,
organizzati in una struttura generale (l’essenza intenzionale conoscitiva):
a) la qualità (posizionalità e non-posizionalità, quando si tratta della differenza tra percezione e
immaginazione);
b) la materia (ciò che è inteso, nel modo in cui è inteso, ovvero il senso apprensionale);
c) il contenuto rappresentante (ovvero la materia nella e con la sua funzione presentativa; o in
altri termini: la materia nella e con la forma in cui è appresa);
d) la pienezza intesa come:
d.1) estensione o ricchezza, ovvero la quantità di caratteri inclusi nel contenuto di un oggetto;
d.2) la vivacità, ovvero il grado di somiglianza tra contenuto presentante e contenuto presentato;
d.3) il portato di realtà, ovvero il numero di contenuti presentanti, di cui fanno parte anche quelli
che concorrono all’individuazione spazio-temporale dell’oggetto e che possono essere recati solo
dalla percezione20.
5.1) L’essenza conoscitiva ha la funzione principale di misurare la differenza, salva materia, tra
un rappresentante signitivo, immaginativo e percettivo, utilizzando, più che la qualità, il contenuto
rappresentante e la terza accezione di pienezza 21.
5.1.1) Nel caso dell’immagine, il rapporto tra materia e contenuto rappresentante è quello della
somiglianza;
5.1.2) Nel caso del segno, il rapporto tra materia e contenuto rappresentante è quello della
contiguità;
5.1.2.1) «l’insieme [Inbegriff] di determinazioni […], che, pur essendo cointenzionate, non
cadono esse stesse nell’apparenza»22, presenta per contiguità23.
18
Husserl (2005b), p. 319. Si badi che esplicitare nell’espressione un implicito in comune – l’intero oggetto
intenzionale della percezione, a cui con ossessione si torna – non significa affatto prendere l’implicito come premessa
da cui inferire l’esplicito, perché un’inferenza esige che siano esplicite tanto le premesse quanto la conclusione. A meno
che non si tratti di una sua occorrenza spuria, come l’abduzione, cosa che però qui mi parrebbe improprio asserire sia
per l’ordine in cui mi pare Husserl ponga implicito ed esplicito, intenzione e riferimento, sia perché quest’ordine nulla
ha a che fare con quella differenza tra non cosciente (e non controllabile) e cosciente (e controllabile), differenza che
sola ha consentito di considerare le espressioni percettive come «un caso estremo di inferenza abduttiva». Peirce (2005),
pp. 556-557.
19
Hobbes (1972), p. 377; cfr. Becker (1998), p. 18; Meinong (1993), p. 77.
20
Husserl (2005b), p. 377.
21
Occorre rammentare che per pienezza s’intende o l’insieme delle determinazioni che costituiscono un oggetto, o
l’insieme delle determinatezze con cui la rappresentazione presenta il proprio oggetto; in ogni caso, comunque, un
insieme unitario a cui ricondurre i momenti che ne dipendono. Nella revisione del terzo capitolo della VI Ricerca,
Husserl rimetterà mano alla nozione di “pieno”, distinguendo tra un suo concetto noematico e uno noetico: il primo,
come «estensione in cui l’oggetto presunto giunge a datità in se stesso, il secondo [come] statuto intuitivo nel portato
reale della percezione», ed aggiungendo alle sue gradazioni anche quelle di favore e sfavore proprie dell’adombramento
(U. Melle, in Hua, XX/1, p. XXXIII). Cfr. Hua, XX/1, pp. 128 ss.
22
Husserl (2005b), p. 380.
258
�Prova e Ragione. Struttura e demarcazione dell’epistemologia
della VI Ricerca logica attraverso alcuni casi di studio
5.1.2.2) Tra la materia del lato visto e la presentazione del lato non visto vi è estraneità, ma tra la
presentazione del lato visto e quella del lato non visto vi è invece somiglianza, così che il lato non
visto si presenta contiguo a quello visto.
5.1.3) Nel caso della percezione, il rapporto tra materia e contenuto rappresentante è quello della
stessità.
6) Un’unità dinamica tra espressione e intuizione espressa si ha qualora vi sia una differenza
temporale tra intenzione e intuizione 24.
6.1) Solo in questo caso, ha luogo una sintesi d’identificazione, ossia un atto di conoscenza vero
e proprio.
6.2) Nell’unità dinamica si compie una posizione relazionante e non una posizione assoluta, non
si pone cioè un oggetto semplice, ma uno stato di cose, un oggetto complesso, una relazione tra
cose, una relazione in cui le cose si trovano.
6.3) Nell’unità dinamica è però inevitabile la concorrenza tra diverse apprensioni 25.
6.4) Sintesi d’identificazione, posizione relazionante e diversità d’apprensioni sono termini
correlativi; ovvero:
6.4.1) Nella sintesi complessiva si superano relativamente le lacune di pienezza delle sintesi
percettive parziali e si richiama correlativamente la prova o conferma o riempimento;
6.5) L’intenzione-guida di una sintesi complessiva non ha il carattere temporale
dell’aspettazione26;
6.5.1) Espressione temporale della differenza tra intenzione e intuizione è la ritenzione;
6.5.2) La ritenzione, in quanto momento non-indipendente della presentazione (insieme
all’impressione), non è propriamente presentativa;
6.5.3) La ritenzione presenta per contiguità;
6.5.4) il rapporto tra impressione e ritenzione si può formulare con:
R ← I,
e quello tra le loro materie con:
(…)m ← Mi,
indicando così il modo in cui si distribuisce la materia nei momenti della presentazione e, quindi,
utilizzando (…)m per dire dell’assenza di materia della ritenzione e Mi per rendere invece la materia
impressionale;
6.5.5) In questo modo, si designa una coscienza epistemica in cui la ritenzione ha un ruolo
prevalente;
6.5.6) La ritenzione adempie la condizione fansiologica dell’espressione percettiva e ne sostiene
quella semantica, completando così quanto avviato in (4.3)27.
23
Husserl (2005b), pp. 360-361. Su come le revisioni della VI Ricerca si “scatenino” per espellere le
rappresentazioni signitive dalle percezioni complesse, cfr. Hua, XX/1, pp. 85 ss., 141 ss.; Hua, XX/2, pp. 131 ss., 393
ss., ma già Hua, XVI, pp. 105 ss.
24
Dall’unità dinamica si distingue il caso limite dell’unità statica, che sarebbe rappresentato dai soli nomi ovvero: o
dai nomi così come sono intesi al primo livello di comprensione di un enunciato (quando cioè non vengono messi a
tema, ma funzionano come parti del complesso espressivo) oppure da quei nomi, i realia ad esempio, che risultano
come incollati alla cosa. Se la distinzione tra concetto statico della conoscenza e concetto dinamico, ovvero tra
posizione assoluta dei nomi e posizione relazionante delle espressioni “predicative” (che pure ebbe grande e favorevole
risonanza, di cui le Ricerche filosofiche di Wittgenstein sono il maggiore esempio) può dirsi già “liberalizzata” con
l’introduzione sul finire della VI Ricerca della coppia “significato proprio” (il nome senza articolo) e “significato
nominale” (il nome con articolo), saranno i lavori di revisione su “Nomi propri ed espressioni occasionali”, iniziati nel
1909, a segnarne il definitivo commiato, in particolare grazie alla ripresa del fenomeno del “si chiama…”, già presente
nell’edizione del 1901, come esempio del vicariato che il nome può fare dell’intuizione corrispondente. Si veda in
proposito Hua, XX/2, pp. 343 ss. Più generalmente sui numerosi progetti di revisione della VI Ricerca si veda
Sinigaglia (1998).
25
Husserl (2005b), p. 367.
26
Husserl (2005b), pp. 338-339.
259
�Felice Masi
6.5.7) La ritenzione è il contrappunto temporale dell’epistemicità della prova.
7) Il riempimento è prova o conferma. Quando le apparenze di un oggetto in quanto lo stesso
s’identificano con le apparenze dello stesso oggetto in quanto lo stesso oggetto, si realizza una
sintesi di riempimento28; in essa cioè l’oggetto così come è inteso coincide con l’oggetto così come
è intuito;
7.1) Il riempimento è il terzo momento di un vissuto di conoscenza, oltre l’intenzione e
l’intuizione;
7.1.2) Esso è pertanto grandezza intensiva, così come lo è la corrispettiva evidenza, ma non la
verità a cui si conforma e riferisce;
7.1.2.1) il riempimento o l’evidenza possono essere parziali, non la verità;
7.1.3) L’adaequatio è l’evidenza in cui l’oggetto (res) è intuito così come è stato inteso
(intellectus), ma non è la verità, ovvero il se stesso dell’oggetto, in quanto lo stesso intuito e inteso.
7.1.2) Il riempimento non coincide con l’intuizione perché mentre quest’ultima presenta
l’oggetto in se stesso, così com’è intuito, il riempimento presenta l’oggetto come lo stesso (inteso e
intuito) 29;
7.1.3) L’identificazione che avviene nel riempimento non è la stessità della percezione, giacché è
una relazione tra due modi di uno stesso oggetto30 e non tra materia e contenuto presentante;
7.1.4) Quando però avviene sulla base di una percezione produce l’effetto ottico per cui l’oggetto
risulta identico al rappresentante intuitivo31.
7.1.5) Nel riempimento viviamo l’esperienza dell’oggetto in quanto lo stesso, ma non intendiamo
l’identità dell’oggetto32, che resta a portata di mano per una riflessione oggettiva 33.
7.2) Si ha un riempimento perfetto quando si realizza (9.1.4), ovvero la saturazione intuitiva di
tutto ciò che è esplicito nell’intenzione;
7.2.1) Anche presentazioni per contiguità, come immaginazioni, indizi, scorci, adombramenti,
possono ricevere conferma. Questa conferma però non suona “è lo stesso”, ma “proprio così
com’è”, “interamente così com’è” 34.
7.2.1.1) L’intero non è lo stesso. Tra l’intero e lo stesso vi è la contiguità, il segno.
7.3) Si ha un riempimento ultimo quando si risolve anche la differenza di (9.1.5), ovvero quando
vengono saturate intuitivamente anche di tutte le possibili esplicitazioni di ciò che è ancora
implicito nell’intenzione35.
5. Contro-tesi: provabilismo ed empirismo riflessivo
Quella della VI Ricerca logica è un’epistemologia descrittivo-specifica (si realizza, cioè, nella
descrizione dei vissuti conoscitivi in specie e delle loro specie contenutistiche) e non ammette
pertanto un’applicazione logico-normativa. In essa infatti l’errore viene classificato come possibilità
dell’assurdo, di una sintesi dissonante, che però resta una sintesi e anzi irrobustisce l’identificazione
di ciò che resta identico (il minimo requisito di materia), e la menzogna viene espulsa dal suo
territorio in quanto doppio gioco sulla posizionalità (il minimo requisito di qualità).
Due sono le lacune su cui essa si regge, due sono, cioè, le principali differenze che non trovano
ricomposizione e che perciò rappresenteranno tra le maggiori spinte alla revisione dell’edizione del
1901:
27
Husserl (2006), pp. 334-335. L’innesto della ritenzione alla radice insieme fansiologica e semantica
dell’espressione percettiva potrebbe essere capace di rispondere all’incrocio di scetticismo linguistico e scetticismo
gnoseologico messo a tema da Kripke (2000), pp. 57 ss., pp. 65 ss.
28
Husserl (2005b), p. 357.
29
Husserl (2005b), p. 355.
30
Tugendhadt (1970), p. 94, intende invece una dualità d’oggetti.
31
Husserl (2005b), p. 418.
32
Husserl (2005b), p. 365.
33
Husserl (2005b), p. 333. Cfr. Husserl (2005b), p. 334. Cfr. Hua, XIX/1, p. 899, p. 901.
34
Husserl (2005b), p. 339.
35
Husserl (2005b), p. 419.
260
�Prova e Ragione. Struttura e demarcazione dell’epistemologia
della VI Ricerca logica attraverso alcuni casi di studio
1) quella tra concetto logico di conoscenza ed essenza conoscitiva, e
2) quella tra identificazione e identità;
entrambe finiscono per collassare sulla nozione di riempimento. Ma in due modi diversi.
La prima ha a che fare con il riempimento perfetto, quello in cui il riempimento, in quanto
conferma, si presenta come una “prova”, così che a ogni operazione con cui viene inclusa, o
recuperata, una parte della molteplicità di riempimenti possibili corrisponde un aumento di
credibilità. Pertanto, la differenza tra concetto logico di conoscenza ed essenza conoscitiva definisce
l’ambito in cui può giocarsi il provabilismo.
La seconda lacuna ha invece a che fare con il riempimento definitivo, laddove cioè il
riempimento, che pur resta una conferma, quand’anche aumentasse non determinerebbe un aumento
di credenza, ma una migliore definizione della molteplicità che segue dalla riflessione su una
qualche unità formale. Il riempimento definitivo può essere ottenuto, in altri termini, solo dal
riempimento intuitivo (dalla conferma) di intenzioni rivolte a formazioni categoriali. Tuttavia,
queste formazioni possono essere pure (la loro prova può condurre alla comprensione evidente della
legge ideale che governa la molteplicità definita, o chiusa, delle loro variazioni) o non pure (e allora
la loro legge ideale è comprensibile in maniera solo indiretta). In entrambi i casi, una riflessione su
tali oggetti formali non ne incrementa la credibilità; nel secondo caso, che Husserl riconosce come
quello più comune, si dimostra l’impossibilità di un linguaggio logicamente adeguato per la
conoscenza36. Entrambi risultano irresolubili in un provabilismo, ma soprattutto il secondo spinge
affinché la teoria della prova s’integri in una forma, che proverò a definire meglio, di empirismo
riflessivo (per ora l’uso di empirismo viene concesso da 4.3 e da 8.5.5).
6. Il caso di studio linguistico: Wahrmachend
Passo ora all’esame di alcuni casi ai quali dovrebbe far fronte il canovaccio definitorio che ho
approntato. E comincio da un termine che da solo basterebbe a far venir giù tutta la mia controargomentazione.
Nella terza definizione di evidenza, data nel § 39, si potrebbe leggere la più sonora smentita a ciò
che ho appena sostenuto, giacché in essa compare, in riferimento alla pienezza vissuta nel
riempimento, l’attributo wahrmachend, di solito tradotto con verificante. Per comprenderla appieno
proporrei di lasciare per il momento sullo sfondo il riordino delle definizioni in due colonne, che lo
stesso Husserl consiglia di fare e che consiste nel sistemare in una, la seconda e la quarta
definizione, con il compito di delimitare il concetto di verità, in riferimento «agli atti stessi e ai loro
momenti idealmente intesi», in quanto «idea dell’adeguazione, oppure come giustezza del
significato e della posizione oggettivante», in un’altra, la prima e la terza, a cui viene invece
ricondotto il concetto di essere, come essere-vero dei rispettivi correlati oggettuali, ovvero come
«identità dell’oggetto al tempo stesso dato e inteso nell’adeguazione», come «ciò che è
adeguatamente percepibile in generale in un riferimento indeterminato a un’intenzione qualsiasi che
dovrebbe così essere verificata [wahrzumachende] (che dovrebbe essere adeguatamente
percepita)»37. Una tale risistemazione impedisce di vedere un altro ordine con cui le definizioni
possono esser lette, quello in cui, assunta la prima come quella più ampia, quasi come un assioma
dei rapporti tra evidenza e verità, ossia tra vissuto e oggetto intenzionali, la seconda introduce una
determinazione della struttura ideale della correlazione, che poi viene descritta dal punto di vista
dell’intenzione (nella terza) e da quello dell’intuizione (nella quarta). Una volta stabilito che per
verità vale l’idea dell’evidenza, «il rapporto ideale […] tra le essenze conoscitive degli atti
coincidenti»38, si può domandare cosa serva all’intenzione per realizzare questo rapporto e cosa
serva all’intuizione, così che le due risposte esprimano rispettivamente il tipo di riempimento
richiesto dall’anticipazione e il tipo di anticipazione ammesso dal riempimento.
36
Husserl (2005b), p. 493.
Husserl (2005b), p. 426
38
Husserl (2005b), p. 423.
37
261
�Felice Masi
Del resto, benché il suggerimento di lettura che sto dando paia contraddire la lettera del testo – si
potrebbe obbiettare che, all’inverso, la terza definizione inizia con «considerando l’atto che dà
pienezza» e la quarta con «dal punto di vista dell’intenzione» –, quello che propongo è di intendere
le ultime due definizioni seguendo lo schema delle “risposte” che ho appena menzionato. Queste
“risposte” sono precedute da altrettante domande che non possono non presentarsi formulate
nell’ordine inverso.
E in fondo, anche la riscrittura dell’intero capitolo – che pure segna una forte rottura rispetto alla
prima edizione, intestando la correlazione evidenza-verità a quella coscienza-essere, tale per cui
«essere nel senso più ampio è necessariamente riferito a coscienza» e a ogni aumento di
riempimento corrisponda un rafforzamento del diritto e della razionalità della posizione – dà
sostegno al mio suggerimento. Infatti, in sostituzione della precedente terza definizione, si legge:
«anche rispetto all’intenzione, il vero significa lo stato di cose dato [o nella versione di Landgrebe:
dato in se stesso], nella misura in cui esso deve essere identificato con quello inteso» 39.
Torniamo ora alla terza definizione e proviamo a leggerla dalla fine all’inizio. Il suo definiendum
è l’oggetto dato nel riempimento così come esso era stato inteso ovvero, se guardiamo alla sua
specie, la «pienezza ideale dell’essenza conoscitiva specifica dell’intenzione»40. La pienezza stessa
– ovvero l’insieme dei caratteri dell’oggetto intenzionale – è ciò che si presenta nel riempimento –
ovvero in correlazione all’insieme dei momenti del contenuto rappresentante nel riempimento – ed
è ciò che il modo in cui l’oggetto era stato inteso o l’essenza conoscitiva dell’intenzione in specie
esigevano perché si realizzassero. La pienezza stessa, e non già la percezione adeguata, realizza
l’intenzione. E la realizza idealmente, ne fa una possibilità reale, nella fattualità del riempimento.
Se è vero che quando fallisco nell’unificare due contenuti, non è detto che abbia motivo per
giungere all’intuizione unitaria dell’impossibilità che quei contenuti siano unificabili in specie, se è
vero cioè che «l’insuccesso di fatto non dimostra la necessità dell’insuccesso»41 , al contrario il
successo di fatto dimostra la necessità del successo, allo stesso modo in cui una parte relativamente
non-indipendente è anche assolutamente non-indipendente, mentre una parte relativamente
indipendente non è per ciò stesso assolutamente non-indipendente; il particolare positivo è la prova
(ovvero l’esempio) della sua specie, la cui estensione può anche essere limitata a quel solo
esemplare.
Il particolare positivo realizza idealmente la possibilità pretesa dall’intenzione. Ma con ciò, dico
anche che la verifica? E che cosa significa, se non questo, che la pienezza ideale è l’oggetto che
verifica, der wahrmacht, l’intenzione? Se non vogliamo fermarci alle parole e alle loro equivoche
assonanze, bisogna ammettere allora un più forte disciplinamento interpretativo. Per questo,
propongo di intendere in senso verificazionista wahrmachen, solo quando vengono soddisfatte due
condizioni: 1) una riduzione di deducibilità (il complesso è deducibile dal semplice e a esso è
ridotto); 2) una pretesa di diritto o di criterio 42 . Qualora queste due condizioni non vi siano o,
peggio, vengano esplicitamente confutate, allora sarebbe necessario ricercare una diversa strada.
Cosa accade allora nella VI Ricerca? Poco dopo la terza definizione di evidenza e verità,
l’aggettivo wahrmachend torna, quando Husserl ribadisce una volta di più la differenza tra
identificazione e identità, ma nella versione della differenza tra l’essere della sintesi giudicativa e
l’esser-vero di questo stesso essere, tra l’espressione, l’oggettivazione cui è sottoposto il primo e la
non espressione, la non oggettivazione in cui resta il secondo. La concordanza tra intenzione e
percezione, «che costituisce la forma sintetica dell’atto di evidenza […] non è enunciata [a
39
Hua, XX/1, p. 259.
Husserl (2005b), p. 423.
41
Husserl (2005b), p. 407.
42
Questo è quanto accade in Bolzano (1837), p. 144, in Wittgenstein (1998), p. 108, e soprattutto in Pfänder (1921),
pp. 373-374, che propone il Satz der Wahrmachung come una versione logica del principio di ragion sufficiente, in
opposizione al tentativo presuntamente relativistico di subordinare l’esame del portato di verità di un giudizio alla
possibilità di darne prova e quindi a un’incontrollabile concatenazione di giudizi. Cfr. Mulligan, Simons, Smith (1987);
Mulligan (2006).
40
262
�Prova e Ragione. Struttura e demarcazione dell’epistemologia
della VI Ricerca logica attraverso alcuni casi di studio
differenza di quella tra soggetto e predicato simboleggiata dalla copula, ma] indubbiamente può
essere sempre enunciata, e lo può con evidenza. In tal caso essa diventa lo stato di cose verificante
[wahrmachend] di una nuova evidenza, per la quale vale la stessa cosa, e così via. Ma a ogni passo
si deve distinguere tra stato di cose verificante [wahrmachend] e quello che costituisce l’evidenza
stessa»43.
Avendo già appurato che nella VI Ricerca non vi è posto per una logica normativa della
conoscenza e quindi per la postulazione di un qualche suo criterio, mi pare che questo brano mostri
a sufficienza l’esclusione anche dell’altra condizione, quella riduttiva: la funzione “verificante” non
viene svolta dall’analogo delle rappresentazioni bolzaniane, ovvero dalle materie apprese in specie,
ovvero dalle essentiae, ma in un’ulteriore esplicitazione di ciò che era rimasto implicito nelle sintesi
di riempimento. Altro è dire che «le differenze tra è e non è sono differenze di materie
intenzionali»44, altro che la funzione verificante delle relazioni che sussistono e identificano uno
stato di cose sia indipendente dall’espressione di quelle relazioni, le quali, in questo modo,
divengono uno stato di cose d’ordine superiore, fondato sul primo. In altri termini, perché di uno
stato di cose1 venga inteso e colto il suo esser-vero è necessario che l’esser-vero dello stato di cose1
venga espresso come stato di cose2, il cui esser-vero, ancora una volta, dipende sì da materie, ma da
materie fondate su quelle dello stato di cose1 e a esse non identiche, né riducibili.
Il wahrmachend ha una doppia fronte: quella di segnalare il realizzarsi, il presentarsi come
presente, della possibilità ideale dell’intenzione e quella di marcare il limite empiristico-riflessivo
della teoria del riempimento come teoria della prova. In un caso, esso, realizzandola, confermandola
nel riempimento, incrementa il grado di credenza dell’intenzione dapprima vuota, nell’altro,
rendendo l’esser-vero della sintesi della è, non la rende affatto più credibile, ma sempre più definita
in una riflessione oggettiva ripetibile in indefinitum. E così, provalibilità e verità restano distinte, e
al contempo tenute insieme, dal riempimento come wahrmachend.
7. Primo caso di studio teorico: identificazioni
Che tipo di identificazione è però il riempimento? A differenza delle mere identificazioni (che, per
dirla in breve, non hanno un limite oltre il quale esse non possono procedere), il riempimento, pur
ammettendo una “relazione di incremento” e quindi una relatività del livello di incremento
raggiunto, possiede un limite ideale: “l’adeguata presentazione in se stesso dell’oggetto”. Non si
dovrebbe avere, quindi, davvero riempimento nei casi che Husserl indica come esempi di mere
identificazioni: le infinite espressioni che hanno lo stesso valore numerico 2, le infinite immagini di
un’unica e identica cosa, «la molteplicità infinita di percezioni possibili di un’unica e identica
cosa»45, l’immagine fantastica di un oggetto che ruoti in tutti i sensi, il «passaggio da un disegno
approssimato e appena abbozzato a uno schizzo a matita più preciso»46 e poi al dipinto ultimato.
Mentre alle sintesi di riempimento si richiede che in esse le materie di intenzione e intuizione,
quanto meno nella loro funzione presentativa, giungano a coincidere, ciò potrebbe non accadere
nelle identificazioni appena elencate. Nelle espressioni segniche, nelle intenzioni immaginative e
anche nelle intenzioni percettive coinvolte in una percezione complessa e quindi duratura, estesa in
una successione di momenti, le materie, e le loro presentazioni, potrebbero o non essere continue,
ma contigue (intervallate cioè da buchi, coperti da connessioni simboliche o analogiche), oppure il
loro peso intuitivo potrebbe variare. Poniamo che con riempimento s’intenda il processo ideale nel
quale una conoscenza acquisisce la sua fondatezza logica e che con identificazione ci si riferisca
invece al processo reale che una qualche serie di vissuti conoscitivi segue. E poniamo che così si
renda anche comprensibile perché il primo abbia un limite ideale (la presentazione in se stesso
dell’oggetto) e il secondo possa procedere all’infinito (è impossibile passare da contiguità a
43
Husserl (2005b), pp. 424-425.
Husserl (2005b), p. 427.
45
Husserl (2005b), p. 366.
46
Husserl (2005b), p. 367.
44
263
�Felice Masi
continuità o equiparare tutti i pesi intuitivi). Il primo sarebbe allora il caso limite e ideale della
seconda, che però solo nella seconda può realizzarsi.
Quando utilizziamo concetti matematici, abbiamo tra le mani rappresentazioni di
rappresentazioni, alla cui comprensione non è necessaria la trasformazione in rappresentazioni
mediate; anzi qualora incontrassimo l’equazione x = (53)4, il suo intendimento verrebbe addirittura
ostacolato, soprattutto nel suo potenziale operativo, se dovessimo risolverla in (53 * 53 * 53 * 53) e
così via.
Ciononostante, in questi casi, «il contenuto delle rappresentazioni – o più chiaramente la materia
– predelinea a priori un decorso graduale determinato del riempimento»47 ed è in questo modo che
Husserl ricusa un carattere tautologico per i concetti matematici, che invece risulterebbe se il
semplice significato verbale coincidesse con il contenuto dell’espressione definitoria. Di questa
predelineazione anzi il concetto matematico è la regola: la simbolizzazione di (53)4 prescrive i modi
e i passi da fare per condurre a evidenza quell’espressione non evidente.
Qualcosa di ancora diverso accade quando adoperiamo modelli o raffigurazioni esemplari,
ovvero quando parlando dell’Inghilterra ci figuriamo i suoi confini, oppure quando per dimostrare
le proprietà di un triangolo ne costruiamo la figura, disegnandola col gesso su una lavagna, o ancora
quando, per capire come funziona un motore, ne leggiamo lo schema di costruzione.
Casi in cui non può compiersi un riempimento perfetto (in cui cioè l’intuizione non può
rispondere a quanto era esplicito nell’espressione) sono infine quelli di quando affermo che il melo
che è dianzi a me è “innestato” o quando dico che il suono che sto ascoltando ha un certo “numero
di oscillazioni”: infatti né l’“innesto” né il “numero di oscillazioni” sono propriamente percepibili 48.
Posso al massimo, avendone la competenza o avvalendomi di quella di qualcuno che la possiede,
notare che i frutti del melo sono più copiosi e che la loro comparsa è più frequente di quanto di
norma è previsto per un albero della stessa essenza, oppure posso mettere sul tavolo un
oscilloscopio e registrane i risultati in presenza di un determinato suono. Questi due casi sono più
utili di quanto possa sembrare, poiché definiscono fattispecie di evidenza chiaramente incompleta e
lo fanno chiamando in causa, non tanto un difetto della percezione sensibile, né una sua possibile
estensione operazionistica o strumentale, ma la reciprocità tra signitività e operazioni o strumenti di
prova.
Di questi casi torneremo a occuparci, quando affronteremo le astrazioni miste.
8. Secondo caso teorico: intuizione sintetica
Nel riempimento, l’oggetto si dovrebbe presentare come se stesso, e ciò sarebbe possibile, in
maniera adeguata, solo sulla base di una percezione. Per giustificare come anche un adombramento
percettivo (che resta una presentazione per somiglianza)49 possa fare da sostegno a un riempimento,
Husserl distingue ulteriormente la pienezza dello statuto sensibile dalla pienezza della funzione
presentativa, così che, quand’anche mancasse uno dei possibili momenti sensibili (e ciò è
inevitabile perché la sensibilità è confinata nella propria attualità), non mancherebbe perciò stesso la
“sensazione di” uno dei lati o dei caratteri dell’oggetto, poiché con “sensazione di” s’intende già –
seppur con un uso un po’ equivoco del linguaggio – la presentazione di qualcosa che esplicita la
sensazione avuta50. «Certi elementi della pienezza – così riassume Husserl – valgono per noi come
una presentazione definitiva degli elementi oggettuali corrispondenti»51.
Ciò è di particolare rilievo nel caso di un’intuizione sintetica, ove, benché l’atto sia sempre
costituito da intenzioni parziali fuse insieme, il riferimento all’oggetto può essere semplice o
47
Husserl (2005b), p. 370.
Sono esempi su cui avrebbe buon gioco a riflettere anche l’epistemologia contemporanea, ad esempio a partire dai
noti esperimenti mentali di Putnam (1975) sulla possibilità di capire e riferire la differenza tra un olmo e un faggio o
quella tra un acido e una base.
49
Cfr. Hua, XIX/1, pp. 899, 901, 908-909.
50
Sul ruolo dell’associazione nella genesi delle sensazioni, cfr. Husserl (2005b), p. 418.
51
Husserl (2005b), p. 418.
48
264
�Prova e Ragione. Struttura e demarcazione dell’epistemologia
della VI Ricerca logica attraverso alcuni casi di studio
complesso, a seconda che vi siano, o no, atti parziali che rappresentano intuitivamente lo stesso
oggetto, avendo però una diversa pienezza contenutistica, salva materia52. Ed è proprio per queste
sintesi continue che varrebbe la distinzione tra adeguatezza e inadeguatezza, giacché in una
continua fusione d’identità si trovano insieme rappresentanti percettivi e rappresentanti non
percettivi (immaginativi o signitivi).
Perché, però, quando mi riferisco in maniera complessa, poliradiale, a un oggetto – quindi a
qualcosa dal primo lato, allo stesso qualcosa dal secondo lato, e così via – non starei compiendo una
serie di identificazioni, ma una sintesi d’identità? Possono la continua fusione d’identità e la
presunta costanza della forma apprensionale (quando questa venga considerata in riferimento
all’intera materia e all’intero contenuto rappresentante e non ai loro momenti corrispondenti),
assicurare che «l’oggetto identicamente unitario si present[i] qui un’unica volta, e non tante volte
quanti sono gli atti singoli distinguibili» 53.
9. Terzo caso teorico: la somma assoluta
Laddove provassi a ridurre una tale intuizione sintetica, per ciò stesso non pura (non formata cioè
da sole intuizioni, né da sole percezioni), alla sequenza dei contenuti rappresentanti, non ritroverei
certo i diversi atti parziali, ma m’accorgerei comunque che «una parte della materia – la materia
dell’intuizione ridotta e che quindi è naturalmente pura – presenta il senso intuitivo in cui il
contenuto viene appreso; la parte restante della materia non esperisce una rappresentazione [ovvero
non funge da rappresentante] per somiglianza o per eguaglianza, ma solo per contiguità, cioè
nell’intuizione mista il contenuto rappresentante funge per una parte della materia come
rappresentante intuitivo, per la parte integrativa come rappresentante signitivo» 54 . Per di più, se
provassi a salvare le sole intuizioni pure, otterrei una molteplicità di «contenuti intuitivi nella quale
ogni momento oggettuale perviene non solo una, ma più volte, a rappresentanza ostensiva, a un
adombramento che cambia di continuo» 55 , disperdendo così anche la costanza della forma
apprensionale e conservando la sola continua fusione di identità come fenomeno dell’unicità
dell’oggetto.
Assunti i risultati della riduzione all’intuizione pura, in che senso potremmo definire lo statuto
intuitivo del riempimento idealmente definitivo e ultimo nei termini di una «somma assoluta dei
pieni possibili»56? Di certo, con “somma assoluta dei pieni possibili” non possiamo intendere la
serie discreta dei contenuti presentanti una volta ridotti, in quanto così avremmo considerato “i
pieni di fatto” e la loro addizione sarebbe inevitabilmente incompleta e non potrebbe presentare
alcun oggetto intero, né la sequenza delle materie che si riferiscono a un medesimo oggetto, poiché
tra i pieni possibili vi sarebbero, oltre i sensibili, anche quelli fantasmatici e simbolici con la stessa
materia, dando luogo a inutili e stranianti duplicati.
L’unico modo per comprendere questa locuzione peculiare è quello di decifrarne il linguaggio
matematico, in cui è scritta, facendo un passo indietro né troppo azzardato né eccessivamente
remoto verso l’utilizzo e la notazione di “valore assoluto”, introdotti da Weierstrass e largamente
usati da Husserl negli anni tra il 1889 e il 1893, quando abbozzava una filosofia del calcolo e
indagava, tra l’altro, la delimitazione di un ulteriore concetto di numero, accanto a quello di
cardinale e di ordinale, ovvero del numero di grandezza, che allora identificava proprio con il
“valore assoluto”57. Come è noto, con “valore assoluto” d’un numero reale, positivo (x) o negativo
(-x), si indica |x| e lo si utilizza, in senso topologico, per indicare la distanza di un punto sul piano (a
cui il numero reale corrisponde) dall’origine. La somma (x+y), quantunque y fosse negativo, se si
considerano i valori assoluti, è uguale a (|x|+|y|), facendo rilevare così la differenza tra numero e
52
Husserl (2005b), pp. 397-398.
Husserl (2005b), p. 398.
54
Husserl (2005b), pp. 392-393.
55
Husserl (2005b), pp. 398-399.
56
Husserl (2005b), p. 418
57
Hua, XXI, p. 96, p. 126. In proposito, anche una lettera a Natorp del 7/9/1901, in Hua, Dok., III/5, p. 80.
53
265
�Felice Masi
segno, ovvero tra grandezza e quantità, che potrebbe corrispondere, nel caso della locuzione
husserliana da cui siamo partiti, a quella tra contenuto rappresentante e contenuto rappresentato.
Al di là del confronto più o meno ardito con l’analisi elementare, il risultato esplicativo che ne
deriva è, a mio modo di vedere, di grande interesse in tre direzioni:
a) anzitutto, si riesce a capire che con “somma assoluta dei pieni possibili” Husserl volesse
intendere l’insieme additivo dei “moduli”, o importi, dei pieni, senza considerare la specifica
funzione presentativa (che qui prende il posto del “segno”) a cui sono sottoposti, ma lasciando
intatto il principio che per ciascuno di essi ne debba valere una; in altri termini: non si sottrae
semplicemente la forma appresensionale, ottenendo solo materie (cosa che prima ho esclusa), ma si
lascia indecisa quale essa sia, potendo così continuare a prendere in esame, quindi, dei contenuti
presentanti;
b) si dà poi così anche giustificazione al passo successivo, in cui Husserl affermerà che, in
questo caso, il «contenuto rappresentante» – ciò che è stato appena definito nei termini della somma
assoluta – «e [il] contenuto rappresentato sono qui una stessa cosa»58, giacché, se per contenuto
rappresentante s’intende il modulo del pieno, allora così come se (x) è positivo allora |x| è lo stesso
di (x), allo stesso modo, qualora la somma dei valori assoluti dei pieni abbracciasse tutti pieni
percettivi (tutti moduli con segno positivo, tutti contenuti presentanti con apprensione percettiva),
allora il contenuto rappresentante, in valore assoluto, sarebbe lo stesso del contenuto rappresentato,
quindi includendo la funzione presentativa o segno 59;
c) infine, si comprende quale sia l’utilità di una descrizione dello statuto intuitivo del
riempimento fatta in questo modo, poiché come il valore assoluto di un numero determina quale sia
la sua distanza da zero, così “la somma assoluta dei pieni possibili” può stabilire quale sia la
distanza tra l’espressione conoscitiva in questione e l’espressione puramente signitiva
corrispondente60.
La somma assoluta definisce così la relazione tra il vissuto dell’intuizione definitivamente e
ultimativamente riempita (intero) e i vissuti delle intuizioni parzialmente e provvisoriamente
riempite; essa si trova connessa all’intero assoluto del vissuto dell’intuizione definitivamente e
ultimativamente riempita e all’insieme assoluto del vissuto dell’intuizione definitivamente e
ultimativamente riempita in specie.
10. Quarto caso teorico: lo switch tra provabilismo ed empirismo riflessivo
Finora ho esaminato per lo più casi di riempimento (non-)perfetto. L’adeguamento completo pare
essere limitato alla sola eventualità di trarre da un giudizio categorico la rappresentazione del suo
soggetto, la forma categoriale che ha concesso a un oggetto di divenire soggetto di quel giudizio,
58
Husserl (2005b), p. 418.
Si potrebbe cioè pensare a una sommatoria di moduli-pieni del tipo (|x|+|y|+|z|…+|n|), a cui potrebbero
corrispondere le specifiche funzioni presentative come dei moltiplicatori, tali che alla presentazione percettiva sia
abbinato (∙n), ove n≤1, a quella immaginativa (∙n), ove n<1, e a quella simbolica (∙n), ove n = 0. Così se le funzioni
presentative di tutti i pieni fossero percettive, allora la somma dei valori assoluti dei contenuti rappresentanti
coinciderebbe con quella dei contenuti rappresentati, poiché, come è ovvio, se |x|∙ 1 = x, e |y|∙ 1= y, e |z|∙ 1 = z, e così via
fino a|n|∙ 1 = n, allora (|x|+|y|+|z|…+|n|) = (x+y+z…+n). A sostegno di quest’ipotesi, viene in soccorso proprio una nota
di uno dei manoscritti husserliani, sopracitati, ove si legge: «|a|=|1|∙ a. […] Si definisce |1|∙ a = a ∙ |1|, cioè non rileva
l’ordine della scrittura. Perciò in generale: |a|∙ b = b ∙ |a|, |1|∙ (a∙b) = |1|∙ (b∙a)» (Hua, XXI, 126). (Nel trascrivere il brano
ho uniformato la notazione che Husserl adopera per il valore assoluto, ovvero ā, a quella posta in uso da Weierstrass,
solo pochi anni prima e poi divenuta consueta).
60
Inoltre, il corretto intendimento della locuzione “somma assoluta” serve anche a evitare l’appiattimento del suo
significato su quello di un’espressione machiana che Boltzmann critica come esempio di “cattiva” fenomenologia. In
Mach (1896), p. 434, si legge: «questo qualcosa (sc.: l’oggetto fisico soggetto a causalità) con cui abbiamo a che fare
sta proprio nella somma delle esperienze precedenti», e in Mach (1905), p. 113: «“ossido” è un concetto che non è
prodotto da una rappresentazione intuitiva, ma soltanto dalla sua definizione, che contiene una somma di esperienze».
Cfr. Boltzmann (1905), p. 143. In questo modo, mi pare che si guadagni uno spazio per la fenomenologia matematica
sin dalla descrizione dell’atto conoscitivo, cosa che sarà utile anche per l’analisi delle astrazioni miste e, quindi, delle
scienze empiriche come modelli.
59
266
�Prova e Ragione. Struttura e demarcazione dell’epistemologia
della VI Ricerca logica attraverso alcuni casi di studio
ovvero di passare da “S è P” a “(S) in quanto…”, ovvero “(S) che è P è lo stesso S che era p e p 1 e
p2 e…pn” o ancora “(S è P) è…”. In realtà, questo significa, nella grammatica dello stato di cose,
anche designare la possibilità di passare da (O1-O2) a (O1) in quanto…, ovvero (O1)-O2 è lo stesso
O1 che era o21, o22 o23 e… o2n. La sua introduzione inoltre funziona per distinguere il risultato così
raggiunto (che è poi l’oggetto dell’intuizione categoriale), e guadagnato attraverso una riflessione
oggettiva, dalla coscienza della generalità. La differenza riguarda lo statuto del riempimento che fa
da base all’una e all’altra e sarà argomento del tormentoso VII capitolo, poiché è così che si decide
sull’esigenza di una rappresentanza categoriale e cioè sul fatto che mentre per avere la coscienza di
una certa generalità, il rosso, l’esempio del momento di colore di un determinato oggetto non viene
utilizzato per un’individuazione, essendo, come è ovvio, sufficiente un qualche rosso per
discriminare tra rosso e giallo, per avere invece coscienza di una forma categoriale (che è un
oggetto individuale) una tale esemplificazione (che certo può essere guadagnata, senza introdurre
alcuna differenza, sia in una percezione che in un’immaginazione) 61 deve poi essere individuata,
giacché la forma S (è P) o di O1(-O2) occupa la stessa posizione e svolge lo stesso ruolo in ogni
asserto con la medesima struttura sintattica.
Che S, in ogni (S è P), indichi sempre l’oggetto del soggetto (la forma sintattico-categoriale del
sostantivo), che i quantificatori (tutti, uno, ecc.) designino sempre una certa formazione categoriale
del soggetto, che i connettivi segnalino la composizione di un collettivo e le disgiunzioni di un
disgiuntivo, che il numero 2 denoti la forma categoriale di una relazione e non corrisponda a una
relazione reale, che, insomma, l’identità sia oggetto di ogni identificazione, tutto questo può essere
ripetutamente inteso e confermato, fino a cogliere la legge ideale che governa la molteplicità
definita (o chiusa) delle variazioni di ciascuna delle proposizioni; ma ciò non fa nessuna differenza
sulla loro credibilità.
Ciò che però è possibile fare con la forma di S o con quella di O1 è di includerli in ulteriori
connessioni, in sempre nuove conformazioni e complicazioni, divenendo oggetti di ulteriori “atti di
connessione (o sintesi), di relazione o di ideazione”, così che ciò che era valso come forma rispetto
a una materia può esser reso materia di una nuova formazione. «Ad esempio, si possono connettere
collettivamente degli oggetti generali, le collezioni formate in questo modo possono a loro volta
essere connesse con altre della stessa specie o di specie diversa, e cosi in infinitum. La possibilità di
una complicazione indefinita è qui una possibilità evidente e a priori»62.
Quando quest’iterazione viene di fatto messa in opera ci si accorge che la ripetibilità del nesso
grammaticale-espressivo di soggetto e predicato e di quello grammaticale-oggettuale O1-O2 sono
entrambe riducibili alle regole che segue lo schema funzionale forma-materia. È questo schema che
segna il limite del provabilismo: dacché esso non solo si ripete sempre allo stesso modo, ma viene
inteso come identicamente sotteso a ogni complicazione, non ne può derivare più alcun
cambiamento di credibilità. Continua a procedere dossicamente a vuoto: la ripetizione non
convince. Tuttavia, Husserl ritiene di dover prestare a questo schema un’ulteriore giustificazione,
questa volta non più verso l’alto (l’iterabilità), ma verso il basso: forma e materia sarebbero anche
distinte in maniera assoluta. Da un lato, la forma categoriale, dall’altro, la materia o, meglio, la
sostanza sensibile63.
61
Sulla funzione dell’immaginazione e quindi anche della variazione (già accennata anche nella VI Ricerca), si veda
Lohmar, (2002), anche in vista della distinzione tra intuizione categoriale e intuizione eidetica. Mi pare che però questa
distinzione possa svolgersi anche su un altro piano e cioè ponendo mente al fatto che la prima ha minore estensione
della seconda. Vincolo dell’intuizione categoriale è il riempimento di un’espressione – dell’espressione di qualcosa su
qualcos’altro, come bene precisa Sokolowski (1970), pp. 65 ss. –, ovvero l’intendimento della posizione relazionante
che regge uno stato di cose, limitazione che non vale per l’intuizione eidetica che può realizzarsi ogni volta nel
passaggio da fatto a eidos, mediante variazione e riduzione. La rimozione di questo vincolo insieme a un guadagno
(evitare di costringersi a definire il ruolo della rappresentanza categoriale), comporta però anche una perdita, ovvero la
minor cura nella descrizione dell’operazione che fa capo all’intuizione eidetica.
62
Husserl (2005b), p. 483.
63
Husserl (2005b), p. 439.
267
�Felice Masi
Faccio un esempio lungo, ma forse utile. Esprimo la percezione di questo concretum: un singolo
oggetto sensibile, questa mela.
a) Dico che “questa mela è rossa”;
b) Isolo il momento cromatico: dico che “questo è il rosso di questa mela”;
c) Con un’astrazione ideante, intendo “il rosso”;
d) Per saturare l’intenzione ideale del “rosso”, non posso ricorrere ad alcuna percezione
sensibile, perché questa sarebbe singolare mentre l’intenzione significativa è generale;
e) Dall’atto espressivo-percettivo “dico che ‘questa mela è rossa’”, posso retrocedere all’atto
percettivo che è alla sua base e utilizzare la sua medesima materia per una diversa funzione
presentativa: quella dell’esempio, così che a essa corrisponda un nuovo atto espressivo percettivo
“dico che ‘ad esempio, questa mela è rossa’”;
f) Dall’esempio passo all’esemplificato, ovvero la specie rosso, e dall’esemplificato
all’esempio e agli esempi come questo;
g) Quante volte posso compiere questo passaggio, questa transizione dall’esempio
all’esemplificato? L’espressione “dico che ‘ad esempio, questa mela è rossa’” vale come “dico che
‘ad esempio, qualcosa è rosso’”. E, per legge di compatibilità, se qualcosa è rosso ogni qualcosa
può essere rosso;
h) “Ogni qualcosa (che abbia un colore, s’intende) [d’ora innanzi: qc, ovvero qualcosa di
colorato] può fare da esempio al rosso in specie [d’ora innanzi: R s]”: posso cioè, in ogni caso,
ripetere le transizioni Rs→ qc e Rs← qc, così che [Rs→ qc e Rs← qc], ovvero [Rs→ qc + Rs← qc] =
Rs↔qc. Ciascuna transizione (→, ←, ↔) presenta caratteri fenomenologici diversi, ripetibili
indefinitamente. Caratteri che possono indefinitamente coincidere nell’identità di R s.
i) Ergo: l’intuizione dell’oggetto generale rosso [d’ora innanzi: I(Rs)] consiste nell’intuizione
della coincidenza delle transizioni da Rs→ qc + Rs← qc + Rs↔qc, indefinitamente ripetibili. Ovvero:
I(Rs) = Rs→ qc + Rs← qc + Rs↔qc;
j) Rs però è una delle specie cromatiche possibili (o semplicemente: una specie cromatica
possibile)64 per qc.
k) Ciò significa che q c può avere un momento della specie cromatica [d’ora innanzi: mCs] rosso
e blu e nero e giallo, ecc., ovvero qc_mRs, qc_mBs, qc_mNs, qc_mGs, ecc. Per ciò che abbiamo già
detto, per ognuno di questi nessi sensibili, su cui abbia agito un’astrazione ideante e una percezione
singolare esemplificante, è poi sempre possibile attivare le transizioni: (qc→Bs + qc←Bs + qc↔Bs) +
(qc→Ns + qc←Ns + qc↔Ns) + (qc→Gs + qc←Gs + qc↔Gs), ecc.
l) In altri termini: (qc→Cs + qc←Cs + qc↔Cs);
m) Ma non basta, perché, anche solo fermandoci all’esempio di partenza rappresentato da un
qualche oggetto cromatico, questo, per essere tale, deve anche essere esteso e la sua estensione non
può non avere una qualche forma e dimensione. Quindi “qualcosa di esteso e, quindi, colorato”
[qe(c)] è tale che non deve avere solo un momento cromatico, ma anche uno estensivo [mEs], formale
[mFs], dimensionale[mDs], locale [mLs]. E ciascuno di questi momenti in specie consente le
seguenti transizioni (q e(c)→Cs + qe(c)←Cs + qe(c)↔Cs) + (qe(c)→Es + qe(c)←Es + qe(c)↔Es) + (qe(c)→Fs
+ qe(c)←Fs + qe(c)↔Fs) + (qe(c)→Ls + qe(c)←Ls + qe(c)↔Ls).
n) Tutte insieme, estensione in specie, colore in specie, forma in specie, dimensione, in specie,
luogo in specie sono i caratteri di qualcosa di esteso e colorato, ovvero Kqe(c), così che, ancora una
volta, sono possibili le seguenti transizioni: Kqe(c)→ qe(c) + Kqe(c)← qe(c) + Kqe(c)↔ qe(c);
o) Questi caratteri, ciascuno isolatamente, oppure a coppie o tutti insieme, possono mutare e
allora (qc_mRs)t ≠ (qc_mRs)t’, e più generalmente (Kqe(c)_qe(c))t≠ (Kqe(c)_qe(c))t’.
64
Utilizzo qui non più un’espressione generale, ma una singolare indeterminata. Una specie, un oggetto generale,
infatti, se espresso a partire da un qualche oggetto singolare, avendo cioè questo come elemento di riferimento, assume
la forma di un singolare indeterminato (“qualcosa di rosso ha un rosso”, “qualcosa di colorato ha un colore”).
Viceversa, un qualche oggetto singolare, se espresso a partire da un oggetto generale, assume anch’esso la forma di un
singolare indeterminato (“il rosso è ad esempio il rosso di un oggetto rosso”, “il colore è il colore di un oggetto
colorato”).
268
�Prova e Ragione. Struttura e demarcazione dell’epistemologia
della VI Ricerca logica attraverso alcuni casi di studio
p) Converrebbe allora scrivere la formulazione sub n) in questo modo (Kqe(c)→ qe(c) + Kqe(c)←
qe(c) + Kqe(c)↔ qe(c))t…tn;
q) Quindi, ∀ (q) (q↔Kq), quindi per ogni qualcosa, questo qualcosa ha un carattere, e ammette
le transizioni elencate. Ho ottenuto così l’intuizione categoriale del rapporto tra materia e forma,
che può essere declinato in quello di soggetto e predicato o in quello tra due oggetti formati ed è
ritrovabile in ogni specie categoriale (collettivi, disgiuntivi, forme sintattiche). Ma tutto questo non
ha conquistato alcuna nuova credibilità. Sempre che non si torni al (q) e lo s’intenda come sostanza
sensibile, obbligandosi a confermare quest’intenzione e ridiscendendo quindi alla teoria della prova.
Ciò che con questo esempio volevo fosse messo in chiaro era non solo il significato delle leggi
aprioriche di connessione, relazione e ideazione su oggetti categoriali, ma anche creare le
condizioni per comprendere cosa serve a queste leggi della complicazione indefinita perché godano
di una “possibilità evidente e a priori”.
Questa possibilità è irrinunciabile per il concettualismo ideale-operativo di Husserl: non solo le
operazioni devono seguire una legge ideale, ma anche la legge ideale deve poter esser colta da
operazioni, che sono operazioni di esplicitazione e di conferma (perché ammettono la possibilità di
un’intuizione), quindi di fondazione (per quello che qui significa e di cui all’inizio ho ripetuto la
definizione) e di giustificazione 65 . Ma questa giustificazione non aumenta la credenza in questa
legge ideale, né conferisce alcun titolo o diritto ad adoperarla 66.
11. Quinto caso teorico: Astrazioni miste e modelli
Potremmo però non avere la fortuna di maneggiare delle formazioni categoriali pure, potremmo
trovarci a pensare non al numero, ma all’assioma delle parallele, o al colore rosso o alla virtù – e
casi come questi sono i più frequenti nella pratica conoscitiva –; allora le riflessioni che possiamo
compiere su questi oggetti, e le prove che possiamo trovare, non solo non aumentano la loro
credibilità, ma non riescono a giungere, se non indirettamente, neanche alla comprensione evidente
della loro legalità67.
L’esempio che mi sembra più opportuno riprendere è quello dell’assioma delle parallele (benché
mi faccia più gola quello sulla virtù!). Perché l’assioma delle parallele, così come la sua refutazione,
è un’astrazione mista, non puramente categoriale? Esso vale come assioma in una morfologia dei
giudizi, quella della geometria euclidea, nella quale “parallela” e “convergente” sono significati non
unificabili; al contrario, in base alla morfologia delle geometrie non-euclidee quei significati sono
unificabili. La seconda è ovviamente più ampia della prima, ma nessuna delle due è però una
morfologia pura, giacché non comprende ogni varietà di significati realmente possibili, ma solo la
varietà dei significati spaziali. E quella spaziale è – giusti Grassmann e Riemann – una varietà
specifica. Ora, l’impurità di queste morfologie, ovvero l’impurità della messa in forma categoriale
delle relazioni che vigono nelle diverse varietà e le definiscono, non è dovuta a un qualche residuo
di sensibilità o alla loro convenzionalità arbitraria68, ma al riferimento segnico che esse fanno a ciò
che distingue una specifica varietà, ovvero al modo in cui può trasformarsi un certo gruppo di
oggetti, o un genere contenutistico, e non un altro. In questo modo, una varietà specifica diviene un
modello.
Se fosse possibile rifondere la logica della scienza formulata da Heirich Hertz – ovviamente
accantonandone l’interpretazione pittorialista invalsa nel Novecento69 – nella prima epistemologia
fenomenologica si potrebbe dire che qualsiasi scienza non pura è una varietà che si definisce come
65
Cfr. Husserl (2005b), pp. 484-485. Questo concettualismo ideale-specifico ed operativo potrebbe ben rispondere
alle critiche sollevate da Stegmüller (1969), in part. pp. 68 ss., pp. 94 ss., e al contempo riuscirebbe a essere una valida
alternativa sia al suo concettualismo costruttivo (Stegmüller (1977), pp. 44 ss.) sia al Locke platonizzante di Sellars
(1989), p. 202.
66
Cfr. Husserl (2005b), pp. 500-501. Su diritto e titolo all’uso delle leggi logiche, si veda almeno Wright (2004).
67
Husserl (2005b), pp. 485-486.
68
Hua, XXI, p. 399.
69
Cfr. Majer (1998), pp. 225-227.
269
�Felice Masi
modello. Un modello non rispecchia la gamma di oggetti che rappresenta, giacché questa è
sottodeterminata, ovvero ammette d’essere rappresentata in più modelli; ma esso deve essere una
rappresentazione congruente di quella gamma di oggetti, deve, cioè, far sì che le conseguenze
necessarie dei suoi simboli «raffigurino le necessarie conseguenze naturali degli oggetti naturali» 70.
È possibile intendere, non già i simboli, ma il rapporto di rappresentazione congruente che essi
intrattengono con gli oggetti, come una forma categoriale impura? Essa sarebbe la correlazione
formale tra una necessità logica e una non-logica. Nei termini di Hertz questa funzionalità potrebbe
essere intesa come funzionalità. L’adozione di un modello, infatti, si decide in virtù:
a) della sua funzionalità, ovvero dal rapporto tra estensione e pienezza, che caratterizza le
denominazioni, le definizioni e le abbreviazioni;
b) della sua correttezza, ovvero dalla conferma dei dati empirici “che sono serviti per la sua
stessa costruzione”;
c) della sua ammissibilità, ovvero dalla sua coerenza logica.
Stante l’ammissibilità, mi pare chiaro che la correttezza dipenda dalla funzionalità; ma questa
non può essere decisa in maniera univoca, poiché un modello «può offrire alcuni vantaggi, un altro
può offrirne altri, e solo attraverso un graduale esame di molti di essi si giunge col tempo a
sceglierne il più funzionale»71. Pertanto la successione delle immagini fisiche del mondo, da quella
della meccanica classica formata da spazio, tempo, forza e massa, a quella energetista, composta da
spazio, tempo, massa ed energia, fino a quella, proposta dallo stesso Hertz, formulata sulla base dai
soli tre principi basilari indipendenti di tempo, spazio e massa, può essere giustificata in ragione di
una maggiore ammissibilità logica, ma non può esserlo quanto alla funzionalità, poiché non
possiamo stabilire una volta per tutte «se il modello tracciato sia più funzionale di un altro; se sia in
grado di comprendere tutte le esperienze future, o abbracciare anche solo quelle presenti» 72. La
conclusione che Hertz ne trae è, a suo modo, deflazionista: dire che un modello è più funzionale di
un altro non solo è impossibile, ma, a conti fatti, anche inutile. «Tutto ciò conta secondo me quasi
nulla rispetto al fatto che tale modello sia chiuso in sé, puro e libero da contraddizioni» 73 . Ma
questo varrebbe per una scienza che fosse una varietà completamente e puramente definita, non per
una che è definita in maniera impura e come modello.
Quella di un’interpretazione fenomenologica dell’epistemologia hertziana è solo un’ipotesi, che
andrebbe esaminata con ben più cura, in particolare rispetto a
a) la definizione del modello come rappresentazione per congruenza;
b) i criteri di decidibilità di un modello;
c) lo statuto segnico della funzionalità di un modello.
Mi pare però che quest’accenno dia maggior peso all’analisi delle forme categoriali impure. In
casi come questi, ciò che davvero diviene evidente in maniera diretta, e forse non è poco, è che «il
campo del significato è più ampio di quello dell’intuizione» 74 e questo non vuol dire solo che anche
l’espressione “montagna senza valle” ha un significato, certo impossibile a intuirsi però, ma che
“f=ma” ha un significato misto, intuitivo (per le sue componenti puramente formali, come
l’uguaglianza) e simbolico (per le sue componenti non puramente formali, come f, m e a). Questo
vuol dire che non è possibile un linguaggio logicamente adeguato per la conoscenza. E così del
resto recita una delle formulazioni possibili – la più ristretta, a dire il vero – dell’empirismo
riflessivo.
70
Hertz (1895), p. 5.
Hertz (1895), p. 6.
72
Hertz (1895), p. 32.
73
Hertz (1895), p. 32.
74
Husserl (2005b), p. 493.
71
270
�Prova e Ragione. Struttura e demarcazione dell’epistemologia
della VI Ricerca logica attraverso alcuni casi di studio
12. Due forme di empirismo riflessivo
All’empirismo riflessivo è stato fatto appello dentro e fuori la “letteratura fenomenologica” 75. Con
empirismo riflessivo intendo, nella sua versione ristretta, il trattamento fenomenologico del concetto
(che sia specie, forma categoriale pura o impura), e, nella sua versione più ampia, l’intera prima
epistemologia fenomenologica; nella prima accezione, l’empirismo riflessivo integra la teoria del
riempimento come provabilismo, nella seconda, l’empirismo riflessivo comprende la teoria della
prova, in quanto sua parte costitutiva.
All’empirismo riflessivo, nella intera sua estensione, concorrono:
a) un concettualismo ideal-specifico, operativo, simbolico e quindi esemplificabile ovvero
impropriamente provabile;
b) la definizione fenomenologica – fansiologica e semantica – di espressione percettiva; e da
ciò
b.1) la peculiare ricorsività tra espressione e percezione, tra significato e intuizione;
c) il provabilismo, quale correlazione tra operazioni (o vissuti) di prova e credibilità di
un’espressione;
d) la rigorosa definizione di “riflessione” non come genere di esperienza, ma come sua
specifica modalità caratterizzata da non-indipendenza e iterabilità.
L’empirismo riflessivo, nella sua versione ristretta, corrisponde all’analisi delle operazioni di
prova che possono essere condotte sui concetti (in quanto significati in specie, unificazioni in specie
di significati, forme sintattico-categoriali di significati complessi), e sia sui concetti primitivi che su
quelli non primitivi. In questo senso, l’empirismo riflessivo prende in carico due infinità: quella
dell’iterazione nella formazione di oggetti categoriali e quella dell’irriducibilità tra linguaggio e
intuizione. Anche, o soprattutto, in questo caso continua a valere l’ideale della conferma, o della
refutazione ultima. Non sorprenda l’accostamento tra ultimatività e infinità.
L’ideale della conferma, o della refutazione ultima, è la regola finita dell’evidenza, della
conferma come se stesso (Selbstbestätigung), del vissuto in cui «l’oggetto non è meramente inteso,
ma è dato in senso rigoroso e posto in unità con l’intenzione»76.
L’evidenza però non è solo regola finita dei suoi gradi o livelli, ovvero dei gradi o livelli di
credenza che le corrispondono, ma anche delle concatenazioni possibili di intenzioni e intuizioni
che giungono fino all’afferramento intuitivo dello stesso77. Ma queste concatenazioni non possono
non essere altrettante identificazioni e, pertanto, non possono non essere infinitarie. Di queste
identificazioni infinitarie è anzitutto regola finita l’evidenza. Così, almeno, nella prima versione del
VI Ricerca, non ne è la norma, il principio di diritto. Tra regola e norma cambia il significato del
principio di decisione che si può mettere in pratica quando siamo alle prese con un’evidenza non
adeguata: nel primo caso si decide di un’inclusione (questo vissuto è incluso nella classe delle
conferme: esso consente di presentare l’oggetto come lo stesso, ma non adeguatamente, restando
esposta al pericolo della refutazione, più che all’eventualità della determinazione ulteriore), nel
secondo di un diritto (c’è ragione che questo vissuto abbia meno diritto di un altro a presentare
l’oggetto come lo stesso). In entrambi i casi, possiamo conservare quanto detto alla fine del § 38 sin
dalla prima edizione; ovvero che: correlato oggettivo dell’evidenza è «l’essere nel senso della
verità»78. Ciò che mi sembra cambiare invece è il rapporto tra conferma e verità. Così che nel primo
caso la conferma non funziona come una verifica, nel secondo, invece, sì, almeno fino a che non sia
stata del tutto definita la noetica.
75
Cfr. Zolo (1989), p. 179; Føllesdal (1991), pp. 32-33.
Husserl (2005b), p. 422.
77
Hua, XX/1, p. 247.
78
Husserl (2005b), p. 422.
76
271
�Felice Masi
13. Oltre il confine nord della prima epistemologia fenomenologica
L’ultima ora del “lavoro sporco” condotto nella VI Ricerca è battuta proprio dalla riscrittura, nel
1913, del § 39, ove non a caso ricorre il rarissimo wahrmachend. Messe in fila conoscenza,
fondazione delle tesi giudicative e motivazione originaria, la domanda che ora pone Husserl è
«prima dell’espressione, la tesi, “fornita” dalle fonti dell’intuizione, non è “motivata”, e già nel
modo più pieno?»79. Ciò di cui si va in cerca è “l’incancellabile diritto della motivazione” ossia che
«la posizione di [una] materia ovvero la proposizione è fondata, è legittimamente motivata, ricava il
suo diritto, è fondata dalla “pienezza” della verità, essa ha in se stessa e direttamente ciò che la
rende vera [wahrmachend]»80.
Lo scivolamento dalla coscienza d’identità – che in quanto esplicita, ancora nel 1906-07, si
distingueva dall’implicita coscienza costante d’unità – alla coscienza della ragione, la quale può
trarre giustificazioni dalle motivazioni più originarie e quindi dai legami che queste intessono e
preservano, risolvendo in ultima istanza così la noetica normativa in una teoria della costituzione,
dipende dalla risoluzione di uno dei principali problemi, che Husserl già nel 1901 riconosceva nella
VI Ricerca: aver lasciato in sospeso «il campo estremamente fecondo del conoscere e del pensiero
mediato»81, quelli in cui l’evidenza rimane imperfetta (quelli in fondo della maggioranza dei cinque
casi di studio).
I passi di allontanamento dall’epistemologia descrittivo-specifica della prima edizione della VI
Ricerca potrebbero essere ritrovati, seppur in maniera sin troppo schematica,
a) nel ricorso al termine Verifikation, che si registra nei corsi del 1902-03 su logica e teoria
della conoscenza, e molto più marginalmente in quello del 1906-07, mentre è pressoché assente nei
testi editi e inediti di Husserl82;
b) nella definizione (tra il 1902 e il 1906) di una teoria della probabilità, in quanto “principio
della conoscenza empirica”, che, nonostante le molte incertezze, offre un chiaro esempio di
normativizzazione della morfologia dei giudizi, ovvero di noetica83;
a) nella proposizione (in due testi del 1913) di una dimostrazione della presentabilità, che dia
«la ragione di diritto per dire “la cosa è reale” (e senza questa ragione di diritto nessuna cosa è una
cosa reale)»84.
14. Risposte
Stanti le varietà di verificazionismo che abbiamo elencato all’inizio, allora da 1)-3), l’epistemologia
fenomenologica, nel suo complesso, si distingue perché:
a) sostiene un idealismo semantico, diverso però da quello che Searle le rimprovera 85 ,
consistendo piuttosto
a.1) nell’attestazione che i significati (ovvero le specie) sono ideali, e che
a.2) ai significati non è, per definizione, necessario alcun riempimento (positivo o negativo),
a.3) mentre la distinzione reale-immaginario vale solo per i significati complessi, ovvero per la
morfologia dei giudizi;
b) ammette come contributore al riempimento dell’intenzione anche un’intuizione non
sensibile.
Inoltre, e ciò vale in particolare per la prima epistemologia fenomenologica,
c) a essere sottoposto alla prova del riempimento non è l’enunciato, ma l’intenzione come
vissuto espressivo, così che:
79
Hua, XX/2, 391.
Hua, XX/2, 391.
81
Husserl (2005b), p. 304.
82
Gli altri luoghi in cui Verifikation compare, con ruolo non certo centrale, sono Hua, XV, p. 48, Hua, XXVI, p.
252, Hua, XXXVI, p. 39, e, infine, Hua, XVI, p. 205.
83
Hua, Mat. II, pp. 264 ss.; Hua, Mat., III, pp. 208, 213-214, 218; Hua, XXVI, pp. 11, 155, 211, 347, 352, 446.
84
Hua, XX/1, p. 268. Cfr. Hua, XXXVI, pp. 73-80. Cfr. Melle (2010).
85
Searle (2008), p. 107.
80
272
�Prova e Ragione. Struttura e demarcazione dell’epistemologia
della VI Ricerca logica attraverso alcuni casi di studio
c.1) all’intenzione può (o non può) corrispondere un’intuizione,
c.2) la quale però non coincide con il suo riempimento, essendo quest’ultimo un terzo vissuto;
d) vige un rapporto di non coincidenza e di riflessività tra intenzione, intuizione e riempimento,
tale per cui il riempimento di un’intenzione esige l’esplicitazione di ciò che ancora era implicito
nell’espressione, determinando un ulteriore corso al riempimento;
e) non include una logica normativa della conoscenza, ma
e.1) un concetto logico di conoscenza e un concetto logico, e non epistemico, di verità,
scongiurando così che la provabilità degeneri in verosimiglianza o probabilità;
e.2) una definizione di essenza conoscitiva come ciò che è essenziale a un vissuto perché possa
dirsi epistemico,
ove però e.1) ed e.2) non coincidono, ma sono reciproche.
Meno semplice appare invece trovare le differenze con 4); tuttavia, come per 1-3), anche 4) è
retta da capo a piedi da un intento normativo e costruisce la teoria della prova che ne deriva
esclusivamente nel quadro della teoria del significato, la quale non sarebbe altro se non «una
descrizione del modo in cui il linguaggio funziona, ossia di tutto quel che un bambino impara
durante il processo di acquisizione di una lingua»86. Al di là del fatto che potrebbero esservi fondati
disaccordi su come “un bambino impari una prima lingua” (laddove si possa dire che la impari!), la
teoria della prova, contenuta in 4), riguarda innanzitutto la giustificazione delle leggi logiche e,
considerate le operazioni di supplementazione che ne costituiscono il suo terzo livello 87, resterebbe
comunque distinta dall’empirismo riflessivo ristretto che integra la husserliana teoria della prova.
Bibliografia
Husserl, E. Gesammelte Werke.
Hua, XV (1973), Zur Phänomenologie der Intersubjektivität, hrsg. von I. Kern, M. Nijhoff, Den
Haag.
Hua, XVI (1973), Ding und Raum. Vorlesungen (1907), hrsg. von U. Claesges, M. Nijhoff, Den
Haag.
Hua, XIX/1 (1984), Logische Untersuchungen. Zweiter Band. Erster Teil, hrsg. von U. Panzer,
Springer, Dordrecht.
Hua, XX/1 (2002), Logische Untersuchungen. Ergänzungsband. Erster Teil, hrsg. von U. Melle,
Kluwer, Dordrecht.
Hua, XX/2 (2005), Logische Untersuchungen. Ergänzungsband. Zweiter Teil, hrsg. U. Melle,
Springer, Dordrecht.
Hua, XXI (1983), Studien Zur Arithmetik und Geometrie (1886-1901), hrsg. von I. Strohmeyer,
Martinus Nijhoff, Den Haag.
Hua, XXIV (1984), Einleitung in die Logik und Erkenntnistheorie (1906-1907), hrsg. von U.
Melle, Martinus Nijhoff, Dordrecht.
Hua, XXVI (1987), Vorlesungen über Bedeutungslehre (SS 1908), hrsg. von U. Panzer, M.
Nijhoff, Dordrecht.
Hua, XXXVI (2003), Transzendentaler Idealismus. Texte aus dem Nachlass, hrsg. von R.
Rollinger-R. Sowa, Springer, Dordrecht.
Hua, Dok., III/5 (1994), Briefwechsel, hrsg. von E. und K. Schuhmann, Springer, Dordrecht.
Hua, Mat., II (2001), Logik (1902-1903), hrsg. von E. Schuhmann, Springer, Dordrecht.
Hua, Mat., III (2001), Erkenntnistheorie (1902-1903), hrsg. von E. Schuhmann, Springer,
Dordrecht.
Husserl, E. (2005a), Ricerche logiche (1900-1901, 1913), vol. 1, trad. it. a cura di G. Piana, Il
Saggiatore, Milano 19681.
86
87
Dummett (1991), p. 29.
Dummett (1991), pp. 341 ss.
273
�Felice Masi
Husserl, E. (2005b), Ricerche logiche (1901, 1921), vol. 2, trad. it. a cura di G. Piana, Il Saggiatore,
Milano 19681.
Husserl, E. (2006), Per la fenomenologia della coscienza interna del tempo (1928), trad. it. a cura di
A. Marini, Franco Angeli, Milano 19811.
Benoist, J. (2013), Le bruit du sensible, Cerf, Paris.
Becker, O. (1998), Della caducità del bello o della natura avventurosa dell’artista (1928), trad. it. a
cura di V. Pinto, Guida, Napoli.
Bernet, R. (1981), “Logik und Phänomenologie in Husserls Lehre von der Wahrheit”, in Tijdschrift
voor Filosofie, vol. 43, n. 1, pp. 18-41.
Boltzmann, L. (19051, 19792), Populäre Schriften, hrsg. von E. Broda, Vieweg,
Braunschweig/Wiesbaden.
Bolzano, B. (1837), Wissenschaftslehre, II, Seidelsche Buchhandlung, Sulzbach.
Carnap, R. (1971), Controllabilità e significato, in Id., Analiticità, significato e induzione (19361937), trad. it. a cura di A. Meotti e M. Mondadori, Il Mulino, Bologna, pp. 151-261.
Chisholm, R. (1968), Teoria della conoscenza (1966), trad. it. a cura di A. Santucci, Il Mulino,
Bologna.
Dummett, M. (1996), La base logica della metafisica (1991), trad. it. a cura di E. Picardi, Il Mulino,
Bologna.
Engel, P. (2006), Truth, McGill-Queen’s University Press, Montreal.
Føllesdal, D. (1991), The Justification of Logic and Mathematics in Husserl’s Phenomenology, in
Phenomenology and formal Sciences, T. Seebohm, D. Føllesdal, J. N. Mohanty (Eds.), Springer,
Dordrecht, pp. 25-34.
Hempel, C. G. (1950), “Problems and Changes in the Empiricist Criterion of Meaning”, Revue
internationale de philosophie, vol. 41, pp. 41-63.
Hertz, H. (2010), I principi della meccanica delineati in una nuova forma (1895), ed it. a cura di A.
Zampini, Bibliopolis, Napoli.
Hobbes, Th. (1972), L’Uomo (1658), in Id., Elementi di filosofia, trad. it. a cura di A. Negri, UTET,
Torino.
Kripke, S. (2000), Wittegenstein su regole e linguaggio privato, trad. it. a cura di M. Santambrogio,
Bollati Boringhieri, Torino 19841.
Lohmar, D. (2002), Husserl’s Concept of Categorial Intuition, in One Hundred of Phenomenology.
Husserl’s Logical Investigations Revisited, D. Zahavi, F. Stjernfelt (Eds.), Springer, Dordrecht,
pp. 125-145.
Mach, E. (1896), Die Principien der Wärmenlehre historisch-kritisch entwickelt, Barth, Leipzig.
Mach, E. (1982), Conoscenza ed errore. Abbozzi per una psicologia della ricerca (1905), trad. it. a
cura di S. Barbera, con un’introduzione di A. Gargani, Einaudi, Torino.
Majer, U. (1998), “Heinrich Hertz’s Picture-Conception of Theories: Its Elaboration, by Hilbert,
Weyl, and Ramsey”, in Heinrich Hertz: Classical Physicist, Modern Philosopher, D. Baird,
R.I.G. Huges, A. Nordmann (Eds.), Springer, Dordrecht, pp. 225-242.
Meinong, A. (1993), Empirismo e nominalismo. Studi su Hume (1877-1882), a cura di R. Brigati,
Ponte alle Grazie, Firenze.
Melandri, E. (1990), Introduzione alle Ricerche logiche di Husserl. Introduzione e commento alla
Prima Ricerca, Il Mulino, Bologna.
Melle, U. (2010), “Husserls Beweis für transzendentalen Idealismus”, in Philosophy,
Phenomenology, Sciences, C. Ierna, H. Jacobs, F. Mattens (Eds.), Springer, Dordrecht, pp. 93107.
Mulligan, K. (2006), Wahrheit und Wahrmacher-Prinzip im Jahre 1921, in Untersuchungen zur
Ontologie, G. Imaguire, C. Schneider (hrsg.), Philosophia, München, pp. 55-77.
274
�Prova e Ragione. Struttura e demarcazione dell’epistemologia
della VI Ricerca logica attraverso alcuni casi di studio
Mulligan, K., Simons, P., Smith, B. (1987), Wahrmacher, in Der Wahrheitsbegriff: Neue
Explikationsversuche, L. B. Puntel (hrsg.), Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, pp.
210-255.
Patzig, G. (1977), Husserl on Truth and Evidence, in Readings on Husserl’s Logical Investigations,
J. N. Mohanty (Ed.), M. Nijhoff, Den Haag, pp. 179-197.
Peirce, C. S. (2005), La logica dell’abduzione nelle Harvard Lectures on Pragmatism del 1903, in
Id., Scritti scelti, trad. it. a cura di G. Maddalena, UTET, Torino, pp. 425-587.
Pfänder, A. (1921), “Logik”, Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung, vol. 4,
pp. 139-494.
Putnam, H. (1975), “The Meaning of ‘Meaning’”, in Minnesota Studies in Philosophy of Sciences,
vol. 7 (Language, Mind and Knowledge, ed. by K. Gunderson), pp. 131-193.
Schlick, M. (1978), Significato e verificazione (1936), in La struttura logica del linguaggio, trad. it.
a cura di A. Bonomi, Bompiani, Milano, pp. 71-101.
Searle, J. R., (2008), Philosophy in a new Century, Cambridge University Press, Cambridge.
Sellars, W. (1989), The Metaphysics of Epistemology, ed. by P. V. Amaral, Ridgeview, Atascadero
(California).
Sinigaglia, C. (1998), “Zeichen und Bedeutung. Zu einer Umarbeitung der Sechsten Logischen
Untersuchung”, in Husserl Studies, vol. 14, pp. 179-217.
Smith, A. D. (2003), Husserl and the Cartesian Meditations, Routledge, London-New York.
Smith, D.-W., McIntyre, R. (1982), Husserl and Intentionality. A Study of Mind, Meaning and
Language, Reidel, Dordrecht-Boston-Lancaster.
Sokolowski, R. (1970), The Formation of Husserl’s Concept of Constitution, M. Nijhoff, Den Haag.
Sokolowski, R. (2000), Introduction to Phenomenology, Cambridge University Press, Cambridge.
Stegmüller, W. (1969), Main Currents in German, British and American Philosophy, Reidel,
Dordrecht.
Stegmüller, W. (1977), The Problem of Universals Then and Now, in Id., Collected Papers, I,
Reidel, Dordrecht, pp. 1-65.
Tugendhadt, E. (1970), Der Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heidegger, De Gruyter, Berlin.
Wittgenstein, L. (1998), Osservazioni filosofiche, trad. it. a cura di M. Rosso, Einaudi, Torino.
Wright, C. (2000), “Cogency and Question-Begging: Some Reflections on McKinsey’s Paradox
and Putnam’s Proof”, in Philosophical Issues, vol. 10, pp. 140-163.
Wright, C. (2004), “Intuition, Entitlement and the Epistemology of Logical Laws”, Dialectica, vol.
58, n. 1, pp. 155-175.
Zolo, D. (1989), Reflexive Epistemology. The philosophical Legacy of O. Neurath, Kluwer,
Dordrecht.
Abstract
Can we say that the epistemology of the first phenomenology is a form of verificationism and that
the VI Logical Investigation has introduced perception in the “space of reasons”? Can we share
what Husserl wrote on the VI Logical Investigation, that is, that it constituted a first step towards a
phenomenological theory of reason? These two questions are mirror-like, even though he first one
concerns the demarcation of phenomenology with respect to the tradition of classical empiricism
and the second with respect to later developments of Husserlian thought, i. e. phenomenological
philosophy or transcendental phenomenology. After a first part dedicated to some operational
definitions, the essay deals with six study-cases, on the basis of which the conclusion is that the VI
Logical Investigation achieves an intersection between theory of provability and reflexive
empiricism.
Keywords: Phenomenology, Epistemology, Verificationism, Provability, Reflexive Empiricism
275
�BRUNO MORONCINI*
Corpo e Spazio: Husserl, Merleau-Ponty, Lacan
1.
Mentre per Freud lo spazio è la proiezione esterna del carattere originariamente esteso della psiche,
della sua suddivisione in parti (sistemi nella prima topica, province nella seconda) esterne l’una
all’altra, e il corpo, stornato, attraverso il lavorio della pulsione, dai bisogni elementari della vita,
funziona solo come una macchina celibe finalizzata al godimento, per Husserl al contrario è
l’estensione ad essere una determinazione secondaria, riferibile infatti alle sole cose materiali, di
una spazialità originaria che, estendendosi anche alle cose animate in generale, quelle dotate cioè di
un corpo vivo [Leib], rende conto della possibilità che la psiche, cioè l’inesteso in quanto tale, abiti
un corpo senza che questo la riduca a qualcosa di frammentabile e suddivisibile 1.
Le stesse espressioni usate da Husserl in queste prime pagine di Ideen II dedicate alla
costituzione della natura materiale sono inequivocabili: dal momento che tutto il problema consiste
nel chiarire «come le determinatezze psichiche che spettano alla realtà animale ottengano una
necessaria determinatezza spaziale in un modo completamente diverso (dalle cose meramente
inanimate), attraverso il fondarsi dello psichico nel materiale», non si potrà parlare dell’estensione
come di qualcosa di separato dalla spazialità, ma bisognerà riferirsi in primo luogo ad una
«estensione spaziale o meglio corporea di una cosa» e in seguito intendere con queste formule «la
corporeità spaziale che inerisce alla sua (della cosa) concreta compagine essenziale, esattamente nel
modo in cui le inerisce, nella sua piena determinatezza»2.
Da questo punto di vista Cartesio ha ragione solo in parte: se è vero infatti che l’estensione «è un
attributo essenziale della cosa materiale, che, proprio per questo, si dice anche semplicemente
corporea, in contrapposizione all’essere psichico o spirituale che, nella sua spiritualità come tale,
non ha un’extensio, e anzi la esclude per essenza», ciò tuttavia, precisa Husserl, vale solo per la
natura intesa «nel primo senso (quello materiale) rispetto alla natura nel secondo senso (l’animale)»,
senza contare il fatto, di per sé risolutivo di tutta la questione, che «l’attributo essenziale e più
comprensivo dell’essere materiale non è la mera estensione bensì la materialità, la quale, in se
stessa, richiede sia un’estensione spaziale sia un’estensione temporale» 3.
In realtà non si dà una percezione dell’estensione in quanto tale: le cose si danno originariamente
nella loro determinatezza spaziale e temporale e solo in seconda battuta si può isolare l’estensione
come tratto caratteristico delle sole cose materiali. Non solo quindi l’estensione è immediatamente
spaziale e temporale, ma nemmeno è isolabile rispetto alle qualità sensibili che accompagnano la
percezione di una cosa; la distinzione fra qualità primarie e qualità secondarie, oggettive e
soggettive, che risale a Galilei e su cui Cartesio fonda la differenza concettuale fra res extensa e res
cogitans, è smentita dalla legge elementare della percezione secondo la quale solo a forza di
astrazione si possono separare l’estensione ed il colore che al contrario vanno necessariamente
insieme: una porzione di estensione sarà sempre colorata e un colore coprirà sempre una porzione di
estensione.
Con una formula azzardata ma efficace si può dire che «qualsiasi qualità corporea di una cosa
“riempie il corpo spaziale”», che «in essa la cosa si diffonde, riempie la sua corporeità
*
Università di Salerno
1
Sulla tesi freudiana del carattere esteso della psiche mi permetto di rinviare ai miei Moroncini (2006) pp. 561-588
e Moroncini (2017), pp. 299-310.
2
Husserl (2002), p. 34.
3
Ivi, p. 33.
Bollettino Filosofico 33 (2018): 276-289
ISSN 1593 -7178 - 00030
E-ISSN 2035 -2670
DOI 10.6093/1593-7178/5923
�Corpo e Spazio: Husserl, Merleau-Ponty, Lacan
(estensione)». Se il corpo è esteso ciò non vuol dire che esso sia come un punto nello spazio vuoto
di cui si può calcolare la posizione esatta che vi occupa in base agli assi delle ascisse e delle
ordinate che formano il piano cartesiano, ma che esso è il risultato dell’estendersi, del diffondersi,
di una qualità sensibile che, riempiendolo, lo fa divenire spazio. Quest’ultimo non è un contenitore
vuoto che di conseguenza si può suddividere, frazionare, a piacere e in cui corpi già costituiti
occupano singole porzioni di estensione; lo spazio fa tutt’uno con l’estensione corporea che a sua
volta è la diffusone, l’espansione di una qualità sensibile primaria o secondaria.
Con espressioni che di primo acchito sembrano smentire quanto va affermando ma che
testimoniano soltanto della difficoltà di restituire attraverso il linguaggio il vissuto fenomenologico,
Husserl dichiara che se non si può considerare «l’estensione come una mera frazione dello spazio,
per quanto in ciascun punto temporale della durata cosale coincida con una frazione del genere» è
perché «per essenza, né lo spazio né un suo frammento può muoversi»; lo spazio «non può mai
presentare una lacuna, cioè un punto vuoto di spazialità, un punto che possa riempirsi soltanto
quando vi si introduca qualche cosa». Lo spazio, da questo punto di vista, è «assolutamente
“rigido”, le sue “parti” non sono “estensioni” nel senso che abbiamo definito, né sono “corpi”, per
esempio corpi rigidi nel senso della fisica»4. Se fosse l’estensione, l’extensio cartesiana, a definire
lo spazio, allora quest’ultimo potrebbe cambiare di posizione nel senso che sue porzioni distaccate
fra di loro e esteriori l’una all’altra si potrebbero muovere a piacimento lungo gli assi, e insieme che
fra una porzione e l’altra ci potrebbero essere punti senza spazio, punti vuoti che diventerebbero
spazio solo se vi si introducesse qualche cosa, ad esempio i corpi solidi di cui parla la fisica. Dire
allora da parte di Husserl che lo spazio è “rigido” non significa non pensarlo più come qualcosa di
qualitativo e di dinamico, il risultato della forza di espansione delle qualità sensibili, un campo di
interconnessioni e di trasformazioni, ma semplicemente che esso non si lascia frazionare, ossia
ridurre a cosa estesa.
Soprattutto lo spazio è localizzazione, si distribuisce in luoghi, centri da cui si origina il
movimento della spaziatura. Questa considerazione è legata a filo doppio con il fatto che fra gli
oggetti naturali un posto preminente è occupato per Husserl dal corpo animato o corpo vivo, quel
corpo che, in particolare nel caso dei soggetti umani, ma il discorso si può estendere a qualunque
cosa animata in generale, si trova legato intimamente ad una psiche. Così, ancora una volta, se è
vero che l’estensione deve essere considerata una «forma essenziale e caratteristica dell’esistenza
dell’essere materiale e fisico», un suo attributo essenziale, ciò vale tuttavia solo per «la cosa
meramente fisica, ma non per la cosa in senso pieno»5. In primo luogo perché la cosa in senso
pieno, come già si è visto, non si definisce soltanto attraverso l’estensione spaziale ma anche
tramite la determinazione temporale. In più il corpo vivo presenta una caratteristica speciale: ciò
che attribuiamo ad esso dobbiamo attribuirlo anche agli uomini, ai soggetti psichici, che abitano
quel corpo. Se è vero che «gli uomini e gli animali hanno una loro posizione nello spazio, si
muovono in esso come se fossero mere cose fisiche», noi possiamo anche spiegare questo strano
fatto affermando che lo «fanno “in virtù” dei loro corpi vivi»6. Ma ciò non significa che a
camminare, passare per la strada, viaggiare in macchina, abitare in campagna o in città, siano solo i
corpi e non gli uomini stessi. In realtà fra ciò che fanno gli uomini e ciò che fanno i corpi vivi non
esiste nessuna differenza, sebbene gli uomini facciano tutto quello che fanno – camminare,
viaggiare in macchina, abitare in campagna o in città – solo in virtù dei loro corpi vivi.
Esistono, insomma, delle «proprietà del corpo vivo, come il peso, la grandezza e simili, che noi
attribuiamo agli uomini, ma con la piena consapevolezza del fatto che essi ineriscono propriamente
soltanto al corpo vivo materiale»7. Così quando mi attribuisco un luogo – sono qui e voglio andare
4
Ivi, pp. 34-35.
Ivi, p. 36.
6
Ibidem. Su questo punto mi permetto di rinviare a Moroncini (2002), pp. 260-276.
7
Ivi, pp. 36-37.
5
277
�Bruno Moroncini
là - «questo luogo è anche il luogo del mio corpo vivo»8, giacché a spostarsi nello spazio, da qui a
là, è il mio corpo vivo e non sono io.
O invece l’essere in un luogo, l’essere localizzato, mi appartiene in un modo più originario e
essenziale? Riprendiamo le mosse dalla considerazione che «gli oggetti della natura, intesa nel
secondo e più ampio senso, presi nella piena concrezione, sono realtà animali, che si caratterizzano
come corpi vivi animati». Questi corpi, a loro volta, «comportano – è questo l’elemento nuovo –
accanto alle determinazioni specificamente materiali, anche altri e nuovi sistemi di proprietà, quelle
psichiche». Tali proprietà appartengono in proprio al «corpo vivo in questione» che, appunto per
questa ragione, si deve definire come «“corpo vivo” per una psiche, oppure per uno spirito»9.
Queste proprietà d’altronde non sono materiali, non hanno cioè estensione, pur riguardando un
oggetto come un corpo vivo che presenta anche un lato materiale e fisico.
La difficoltà è di conseguenza la seguente: da un lato sia gli uomini che gli animali «hanno corpi
vivi materiali e per questo hanno una spazialità e una materialità», dall’altro però essi, in quanto
dotati di proprietà psichiche, «non sono materiali e, per questo anche presi come totalità concrete,
non sono realtà materiali in senso proprio», vale a dire che mentre «le cose materiali sono
frammentabili, parallelamente all’estensione che appartiene alla loro essenza, gli uomini e gli
animali»10 non lo sono affatto. La contraddizione, come si vede, sembra giocarsi nel rapporto fra
l’avere e l’essere: gli uomini e gli animali hanno un corpo vivo e di conseguenza spazialità e
materialità, ma non sono cose materiali. Forse la soluzione (se soluzione c’è) sta nel fatto che un
corpo vivo non lo si ha, ma lo si è, e se lo si è e non lo si possiede come un oggetto materiale, allora
si è anche quella spazialità che gli inerisce per essenza: «gli uomini e gli animali, conclude Husserl,
sono (corsivo mio) localizzati spazialmente» e persino «la loro dimensione psichica, perlomeno in
virtù del suo essenziale fondarsi nella dimensione corporea, si ordina nello spazio»11. Psiche è
corpo, direbbe Nancy12, e di conseguenza si spazializza e localizza, ma non è estesa. Pur di non
attribuire allo psichico l’attributo dell’estensione che per lui coincide con la materialità e la fisicità,
Husserl arriva a sostenere – ed è una prestazione filosofica visionaria e iperbolica – che anche lo
psichico, sebbene in un modo per ora poco chiaro, «possiede qualcosa come una diffusione
[Ausbreitung]», e diffondendosi come una qualsiasi qualità sensibile, riempie un corpo, diviene un
corpo e in tal modo si spazializza e si localizza. Si fa luogo spaziale che estendendosi (ma non nel
senso dell’extensio) genera altro spazio, origina la spazializzazione in generale.
2.
Fra gli effetti più sconvolgenti della prestazione dell’epoché fenomenologica, vale a dire della
messa fra parentesi di ogni riferimento alla realtà degli oggetti della percezione e del pensiero, di
ogni loro assunzione come dei meri “dati di fatto”, per concentrare invece l’attenzione solo sul
contenuto eidetico del vissuto intenzionale, sul lato delle essenze, va sicuramente posta in primo
piano l’impossibilità di distinguere immediatamente, al livello appunto della percezione, il fantasma
di una cosa dalla cosa nella sua materialità. Ci convinciamo con facilità, scrive Husserl, che
l’essenza della cosa materiale in generale implichi «per principio le possibilità del moto e della
quiete, della modificazione qualitativa e dell’immodificazione». Le cose si muovono e/o si fermano,
si trasformano e/o restano quel che sono, e anche nel caso che restassero immote e immodificate
non per questo cesserebbero in linea di principio d’essere mobili e modificabili. Tuttavia, nulla vieta
che ci si formi nell’intuizione l’idea di una cosa «assolutamente immutata», fosse pure nient’altro
che un «caso limite ideale». Ed è a questo punto che, procedendo da questa idea e attenendoci alla
cosa per sé, prescindendo dal suo contesto (l’insieme delle sue determinatezze spaziali e temporali e
quello delle sue proprietà materiali e fisiche), noi ci accorgiamo di non disporre «di nessun mezzo
8
Ivi, p. 37.
Ibidem.
10
Ibidem.
11
Ivi, pp. 37-38.
12
Cfr. Nancy (1995), p. 21.
9
278
�Corpo e Spazio: Husserl, Merleau-Ponty, Lacan
per distinguere l’essenza della cosa dall’essenza di un vuoto fantasma [Phantom]» e che tutto ciò
che della cosa eccede il suo fantasma «non può giungere per noi a vera datità» 13, vale a dire non ci
si mostra in carne ed ossa.
Per ragioni che sono strutturali e che quindi sorpassano di molto specifiche correnti filosofiche e
determinati stili di pensiero, quando in gioco è la comprensione rigorosa dell’attività psichica, e
ancor di più quando la psiche in questione è di per se stessa corpo, estensione spaziale come dice
Husserl, è inevitabile, per illustrarne il funzionamento, il ricorso ad un qualche congegno
meccanico, ad uno strumento all’apparenza ausiliario e neutro, ad un apparecchio, insomma a un
“apparato”. Quello usato da Husserl è lo stereoscopio. Quando usiamo questo strumento che ci
permette di avere una visione tridimensionale, vale a dire spaziale, di immagini che invece sono
disegnate su superfici a due dimensioni, ciò che percepiamo è «un mero fantasma»: noi vediamo un
«corpo spaziale» su cui si possono porre domande ragionevole che riguardano la sua forma e il
colore, il carattere ruvido o liscio della sua superficie, domande alle quale è possibile trovare una
risposta in ciò che si vede; se invece volessimo sapere se quel che vediamo «sia pesante o leggero,
elastico o magnetico», queste domande non avrebbero alcun senso perché non troverebbero alcun
appiglio nei dati della percezione. Manca nel caso della visione stereoscopica «l’intero gruppo delle
determinazioni materiali», ma non perché resterebbero indeterminate o in sospeso come nel caso in
cui non fossimo in grado di sapere se la faccia nascosta dell’oggetto che abbiamo davanti abbia lo
stesso colore di quella che ci si manifesta, bensì perché nel caso in questione «nell’apprensione non
sono rappresentati gruppi essenziali di note caratteristiche, in particolare i gruppi della materialità
specifica». Se è per essenza che i dati della materialità vengano a mancare nella stereoscopia o nella
percezione del fantasma della cosa, lo stesso non si può dire di quelli che attengono alla corporeità
spaziale. Sia ad esempio il caso dell’arcobaleno o quello del cielo azzurro o ancora del sole: anche
qui vediamo dei corpi nello spazio, corpi riempiti, come tutti gli altri, «attraverso il plenum
sensibile che ha un’estensione», e tuttavia corpi che «non equivalgono ancora a una cosa, a una cosa
nel senso usuale, una cosa in quanto materialmente reale». Ne deduciamo un principio generale:
«qualsiasi cosa sensibile esige per la sua datità, quale elemento fondamentale della sua essenza […],
un simile corpo riempito nello spazio». Definiremo questo elemento appena individuato uno
“schema sensoriale” intendendo con esso questa «intelaiatura fondamentale, questa forma corporea
(“spaziale”), col plenum che si estende su di essa».
Sulla base, allora, di questa definizione di schema sensoriale si potrebbe sostenere che quella
cosa, ipotizzata all’inizio di questo ragionamento, che ci «appare immobile e qualitativamente
immutata non ci “mostra” altro che il suo schema, o meglio l’apparenza [Apparenz], mentre tuttavia
viene appresa come materiale». È vero che la cosa, da questo punto di vista, non «si “mostra”, non
si presenta al nostro sguardo, non giunge a una datità originale», e tuttavia in una cosa che «fosse
“propriamente” data non cambierebbe nulla se l’intero strato della materialità venisse cancellato
dall’appercezione». Ciò è dovuto al fatto che mentre «nell’esperienza originale, nella percezione, il
“corpo” è impensabile senza una qualificabilità sensoriale», il fantasma, invece, «è dato
originalmente e quindi è pensabile senza le componenti della materialità». Né le cose
cambierebbero se provassimo a far leva (per riuscire a distinguere fra il fantasma di una cosa e la
cosa stessa) sulle modificazioni di luogo e di qualità quali si danno nella percezione: il fatto di
considerarle come «decorsi continui dello schema sensoriale» non toglie che anche «i fantasmi
possano essere fantasmi che si muovono, che si deformano, che si modificano qualitativamente, nel
colore, nella lucidità, nel suono»14. Vale anche in questo caso la considerazione che la materialità di
una cosa può essere «co-appresa e tuttavia non data».
A partire da qui sembra che nel ragionamento di Husserl si operi una svolta. Da un lato schema
sensoriale e fantasma diventano la stessa cosa: riferendosi al concetto dello schema e al fatto che
13
Ivi, p. 40.
La cosa non cambia se si ha a che fare con lo spettro: «Persino lo spettro (Gespenst) ha necessariamente un corpo
vivo spettrale. Certamente, quest’ultimo non è una cosa reale e materiale, la materialità che si manifesta è un inganno,
ma proprio per questo è un inganno anche la sua psiche e lo spettro nel suo insieme» [Husserl (2002), p. 98].
14
279
�Bruno Moroncini
esso non può più essere limitato alla sola sfera sensoriale, Husserl dopo “schema” scrive fra
parentesi “fantasma”15. Dall’altro il concetto di schema sembra, almeno a prima vista, sdoppiarsi e
accanto al primo, lo schema-fantasma sensoriale (che coincide a questo punto con la sola scopia,
con la visione), Husserl introduce uno schema tattile: «una cosa percepita ha anche un suo schema
tattile, che viene in luce nel suo afferramento tattile». In realtà, come Husserl precisa subito dopo, lo
schema resta uno anche se si distribuisce in «tanti strati quanti sono i generi di dati sensoriali che
noi vi possiamo trovare, e che si diffondono per tutta l’estensione spaziale che appare come
identica, della cosa». C’è un “pieno [voll] schema” che non si può moltiplicare né scomporre. Ciò
che si da è che un unico e medesimo corpo si presenti in un duplice modo, ossia «con una corporeità
vista e palpata»: un corpo è colorato per tutta la sua estensione o in maniera uniforme o con colori
diversi, ma lo è soltanto nella sua «manifestazione ottica». Nello “spazio tattile” invece non c’è
colore: c’è il liscio o l’umido che non possono essere visti ma solo palpati. O al massimo con-visti:
ad esempio le nervature presenti su di una superficie permettono di “vedere” il ruvido. Ciò che
conta è che il corpo resti identico nonostante i differenti approcci sensoriali e soprattutto che una
declinazione dello schema, ad esempio quella tattile, possa presentare qualità della cosa che l’altra
è, per essenza, impossibilitata a dare.
Tuttavia questa ulteriore articolazione dello schema sensoriale non risolve la questione del
fantasma: se il carattere materiale della cosa continua a non essere dato ma solo co-appreso, la
semplice esperienza della cosa, senza alcun riferimento al contesto e alle circostanze, non ci offre
«alcuna possibilità di decidere, attraverso una effettiva esibizione, se la cosa materiale esperita sia
reale oppure se siamo vittime di un mero inganno e se l’esperito sia un mero fantasma». Per riuscire
a distinguerli non resta che prendere la cosa non, come abbiamo fatto finora, «al di fuori del
contesto delle cose», vale a dire isolata, ma nella sua dipendenza dalle “circostanze”, nella sua
relazione ad un contesto.
3.
Lasciamo il fantasma (salvo a ritrovarlo in seguito nell’aspetto di un arto che, pur mancando,
continua a manifestare la sua esistenza a dimostrazione ulteriore che il corpo non sia altro che uno
schema o un’immagine), e passiamo al ruolo che la doppia articolazione, visiva e tattile, della
percezione ha nella questione della costituzione della realtà psichica a partire dall’esperienza del
corpo vivo.
La questione è ancora una volta la seguente: come rendere conto di una cosa materiale, il corpo
vivo e animato, che sia allo stesso tempo, e proprio in nome di queste sue caratteristiche, il luogo
della diffusione della psichicità quasi quest’ultima fosse una qualità sensibile che si localizza?
In quanto cosa materiale e estesa il corpo [Körper] è un oggetto come gli altri – la tastiera di
computer con cui scrivo, il leggio che regge il libro da cui cito –, ma in quanto corpo vivo è il
nostro corpo, anzi siamo noi – se il corpo si alza e incomincia a camminare sono io che mi
sgranchisco un po’. Ma questa distinzione fra Leib e Körper è, per dirla con un gergo hegeliano, per
noi o per sé? Perché se fosse solo per noi la compresenza di corpo e realtà psichica sarebbe, per
usare invece un lessico husserliano, solamente appresa ma mai data. Dire che questa distinzione è
per sé vuol dire che essa si coglie, è data, attraverso il corpo: il corpo è il luogo in cui si dà per il
corpo stesso la differenza fra il corpo come cosa materiale e il corpo come corpo vivo. E ciò è reso
possibile dalla costituzione del corpo come cosa materiale: se infatti il corpo non avesse due braccia
con annesse due mani, se non fosse la localizzazione delle qualità sensibili, se non presentasse più
schemi sensoriali o uno stesso schema fatto di più strati, l’esperienza della differenza non sarebbe
possibile.
Prima di percepire le cose esterne, prima di vederle e coglierne la lucentezza o le parti in
penombra, prima di palparle e saperne il ruvido o il liscio, il pesante o il leggero, il corpo percepisce
se stesso. O per dirlo meglio si percepisce allo stesso tempo come corpo materiale e come corpo
15
«A questo punto dobbiamo espressamente sottolineare che il concetto di schema (di fantasma) non si limita affatto
ad una sfera sensoriale» (Ivi, p. 42).
280
�Corpo e Spazio: Husserl, Merleau-Ponty, Lacan
vivo, e l’una cosa attraverso l’altra. Se l’esperienza cui Husserl fa riferimento è quella ormai
classica delle mani che si toccano, in cui quello che conta è che contemporaneamente si
percepiscano la mano che tocca, ossia il lato soggettivo, del Leib o del percipiens, e la mano che è
toccata, quello oggettivo, del Körper o del perceptum, senza che nulla cambi alternando nei ruoli la
destra e la sinistra, il punto decisivo è che nella mano che è toccata non solo sono percepibili dalla
mano toccante le sensazioni che le ineriscono come cosa materiale – la morbidezza, la lisciezza etc.
– ma anche quelle che, pur localizzandosi in essa, non fanno parte delle sue proprietà obiettive, ma
appartengono invece alla mano toccante. Ciò vale in generale: quando tocco un oggetto diverso da
una parte del mio corpo percepisco insieme alle sue qualità sensibili obiettive anche quelle del mio
corpo vivo.
Il punto fondamentale di tutta questa descrizione husserliana dell’esperienza originaria del mio
corpo vivo è che in essa si costituisce qualcosa come il sé, ossia la realtà psichica. Il sé come senso
di sé, sensus sui, auto-coscienza, si costituisce attraverso l’autoaffezione tattile del corpo vivo, è
l’effetto dell’incontro delle due mani che, essendo entrambe terminali della localizzazione
sensoriale, toccandosi l’un l’altra fondano ed avvertono l’apertura della differenza fra chi sente e
chi è sentito. Il sé in altri termini non preesiste, non funge da apriori, come il cogito cartesiano o l’io
penso kantiano, al dispiegarsi del mondo della rappresentazione, ma è il risultato, a posteriori, o
come un apriori materiale, del ripiegarsi, dell’avvolgersi, del corpo su se stesso, del suo toccar-si.
Nulla di simile, aggiunge Husserl, «nel caso dell’oggetto che si costituisce in modo puramente
visivo»16. L’occhio infatti non si vede vedente come al contrario la mano si tocca toccante: l’occhio
che guarda, insiste Husserl, non si manifesta visivamente, e quindi le qualità sensibili, per esempio i
colori, che nell’apprensione di una cosa esterna si attribuiscono all’oggetto, non si presentano anche
come localizzazioni dell’occhio e sull’occhio. Un occhio non può toccare l’altro e di conseguenza
non può generarsi il fenomeno della duplice sensazione. Resta la possibilità offerta dagli specchi e
dalle superfici riflettenti in generale; Husserl la contempla ma solo per escluderla. Scrive in nota:
«Naturalmente non si dirà: vedo il mio occhio nella specchio; perché io non percepisco il mio
occhio, il qualcosa che vede in quanto tale; io vedo qualche cosa di cui giudico indirettamente,
“attraverso l’entropatia”, qualcosa di identico con la mia cosa occhio (che per esempio si costituisce
attraverso il tatto) così come vedo l’occhio di un altro»17.
Nello specchio non vedo il mio occhio o, per dirlo meglio, il mio occhio non si vede. Posso
toccare il mio occhio ma toccandolo è come se toccassi l’occhio di un altro perché non è il mio
occhio che tocca se stesso ma è toccato da un’altra parte del mio corpo che non è a sua volta
vedente. Mentre le mani si toccano l’un l’altra e assumendo alternativamente il ruolo del toccante e
del toccato restano le mani di uno stesso corpo, sono le due facce dello stesso sé che continua a
essere uno, l’occhio toccato e la mano toccante è come se appartenessero a due corpi distinti o
fossero le partes extra partes di uno stesso corpo. Nello specchio l’occhio che vedo non è più il mio
occhio ma è l’occhio di un altro. Il corpo non è più spazialità ma torna ad essere estensione.
4.
Ritornando una volta ancora (forse l’ultima) in una nota del Visibile e l’invisibile, datata “maggio
1960” e intitolata «Toccare-toccarsi/vedere-vedersi/il corpo, la carne come Sé», sull’esempio
husserliano delle mani che si toccano, Merleau-Ponty sorprendentemente lo decostruisce mettendo
in discussione la sua tesi centrale: nel toccarsi, il toccante e il toccato, in realtà, «non coincidono nel
corpo: il toccante non è mai esattamente il toccato»18. Come aggiunge Daniel Heller-Roazen «anche
ove io ponga una mano sull’altra, la mano che tocca, in altre parole, “non è mai esattamente quella
toccata”»19. Ciò non vuol dire, prosegue Merleau-Ponty, che «essi coincidano “nello spirito” o al
livello della “coscienza”». Ma se bisogna ipotizzare qualcosa di diverso sia dal corpo che dallo
16
Husserl (2002), p. 150.
Ibidem.
18
Merleau-Ponty (1969), p. 287.
19
Heller-Roazen (2013), p. 149. Sulla questione vedi Masullo (2018), p. 24.
17
281
�Bruno Moroncini
spirito, questo terzo o medium non potrà avere nessun tratto positivo, non sarà dotato di caratteri
specifici e determinati. Esso deve, piuttosto, essere qualcosa di negativo, propriamente il lato
negativo del toccante e del toccato, l’incavo in cui chiasticamente essi si rovesciano: nei termini di
Merleau-Ponty «l’invisibile del visibile, la presentazione originaria del non presentabile […],
l’originario dell’altrove, un Sé che è un Altro»20. Detto in altri termini, Il negativo del toccabile è
l’intoccabile.
Questa tesi di Merleau-Ponty azzera di fatto la distanza che in Husserl separava la prestazione
del tatto da quella della visione: come l’occhio non si vede così il corpo non si tocca, come il mio
occhio che vedo allo specchio è l’occhio di un altro, così la mano toccata è la mano di un altro.
Pochi mesi prima nel saggio Il filosofo e la sua ombra Merleau-Ponty aveva già postulato la
mancanza di differenza fra il tatto e la visione facendo notare che come «la mia mano destra
assisteva allo svelamento del tatto attivo nella mia mano sinistra, non diversamente si anima davanti
a me il corpo altrui, quando stringo la mano di un altro uomo o quando soltanto lo guardo»21. Ciò
vuol dire che già al livello dell’esperienza del’autoaffezione tattile si pone la questione
dell’esistenza delle altre realtà psichiche senza che sia necessario ricorrere ai dispositivi della
proiezione e dell’introiezione, ossia alla “entropatia”: se infatti «stringendo la mano dell’altro
uomo, io ho l’evidenza del suo esserci, è perché essa si sostituisce alla mia mano sinistra, perché il
mio corpo si annette il corpo dell’altro in quella “specie di riflessione” di cui è paradossalmente la
sede»22. Un elemento “visionario”, la riflessione, contamina lo schema sensoriale tattile.
L’intoccabile e l’invisibile in Merleau-Ponty si toccano: toccarsi è un modo di vedersi. In
entrambi i casi si ha a che fare con l’altro: la mano che tocca è altra dalla mano toccata e viceversa,
l’occhio che vedo nello specchio è altro da quello che lo guarda. Questo riavvicinamento fra il tatto
e la visione (che non cancella la loro differenza: essi non sono comunque sovrapponibili) è
propedeutico in Merleau-Ponty ad una modifica essenziale nella concezione del corpo vivo secondo
la declinazione husserliana: il corpo si trasforma in carne [chair] e la carne «è fenomeno di
specchio», nella misura in cui quest’ultimo «è estensione del mio rapporto con il mio corpo»23. Lo
specchio esterno, si potrebbe dire, lo specchio oggetto, non è altro che l’estensione di uno specchio
interno (i neuroni-specchio?) che rende possibile la costituzione del corpo vivo. Quest’ultimo cioè
non si è già costituito attraverso il tatto prima di potersi vedere riflesso nello specchio, ma al
contrario è in grado di toccarsi solo se si è preliminarmente visto in virtù di un dispositivo riflettente
preesistente. Il corpo si costituisce a partire dal fatto che si vede riflesso nello specchio, acquista il
sensus sui a partire dal fatto di essere oggetto di visione. Pima di essere il vedente, il corpo è un che
di visto – dall’altro.
Senza voler ricostruire tutta la genealogia della nozione della carne basti qui dire che per
Merleau-Ponty essa rappresenta la parte esposta e visibile del corpo vivo, quella parte del corpo
vivo che indipendentemente dalla volontà del soggetto è inevitabilmente esposta allo sguardo
dell’altro. La carne è in altri termini la parte esteriore del corpo vivo, ossia quella parte che sfugge
in linea di diritto alla capacità del corpo di restare uno nella differenza (fra la mano che tocca e la
mano toccata), ciò che lo esteriorizza da se stesso, che impedisce che il corpo vivo possa restare
sempre presso di sé, nell’intimità con sé. La carne è l’alterità che affetta dall’inizio il corpo vivo e
gli impedisce di essere soltanto il mio corpo. Dire che la carne è “fenomeno di specchio” significa
che è il visto, ossia quella declinazione del corpo vivo in nome della quale esso è in primo luogo
guardato da ciò che Lacan ha chiamato il mondo omnivouyer, che, riflettendo se stesso nello
specchio, guardandosi, si trasforma chiasticamente nel vedente, nel soggetto della percezione.
Prima però di occuparci direttamente del rapporto che, fin dalle lezioni tenute tra il 1949 e il
1952 alla Sorbonne sulla psicologia infantile, Merleau-Ponty intreccia con le tesi sullo stadio dello
specchio di Lacan, torniamo sul tema del fantasma. Una delle prestazioni fondamentali del pensiero
20
Ibidem.
Merleau-Ponty, (1967), p. 221.
22
Ibidem.
23
Ibidem.
21
282
�Corpo e Spazio: Husserl, Merleau-Ponty, Lacan
del primo novecento, dalla psicologia della Gestalt alla fenomenologia, dall’empirismo radicale di
William James ad alcune tesi di Bergson, consiste certamente, nell’aver messo l’accento, contro la
tradizione empirista classica e la psicologia scientifica della scuola di Wundt, sia sul fatto che
oggetto di esperienza non siano soltanto le singole e irrelate impressioni sensibili, ma anche le
relazioni formali che organizzano e danno senso alle datità empiriche, sia su quello per cui gli interi,
della percezione o del pensiero, non siano il risultato della sommatoria delle parti di cui sono
composti, ma al contrario le precedano anticipandone in tal modo sia l’ordine che il senso.
Ci sono forme, strutture, della percezione che letteralmente inventano ciò che il soggetto
percipiente crede al contrario essere ciò che realmente accade là di fronte a lui. È il caso del
movimento apparente o stroboscopico descritto già nel 1912 da Max Wertheimer e con l’analisi del
quale cui si può dire che nasca la psicologia della Gestalt. In un ambiente completamente buio di
fronte al quale è posto un osservatore un raggio luminoso inquadra per pochi secondi un punto
qualsiasi; se a breve distanza di tempo un altro raggio luminoso inquadra un altro punto situato
molto vicino al precedente e se questo esperimento viene ripetuto più volte a intervalli di tempo
regolari, l’osservatore vedrà un oggetto muoversi rapidamente da un punto all’altro. Un tale
movimento che nella realtà non c’è ma è il prodotto, la prestazione specifica, dell’atto percettivo, è
ciò che dà senso ad un’esperienza che altrimenti resterebbe incompresa e darebbe adito soltanto a
disorientamento e perdita d’equilibrio.
La percezione, in altri termini, ha leggi proprie che né sono ricavabili dai dati grezzi della
sensazione, né sono il prodotto intellettualistico di dispositivi mentali quali l’associazione o la
somiglianza. Una delle prime leggi della percezione è quella del rapporto figura-sfondo: il campo
percettivo non è mai bidimensionale ma implica la profondità. Non vi sarebbe percezione se non
fosse possibile situare una parte del campo percettivo sullo sfondo in modo che ciò su cui si porta
l’attenzione venga in primo piano come un attore su un proscenio. E il rapporto figura-sfondo non è
fisso ma variabile come dimostrano quelle strane figure doppie che una volta possono essere viste
come la silhouette di un vaso e un’altra come due profili che si fronteggiano.
Se questo è vero per la percezione in generale, lo dovrà essere anche per quella del corpo, e non
solo del corpo oggetto, ma anche e a maggior ragione del mio proprio corpo, ossia del corpo vivo. Il
corpo vivo, il corpo che tocco e che si tocca, il corpo che si autoaffetta, è il risultato di
un’anticipazione percettiva e come il movimento stroboscopico è apparente, vale a dire un
fantasma. L’esperienza clinica del cosiddetto “arto fantasma” acquista allora un ruolo decisivo
nell’elaborazione concettuale di Merleau-Ponty. Come spesso accade la guerra permette
avanzamenti nella conoscenza e rettifiche etiche che altrimenti faticherebbero un tempo quasi
interminabile per riuscire ad affermarsi: lo studio finalmente sistematico da parte di medici e
psichiatri del comportamento dei soldati che durante la prima guerra mondiale avevano subito
l’amputazione di un arto permette d’isolare un fenomeno specifico. Per un tempo più o meno lungo
il soggetto in questione continua a percepire la presenza dell’arto perduto, vive il suo corpo vivo
come se fosse integro, privilegia contro il corpo reale mutilato lo schema del corpo che prevede due
arti simmetrici, tali, nel caso fossero le braccia con il prolungamento delle mani, da potersi toccare
ed essere toccati. «Una emozione, scrive Merleau-Ponty, una circostanza che ricordi quelle della
ferita fanno apparire un arto fantasma in soggetti che non ne avevano. Accade che il braccio
fantasma enorme dopo l’operazione, si restringa poi per scomparire infine nel moncherino» 24.
L’uso di definire questo arto inesistente, ma egualmente percepito, “fantasma” riavvicina i due
sensi del termine che Husserl teneva il più possibile lontani: fantasma come immagine di fantasia e
fantasma come spettro, come revenant. Ma se questo è vero, allora è lo stesso corpo vivo ad essere
per così dire predisposto al ritorno spettrale. La possibilità del fenomeno dell’arto fantasma si fonda
sul fatto che il corpo vivo sia esso stesso un che di fantasmatico. Riallacciandosi a Husserl,
Merleau-Ponty può a questo punto concettualizzare meglio la definizione dello schema corporeo –
gli schemi sensoriale e tattile di cui si parlava in Ideen II – chiarendo che quest’ultimo «non sarà più
il semplice risultato delle associazioni stabilite nel corso dell’esperienza, ma una presa di coscienza
24
Merleau-Ponty (1965), p. 125.
283
�Bruno Moroncini
globale della mia postura nel mondo intersensoriale, una “forma” nel senso della
Gestaltpsichologie»25.
La forma qui non è un mosaico, bensì un nuovo tipo d’esistenza: «se l’arto paralizzato non conta
più nello schema corporeo dell’anosognosico è perché lo schema corporeo non è né il semplice
calco, né la coscienza globale delle parti esistenti del corpo, ma se le integra attivamente in ragione
del loro valore per i progetti dell’organismo. Gli psicologi dicono spesso che lo schema corporeo è
dinamico. Ricondotto a un senso preciso, questo termine significa che il mio corpo mi appare come
un atteggiamento in vista di un certo compito attuale o possibile» 26.
Ma come si costituisce a propria volta questo schema corporeo o, in altri termini, come avviene
che sull’impalcatura del corpo oggetto si possa innestare uno schema fantasmatico? Se non ci fosse
la tematizzazione del corpo sessuato e la conseguente chiamata in causa della psicoanalisi
freudiana, Fenomenologia della percezione, che è del 1945, potrebbe sembrare una semplice glossa
alla fenomenologia husserliana e alla psicologia della Gestalt. Bisogna andare invece alle lezioni
sulle Relazioni dell’infante con altri [autrui], svolte negli anni immediatamente successivi, per
trovare la risposta alla questione, una risposta che sarà ripresa negli appunti incompiuti del Visibile
e l’invisibile.
Merleau-Ponty parte da lontano: in primo luogo bisogna ribaltare l’assunto da cui parte la
psicologia classica secondo la quale «l’attività psichica è ciò che è dato a ciascuno nella sua
solitudine»27. Per la psicologia classica lo psichico è “incomunicabile”, la sensazione del verde o
del rosso è esclusivamente mia, nessuno la potrà conoscere come la conosco io. Se la conseguenza
inevitabile di questa posizione è che la vita psichica degli altri è inaccessibile, la soluzione della
difficoltà sarà cercata dalla psicologia classica nel meccanismo della proiezione secondo la quale
trasferirei sull’altro quell’esperienza intima che ho di me stesso.
Se ciò vuol dire che la costituzione dell’altro soggetto è successiva, avviene in un secondo
tempo, rispetto a quella di me stesso, tuttavia molti fatti empiricamente accertati smentiscono la
tesi: si è consapevoli ormai che «la percezione dell’altro è precoce, anche se non è certo precoce la
conoscenza esatta del significato di ciascuna delle espressioni emotive che l’altro ci presenta» 28. Si
è notato ad esempio, prosegue Merleau-Ponty, che molto presto i bambini risultano essere sensibili
al sorriso dell’altro senza che ciò sia spiegabile ricorrendo al metodo proiettivo che dovrebbe
implicare una conoscenza precoce da parte del bambino del proprio sorriso in modo da poter
proiettare gli stati psichici corrispondenti sull’altro per via cinestetica. Ma come ha già mostrato
Husserl, il bambino ha un’esperienza visiva del proprio corpo molto piccola se confrontata con
quella derivabile dal tatto: «ci sono molte parti del corpo che egli non vede, ce ne sono alcune che
non vedrà mai, che non conoscerà mai se non con l’aiuto dello specchio»29. Se pure gli riesce di
identificare i corpi degli altri e il suo come corpi animati, «ciò può accadere solo perché li identifica
globalmente e non perché costituisce punto per punto una corrispondenza tra l’immagine visiva
dell’altro e l’immagine introcettiva del suo corpo»30.
Non si passa da un di dentro a un di fuori cui si attribuisce in un secondo momento la psichicità.
L’altro lo si incontra subito e nella totale esteriorità. Merleau-Ponty valorizza i risultati della
tradizione fenomenologica e non solo: la coscienza è sempre coscienza di mondo e l’altro lo
incontro in primo luogo nel mondo. Io e l’altro ci affacciamo sullo stesso mondo.
Riconoscerò di conseguenza la presenza dell’altro dal modo con cui si atteggia di fronte al
mondo, da come lo tratta; lo conoscerò in altri termini non per le vie dell’introcezione e della
proiezione ma per quelle dell’azione esteriore e visibile. Si conosce l’altro non attraverso
l’Einfühlung ma imitandone il comportamento visibile. Così si acquisisce il linguaggio, ascoltando
25
Ivi, p. 153.
Ibidem.
27
Merleau-Ponty (1968), p. 82.
28
Ibidem.
29
Ivi, p. 85.
30
Ivi, p. 86.
26
284
�Corpo e Spazio: Husserl, Merleau-Ponty, Lacan
e imitando la lingua materna. Si conosce l’altro non nonostante il suo corpo, ma attraverso il suo
corpo, il quale allora non è un agglomerato di sensazioni conosciuto per cinestesia bensì una postura
globale, uno schema posturale, un modo di stare al mondo. A permettere la comprensione dell’altro
è quindi lo schema corporeo, l’immagine visiva dell’altro quale la vedo nel suo corpo che si
affaccia sul mondo è l’involucro visivo di un altro schema corporeo.
Una simile tesi è anticipata per Merleau-Ponty da quella husserliana secondo la quale
l’esperienza dell’altro è governata da un’intenzionalità obliqua e indiretta, da un rapporto
complesso fra presenza originaria e presenza secondaria, fra presenza e appresenza. Se è vero che la
presenza dell’altro resta una presenza differita rispetto a quella di me a me stesso, tuttavia tale
presenza secondaria è data insieme a quella originaria, in contemporanea e non in un secondo
momento. Il fenomeno dell’altro è di conseguenza il darsi originario di una coppia, di una Paarung,
dell’apparire insieme dell’ego e dell’alter.
Forzando il dettato husserliano Merleau-Ponty può allora sostenere che ci sia un punto in cui io e
l’altro non saremmo del tutto distinguibili: in realtà all’inizio non ci sono due individui uno di
fronte all’altro, bensì una forma di «collettività anonima»31. Come avviene allora la
differenziazione, come acquisto coscienza di me? Se la risposta è conosciuta: acquisto coscienza di
me attraverso quella del mio corpo come corpo vivente, ciò che non è ancora chiaro è come invece
si costituisce in me questa stessa corporeità vivente dal momento che la soluzione husserliana
secondo la quale essa avverrebbe attraverso il tatto siamo ora costretti ad escluderla.
È a questo punto che Merleau-Ponty, servendosi delle ricerche di Henry Wallon sulla percezione
dell’altro nel bambino nel periodo che va dalla nascita a sei mesi e soprattutto di quelle di Jacques
Lacan sullo stadio dello specchio nella formazione dell’io, spiega la formazione del sé corporeo a
partire dall’altro e la colloca nel momento in cui avviene da parte del bambino il riconoscimento
della propria immagine allo specchio. Se non si percepisce prima l’altro e di conseguenza sé come
un altro, non può darsi alcuna formazione dello schema corporeo, nessun senso di sé.
Fino ai tre mesi il bambino è introcettivo, non ha alcuna percezione dell’altro. I suoi gesti
rispetto alla madre o alla bambinaia non implicano una loro vera percezione, indicano soltanto degli
stati di maggiore o minore benessere che il bambino esperisce su di sé32: come direbbe Lacan il
seno non è una parte del corpo della madre, ma del bambino stesso. Per avere in primo stimolo
estrocettivo, che attesti cioè che il bambino incomincia ad uscire da se stesso e a sperimentare
l’esistenza di altri, bisogna aspettare le sue reazioni all’esperienza della voce dell’altro: «la voce
umana che il bambino sente provoca in un primo momento degli strilli quando il bambino ha paura;
poi, a due mesi, dei sorrisi» 33.
Ma una vera percezione dell’altro come altro e di conseguenza una percezione di sé stessi
possibile solo dopo essersi differenziati rispetto all’altro si dà solo verso i sei mesi di vita quando il
bambino acquista la capacità di riconoscere l’immagine dell’altro nello specchio e in seconda
battuta la propria. Se per il bambino è più facile riconoscere per prima l’immagine speculare
dell’altro è perché egli non si vede nello specchio così come vede per esempio il padre. In questo
caso infatti il bambino può confrontare le sue immagini; invece quando si tratta di sé e della sua
immagine speculare si apre una discrasia fra il suo sapere di sé attraverso la cinestesia e il sapere
derivante dalla percezione visiva, fra il come “si sente” e il come “si vede”. È per questo che
l’immagine dell’altro è la via maestra per pervenire al riconoscimento della propria immagine: «egli
(il bambino) deve quindi comprendere che quell’immagine visiva del suo corpo che vede laggiù
nello specchio non è lui, poiché egli non è nello specchio ma là dove si sente; e in secondo luogo,
egli deve comprendere che, pur non essendo situato là nello specchio, ma là dove si sente attraverso
31
Ivi, p. 91.
«Finché l’altro non è avvertito che come una specie di benessere nell’organismo del neonato, che viene tenuto più
saldamente o più dolcemente fra le braccia, non si può affermare che l’altro venga percepito», ivi, p. 99.
33
Ibidem.
32
285
�Bruno Moroncini
l’introcettività, egli è ciononostante visibile da un testimone esterno, nel punto stesso in cui egli si
sente, con l’aspetto visivo che lo specchio gli presenta»34.
La percezione dell’altro non serve solamente da modello per l’identificazione fra il bambino e la
sua immagine allo specchio, serve soprattutto da prova che lui è visto come l’immagine di suo
padre è vista da lui allo specchio. L’immagine dell’altro permette di acquisire il fatto decisivo che si
è visti prima di vedere, che si è altri per altri, corpo per altri corpi. L’altro in quanto vedente che mi
vede e rispetto al quale io sono visto mi precede. Poiché io sono visibile, io vedo e mi vedo vedente,
cioè sono cosciente di me. Si è coscienti di sé solo perché il sé è altro: Il bambino, scrive MerleauPonty, «sa bene di essere situato là dove è il suo corpo introcettivo, e ciononostante vede in fondo
allo specchio lo steso essere stranamente presente sotto un’apparenza sensibile»35.
Se fino a questo punto Merleau-Ponty si è lasciato guidare nella ricostruzione del riconoscimento
della propria immagine allo specchio da parte del bambino dalla ricostruzione offerta da Henry
Wallon, è pero intorno alla valutazione del “giubilo” manifestato dal bambino quando guarda se
stesso nello specchio che il suo percorso devia e si sposta dal lato di Lacan. In effetti Wallon non
valuta positivamente l’immagine speculare; egli s’impegna nel mostrare piuttosto come il bambino
impari a considerarla «come non reale» e tenti di «ridurla»36. Resta fuori dalla sua analisi, pur
riconoscendola, quella reazione divertita del bambino di fronte alla propria immagine allo specchio
che al contrario Lacan valorizza.
Perché il bambino testimonia di un così vivo interesse, che culmina in una gioia manifesta, in un
giubilo visibile, per la propria immagine allo specchio non appena la riconosca come tale? Perché
attraverso questa esperienza il bambino subisce una trasformazione straordinaria, fa un salto di
personalità, passa in altri termini da uno stato in cui la sua esistenza come sé è avvertita in modo
confuso, il corpo è parcellizzato e privo di coordinamento, ad un altro in cui si è costituito un ideale
dell’io attraverso il quale il bambino acquista il controllo di sé stesso e del proprio corpo
esattamente perché lo spettacolo di se stesso che vede nello specchio gli ha permesso l’assunzione
dello schema corporeo con il quale egli è ora in grado di totalizzare tutto il complesso della sua
esperienza. Il riconoscimento dell’immagine allo specchio affranca il bambino dal vissuto
immediato e lo proietta in modo anticipato nel mondo degli adulti.
5.
Lo spostamento operato da Merleau-Ponty dal corpo vivo alla carne (morta: latino caro, greco
κειρω = taglio; greco σαρξ = sarcoma) restituisce, contro Husserl, spessore concettuale alla tesi
freudiana secondo la quale psiche è estesa e lo spazio è soltanto la sua proiezione esterna. Solo che
adesso l’esteriorità, l’essere partes extra partes, che caratterizza l’estensione, non è più riferita al
piano cartesiano bensì a quella scienza dei luoghi che è la topologia moderna. Se la carne indica ciò
che del corpo è esposto alla visione altrui, una visibilità anteriore alla stessa costituzione di un
soggetto che vede e che si vede (che tocca e che si tocca), della quale quindi non può darsi nessun
sapere preventivo e sulla quale non si può operare alcun controllo, essa allora è quella parte del
corpo con la quale il corpo stesso non ha che un rapporto di esteriorità. Allo stesso tempo però
un’analisi rigorosamente fenomenologica dell’esperienza del mio corpo non potrà che attestarne
l’intimità e la prossimità con sé, la sostanziale indistinguibilità del suo bordo interno e di quello
esterno.
A risolvere questa solo apparente contraddittorietà dell’esperienza della carne soccorre la
geometria topologica: la carne ha la stessa struttura della striscia di Moebius che è quella figura
topologica ad una dimensione in cui si passa dal dritto al rovescio e viceversa senza mai incontrare
un limite o dover fare un salto, in cui cioè i due lati, dritto e rovescio, interno e esterno, sono
indistinguibili pur restando diversi. D’altronde la struttura a chiasmo ripetutamente invocata da
Merleau-Ponty per illustrare la natura della carne è un concetto della topologia. Ciò vuol dire che i
34
Ivi, p. 107.
Ivi, p. 108.
36
Ivi, p. 117. Su questo punto si veda Gambazzi (1999), pp. 75ss.
35
286
�Corpo e Spazio: Husserl, Merleau-Ponty, Lacan
lati del soggetto della percezione – quello visto e quello vedente – conservano la loro esteriorità
reciproca pur risultando indistinguibili, essendo l’uno il rovescio, l’incavo, dell’altro; il visibilevisto si rovescia nell’invisibile vedente che anche quando si vede resta segnato dall’alterità:
qualcosa di visto, quindi di esteriore, continua a parassitare il vedente che si vede, impedendogli di
essere, sempre e comunque, presso di sé, di far tutt’uno con sé.
Il riferimento topologico, che va di pari passo con la presenza sempre più massiccia della
psicoanalisi freudiana, è il fondamento teorico su cui si costruisce il tentativo perseguito da
Merleau-Ponty negli ultimi appunti di lavoro di passare dalla fenomenologia all’ontologia senza
ricadere nella vecchia metafisica sostanzialistica e gerarchica. Se l’essere è d’ora in poi “selvaggio”,
è appunto perché il suo modello è «lo spazio topologico»37. L’essere è selvaggio perché non è
categorizzabile, perché ad esso non si possono applicare le distinzioni classiche di luogo e di tempo
o di sostanza e accidente e di potenza e atto. I termini stessi si indeterminano: il fuori è dentro, la
sinistra è destra e viceversa, l’essere come ciò che è il più vecchio, come passato senza tempo
(essenza), è il sempre attuale, come nato adesso38.
Il corpo è, come l’essere, due in uno, qualcosa che si scinde, si frantuma. Il corpo è “due” o
“paio”: «non è due atti, due sintesi, è frammentazione dell’essere, è possibilità dello scarto (due
occhi, due orecchie [anche due mani?]: possibilità di discriminazione, di impiego del diacritico) è
avvento della differenza (su sfondo di somiglianza dunque)»39.
È questa spinta ad abbandonare la fenomenologia, ossia l’idealismo, e a muoversi verso
un’ontologia della carne, vale a dire nei termini della psicoanalisi verso un corpo godente, un corpo
che gode e che si gode, l’aspetto che Lacan valorizza dell’ultima produzione dell’amico scomparso
nelle lezioni che gli dedica nel seminario del 1964 I quattro concetti fondamentali della
psicoanalisi. L’importanza del Visibile e l’invisibile sta infatti per Lacan nel «servirci a sottolineare
il punto d’arrivo della tradizione filosofica – quella tradizione che inizia da Platone con la
promozione dell’idea, di cui può dirsi che partita da un mondo estetico, termina e si determina
nell’assegnare all’essere il fine di sommo bene, raggiungendo così una bellezza che ne è anche il
limite. Non per nulla Merleau ne riconosce nell’occhio il fattore portante»40. Rispetto a questa
tradizione e ai suoi eccessi già la Fenomenologia della percezione aveva preso posizione invocando
«la funzione regolatrice della forma» cui presiedeva non solo l’occhio del soggetto, ma tutta la sua
attesa, il suo movimento, la sua emozione muscolare e anche viscerale – in breve la sua presenza
costitutiva, messa a fuoco in quel che è chiamato la sua intenzionalità totale» 41. Ma Merleau-Ponty
va oltre anche rispetto alla Fenomenologia perché al di là dell’occhio, cioè della fonte della vista,
del luogo del vedente, si spinge verso lo sguardo inteso come la pousse, la spinta e il germoglio del
vedente: «quel che si tratta di mettere in evidenza, attraverso le vie che egli ci indica, è la
preesistenza dello sguardo – io non vedo che da un punto, ma nella mia esistenza sono guardato da
ovunque»42.
Due sono le mosse con cui Merleau-Ponty dà scacco all’idealismo secondo Lacan: la prima è di
abbassare le pretese della forma, dell’idea, declassandola dalle vette del sommo bene, un oggetto
puro di uno sguardo puro, ai piani bassi delle funzioni regolatrici e limitanti. Infatti il compito
precipuo della forma è di adattare l’occhio al mondo, sottoponendo il vedere a leggi vincolanti
come quella del rapporto figura-sfondo, costringendolo a muoversi soltanto nell’ambito del campo
percettivo delimitato e circoscritto dalla linea d’orizzonte. Nessun volo socratico a rimorchio di
Diotima.
La seconda è di postulare uno sguardo al di là dell’occhio come organo della visione. E non tanto
una differenza ma una vera e propria schisi, un taglio netto fra il vedere e l’essere guardati. Prima di
37
Merleau-Ponty, (1969), p. 243.
Cfr. ibidem.
39
Ivi, p. 249.
40
Lacan, (1979), p. 73.
41
Ibidem.
42
Ivi, p. 74
38
287
�Bruno Moroncini
vedere, l’occhio è oggetto dello sguardo dell’altro. E ciò significa non semplicemente essere visto,
ma soprattutto desiderato, costituire il termine di un investimento libidico e di una aspettativa di
godimento che espropria il soggetto percettivo, lo altera e lo rende altro da se stesso, esteriore a sé.
Lo sguardo sfugge al potere regolatore della forma, mette in crisi lo schema corporeo, rispetto
all’anticipazione fantasmatica di quest’ultimo che tuttavia dà ordine e senso ad una congerie di
elementi corporei altrimenti irrelati e centrifughi è una pura contingenza, un tocco di qualcosa di
reale imprevedibile e angosciante. «A noi, dice Lacan, lo sguardo non si presenta che nella forma di
una strana contingenza, simbolica di ciò che troviamo all’orizzonte e come limite della nostra
esperienza, cioè la mancanza costitutiva dell’angoscia di castrazione» 43. Tutta la costruzione
percettiva e quindi identitaria del soggetto incontra nello sguardo un limite, fosse pure quest’ultimo
il nostro sguardo caduto via dall’occhio - uno sguardo di amore o d’odio, che anche quando ama
medusizza e si trasforma in uno sguardo cattivo, in un malocchio – e che, divenuto altro, ci guarda
dall’al di là della linea d’orizzonte.
Questa glossa lacaniana getta luce retrospettivamente su quelle ultime note di lavoro in cui
Merleau-Ponty si avventurava nell’ipotesi di una psicoanalisi non esistenziale e non
fenomenologica, bensì ontologica, una psicoanalisi non dell’uomo, quasi fosse una nuova e più
aggiornata antropologia fondamentale, ma della Natura, vale a dire della carne: e dove ognuno di
noi incontra la carne del mondo sul cui rovescio prende forma il suo corpo vivo se non nell’intrico,
nel chiasmo, costituito da quel due in uno, da quel paio che sono una madre ed un bambino? Non a
caso nella frase che legava insieme psicoanalisi, natura e carne, a quest’ultimo termine seguiva
senza alcuna soluzione di continuità quello della madre44. Adesso la sequenza è completa: la natura
è la carne, la carne è la madre, e la madre è quella cosa oscura il cui corpo, indistinguibile da quello
del bambino, è tuttavia l’altro a partire dallo sguardo del quale egli ex-siste, viene al mondo come
un occhio che vede. Uno sguardo che lo perturba e lo angoscia perché lo inchioda alla sua
essenziale finitezza, al suo mancare come essere pieno ed autosufficiente, in altri termini alla sua
costitutiva dipendenza dall’altro che come un fantasma o uno spettro che ritorna infesta le più
riposte fibre del suo corpo.
Bibliografia
Gambazzi, P. (1999), L’occhio e il suo inconscio, Raffaello Cortina, Milano.
Heller-Roazen, D. (2013), Il tatto interno. Archeologia di una sensazione, trad. it. a cura di G.
Lucchesini, Quodlibet, Macerata.
Husserl, E. (2002), Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, vol. II,
trad. it. a cura di E. Filippini rivista da V. Costa, Einaudi, Torino.
Masullo, A. (1965), La comunità come fondamento. Fichte, Husserl, Sartre, Libreria scientifica
editrice, Napoli.
Masullo, A. (2018), L’arcisenso. Dialettica della solitudine, Quodlibet, Macerata.
Merleau-Ponty, M. (1965), Fenomenologia della percezione, trad. it. a cura di A. Bonomi, Il
Saggiatore, Milano.
Merleau-Ponty, M. (1967), Il filosofo e la sua ombra, in Id., Segni, trad. it. a cura di G. Alfieri, Il
Saggiatore, Milano.
Merleau-Ponty, M. (1968), Il bambino e gli altri, trad. it. a cura di G. Goeta, Armando, Roma.
Merleau-Ponty, M. (1969), Il visibile e l’invisibile, trad. it. a cura di A. Bonomi, Bompiani, Milano.
Moroncini, B. (2002), Corpo e terra, in AA. VV., Per Alberto Abruzzese, Luca Sossella editore,
Roma.
Moroncini, B. (2006), “La psiche è estesa, di ciò non sa nulla”. Il problema dello spazio in
psicoanalisi, in Conforti, R. (a cura di), La psicoanalisi tra scienze umane e neuroscienze.
Storia, alleanze, conflitti, Rubbettino, Soveria Monnelli, pp. 561-588.
43
44
Ivi, pp. 74-75.
«Fare una psicoanalisi della Natura: è la carne, la madre», cfr. Merleau-Ponty (1969), p. 301.
288
�Corpo e Spazio: Husserl, Merleau-Ponty, Lacan
Moroncini, B. (2017), Spazio e tempo nella psicoanalisi freudiana, in Sibilio, M. (a cura di),
Vicarianza e didattica. Corpo, cognizione, insegnamento, E. L. S. La Scuola, Brescia.
Lacan, J. (1979), Il seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi, Einaudi,
Torino.
Nancy, J.-L. (1995), Corpus, trad. it. a cura di A. Moscati, Cronopio, Napoli.
Wallon, H. (1933), Les origines du caractère chez l’enfant, Puf, Paris.
Wertheimer, M. (1912), “Experimentelle Studien über das Sehen von Bewegung”, Zeitschrift für
Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane», vol. 61, n. 1, Verlag von Johann Ambrosius
Barth, Leipzig.
Abstract
Starting from the analysis of the body in the phenomenological tradition, and by means of the
mediation of Merleau-Ponty’s thought, the essay aims to address the Lacanian theorization of the
body as a pulsional body, in which the phenomenological centrality of vision is traced back to the
specific performance of the scopic pulsion. The essay will be divided into three parts. The first one
will reconstruct the Husserlian theorization of the theme of the proper body (Leib) or living body,
mainly from Ideas II, the lessons on passive synthesis, and those on the Crisis of European
Sciences, in which the concept of “world of life” is put at stake. In the second part, after a few
words on the Gestalt-psychology, the production of Maurice Merleau-Ponty will be analyzed
starting from the Phenomenology of perception, passing through the Lessons on child psychology
held at the Sorbonne in 1949 – in which the relationship with Lacan and more specifically with his
writing on the mirror stage is already present –, until the thesis on the flesh and the relationship
between “seeing” and “being seen” in The Visible and the Invisible. Finally, in the third part, I will
analyze Lacan’s conferences on Merleau-Ponty, and the section of the seminar on the four
fundamental concepts of psychoanalysis entitled The gaze as object a, in which the scopic pulsion is
discussed.
Keywords: Body, Space, Touch, Gaze, Phantom
289
�FABRIZIO PALOMBI*
“L’effetto fantasma”: Jacques Derrida e l’“iperfenomenologia”1
Entrambi […] si propongono di cacciare lo spettro […],
sembrano […] “decostruire”, una fenomenologia ontoteologica […]. La loro “decostruzione” si arresta al punto in
cui oppongono, entrambi […] a questa onto-teologia
spettrale, il principio iper-fenomenologico della presenza in
carne e ossa della persona vivente […], della sua presenza
[…] non fantomatica.
Jacques Derrida2
Lo spettro è dello spirito, ne partecipa […]. La differenza
tra i due è […] quel che tende a scomparire nell’effetto
fantasma.
Jacques Derrida3
Karl Marx e Max Stirner sono i soggetti della prima citazione: Jacques Derrida interpreta il loro
confronto, in modo originale e anacronistico, come il tentativo di decostruire una fenomenologia
che coniuga ontologia e teologia. La sua lettura retroattiva attribuisce ai due autori tedeschi i propri
interessi filosofici per valutare quel limite specifico, costituito dal fantasma, innanzi al quale
s’arresterebbe la loro critica.
Derrida ritiene che entrambi anticipino, in qualche modo e misura, una tendenza della
fenomenologia novecentesca dedita allo studio dell’aptocentrismo ovvero alle problematiche
caratteristiche dell’affezione e dell’autoaffezione. È un importante tema che accompagna una parte
significativa della produzione del filosofo francese e costituisce un corollario del suo teorema
filosofico dedicato alla critica della metafisica della presenza4.
Derrida procede, seguendo questa prospettiva decostruttiva, a esporre un’originale reinterpretazione
della fenomenologia attraverso l’esame del concetto di fantasma e dei suoi effetti ontologici. Queste
riflessioni sono presentate in Spettri di Marx che non possiamo considerare solo come un testo di
filosofia della politica, seppure interpretata nell’amplissima accezione decostruttiva derridiana5. Il
libro consolida, infatti, una sorta di svolta spettrale che, nel volgere d’alcuni anni, consente allo
studioso francese di ripensare gran parte del proprio itinerario teorico e della sua critica
fenomenologica della fenomenologia. Possiamo, allora, considerare Spettri di Marx come una sorta
d’ulteriore puntata della serie filosofica derridiana, dedicata alla decostruzione della metafisica della
presenza, declinata in termini economici e politici, che potrebbe essere intitolata iperfenomenologia.
Segnaliamo preliminarmente che quest’ultimo termine non sembra possedere molte occorrenze nei
testi di Derrida e sembrerebbe comparire per la prima volta, in forma aggettivale, proprio nella
*
Università della Calabria
1
Il presente articolo è un testo inedito scritto nel quadro del progetto “Estudio sistemático de las lecturas
heideggerianas de Jacques Derrida. Confluencias y divergencias (FFI2016-77574-P). Ministerio de Economía, Industria
y Competitividad (Dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D)”.
2
Derrida (1994), pp. 239-240, n. 19, secondo corsivo nostro.
3
Ivi, p. 159, secondo corsivo nostro.
4
Cfr. Facioni, Regazzoni, Vitale (2012), pp. 29, 33-34. Cfr. Kochhar-Lindgren (2011), pp. 46-47.
5
Cfr. Derrida (1994), p. 231, n. 7. Sui rapporti tra marxismo e decostruzione e per una critica lacaniana della lettura
derridiana di Marx cfr. Habjan (2014).
Bollettino Filosofico 33 (2018): 290-303
ISSN 1593 -7178 - 00030
E-ISSN 2035 -2670
DOI 10.6093/1593-7178/5924
�“L’effetto fantasma”: Jacques Derrida e l’“iperfenomenologia”
citazione di Spettri di Marx posta in esergo6. Ciò non toglie, tuttavia, che la parola abbia goduto
d’una discreta fortuna presso gli studiosi derridiani che lo hanno usato per interpretare, anche
retroattivamente, l’evoluzione della riflessione del filosofo francese. Mario Vergani, per esempio,
commentando Della grammatologia, la usa per descrivere, in generale, quel gesto decostruttivo che
costituisce la cifra di Derrida7. La fortuna del suo volume introduttivo, dedicato al filosofo francese,
potrebbe aver contribuito a far conoscere il termine derridiano anche nel nostro paese dove
“iperfenomenologia” compare in testi d’estetica, etica e filosofia del diritto, ed è riproposto, seppure
in contesti e con intenti differenti, in articoli pubblicati su alcuni quotidiani nazionali 8. Tali
considerazioni ci inducono a focalizzare le nostre riflessioni sull’occorrenza di
“iperfenomenologia”, proposta dal nostro esergo, e sul suo peculiare contesto politico e filosofico
costituito da Spettri di Marx.
Proveremo, dunque, a riflettere brevemente su alcuni degli aspetti politici di questo libro per
lavorare successivamente, nelle sue ampie pieghe teoretiche, approfondendo alcuni aspetti della
«logica spettrale»9 derridiana e dedicando particolare attenzione alle originali e complesse analisi
sul rapporto tra fenomenologia e fantasma. Spettri di Marx sembra proporre due accezioni di
“iperfenomenologia”: una di carattere negativo, ancora condizionata dalla metafisica della presenza
e dall’aptocentrismo e, un’altra propositiva, che cerca di raffinare ulteriormente il metodo
husserliano attraverso un suo paradossale rovesciamento. Potremmo dire, in altre parole, che
Derrida parta da una fenomenologia del fantasma per giungere a una fantasmatizzazione del
fenomeno oppure a una sua spettrologia10. Proviamo a esplorare entrambe le accezioni
dell’iperfenomenologia partendo da alcune riflessioni sulla nuova ontologia non presentificata
dell’economia che costituisce una parte molto interessante e attuale dell’eredità di Derrida.
1. Contributo alla critica dell’ontologia economica
Spettri di Marx oppone alla tradizionale ontologia dominata dalla “metafisica della presenza”
un’altra di tipo spettrale inizialmente ispirata dalla riflessione heideggeriana e, poi, dai fenomeni
politici, scientifici ed economici della contemporaneità. Non è, infatti, un caso se l’ultima fase del
pensiero di Derrida applica l’ontologia spettrale anche alle tecnologie informatiche e multimediali
che s’affermano prepotentemente sul finire del secolo scorso11. Il volume dimostra, una volta
ancora, come non sia possibile individuare nella sua produzione una netta cesura tra le opere di
carattere teoretico e quelle di tipo etico, estetico e politico. Riteniamo che tutti questi temi debbano
essere pensati attraverso la critica derridiana alla “metafisica della presenza” e alla correlata
questione della scrittura che costituisce la cifra filosofica della sua riflessione.
Potremmo, dunque, rileggere, almeno retroattivamente, anche tali tradizionali problemi della
speculazione di Derrida attraverso il tema della spettralità evidenziando come la radicalità della sua
riflessione si possa meglio comprendere concentrandosi sul doppio genitivo della preposizione
articolata che abbiamo corsivato. Essa, infatti, ci permette d’evidenziare non solo la decostruzione
6
Usiamo il condizionale perché la mole della produzione di Derrida, ancora in parte inedita, e la mancanza d’una
edizione critica completa delle sue opere, impone d’essere estremamente prudenti. Quanto proponiamo in queste righe,
di conseguenza, ha solo il carattere d’ipotesi, formulata sulla base delle nostre ricerche effettuate sui testi e motori di
ricerca, che dev’essere controllata accuratamente.
7
Cfr. Vergani (2000), pp. 25, 117-118 e Derrida (1969), p. 70.
8
Cfr. Andronico (2006), p. 35; Grazioli (2004), p. 174; Zanardo (2007), p. 352. Una ricostruzione esaustiva della
genesi e della diffusione del termine iperfenomenologia e dei suoi aggettivi nelle traduzioni italiane, inglesi e tedesche
esula, ovviamente, dagli scopi del presente contributo. Ci limitiamo, pertanto, a segnalare alcuni interessanti occorrenze
tra le quali si evidenzia la parola uberphenomenalism, usata per descrivere l’approccio derridiano in Appelbaum,
(2009), p. 21, e il termine hyper-phenomenology, con cui Postone (1998), pp. 377, 384 si riferisce ai medesimi brani di
Spettri di Marx da noi considerati. Segnaliamo, inoltre, che O’Malley (1966) e Spiegelberg (2013), pp. 424, 437 usano
tale parola riferendosi alla filosofia di Gabriel Marcel.
9
Ivi, p. 222, n. 3; sulla particolare accezione derridiana del termine “logica” in questo contesto cfr. Appelbaum,
(2009), p. 123, n. 8, Kochhar-Lindgren (2011), pp. 3, 85, 165, 200-202 e Palombi (2017a).
10
Cfr. Derrida (1994), p. 159.
11
Cfr. Ivi, pp. 104-106, Derrida (2010), Derrida (2002) e Derrida, Stiegler (1997).
291
�Fabrizio Palombi
della “metafisica della presenza” ma anche comprendere la persistente “presenza della metafisica”
nella cultura occidentale attraverso la questione della scrittura12. Quest’ultima mostra come l’autore
di un testo sia già sempre, in qualche modo, un fantasma, o meglio un ghost writer, che scrive sotto
dettatura della metafisica nella prospettiva della propria morte13. Per questo, parafrasando Derrida,
possiamo dire che esiste sempre un testo scritto che sorveglia qualunque nostro discorso per quanto
possiamo sforzarci di pensarlo come espressione del nostro «presente vivente»14.
Tali questioni non solo consentono di rileggere aspetti fondamentali dell’evoluzione storica
dell’occidente ma anche di studiare alcune urgenze politiche e culturali della nostra epoca
globalizzata. Le analisi delle ideologie contemporanee, dei nazionalismi15, dei fondamentalismi
religiosi16, dell’apologia della multimedialità e della virtualità, costituiscono, dunque, altrettante
ragioni per raffinare la riflessione su “presenza” e “metafisica” radicalizzando, in questa occasione,
l’atteggiamento critico marxiano e quello fenomenologico husserliano e heideggeriano. Derrida
rielabora la sottile pratica del sospetto, caratteristica del filosofo di Treviri, sforzandosi di rendere
ragione anche di quell’oscurità superstiziosa che quest’ultimo considera come sintomo d’un
ragionamento fallace e, per questo, liquida come “fantasma”. Il materialismo marxiano in tutte le
sue versioni risulterebbe inadeguato, dopo la crisi del socialismo reale, a decostruire le ideologie
neoliberiste e, per tale motivo, Derrida si sforza d’applicare ai fenomeni fantasmatici, caratteristici
di merci, servizi e relazioni sociali del tardo capitalismo, strumenti filosofici e lessicali di nuovo
tipo17. Ecco perché, secondo il filosofo francese, «l’avvenire non può che appartenere ai
fantasmi»18.
Si tratta, innanzitutto, d’approfondire la critica marxiana all’economia politica nei termini d’una
«disincarnazione spettralizzante» capace di pensare, in forma iperfenomenologica, le nuove forme
di quella «apparizione del corpo senza corpo del denaro»19. Non è difficile cogliere l’attualità della
speculazione derridiana pensando al vertiginoso processo di smaterializzazione subito dal denaro
negli ultimi decenni che parte dalla carta moneta, passa per assegni e carte di credito e arriva agli
algoritmi dei bitcoin. Il carattere fantomatico dell’economia finanziaria, esaminato da Derrida, si
coglie anche nel recente dibattito sul debito economico contratto dagli stati. La sua natura sembra
venir fraintesa da quelle interpretazioni che pensano, surrettiziamente e inadeguatamente, gli
scambi economici come una sorta di partita doppia sul modello di quelli che intercorrono tra
individui o aziende di piccole dimensioni. Al contrario, la natura complessa degli strumenti
finanziari, come i derivati, e la loro gigantesca scala di grandezza, relativa a grandi imprese
multinazionali o alle entità statali, nazionali e sovranazionali, modificano profondamente il loro
statuto ontologico.
Non si tratta più d’un debito del quale il debitore è comunque responsabile e, in qualche modo
anche colpevole20, quanto d’una nuova modalità di «appropriazione» e di «guerra» seppure
declinate in termini economici21. Derrida stigmatizza, già nel 1993, «l’aggravarsi del debito estero e
di altri meccanismi connessi che affamano o costringono alla disperazione una gran parte
dell’umanità e che tendono così a escluderla contemporaneamente dal mercato che questa logica
cercherebbe tuttavia di estendere»22. L’ontologia stessa del debito dovrebbe, allora, essere ripensata
nel contesto della metafisica della semplice presenza della quale essa costituirebbe uno degli ultimi
prodotti storici.
12
Appelbaum (2009), p. 6.
Cfr. Derrida (2017), pp. 11-369 e Appelbaum (2009), pp. 7, 24.
14
Derrida (1997), p. 31.
15
Cfr. Hull (1997).
16
Cfr. Chung-Hsiung (2016).
17
Cfr. Debrix (1999).
18
Derrida (1994), p. 51.
19
Ivi, p. 56.
20
Cfr. Stimilli (2015).
21
Derrida (1994), pp. 102-103.
22
Ivi, p. 106.
13
292
�“L’effetto fantasma”: Jacques Derrida e l’“iperfenomenologia”
Derrida ha in mente anche questo genere di problemi quando si propone d’interpretare
retroattivamente la critica marxiana come una sorta di iperfenomenologia applicata all’ontologia
economica. Il futuro del marxismo, nella prospettiva derridiana, sarebbe costituito da una pratica
spettrale che potrebbe contribuire anche a decostruire il pensiero unico neoliberista e
neocapitalista23. Spettri di Marx ci aiuta a comprendere come la filosofia, anche quella di sofisticata
marca fenomenologica, sia ancora condizionata dalle ipoteche metafisiche che la inducono ad
aderire al privilegio della presenza e della coscienza, concepite quali fondamenti del sapere
filosofico, scientifico, economico e politico. In questa prospettiva possiamo ripensare l’amara
costatazione di Friedrich Engels e Marx secondo i quali «le idee della libertà di coscienza […]
furono soltanto l’espressione del dominio della libera concorrenza nel campo della coscienza»24.
Derrida sembrerebbe pensare a questo brano quando afferma che
mai la democrazia liberale a forma parlamentare è stata così minoritaria e isolata nel mondo […]. La
rappresentatività elettorale o la vita parlamentare non è solo falsificata, come è sempre stato, da un gran
numero di meccanismi socio-economici, ma si esercita sempre peggio in uno spazio pubblico
profondamente sconvolto dagli apparati tecno-tele-mediatici e dai nuovi ritmi dell’informazione. 25
Le recenti vicende del cosiddetto Russiagate e l’influenza delle manipolazioni comunicative sulla
vita democratica costituiscono solo l’ultima tragica conferma delle riflessioni del filosofo francese.
Derrida è convinto che il «buon senso fenomenologico della cosa stessa» possa applicarsi solo a
quell’aspetto del valore che Marx considera come caratteristico dell’uso delle merci. Egli, per tale
motivo, mette in guardia il lettore da quelle deformazioni ideologiche della fenomenologia che
assumono la forma di un sofisticato «discorso sul valore d’uso» il cui fine ultimo sarebbe quello di
«non pensare il mercato»26. Quest’ultimo appare al senso comune, oggi come al tempo di Marx,
sotto la forma d’un fenomeno naturale e indiscutibile, oggetto ideologico d’una coscienza che può
definirsi fenomenologica malgrado la sua falsità.
2. Fenomenologie
La fenomenologia è un elemento fondamentale della formazione di Derrida al punto che
frequentemente rivolge la sua riflessione verso di essa per orientarsi nel suo percorso teorico. Il
termine ha conosciuto molteplici significati, da quando venne coniato da Johann Heinrich Lambert
nel 1764, ma Spettri di Marx ne considera soprattutto due costituiti rispettivamente dall’accezione
hegeliana e da quella husserliana e heideggeriana27. Derrida aveva già proposto elementi di critica
antiumanistica e anticoscienziale, molti anni prima, sottolineando come Hegel si sia rifiutato di
«pronunciare la parola “uomo” nella Fenomenologia dello spirito e descrive […] per esempio la
dialettica del signore e del servo […], senza alcun riferimento antropologico, nel campo di una
scienza della coscienza, cioè della fenomenicità stessa»28.
Derrida tenta d’approfondire la ricerca fenomenologica, incrociandola con quella marxiana, per
indagare quelle «condizioni di possibilità dell’esperienza» che oltrepassano i confini delle ricerche
husserliane dedicate all’intenzionalità coscienziale29. Questo riferimento contribuisce a chiarire,
almeno storicamente, perché egli si rivolga a Hegel, come a suo tempo già fece Marx, per articolare
alcune delle sue argomentazioni tese a oltrepassare quelli che considera come limiti della ricerca
husserliana. Derrida si propone, infatti, di «risalire alla genesi dell’esperienza della coscienza a
23
Ivi, p. 51.
Engels, Marx (1998), p. 50.
25
Derrida (1994), pp. 102-103.
26
Ivi, p. 189, corsivo dell’autore.
27
Lo dimostrano 13 delle complessive 37 occorrenze del sostantivo “fenomenologia” (e del relativo aggettivo
“fenomenologico”) che sono direttamente o indirettamente pertinenti a quella dello spirito hegeliana. Le occorrenze
restanti riguardano la fenomenologia novecentesca nella sua interpretazione husserliana o heideggeriana.
28
Derrida (1971), p. 164.
29
Facioni, Regazzoni, Vitale (2012), p. 22.
24
293
�Fabrizio Palombi
partire dalla sua costituzione naturale quale individualità vivente»30. Il conseguimento di questo
risultato impone, di conseguenza, la decostruzione di quel vero e proprio caposaldo della
fenomenologia husserliana che è costituito dal «presente vivente»31.
Tale lavoro decostruttivo viene riproposto con modalità diverse in momenti differenti del suo
itinerario teorico che intendiamo chiarire considerando sommariamente alcune tappe, alquanto
distanti tra loro cronologicamente, costituite da La voce e il fenomeno (1967), La scrittura e la
differenza (1967) e, ovviamente, da Spettri di Marx (1993). Il primo testo affronta tale questione,
con argomentazioni ed esempi appartenenti alla tradizione fenomenologica novecentesca, per così
dire, più ortodossa, usando estese citazioni husserliane volte a esaminare la problematica
fondazione temporale della «presenza immediata della coscienza all’intuizione»32. La riflessione
dedicata al contesto sul quale si staglia tale immediatezza coscienziale evidenzia alcuni suoi
caratteri aporetici dovuti alla sua secondarietà e differenzialità. Più in particolare, sarebbe proprio
una forma di
alterità […] la condizione della presenza […], prima di tutte le dissociazioni che potrebbero produrvisi. La
differenza tra la ritenzione e la riproduzione, tra il ricordo primario e […] secondario, è la differenza, che
Husserl vorrebbe radicale, non tra la percezione e la non-percezione ma tra due modificazioni della nonpercezione.33
La coscienza, di conseguenza si rivelerebbe progressivamente come «effetto e non origine» di un
complesso processo che si potrebbe definire come di «ri-rap-presentazione»34. Derrida prova a
ripensare i limiti del coscienzalismo fenomenologico che altrove aveva affrontato per mezzo della
psicoanalisi o della filosofia heideggeriana. Non ci sembra improprio richiamare, a tal proposito, la
tesi formulata da Engels e Marx secondo la quale «la coscienza non può mai essere qualche cosa di
diverso dall’essere cosciente, e l’essere degli uomini è il processo reale della loro vita […]. Non è la
coscienza che determina la vita, ma la vita che determina la coscienza»35.
Il primo periodo citato sembra abbastanza vicino alla tesi fondamentale dell’intenzionalità
husserliana per la quale la coscienza è sempre coscienza di qualcosa. Il secondo, invece, pare
anticipare, sebbene in forma materialistica e storicamente condizionata, il carattere secondario della
coscienza sostenuto da Derrida.
Spettri di Marx richiama queste analisi ma soprattutto usa il fantasma come caso esemplare di
fenomeno che eccede costitutivamente e irriducibilmente la presenza e la sua genesi temporale
costituita dal presente. Derrida non scava all’interno dell’ordinaria esperienza, per mostrare
l’importanza dei suoi aspetti aporetici rispetto alla teoria husserliana, ma vi oppone il fantasma
come paradigma dei fenomeni che non possono essere assimilati alla presenza.
3. La piega fenomenologica
Il fantasma ha dei fratelli che evochiamo rapidamente per poi considerare la prima accezione
derridiana del termine iperfenomenologia e i suoi limiti condizionati dall’aptocentrismo. Dello
spirito, Heidegger e la questione (1987), Spettri di Marx ed Ecografie della televisione (1996)
sviluppano le analisi derridiane usando una serie che a noi, parafrasando Derrida, piace definire
spettrale.36 Essa è costituita da quattro termini parzialmente sinonimici ovvero spettro, revenant,
spirito e fantasma. Nei brani di rilevanza fenomenologica che consideriamo vengono tematizzati
soprattutto il primo e l’ultimo termine assimilando a essi anche lo spirito. Per questi motivi
30
Ibidem.
Ivi, p. 23.
32
Ibidem.
33
Derrida (1968), p. 103.
34
Facioni, Regazzoni, Vitale (2012), p. 24.
35
Marx, Engels (1972), p. 13.
36
Derrida esamina la sorta di autocensura metodologica heideggeriana volta a evitare termini come “soggetto”,
“anima”, “coscienza”, “spirito”, “persona” in Essere e tempo definendola come «serie soggettiva» Derrida (2010), pp.
26-27 e Heidegger (1976), pp. 69-70; la nostra definizione parafrasa quella derridiana.
31
294
�“L’effetto fantasma”: Jacques Derrida e l’“iperfenomenologia”
dedichiamo particolare attenzione, in questa sede, al fantasma, allo spettro e alle loro occorrenze
concentrate nell’ultimo capitolo di Spettri di Marx37 per evidenziare quel peculiare effetto evocato
nel titolo del presente contributo.
La corrente fondata da Husserl si propone, almeno da un certo punto di vista, come radicalmente
antimetafisica perché mette in questione una delle polarità fondamentali della tradizione filosofica
occidentale costituita dall’opposizione tra essere e apparire. L’ontologia fenomenologica afferma
che l’essere è costituito dalla totalità delle sue manifestazioni, alle quali sono dedicate le
dettagliatissime analisi husserliane, dissolvendo l’opposizione tra il mondo e il suo manifestarsi38.
Derrida tocca, a suo modo, tale questione metafisica ribattezzandola con la suggestiva
definizione di «piega fenomenologica» nella quale si tratta di pensare «quella differenza, decisiva e
insieme inconsistente, che separa l’essere dall’apparire. L’apparire dell’essere, in quanto tale, in
quanto fenomenicità del suo fenomeno, è e non è l’essere che appare, e questa è la piega
dell’unheimlich»39.
La piega ha un carattere inquietante e perturbante, definito dal termine tedesco di sapore
freudiano unheimlich, perché evoca tutta la storia dell’ontologia e delle sue evanescenti opposizioni
che Heidegger si prefiggeva di decostruire in Essere e tempo40. Il paragrafo 7 di quest’ultimo
affronta la questione distinguendo i significati delle parole tedesche Phänomen, Schein e Erscheinung
in relazione al problema della manifestazione 41.
Il primo termine indica «ciò che si manifesta in se stesso»42 come chiarisce l’etimologia greca
del termine phainomenon e del verbo phaino che, nelle sue varie forme, esprime il «mostrare,
mettere in luce, far conoscere […] divenire visibile, venire alla luce, mostrarsi, apparire»43.
Heidegger evidenzia come questi significati richiamino, direttamente o meno, la luce, phos in
greco44, come condizione di possibilità dello stesso manifestarsi45. In virtù dei nostri interessi è
interessante sottolineare che tra i molteplici termini composti derivati da phaino si trova anche la
parola phantasma con il significato di «apparizione», «immagine» e, appunto, «fantasma»46.
Derrida evidenzia queste derivazioni etimologiche, nelle quali la sua ricerca incrocia la
fenomenologia heideggeriana, affermando che il sostantivo greco phantasma, «figura», «visione» e,
più in generale, immagine sia da ricondurre al «phainesthai» e alla «fenomenalità»47. Torneremo
sulla questione ma, per il momento, ci limitiamo a sottolineare che, per Heidegger, il fenomeno
sarebbe «ciò che […] viene in chiaro all’interno di un determinato orizzonte luminoso»48. Schein,
invece, esprime la «parvenza» intesa come «modificazione privativa» del fenomeno nella quale
qualcosa si mostra come essa non è.
37
Relativamente all’analisi di questi concetti derridiani e, in particolare, di quello di revenant, che non toccheremo
in questo contributo che abbiamo già trattato in Palombi (2017a), pp. 274-276. Rinviamo, inoltre, a Appelbaum, (2009),
pp. 13, 19-21, 93; Kochhar-Lindgren, G. (2011), pp. 40, 71, 74, 76, 179.
38
Relativamente agli aspetti linguistici e pratici che limitano il carattere antimetafisico della fenomenologia, già
denunciati dal secondo Heidegger, rinviamo al saggio intitolato La différance in Derrida (1997), pp. 27-59. Cfr. inoltre
Vergani (2000), pp. 37-51.
39
Derrida (1994), p. 183.
40
Ci sembra importante sottolineare come Gilles Deleuze abbia insistito in diversi luoghi della propria opera sul
senso del concetto di piega per la fenomenologia heideggeriana. Più precisamente, Deleuze legge nello Zwiefalt
(concetto che compare per un periodo limitato nell’opera del pensatore tedesco) una piega della differenza che motiva e
alimenta il superamento e il distacco da Husserl. Cfr. Deleuze (1971), p. 111 nota 23. Ringraziamo Claudio D’Aurizio
per questo prezioso suggerimento.
41
Heidegger (1976), pp. 46-51; cfr. Fabris, 2000, p. 68 e Kochhar-Lindgren, G. (2011), pp. 56-63.
42
Heidegger (1976), p. 48, corsivi dell’autore.
43
Chantraine (1984), p. 1170. Ringraziamo Francesca Biondi per il prezioso confronto su questo tema.
44
Heidegger (1976), p. 47.
45
Cfr. Kochhar-Lindgren, G. (2011).
46
Chantraine (1984), p. 1171.
47
Derrida, Stiegler (1997), p. 131.
48
Fabris (2000), p. 68.
295
�Fabrizio Palombi
I significati dei primi due termini esaminati da Heidegger si distinguono radicalmente da quello
del terzo, definito come «semplice apparenza»49, che esprime «qualcosa che non è necessariamente
destinato a una piena manifestazione»50. Il Phänomen, secondo Heidegger, non può in alcun caso
essere Erscheinung mentre quest’ultimo rimanda sempre a una qualche forma del primo poiché
preannuncia qualcosa di differente. Heidegger, in questa prospettiva critica Immanuel Kant perché
avrebbe
confuso […] ciò che viene indicato dai concetti di Phänomen e di Erscheinung, e […] ha interpretato
quest’ultima come il prodotto, […] di una cosiddetta “cosa in sé”, che però è tale da non potersi mai
esprimere completamente nelle sue apparizioni. Ha ragione quindi la successiva riflessione filosofica, da
Hegel fino a Husserl, a recuperare in pieno la rivelatività del fenomeno, eliminando ogni costitutivo
rimando di quest’ultimo a ciò che non si rivela.51
4. Ottica e ontologia
La luce e le sue metafore costituiscono il fulcro della nostra analisi del testo derridiano e, in
particolare, del suo tentativo di rovesciare la fenomenologia in una spettrologia, come vedremo tra
poco. Dobbiamo, allora, brevemente soffermarci su questo aspetto per evitare di trattare in modo
ingenuo tale strategia metaforica che è, invece, pesantemente condizionata dalle stratificazioni della
tradizione filosofica.
La critica dell’ontologia della presenza deve considerare questi aspetti ottici in quanto il pensiero
filosofico dell’essere viene da essi, esplicitamente o implicitamente, influenzato. Lo stesso
Heidegger formulando la sua definizione di fenomenologia come ermeneutica, ancora nel paragrafo
7 di Essere e tempo, presta particolare attenzione a tale questione coniugando l’etimologia del
fenomeno, che richiama la luce, con quella del logos, che evoca pensiero e parola. Tale questione
accompagnerà una gran parte della sua riflessione che articolerà vista, linguaggio e udito per trovare
nella metafora della Lichtung la condizione di possibilità chiaroscurale 52 della luce e del buio. Il
filosofo tedesco si sarebbe mosso, secondo la critica di Emmanuel Levinas ripresa da Derrida,
«all’interno di una tradizione greco-platonica, controllata […] dalla metafora della luce»53.
Il nostro autore è consapevole di questo problema e aveva esaminato, anni prima, la disamina
levinasiana alla fenomenologia che, sulle orme di Platone, doveva risultare più d’ogni altra
filosofia, investita di luce. Levinas critica l’impostazione fenomenologica perché, non essendo stata
«capace di ridurre l’estrema ingenuità, quella dello sguardo […] predeterminava l’essere come
oggetto»54. Derrida sottolinea la difficoltà di «costruire un discorso filosofico contro la luce» ed
evidenzia come lo stesso Levinas, in alcuni suoi brani, ricada all’interno di quelle stesse metafore
luminose che intendeva criticare seppure nella forma etica d’una sorta di metaluce oppure in quella
della epifania del volto55. Tutte queste argomentazioni filosofiche e le loro innumerevoli varianti
sembrerebbero irrimediabilmente coinvolte in una sorta di conflitto interno all’ottica potendo
variare «soltanto la stessa metafora […] scegliendo la luce migliore»56.
Allora, nell’impossibilità di sottrarsi a questa immane fotomachia, Derrida ritiene opportuno
radicalizzarla fenomenologicamente rivolgendosi ai fantasmi. Sarebbe, forse, questa la direzione
che prende l’iperfenomenologia derridiana quando lavora decostruttivamente sulle metafore ottiche
e sul tentativo di criticarle. Infatti, «non potendo sfuggire all’ascendenza della luce, anche la
metafisica presuppone sempre una fenomenologia, nella sua critica stessa della fenomenologia»57.
49
Heidegger (1976), p. 48.
Fabris (2000), p. 68.
51
Ivi, pp. 68-69.
52
Cfr. Kochhar-Lindgren, G. (2011), p. 64.
53
Derrida (1971), p. 112; cfr. Appelbaum (2009), p. 30 e Kochhar-Lindgren, G. (2011), pp. 44-45.
54
Ivi, p. 107.
55
Ivi, pp. 107-108.
56
Ivi, pp. 116-117.
57
Ivi, p. 149.
50
296
�“L’effetto fantasma”: Jacques Derrida e l’“iperfenomenologia”
5. Critica dell’aptocentrismo
La derivazione del fenomeno, studiato dalla fenomenologia, e del fantasma, criticato dalla filosofia
marxiana, al verbo phaino e alla luce ci riconducono, almeno implicitamente, al primo esergo. Il
brano evoca la critica rivolta a ogni ontologia affetta da forme fantasmatiche che
comprometterebbero la presenza in carne e ossa. Marx e Stirner intenderebbero, ciascuno con le
proprie modalità e scopi, esorcizzare e smontare un’ontologia ispirata dalla teologia cristiana che
Derrida interpreta in senso fenomenologico. Il punto d’arresto della loro critica sarebbe costituito da
una sorta di limite «iperfenomenologico» costituito dalla «persona vivente» e dalla «sua presenza
effettiva e non fantomatica»58.
La letteratura romantica e popolare dedicata ai fantasmi concorda nel descrivere queste entità
come incorporee e suscettibili d’essere colte solo dalla vista o dall’udito ma non dagli altri sensi e,
in particolare, dal tatto. Sembrerebbe che Derrida, attraverso la disamina critica del dibattito tra
Marx e Stirner, consideri gli effetti filosofici d’una diffusa critica alla fenomenologia sviluppatasi
nel Novecento. Pensiamo, più precisamente, all’accusa secondo la quale la fenomenologia
attribuirebbe un primato alla vista e ai concetti a essa correlati, come quelli prospettici, a discapito
degli altri sensi e, soprattutto, della loro sinergia59.
Una risposta a tali critiche è costituita dalle ricerche dei fenomenologi francesi che valorizzano
nella riflessione husserliana l’importanza dell’esperienza tattile e delle sue varie forme. Nei testi di
Levinas e Maurice Merleau-Ponty, per esempio, l’analisi delle esperienze tattili sembrerebbe
«offrire la possibilità di sottrarre la fenomenologia alle maglie della metafisica»60 che ripropone, in
forma ottica, l’opposizione tra essere e apparire. Nei loro testi, la piega fenomenologica si
presenterebbe in una forma tranquillizzante che sembrerebbe, finalmente, capace di fare coincidere
noesi e noema. Il decorso autoaptico sarebbe in grado di piegare il tessuto dell’intenzionalità
facendo coincidere i suoi poli, soggettivo e oggettivo, attraverso l’identificazione tra colui che tocca
e quello che viene toccato.
Derrida è insoddisfatto dalla loro proposta perché, incapace d’oltrepassare i limiti della
riflessione husserliana, resterebbe ancora interna a un’ontologia coscienzialistica condizionata dalla
forma temporale della presenza. Il filosofo francese non sottovaluta l’importanza delle esperienze
tattili e, in particolare, di quelle autotattili, ma ritiene che esse non siano in grado d’uscire dai limiti
intuizionistici della tradizione fenomenologica 61. Si tratterebbe, infatti, d’un modo, per quanto
raffinato, di ribadire il primato della coscienza e della sua purezza quando esso assuma la forma
autoreferenziale del soggetto che tocca se stesso. Il problema non è quello di contestare la
possibilità di simili forme d’esperienza quanto quello di prendere atto delle loro conseguenze
teoriche qualora il tatto sostituisca la vista come modello paradigmatico o privilegiato
dell’esperienza. Ci si potrebbe chiedere, in altre parole,
se vi sia una pura auto-affezione del toccante o del toccato, dunque una pura esperienza immediata […], del
corpo proprio […], puramente vivente. O se, al contrario, questa esperienza non sia già […],
costitutivamente assillata, da qualche etero-affezione legata alla spaziatura, poi alla spazialità visibile, un
pharmakon che, disponendo già del suo alloggio sul posto, abita spettralmente qualsiasi foro interiore. 62
Il filosofo francese, con queste parole, rievoca gran parte del proprio percorso teorico per sostenere
che «il privilegio dell’auto-affezione tattile» costituirebbe una semplice «variante della metafisica
58
Derrida (1994), pp. 239-240, n. 19, corsivi dell’autore.
Cfr. Palombi (2017b), pp. 61-67.
60
Facioni, Regazzoni, Vitale (2012), pp. 37-38.
61
Cfr. Ivi, p. 38.
62
Derrida (2007), pp. 229-230.
59
297
�Fabrizio Palombi
della presenza», ribattezzata come aptocentrica63. Derrida individua una precisa coordinata per la
critica al privilegio della presenza assoluta che vedrebbe le sue basi minacciate dai pericoli della
«non-presenza» e della «mediazione». Tale minaccia si collocherebbe nel passaggio dalla
«ritenzione» alla «ri-presentazione» che è fondamentale per la costituzione della presenza di un
oggetto la cui identità possa essere temporalmente ripetuta soprattutto quando quest’ultimo sia
costituito da «l’alter ego»64. Tale questione renderebbe problematica, secondo il filosofo francese,
la stessa possibilità fenomenologica della costituzione d’una oggettività ideale in generale.
6. L’escamotage fenomenologico come rovescio del fenomeno
Il problema generale della fenomenologia, come abbiamo sin qui visto, è quello della
manifestazione del fenomeno come orizzonte ontologico universale. Heidegger, per esempio,
commenta, nel paragrafo 7 di Essere e tempo, il motto husserliano «verso le cose stesse»
richiamando il significato greco delle due parole, “fenomeno” e “logos”, che compongono il
termine “fenomenologia”. Quest’ultimo, secondo il filosofo tedesco, esprimerebbe l’apophàinestai
ta phainòmena ovvero la tensione a «lasciar vedere da se stesso ciò che si manifesta, così come si
manifesta da se stesso»65. Derrida attribuisce al fantasma il valore di un modello ontologico che,
eccedendo quello della semplice presenza, sembra in grado di rovesciare la posizione
heideggeriana. Cerchiamo d’esplicitare la posizione del filosofo francese parafrasando la formula
heideggeriana, appena ricordata, per proporre un’interpretazione fantasmatica della fenomenologia
che potremmo definire come “lasciar nascondere da se stesso ciò che si nasconde, così come si
nasconde da se stesso”.
Potremmo sostenere, in modo grossolano ed esplicativo, che la fenomenologia parte dal rivelarsi
delle cose per pensare il loro occultarsi come un caso particolare del primo. Derrida sembra voler
rovesciare tale impostazione e pone la manifestazione come una possibilità particolare della
generale condizione d’occultamento del fenomeno rielaborando un modello argomentativo che
trova uno dei suoi principali riferimenti teorici nel dibattito su La lettera rubata (1845) di Edgar
Allan Poe66. Potremmo ancora dire, in altre parole, che anche il manifestarsi sarebbe una modalità
dell’occultarsi, del nascondersi, dei fenomeni. Questa prospettiva invertita era stata già adombrata,
come abbiamo visto, molti anni prima in un saggio dal titolo Violenza e metafisica. Saggio sul
pensiero di Emmanuel Levinas (1964)67 quando, riflettendo sulla problematicità dell’altro, giungeva
a sostenere la sua caratteristica «fenomenicità come sparizione»68. Il nostro autore ritorna
estesamente sulla questione nell’ultimo capitolo di Spettri di Marx che è significativamente
intitolato: «apparizione dell’inapparente: l’“escamotage” fenomenologico»69.
È possibile intendere il termine francese apparition, usato da Derrida, come una traduzione
dell’heideggeriano schein che Pietro Chiodi esprime in italiano con «parvenza»? In caso di risposta
affermativa le possibili relazioni semantiche di queste parole nelle tre lingue potrebbero, forse,
fornire un sostegno lessicale al rovesciamento di prospettiva teorica che sembrerebbe proporre
Derrida. Lo dimostrerebbe anche la lunga riflessione sulla parola francese «escamotage» proposta
da Spettri di Marx: il termine deriva dal verbo «escamoter», che significa “fare scomparire
qualcosa”, come accade nei trucchi dei prestigiatori. Escamotage indica in francese «anzitutto il
gioco […] con cui l’illusionista fa sparire anche il corpo più sensibile. Si tratta di un’arte o di una
tecnica del far sparire. L’escamoteur sa rendere inapparente. È l’esperto d’una
iperfenomenologia»70.
63
Facioni, Regazzoni, Vitale (2012), pp. 37-38. Sulla «complicazione originaria» tra empirico e trascendentale
propria della fenomenologia cfr. Vergani (2000), pp. 27-28, 100-101.
64
Derrida, 2010, p. 35.
65
Heidegger (1976), p. 55. Cfr. Kochhar-Lindgren, (2011), p. 48.
66
Cfr. Palombi (2011) e (2014).
67
Derrida (1971), pp. 99-198.
68
Ivi, p. 164, corsivo nostro.
69
Derrida (1994), pp. 159-220.
70
Ivi, p. 162, corsivi dell’autore.
298
�“L’effetto fantasma”: Jacques Derrida e l’“iperfenomenologia”
Alcuni aspetti della riflessione di Derrida richiamano alla nostra mente la Darstellungmethode
marxiana esaminata da Louis Althusser soprattutto per gli aspetti teatrali che sempre caratterizzano
il gioco di prestigio. La lingua tedesca traduce la parola italiana “rappresentazione” con due termini
distinti: Vorstellung e Darstellung. Il primo può essere più facilmente assimilato al processo del
portare alla presenza in un senso vicino a quello criticato da Derrida che, in diverse occasioni,
precisa l’accezione di “rappresentazione”, da lui considerata, usando proprio questo termine
tedesco71.
La parola Darstellung possiede, invece, un’etimologia che richiama, direttamente o meno, una
“rappresentazione” nel senso italiano della messa in scena teatrale 72. Pensiamo, soprattutto, al passo
nel quale Derrida usa diverse metafore relative a quest’ultimo contesto affermando che
Marx deve ricorrere al linguaggio teatrale e descrivere l’apparizione della merce come una entrata in scena
[…], descrivere il tavolo divenuto merce [...] come una silhouette fantomale, la raffigurazione di un attore o
di un ballerino. Figura teo-antropomorfa […] il tavolo ha piedi […], una testa, il suo corpo si anima. 73
Il principale escamotage de L’ideologia tedesca sarebbe costituito dalla possibilità di usare il
tedesco Geist sia nell’accezione di “spirito”, sia in quella di “spettro” o “fantasma”; abbiamo già
esaminato in un precedente contributo74 questi diversi significati che ricordiamo qui brevemente.
L’accezione del primo termine evoca gli aspetti più metafisici che caratterizzano l’analisi filosofica
della soggettività, in particolare, di quella hegeliana. Quella del secondo possiede un valore
scientifico che richiama l’operazione di decomposizione d’un fenomeno elettromagnetico nelle
lunghezze d’onda che lo costituiscono. Un approccio analitico che, almeno metaforicamente,
associa l’approccio spettrale a quello della classica pratica decostruttiva derridiana. Si deve, inoltre,
considerare il processo inverso che permette di sintetizzare fenomeni complessi a partire dalla
composizione di elementi più semplici. Il terzo, come vedremo tra poco, evoca maggiormente gli
aspetti relativi alla manifestazione d’un individuo defunto o di un’entità soprannaturale.
Derrida ritiene che la differenza e la distinzione tra i primi sia proprio quello che «tende a
scomparire nell’effetto fantasma»75 nel quale lo spirito assume una natura ecloplasmatica. Il
dibattito tra Marx e Stirner viene riassunto in un confronto nel quale ognuno dei due accusa l’altro
d’ipostatizzare, di dare indebita materialità, a dei semplici fantasmi76. L’argomentazione marxiana,
in particolare, accusa l’avversario di autonomizzare scorrettamente lo spirito attribuendogli
addirittura una forma carnale. Derrida definisce come «processo spettrogeno» la possibile
reversibilità del decorso precedentemente descritto: si tratterebbe d’una sorta di spettralizzazione
inversa nella quale si sintetizza un fenomeno associandogli aspetti concreti che non gli competono.
Tale ipostatizzazione corrisponderebbe, infatti, a una forma di «incorporazione paradossale. Una
volta separati l’idea o il pensiero […] dal loro substrato, si produce un fantasma dando loro un
corpo»77. Il «processo spettrogeno» corrisponderebbe, nell’interpretazione derridiana del testo di
Marx, a una «posizione dialettica» nella quale il «corpo fantomale» si sostituisce a quello che la
fenomenologia definisce come “proprio”78. Derrida prosegue la sua argomentazione sovrapponendo
le categorie husserliane a quelle marxiane per esaminare il suo «effetto fantasma» e concludere che
il processo stirneriano di «riduzione fenomenologica del fantasma» viene criticato da Marx come
«riduzione fenomenologica al fantasma»79.
71
Pensiamo, per esempio, a un brano già considerato nel quale si riflette sulla «condizione della presenza»
precisando che s’intende «della Vorstellung in generale», Derrida (1968), p. 103. In Spettri di Marx esistono almeno 5
occorrenze di questo tipo.
72
D’Alessandro (1980), pp. 180-181 e n. 27.
73
Derrida (1994), pp. 190; cfr. anche pp. 242-243 n. 44.
74
Cfr. Palombi (2017a), pp. 271-274.
75
Derrida (1994), p. 159.
76
Ivi, pp. 159, 160, 163.
77
Ivi, p. 160, corsivi dell’autore.
78
Ivi, p. 162.
79
Ivi, p. 164, corsivi dell’autore.
299
�Fabrizio Palombi
7. Una spettralizzazione della fenomenologia
Derrida procede nel rovesciamento delle argomentazioni marxiane mostrando come il fantasma non
sia un problema per la contemporaneità ma, piuttosto, una possibile soluzione ai suoi dilemmi
ontologici. Ci concentriamo, in particolare, su due pagine e una nota dell’ultimo capitolo di Spettri
di Marx per tentare di chiarire la complessa e, per certi aspetti, involuta prosa derridiana 80. Tali
brani potrebbero contribuire a comprendere come Derrida possa slittare dalla Fenomenologia dello
spirito hegeliana sino a quella husserliana ed heideggeriana, passando per la critica dell’economia
politica marxiana. Il filosofo francese propone «una logica del phaínesthai e del phántasma»
affermando temerariamente che «ogni fenomenologia» riguarderebbe, in qualche modo, fantasmi e
processi di spettralizzazione81.
Accennando ad alcuni fondamenti della teoria fenomenologica Derrida afferma che l’approccio
spettrale potrebbe essere applicato a «ogni cogito» in modo che la fenomenologia sia intesa come
una «fenomenologia dello spettro»82. I due poli della relazione intenzionale sono così riformulati in
modo che la «forma fenomenica del mondo» e «l’ego fenomenologico» possano essere interpretati
spettralmente83.
Husserl e Heidegger sono evocati per esaminare in modo raffinato l’opposizione tra reale e
irreale attraverso il possibile «effetto di un trattamento ontologico della spettralità del fantasma».
Non dobbiamo dimenticare, infatti, che il fantasma è considerato, al tempo di Marx come oggi, alla
stregua d’un paradigma dell’irrealtà. Una tale operazione teorica dev’essere irriducibile alle
tradizionali opposizioni concettuali tra presenza e assenza, visibile e invisibile, vivente e morto e,
più in generale a tutte quelle di tipo dialettico84. Si tratta di un periodo estremamente denso dal
punto di vista teorico che deve essere ulteriormente e faticosamente decompresso e interpretato.
Derrida ritiene importante considerare quale vantaggio per la comprensione ontologica possa
derivare dall’analisi dei fenomeni fantasmatici e cerca di sviluppare questo compito per mezzo
d’alcune riflessioni fenomenologiche che, purtroppo, restano in gran parte solo abbozzate. Esse
sono contenute in una lunga nota nella quale il filosofo francese espone alcuni ragionamenti che
sono molto significativi per i nostri interessi. Derrida considera, innanzitutto, una prospettiva
ortodossa supportata da una «buona logica husserliana» per prospettare una «fenomenologia dello
spettrale». Questo primo e tradizionale approccio consiste nell’individuazione d’una specifica area
«regionale» quale potrebbe essere quella relativa «all’immagine» richiamando quella peculiare
accezione del fantasma alla quale avevamo precedentemente accennato85.
A nostro avviso, una “buona” interpretazione della fenomenologia husserliana consiste nel
ribadire la sua portata rivoluzionaria che sovverte ogni pretesa originarietà del soggetto o
dell’oggetto per ricomprendere il senso della loro opposizione come derivata rispetto
all’intenzionalità. La fenomenologia, in altre parole, non attribuisce priorità al soggetto oppure
all’oggetto per poi discutere le loro possibili relazioni come è consuetudine della tradizione
filosofica. La fenomenologia, al contrario, pensa la relazione intenzionale come originaria per porre
ai suoi poli un correlato soggettivo e uno oggettivo. Husserl ritraduce tale opposizione nel proprio
lessico usando appunto i termini di «noema» e «noesi», evocati da Derrida, che possono essere
rispettivamente definiti come i «correlati soggettivi» e quelli oggettivi dell’intenzionalità86. Questi
due termini possiedono la medesima radice greca costituita dal «verbo noein che significa
80
Ivi, pp. 169, 171 e 237, n. 12. Sull’importanza generale delle “note” per Derrida e, in particolare, per alcune di
quelle che corredano Spettri di Marx cfr. Palombi (2017a).
81
Derrida (1994), p. 169; cfr. Appelbaum (2009), pp. 29-30, 126 nn. 13 e 14.
82
Ibidem.
83
Ivi, p. 171.
84
Derrida (1994), p. 118 e Derrida, Stiegler (1997), pp. 24, 27; Kochhar-Lindgren (2011), pp. 66.
85
Derrida (1994), p. 237, n. 12.
86
Sokolowski (2002), pp. 78-79; cfr. Appelbaum (2009), p. 30 e Kochhar-Lindgren (2011), pp. 66.
300
�“L’effetto fantasma”: Jacques Derrida e l’“iperfenomenologia”
“pensare”, “considerare”, “percepire”. Il termine greco noesis significa un atto di pensiero, e […]
noema […] ciò che è pensato. In greco il suffisso –ma aggiunto a una radice verbale significa il
risultato o l’effetto dell’azione espressa nel verbo. Così, phantasma significa l’oggetto del
fantasticare»87.
Questa precisazione etimologica non deve indurre a interpretare erroneamente la nostra analisi
come uno spostamento da un piano filosofico, vincolato dal rigore argomentativo, verso quello
letterario e narrativo, assolutamente libero e privo di condizionamenti logici. Al contrario l’analisi
lessicale deve contribuire a meglio comprendere il potenziale filosofico del noema. Infatti, il
concetto husserliano è così esteso da poter essere applicato a «ogni oggetto di pensiero […]
considerato precisamente come […] il correlato d’una intenzionalità» senza che quest’ultimo sia
interpretato in senso naturale o psicologistico 88. Anche la speculazione aptocentrica, per esempio,
sembrerebbe seguire questa strada, sebbene con altri propositi, provando a piegare la struttura
intenzionale per far coincidere noesi e noema.
Derrida è, tuttavia, interessato a una seconda ed eterodossa prospettiva capace d’individuare «la
possibilità radicale» della spettralità nel noema husserliano come «inclusione intenzionale ma non
reale» che non può essere confinata nel mondo oggettivo o nel soggetto e diventerebbe, per questo,
«la condizione […] di ogni fenomenicità»89. Questo quadro adombra l’ipotesi di confrontare il
concetto husserliano di “noema” con quello di “spettro” in relazione alle loro comuni caratteristiche
di «irrealtà» e di «possibilità essenziale»90. Derrida legge interlinearmente il testo marxiano per
proporre un altro tipo d’iperfenomenologia capace di «far sparire producendo delle apparizioni» e
una suggestiva reinterpretazione dell’epoché come «riduzione fenomenologica del fantasma»91.
Queste considerazioni gli consentono di nascondersi dietro la maschera del filosofo di Treviri per
ritornare alle origini del proprio percorso intellettuale, proporre le sue ambizioni teoretiche e
decostruire le tradizionali interpretazioni filosofiche. In qualche modo, anche lui è già qui un
revenant che ricompare alle proprie speculazioni giovanili in forma spettrale.
Derrida sembra voler impostare una sorta di comparazione tra l’indagine fenomenologica e
l’analisi spettrale in quanto il «phaínesthai» costituirebbe una «possibilità» che precede
logicamente la «sua determinazione in fenomeno o in fantasma»92. Sono tesi estremamente
sofisticate e complesse che vengono, oltretutto, presentate in modo succinto e laconico e sono,
anche per questo, d’ardua interpretazione. Tuttavia, ci sentiamo d’ipotizzare che questa seconda
accezione derridiana d’iperfenomenologia sembri prospettare una radicalizzazione
dell’intenzionalità fenomenologica al di là delle accuse d’idealismo imputate alla filosofia
husserliana. Si potrebbe, forse, dire che il filosofo francese cerca di forzare i limiti della tradizione e
del lessico filosofico con la sua accezione di fantasma riproponendo un approccio analogo a quello
precedentemente tentato da Heidegger con la riflessione sulla Lichtung.
Derrida sembrerebbe percorrere questa strada non solo per approfondire il suo antico interesse
per la fenomenologia ma anche per sviluppare degli strumenti teorici utili per la critica
dell’economia politica contemporanea che abbiamo prima considerato. Tali problemi tendevano a
occultarsi, all’epoca di Marx e Stirner, perché adombravano fenomeni ancora inattuali per la società
del tempo. Si potrebbe pensare, attraverso la critica derridiana all’aptocentrismo, all’effetto
fantasma come a una sorta d’arto filosofico che mancava alla filosofia ottocentesca non perché le
fosse stato amputato ma perché, al contrario, essa non l’aveva ancora generato93.
I problemi del lavoro, del debito e d’una nuova internazionale, prospettati dal sottotitolo del testo
di Derrida, sono oggi più che mai attuali nel bicentenario della nascita di Marx. Una delle
87
Sokolowski (2002), p. 79.
Ivi, p. 80.
89
Derrida (1994), p. 237, n. 12, corsivi dell’autore.
90
Ivi, p. 237, n. 12.
91
Ivi, pp. 162, 164.
92
Ivi, p. 171.
93
Pensiamo in particolare a Merleau-Ponty (2003), pp. 77, 129.
88
301
�Fabrizio Palombi
condizioni della loro soluzione potrebbe, allora, essere chiasmaticamente sintetizzata dall’esigenza
di passare dalla critica del fantasma al fantasma come strumento critico della contemporaneità.
Bibliografia
Andronico, A. (2006), La disfunzione del Sistema. Giustizia, alterità e giudizio in Jacques Derrida,
Roma, Giuffré.
Appelbaum, D. (2009), Jacques Derrida’s ghost: a conjuration, State University of New York
Press, Albany.
Chantraine, P. (1984), Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots,
Klincksieck, Paris.
Chung-Hsiung, L. (2016), “On (Im)Patient Messianism: Marx, Levinas, and Derrida”, in Levinas
Studies, vol. 11, pp. 59-93.
D’Alessandro, P. (1980), Darstellung e soggettività. Saggio su Althusser, Firenze, La Nuova Italia.
Debrix, F. (1999), “Spectres of postmodernism: Derrida’s Marx, the New International and the
Return of Situationism”, in Philosophy & Social Criticism, vol. 25, n. 1, pp. 1-21.
Deleuze, G. (1971), Differenza e ripetizione, trad. it. a cura di G. Guglielmi, il Mulino, Bologna.
Derrida, J. (1968), La voce e il fenomeno. Introduzione al problema del segno nella fenomenologia
di Husserl, trad. it. a cura di G. Dalmasso, Jaca Book, Milano.
Derrida, J. (1969), Della grammatologia, trad. it. a cura di R. Balzarotti, F. Bonicalzi, G. Contri, G.
Dalmasso, A. C. Loaldi, Jaca Book, Milano.
Derrida, J. (1971), La scrittura e la differenza, trad. it. a cura di G. Vattimo, Einaudi, Torino.
Derrida, J. (1994), Spettri di Marx, trad. it. a cura di G. Chiurazzi, Raffaello Cortina, Milano.
Derrida, J. (1997), Margini della filosofia, trad. it. a cura di M. Iofrida, Einaudi, Torino.
Derrida, J. (2002), “Il cinema e i suoi fantasmi”, Aut aut, n. 309, pp. 52-68.
Derrida, J. (2007), Toccare. Jean-Luc Nancy, trad. it. a cura di A. Calzolari, Marietti, GenovaMilano.
Derrida, J. (2010), Dello spirito. Heidegger e la questione, trad. it. a cura di G. Zaccaria, SE,
Milano.
Derrida, J. (2017), La cartolina da Socrate a Freud e al di là, trad. it. a cura di S. Facioni e F.
Vitale, Mimesis, Milano.
Derrida, J.-Stiegler, B. (1997), Ecografie della televisione, trad. it. a cura di L. Chiesa, Raffaello
Cortina, Milano.
Engels, F.-Marx, K. (1998), Manifesto del partito comunista, trad. it. a cura di P. Togliatti, Meltemi,
Roma.
Fabris, A. (2000), Essere e tempo di Heidegger. Introduzione alla lettura, Carocci, Roma.
Facioni, S.-Regazzoni, S.-Vitale, F. (2012), Derridario. Dizionario della decostruzione, il
melangolo, Genova.
Grazioli, E. (2004), La polvere dell’arte, Milano, Bruno Mondadori.
Habjan, J. (2014), The Eighteenth Brumaire of Jacques Derrida, in Habjan, J.-Whyte, J. (Eds.),
(Mis)readings of Marx in Continental Philosophy, Palgrave Macmillan, London-New York, pp.
128-144.
Habjan, J.-Whyte, J. (Eds.) (2014), (Mis)readings of Marx in Continental Philosophy, Palgrave
Macmillan, London-New York.
Heidegger, M. (1976), Essere e tempo, trad. it. a cura di P. Chiodi, edizione a cura di F. Volpi,
Longanesi, Milano.
Hull, G. (1997), “The Jewish question revisited. Marx, Derrida and ethnic nationalism”, Philosophy
& Social Criticism, vol. 23, n. 2, pp. 47-77.
Kochhar-Lindgren, G. (2011), Philosophy, Art, and the Spectres of Jacques Derrida, Cambria
Press, Amhrest (New York).
Marx, K.-Engels, F. (1972), L’ideologia tedesca, trad. it. a cura di F. Codino, Editori Riuniti, Roma.
Merleau-Ponty, M. (2003), Fenomenologia della percezione, trad. it. a cura di A. Bonomi,
Bompiani, Milano.
302
�“L’effetto fantasma”: Jacques Derrida e l’“iperfenomenologia”
O’Malley, J. B. (1966), The Fellowship of Being: An Essay on the Concept of Person in the
Philosphy of Gabriel Marcel, Springer, Dordrecht.
Palombi, F. (2011), “La riproduzione interdetta: ermeneutica e ripetizione in un confronto tra Lacan
e Derrida”, Bollettino Filosofico, vol. 27, pp. 127-144.
Palombi, F. (2014), Un ripetuto occultamento. Jacques Lacan e “L’origine del mondo”, in
Bonicalzi, F.-Facioni, S. (a cura di), L’intrico dell’io, Milano, Jaca Book, pp. 145-162.
Palombi, F. (2017a), “Jacques Derrida e la logica spettrale”, in Giornale di Metafisica, vol. 1, pp.
265-281.
Palombi, F. (2017b), Elogio dell’astrazione. Gaston Bachelard e la filosofia della matematica,
Mimesis, Milano.
Poe, E. A. (2009), La lettera rubata, trad. it. a cura di F. Fantaccini, Mursia, Milano.
Postone, M. (1998), “Deconstruction as Social Critique: Derrida on Marx and the New World
Order”, History and Theory, vol. 37, n. 3, pp. 387-370.
Saghafi, K. (2010), Apparitions – Of Derrida’s Other, Fordham University Press, New York.
Sokolowski, R. (2002), Introduzione alla fenomenologia, Università della Santa Croce, Roma.
Spiegelberg, H. (2013), The Phenomenological Movement: A Historical Introduction, Springer, The
Hague.
Sprinker, M. (ed.) (1999), Ghostly Demarcations. A symposium on Jacques Derrida’s Specters of
Marx, Verso, London.
Stimilli, E. (2015), Debito e colpa, Ediesse, Roma.
Vergani, M. (2000), Jacques Derrida, Bruno Mondadori, Milano.
Zanardo, S. (2007), Il legame del dono, Vita e pensiero, Milano.
Abstract
In the late 1980s and the mid-1990s Derrida carried his research to a spectral turn, which has
hyperphenomenology as one of its results. The paper examines the main points of this Derridean
stage, starting from some short observations on Specters of Marx’s political aspects and analyzing,
then, certain dimensions of his “spectral logic.” The paper is particularly focused on the original
and complex analyses of the relation between phenomenology and the ghost. In Derrida’s volume,
at least two meanings of “hyperphenomenology” can be found: the first destructive, influenced by
the metaphysics of presence and the haptocentrism; the second constructive, which refines Husserl’s
method through a paradoxical overthrowing. The paper claims that the Derridean spectral turn starts
from a phenomenology of the ghost and comes to a ghostification of the phenomenon.
Keywords: Ghost, Hyperphenomenology, Derrida, Heidegger, Marx
303
�GIOVANNI PIANA*
“Occorre riflettervi ancora”.
Considerazioni in margine a Fantasia e immagine di Edmund Husserl
È recentemente stato pubblicato il volume di inediti husserliani riuniti sotto il titolo di Fantasia e
immagine (Rubettino, 2017), nella traduzione italiana dovuta a Claudio Rozzoni. Si tratta di una
parte del volume XXIII della Husserliana intitolato Erinnerung, Bidbewusstsein, Phantasie (1980), a
cura di Eduard Marbach. Vorrei cogliere questa occasione per alcune poche considerazioni intorno all’orientamento fenomenologico così come può oggi essere riconsiderato. Una discussione
realmente approfondita del contenuto del testo il lettore la troverà nella ricca e penetrante introduzione che Claudio Ronzoni ha premesso al volume, illustrandone i temi in modo veramente
esemplare, così come è del resto esemplare la stessa traduzione – impresa questa, nel caso degli
inediti di Husserl, tutt’altro che facile.
Mi sembra intanto che la traduzione italiana di quest’opera mostri come il flusso di interesse
verso la filosofia fenomenologica in Italia, iniziato tanti e tanti anni fa, non si sia affatto esaurito
e che quello che a molti era parso un fenomeno alla moda, tale non era e persino una certa lentezza di questo flusso lo conferma, perché nella filosofia, se si corre troppo, viene il fiato corto.
Ma questa raccolta di inediti mi sembra anche che rafforzi una linea di tendenza interpretativa
all’interno della grande varietà di possibili riprese e sviluppi che hanno tratto ispirazione dal
pensiero husserliano. Essa mostra infatti un Husserl “al lavoro” – un lavoro che consiste soprattutto, non tanto di riflessioni su tematiche generali di ampio respiro, che certo non mancano,
quanto piuttosto di analisi fenomenologiche concretamente effettuate, certo presenti in opere
come il secondo volume di Idee o in Esperienza e giudizio, ma che hanno stentato ad affermarsi
come un vero e proprio stile di indagine filosofica che avrebbe consentito di dare concretezza,
ma anche di arricchire le tematiche filosofiche di ordine generale.
Anzitutto vorrei richiamare l’attenzione sugli aspetti metodici che da queste ricerche si possono trarre proprio sull’idea di analisi fenomenologica. Si noterà, forse con una certa sorpresa, che
in esse ci si richiama ben poco alla teoria della riduzione fenomenologica, che per certi versi rappresenta la spinta dorsale del metodo e che trova un’elaborazione sempre più approfodita e complessa aggrovigliandosi sempre più nelle opere più note, dalle Meditazioni cartesiane e Filosofia
prima sino alla Crisi delle scienze europee. Tutte queste analisi assumono come problema prevalente, anche se non unico, quello di stabilire con un metodo descrittivo, non psicologizzante e
che non ha nulla da spartire con l’“introspezione”, la differenza che caratterizza le immagini di
ciò che Husserl chiama “fantasia” rispetto ai dati della percezione. E forse si noterà anche, con
non minor sorpresa, il fatto che non vi è nemmeno una teorizzazione preliminare vera e propria,
ma che in realtà tutto prende le mosse da interrogativi iterati a cui si può rispondere soltanto attraverso esempi che esibiscono analogie e differenze di struttura. Uno stesso esempio viene poi
variato in qualche suo dettaglio che impone un nuovo approfondimento. Le interrogazioni iterate
e le risposte che hanno regolarmente la forma dell’“a differenza di…” e che avvengono su base
esemplificativa è l’autentica ossatura del metodo.
In ogni caso si osserverà che in queste ricerche si tratta pur sempre di “opinioni” del filosofo
Edmund Husserl – e questa osservazione ha la sua ovvietà. Ma va subito detto che proprio in
forza di questa “assenza di teoria” e in un’indagine che mette alla prova i propri risultati su
esempi e sulla loro variazione, ciascuno è messo in grado di compiere per proprio conto una verifica, di mettere alla prova l’esempio e la sua interpretazione. Sembra singolare il dirlo, ma nonostante la ricchezza di neologismi, di prestiti terminologici presi dalla tradizione filosofica, per di
più impiegati in modo nuovo e inconsueto, che rende talvolta così difficile la lettura di un testo
_______________________
*
Università degli Studi di Milano
Bollettino Filosofico 33 (2018): 304-307
ISSN 1593 -7178 - 00030
E-ISSN 2035 -2670
DOI 10.6093/1593-7178/5925
�“Occorre riflettervi ancora”. Considerazioni in margine a Fantasia e immagine di Edmund Husserl
hussserliano, quando una ricerca fenomenologica effettiva prende l’avvio, tutto diventa, e necessariamente, alla nostra portata – e questo, io credo, è un punto di forza di un orientamento interpretativo del metodo fenomenologico che, certamente operando precise scelte all’interno
dell’elaborazione husserliana, ponga l’accento su analisi concretamente sviluppate.
Alla nostra portata significa: non abbiamo bisogno di ricorrere a speciali terminologie magari
tratte da discipline scientifiche o da altri indirizzi filosofici, e naturalmente nemmeno abbiamo
bisogno di aderire letteralmente alla terminologia husserliana nei suoi aspetti più complessi,
mentre ci è utile usare quella terminologia per dire semplicemente: ciò che importa, ciò che ci sta
di fronte, ciò che è oggetto della nostra ricerca è… la cosa stessa!
Ciascuno è in grado di percepire un tavolo o un bicchiere – oppure di “immaginarlo”. Ed è allora portata di ciascuno interrogarsi sul modo in cui questi atti vengono compiuti e sulle differenze da cui vengono contraddistinti.
Un compito che certo non sarà troppo facile! Chi a suo tempo ha ironizzato sulla nozione fenomenologica di “evidenza” interpretandola come se con essa si volesse alludere ad una “visione” che in un lampo ci fornisce certezze definitive dovrà, leggendo questo testo, ampiamente ricredersi. Infatti Husserl sembra di continuo lottare di fronte a difficoltà che si ripresentano sotto
nuova forma, e spesso si dichiara insoddisfatto delle risposte e si sente costretto a interrogativi
ulteriori. Vi è un punto in cui egli non esita a scrivere: «Qual è l’origine dei tentativi sempre di
nuovo ripetuti e sempre di nuovo falliti volti al chiarimento dei rapporti tra percezione e fantasia,
o, piuttosto, qual è l’origine del fallimento di questi tentativi? Questo io penso!»1. Ma a parte
queste dichiarazioni estreme, perplessità e dubbi sono ovunque presenti ed esplicitamente formulati.
Proprio per questo, in fin dei conti, siamo tentati di inserirci in questa meditazione solitaria
per dire la nostra: siamo quasi invitati ad esprimere le nostre perplessità, i nostri dubbi. Vorrei in
proposito solo rapidamente accennare ad alcuni aspetti che mi sembra interessante mettere in rilievo. In ciò che Husserl chiama “fantasia”, in questi inediti, prevale certamente l’idea del rendersi presente un oggetto nella sua assenza, sulla base dell’“evidenza” secondo la quale:
a ogni possibile rappresentazione percettiva appartiene una possibile rappresentazione di fantasia che si
riferisce al medesimo oggetto e, in un certo senso, esattamente nello stesso modo. Se ci presentifichiamo un paesaggio, ad esso corrisponde il paesaggio della percezione, e alla stanza fantasticata corrisponde la stanza percepita.2
Ciò significa che la ricerca non si orienta fin dall’inizio verso una accezione di fantasia che mette
al primo posto la libera creazione di cose ed eventi che non appartengono al nostro mondo – draghi, centauri, cavalli alati – ma verso “una rappresentazione a carattere di immagine” (Bildlichkeitsvorstellung). Ciò ha varie conseguenze, e soprattutto una merita di essere segnalata: anzitutto si pone il problema di chiarire l’inciso presente nella precedente citazione – «in un certo
senso, esattamente nello stesso modo»: solo in un certo senso! e precisamente nel senso per cui
possiamo dire che il paesaggio “immaginato” è proprio lo stesso paesaggio che può essere visto e precisamente secondo l’angolatura in cui posso coglierlo guardando dalla mia finestra. Una volta detto
questo, subito si apriranno tutti i problemi che riguardano proprio la differenziazione del modo. Ma la
questione, oltre ad essere complicata in se stessa, lo diventa ancor più se si tiene conto che una rappresentazione a carattere di immagine è anche quella che si propone in un paesaggio dipinto. Il problema
della differenza si pone dunque oltre che nel rapporto con la percezione anche nel rapporto con quella
nozione di immagine che potrebbe forse, per evitare confusioni terminologiche, essere chiamata “raffigurazione”.
Analizzando questa diversa nozione di immagine, a cui Husserl dedica largo spazio, emerge
1
2
Husserl (2017), p. 155.
Ivi, p. 19.
305
�Giovanni Piana
in rapporto alla “fantasia” una problematica specifica. Nella raffigurazione concretamente realizzata in un dipinto si possono distinguere infatti tre strati: lo strato della cosa, il dipinto stesso con
la sua cornice e la sua superficie di tela che si può vedere e toccare (che Husserl chiama immagine fisica (physisches Bild)), ciò che nella cosa viene presentato (che Husserl chiama oggetto–
immagine (Bildobject)) e ciò che è l’oggetto rappresentato vero e proprio, il suo tema effettivo
(che Husserl chiama sujet-immagine (Bildsujet). La distinzione viene bene spiegata da una riproduzione di un dipinto di Raffaello che sta proprio sopra la scrivania del filosofo:
Se, per esempio, osservo l’immagine della Teologia di Raffaello che è appesa sopra la mia scrivania,
questa immagine mi si manifesta in quanto cosa fisica, in quanto immagine appesa alla parete, bado ad
essa. Se cambio la direzione del mio osservare e bado all’oggetto-immagine, qui mi si manifesta allora
una piccola figura di donna, incolore, tinta semplicemente in bianco e in nero, di circa una spanna e
mezza di altezza, con due pupazzetti dalle fattezze d’angelo della stessa tinta, considerevolmente più
piccoli, che svolazzano attorno, ecc. Nella normale considerazione d’immagine vivo nella coscienza del
carattere di immagine, bado in tal caso a qualcosa di completamente diverso, vedo una figura femminile
sublime, di grandezza sovrumana, due cherubini grandi e robusti, ecc. Anche di questo dico che “si manifesta” ma ciò non accade, evidentemente, in senso proprio. Io vedo il sujet nell’oggetto
dell’immagine, ed è questo ciò che direttamente e propriamente si manifesta. La plasticità e le gradazioni di luminosità dell’oggetto-immagine che si manifestano convertono in immagine il sujet riguardo alla
sua forma plastica e alla sua vera colorazione, che non trova ulteriore espressione nell’immagine.3
Il passaggio all’immagine nella considerazione normale prevede dunque una “mediazione” che è
fornita dall’oggetto-immagine. Ma qualcosa di simile accade nella semplice percezione –
l’oggetto stesso è dato dalle sensazioni, senza sensazioni nessuna apprensione oggettuale percettiva può essere attiva.
Ora a me sembra che da entrambi questi riferimenti venga tratta da parte di Husserl l’idea che
anche nel caso della fantasia, nel senso qui prevalente, una mediazione sia indispensabile: «Alla
base delle percezioni vi sono le sensazioni, alla base delle fantasie i fantasmi sensibili (die sinnlichen Phantasmen)»4. Del resto come potrebbe rendersi presente un oggetto assente senza un
qualche sostegno che lo consenta, come nel caso dell’oggetto-immagine che rende possibile
l’apprensione del tema effettivo della raffigurazione e delle sensazioni che sono necessarie per
realizzare l’apprensione percettiva dell’oggetto? Io azzardo l’ipotesi interpretativa che la nozione
di “fantasma” intorno alla quale Husserl si aggira tormentosamente a lungo e sulla quale non
sembra venire a capo abbia questa origine nell’impostazione del problema. Ma aggiungo subito
che nello sviluppo della ricerca vi è una graduale schiarita che procede in altra direzione. Si tratta
dell’idea affiorante, a mio avviso di importanza cruciale per una filosofia dell’immaginazione,
del “come se”. Detto in una parola e con un esempio: se io ed un amico decidiamo di giocare a
guardia e ladri, ciò significa: io farò come se fossi il ladro, e tu la guardia. Questo gioco è un gioco dell’immaginazione (come la maggior parte dei giochi, e forse tutti). Qui non ci sono mediazioni, non ci sono “fantasmi”. O se vi sono mediazioni, come nel caso degli attori in una rappresentazione teatrale che è una fantasia in atto, essi non sono “fantasmi”. Questa idea fondamentale
affiora ogni qualvolta un per così dire (gleichsam) si presenta in contesti in cui può essere interpretato nel senso del come se (als ob), espressione del resto non assente da questo testo. Questo
per così dire ovvero come se equivale alla virgolettatura a cui dovremmo ricorrere ogni volta che
parliamo di oggetti o di azioni immaginarie. Mi chiedo se, prendendo decisamente questa strada,
che viene in ogni caso chiaramente indicata e che certamente incontrerebbe eventualmente in
nuova forma tutti i temi esplorati in questo testo, la ricerca non avrebbe potuto avvantaggiarsene.
Su questo come su altri interrogativi che sorgono nella lettura di un libro così denso di problemi, sulle estensioni possibili che si intravedono, ed anche sulle motivazioni interne di lacune che sembrano
inesplicabili proprio assumendo un punto di vista fenomenologico – penso soprattutto ad una no3
4
Ivi, p. 53.
Ivi, p. 14.
306
�“Occorre riflettervi ancora”. Considerazioni in margine a Fantasia e immagine di Edmund Husserl
zione di immaginazione che sappia riprendere in modo nuovo la tematica dell’“associazione delle
idee” – su tutto ciò “occorre riflettervi ancora”5.
Bibliografia
Husserl, E. (2017), Fantasia e immagine, trad. it. a cura di C. Rozzoni, Rubettino, Soveria Mannelli.
Abstract
The publication in Italian of Husserl’s unpublished manuscripts on the subject of
the philosophy of imagination is the starting point of this paper for some general
considerations on the method followed by Husserl in a phenomenological research
that he personally carried out. Some doubts that may arise in the development of
the investigation are touched upon, especially in relation to the problem of the
notion of “Phantasm” as a mediation for the production of images of fantasy.
Keywords: Imagination, Phantasy, Philosophy of Imagination, Phantasm
5
Ivi, p. 144
307
�CATERINA RESTA*
Jacques Derrida e il non fenomenologico
La costituzione dell’altro e del tempo rinviano
la fenomenologia ad una zona nella quale il suo
«principio dei principi» (secondo noi, il suo principio
metafisico: l’evidenza originaria e la presenza della
cosa stessa in persona) è radicalmente messo in
questione.
J. Derrida, “Genesi e struttura” e la fenomenologia
1. A partire da e contro Husserl
Che gli esordi del pensiero di Derrida siano segnati in maniera vistosa da un confronto con la
fenomenologia husserliana, è un dato oggettivo, difficilmente confutabile. Basta scorrere un elenco
ordinato cronologicamente delle sue pubblicazioni, per constatare come, in un arco temporale che
va grosso modo dalla metà degli anni Cinquanta alla metà degli anni Sessanta e che copre poco più
di un decennio, è essenzialmente con la fenomenologia di Husserl che il giovane Derrida si cimenta.
A partire da Il problema della genesi nella filosofia di Husserl, mémoire d’étude supérieur redatto
da Derrida negli anni 1953-54, mentre era studente del secondo anno dell’École Normale
Supérieure, sotto la guida di Maurice de Gandillac e dato alle stampe soltanto nel 1990, fino alla
conclusiva resa dei conti, che avviene nel 1967, con la pubblicazione de La voce e il fenomeno, non
vi è dubbio che l’interlocutore privilegiato di Derrida rimane in questo periodo Husserl e la sua
fenomenologia trascendentale. Si tratta di una serie di lavori1 che costituiscono, nel loro insieme,
non solo un prezioso documento della “storia degli effetti” e della recezione della fenomenologia in
Francia, ma anche di quel laboratorio in cui si forgerà l’armamentario concettuale del pensiero della
différance derridiano, il quale trae proprio da questo iniziale serrato corpo a corpo con la
fenomenologia husserliana alcuni dei suoi elementi caratterizzanti, in primo luogo la decostruzione
della metafisica della presenza e di quei principi “cardine” della fenomenologia che ad essa vanno
ricondotti: l’intuizione, l’evidenza, come pure l’idea di un’origine pura. Per tali motivi, al di là del
complesso rapporto che Derrida intrattiene con la fenomenologia husserliana, non mi sembra
*
Università degli Studi di Messina
1
Nella loro successione cronologica: Derrida (1992, 1971b, 1987, 1963, 1964, 2016, 1997b, 19973). Ma, a questi
testi, più direttamente in dialogo con Husserl, che segnano indubbiamente una precisa “fase” del pensiero di Derrida, se
ne potrebbero aggiungere anche altri che, in modo diretto o indiretto, si misurano decostruttivamente con la
fenomenologia, come attestano molti dei saggi contenuti in Derrida (1971a) o in Derrida (1997a), ma anche Derrida
(19982) e, infine, Derrida (2007). Questo ultimo testo, la cui prima versione fu redatta nel 1992, attraverso un serrato
confronto con l’istanza del “toccare”, significativamente presente nel pensiero di Jean-Luc Nancy, di fatto
“decostruisce” il richiamo all’aptico, considerato da Derrida strettamente intrecciato al predominio dell’ottico, che
attraversa tutta la storia del pensiero occidentale, prendendo le mosse da Aristotele e giungendo fino alla più recente
fenomenologia francese. In questo contesto, Derrida torna a confrontarsi con la fenomenologia di Husserl, ma anche
con quella di Merleau-Ponty. Volendo ulteriormente chiarire lo stretto legame tra ottico e aptico al centro di questo
lavoro, Derrida ha in seguito affermato nel corso di un’intervista: «La tradizione più poderosa della filosofia ha
privilegiato sempre, direttamente o no, l’intuizione, la relazione immediata, sensibile, intelligibile, con la cosa stessa.
Questo intuizionismo, nonostante quello che il suo nome sembra implicare, (cosa dello sguardo, intueor), non sempre,
contrariamente a quello che si è pensato con Heidegger e Blanchot, ha privilegiato lo sguardo. Il primato ottico o
scopico, per globale che sembri, riposa sempre, perfino nella fenomenologia o nell’eidetismo husserliano, in una figura
del tatto, in un fondamento tattile» (Derrida, 2010, p. 29).
Bollettino Filosofico 33 (2018): 308-321
ISSN 1593 -7178 - 00030
E-ISSN 2035 -2670
DOI 10.6093/1593-7178/5926
�Jacques Derrida e il non fenomenologico
azzardato sostenere che il pensiero della decostruzione si annuncia innanzitutto – ossia fin dal suo
inizio – come decostruzione della fenomenologia2.
Non è mio intento entrare analiticamente nel merito del rapporto tra Derrida e Husserl risalente a
questi anni: numerosi e pregevoli studi hanno contribuito a mettere in luce, sia dal punto di vista
storico-filosofico che teoretico, la posta in gioco di questo confronto, verificandone anche le
eventuali forzature ermeneutiche3. Più che sull’analisi del “debito” contratto nei confronti della
fenomenologia o degli scarti che marcano una inequivocabile presa di distanza, vorrei, in generale,
avanzare l’ipotesi che, contrariamente al convincimento della maggior parte degli interpreti, tra la
decostruzione di Derrida e la fenomenologia, non solo husserliana, si stabilisce, fin dall’inizio, una
rottura irricomponibile. Se, per lo più, si tende a rimarcare comunque l’appartenenza di Derrida
all’eredità fenomenologica, da parte mia vorrei invece evidenziare come la decostruzione, proprio
per il suo «gusto del segreto»4, al di là delle stesse reticenze di Derrida in proposito, intenda
decisamente “rompere” con essa, considerando la fenomenologia husserliana e la sua variegata
discendenza un pensiero che porta a compimento quella che già Heidegger aveva definito
“metafisica della presenza”, la quale si dispiega nei suoi principi portanti dell’intuizione,
dell’evidenza, della purezza dell’origine, del presente vivente e di una metafisica della vita che
disconosce la morte. A tale proposito, la presa di posizione di Derrida è sempre stata
inequivocabile.
Se, nella temperie filosofica francese degli anni Sessanta, il confronto con la fenomenologia di
Husserl sembrava a Derrida ineludibile, tanto da poter affermare in un testo che risale a quel
periodo: «non c’è filosofo oggi che non si definisca essenzialmente in base alla sua relazione con la
fenomenologia»5, d’altra parte i termini di questa relazione sono posti immediatamente con
sufficiente chiarezza. Pur riconoscendo il ruolo «rivoluzionario» e «radicale» svolto dalla
fenomenologia husserliana a fronte della crisi delle grandi metafisiche post-kantiane, tanto
dell’idealismo che del positivismo, tuttavia si tratterebbe di una “rivoluzione restauratrice”. La
risposta data dalla fenomenologia alla crisi che attraversa la filosofia è dunque ambigua: per un
verso, sembra volersi spingere al di là della chiusura metafisica, per l’altro si trattiene tenacemente
e regressivamente all’interno di essa:
La fenomenologia si presenta contemporaneamente già da subito come la trasgressione risoluta e audace
della metafisica […] e come la restaurazione più coerente della metafisica. Se essa compie un passo oltre
un certo hegelismo, in cui si raccoglie e si compie tutta la storia della metafisica, è per ritornare all’origine,
all’ideale platonico della filosofia come epistéme e al progetto aristotelico della philosophia prote. La
nuova metafisica, esito finale della fenomenologia trascendentale, sarà la scienza rigorosa e la filosofia
prima 6.
2
Pur considerando riduttiva questa chiave di lettura, Costa non ha mancato di osservare: «sembrerebbe che
l’unico rapporto che lega Derrida alla fenomenologia husserliana sia quello “decostruttivo”» (Costa, 1992, p. 9).
3
A fronte dell’abbondante mole di studi dedicati al rapporto tra Derrida e la fenomenologia, mi limito a citare
quelli che ritengo tra i più significativi. Innanzitutto, per una puntuale ricostruzione dell’ambiente culturale francese
degli anni Sessanta, monopolizzato dallo strutturalismo e dall’attenzione a questioni epistemologiche, all’interno del
quale collocare il confronto di Derrida con la fenomenologia husserliana, particolarmente prezioso e documentato è
Perego (2016), con ampia, specifica e aggiornata bibliografia su Derrida e la fenomenologia. Anche Perego ritiene
che il pensiero di Derrida «possa e debba essere inserito nella tradizione fenomenologica e nel dibattito dei più
importanti interpreti di Husserl» (ivi, p. 11). Un utile inquadramento generale è anche quello offerto da Vergani
(2000). Per rimanere in ambito italiano, si vedano i fondamentali lavori di Costa (1992, 1996, 1997, 2016). Cfr.
anche: Di Martino (1987 e 2001), Nobile (2004), Tarditi (2008). Tra la vasta produzione in campo internazionale:
Bernet (1994 e 2008), Dastur (2016), Houillon (2002), Howells (1998), Lawlor (2002), Marrati (1998 e 2000),
McKenna - Evans (eds.) (1995), Sebbah (2001), Völkner (1993). Un caso a parte è costituito dall’importante
confronto diretto intercorso tra Derrida e Jean-Luc Marion (Marion, 2010 e 2012), incentrato soprattutto sulla
questione della “donazione” fenomenologica e sul diverso modo di intendere quella che Heidegger, in modo
ossimorico, ebbe a definire «fenomenologia dell’inapparente [Phänomenologie des Unscheinbaren]» (Heidegger,
1992, p. 179). Per il significato di questa espressione cfr. Courtine (1990).
4
Cfr. Derrida - Ferraris (1997).
5
Derrida (2016), p. 48.
6
Ivi, p. 49.
309
�Caterina Resta
Quanto Derrida affermava in questo scritto del 1966, intitolato significativamente La fenomenologia
e la chiusura della metafisica. Introduzione al pensiero di Husserl, sarà ribadito l’anno successivo
ne La voce e il fenomeno, tra i lavori dedicati a Husserl in questo periodo certamente quello più
noto e teoreticamente più ambizioso, che ingaggia una vera e propria resa dei conti con la
fenomenologia trascendentale e sancisce una presa di distanza definitiva da essa. Di questo testo,
così ricco di motivi e di spunti “decostruttivi”, vorrei limitarmi a sottolineare solo l’aspetto più
decisivo: il riferimento alla concezione dell’esperienza trascendentale in quanto «presente vivente»
[lebendige Gegenwart], che iscriverebbe a pieno titolo la fenomenologia husserliana all’interno di
quella “metafisica della presenza” – denunciata per primo da Heidegger – che Derrida si impegnerà
a decostruire senza sosta, fino all’ultimo. Dal momento che il presupposto fondamentale, il
“principio dei principi” dal quale la fenomenologia prende le mosse, è «l’evidenza originariamente
offerente, il presente, o la presenza del senso ad un’intuizione piena e originaria»7, occorre trarre la
conclusione che «la risorsa della critica fenomenologica è il progetto metafisico stesso nel suo
compimento storico e nella purezza solamente restaurata della sua origine» 8. Inoltre, privilegiando
la presenza del presente vivente, «la fenomenologia, metafisica della presenza nella forma
dell’idealità, è anche una filosofia della vita»9, che non riesce a confrontarsi con la morte. Da qui
discende quel privilegio della phoné, nell’immediatezza del sentirsi parlare, a scapito di quella che
proprio in questi stessi anni Derrida chiamerà écriture, quel fono-logocentrismo, che caratterizza
l’intero decorso del pensiero occidentale 10, alla cui decostruzione Derrida si impegnerà soprattutto
in questa prima fase, contrapponendovi un pensiero della différance, insieme differimento e
temporeggiamento, spaziatura, scarto spazio-temporale irriducibile, che impedisce ogni
immediatezza, così come preclude ogni accesso all’origine. Metafisica della presenza e della vita, la
fenomenologia non è dunque in grado di “assumere” la morte. Comprendiamo a questo punto come
tutto lo sforzo filosofico di Derrida, dall’inizio alla fine, dalla prima sino all’ultima parola, non sia
stato altro che la ricerca di un pensiero che, a differenza della fenomenologia, fosse in grado di non
denegare la morte, ma, anzi, di “ospitarla” al cuore della vita, riconoscendo il rapporto inscindibile
che lega la vita alla morte11. È questa tensione il propulsore della decostruzione, il suo “movente”,
quel che le dà la spinta, ciò che la tiene in costante movimento, e, al tempo stesso, essa costituisce il
fil rouge capace di imbastire la trama di un pensiero che programmaticamente rifiuta ogni
Versammlung e si offre “disseminato” in disiecta membra.
È della morte – il non-fenomenologico per eccellenza, che si rifiuta ad ogni possibile
fenomenologia – nella vita, che La voce e il fenomeno ci parla da ogni pagina, quando, ad esempio,
vi leggiamo: «Il sé del presente vivente è originariamente una traccia» 12, oppure quando si afferma:
«Io sono vuol dire originariamente io sono mortale»13, poiché «la mia morte è strutturalmente
necessaria alla pronuncia dell’Io»14, sicché «l’enunciato “io sono vivo” si accompagna col mio
essere-morto e la sua possibilità richiede la possibilità che io sia morto; e viceversa»15. Nessuno
potrà mai dire, come accade a Valdemar, il protagonista del racconto di Poe, citato non a caso in
epigrafe a La voce e il fenomeno: «Io sono morto». A causa di questa insormontabile impossibilità,
la fenomenologia, il cui concetto fondatore è quello della «presenza a sé della vita trascendentale»16
7
Derrida (19973), p. 33.
Ibidem.
9
Ivi, p. 39.
10
Per lo sviluppo di questi temi si veda soprattutto Derrida (19982) e i saggi raccolti in Derrida (1971a e 1997a).
11
Per una sintetica presentazione del nesso inscindibile tra vita e morte, cfr. Vitale (2012). Sulla centralità del tema
della morte nel pensiero di Derrida mi sono soffermata in Resta (2016), II cap.: Ospitare la morte, cui mi permetto di
rinviare. Sul nesso tra vita, morte e potere, anche sulla scorta di un’originale interpretazione della pulsione di morte
freudiana, rinvio a Resta (2017).
12
Derrida (19973), p. 123. Sulle diverse ascendenze del concetto di “traccia” (Heidegger, Levinas, ma anche Freud),
si veda Derrida (1997c).
13
Derrida (19973), p. 88.
14
Ivi, p. 136.
15
Ivi, p. 137.
16
Ivi, p. 140.
8
�Jacques Derrida e il non fenomenologico
e del presente-vivente, restaura la metafisica, in quanto occulta l’inaggirabilità della morte. Una
voce senza differenza, come quella fenomenologica, disconosce e anzi denega quella che, con
accenti heideggeriani, Derrida chiama «la finitezza della vita come rapporto essenziale a sé come
alla sua morte»17.
È dunque in direzione opposta a quella della fenomenologia husserliana che Derrida muoverà i
propri passi, dopo aver fatto i conti con essa e dopo aver incontrato sulla sua strada Nietzsche,
Freud, Heidegger, Levinas, Blanchot. In direzione di quello che non esiterei a chiamare, non certo
per difendere qualche presunta ortodossia, il non-fenomenologico, indicando con questa espressione
una zona di assoluta impenetrabilità alla luce, di radicale irrappresentabilità e inapparenza, di
irriducibile impresentabilità come quella offertaci dalla morte, «esperienza non provata»18, secondo
la folgorante espressione impiegata da Blanchot. La morte: il limite invalicabile a partire dal quale
l’esperienza diventa impossibile.
Non si tratta, dunque, come in analoghi casi di interpretazioni caratterizzate da una vistosa
violenza ermeneutica, di stabilire quanto fedele o infedele al dettato di Husserl e ai presupposti,
oltre che agli sviluppi, della fenomenologia sia la lettura di Derrida. Se un approccio filologico ai
testi derridiani ci può senz’altro dare la misura di un’esegesi scrupolosa, degli scarti, degli
spostamenti, delle forzature di un confronto e di una interpretazione sempre, al tempo stesso,
rigorosi, ma anche radicali, non è tanto sul piano filologico che se ne può trarre un bilancio, il quale
per lo più si risolve nell’iscrizione, nonostante tutto, di Derrida all’interno di quella fenomenologia
dalla quale ha preso le mosse solo per allontanarsene. Non si tratterebbe, dunque, a mio avviso, di
rimarcare semplicemente una “fedele infedeltà” o un “tradimento”, che darebbe luogo all’ennesima
eresia fenomenologica19, come per lo più si ritiene, magari ponendo l’accento sul carattere di
sospensione di una tradizione – quella fenomenologica, appunto, – cui proprio in tal modo si
assicurerebbe un rilancio e un avvenire, tali da non interromperla20. È, in generale, significativo che
si debba ricorrere ad ossimori, iperboli o paradossi – figure retoriche, del resto, del tutto compatibili
con il pensiero di Derrida e assai frequenti nei suoi testi – per designare quello che, non a caso, è
stato definito lo «strano rapporto che Derrida intrattiene con la fenomenologia husserliana»21. Così
Vincenzo Costa ha parlato di «fenomenologia della contaminazione»22, riferendosi a quella che
Derrida chiama la «legge della contaminazione differenziale»23, con l’intento di mostrare il
passaggio, operato da Derrida, da una fenomenologia pura, come quella trascendentale husserliana,
ad una “impura”. Nella sua pregevole introduzione al pensiero di Derrida, Mario Vergani, dal canto
suo, si è servito delle espressioni «fenomenologia dell’impossibile, dell’impresentabile,
dell’irrappresentabile. […] Fenomenologia di ciò che non è fenomeno, che non appare»24,
giungendo ad affermare che «la decostruzione si costituisce, nella sua possibilità, a partire dalla
fenomenologia e come gesto paradossalmente iperfenomenologico»25. Mentre Rovatti, in modo a
mio avviso più corretto, anche dal punto di vista filologico, a proposito del dono, ha impiegato la
17
Ivi, p. 143.
Blanchot (1990), p. 85.
19
Come suggerisce Vergani (2000), p. 26, si tratta di ribadire al contempo «la filiazione fenomenologica della
decostruzione e insieme il necessario tradimento dell’eredità da parte di Derrida». Cfr. anche Tarditi (2008), che
parla di «eresia fenomenologica».
20
Così scrive Houillon (2002), p. 29: «una interruzione della fenomenologia al suo interno travaglia stranamente
la storia dell’infedele fedeltà di uno degli eredi più paradossali della fenomenologia: Jacques Derrida. Contro i
tentativi ortodossi di esclusione della scrittura derridiana fuori dalla fenomenologia, contro la negazione dei
guardiani di un’eredità che, a sua volta, egli rivendica, tenteremo di ricucire il filo della tradizione al fine di
riconoscere in Jacques Derrida uno dei fili della tradizione fenomenologica. Il figlio interrompe il Padre e solo
questa interruzione costituisce la tradizione filiale: ogni filiazione originale è di interruzione». In questo senso
Houillon può parlare di un «héritage in-interrompu».
21
Costa (1992), p. 11.
22
Si tratta del titolo della sua prefazione a Derrida (1992).
23
Derrida (1992), p. 51.
24
Vergani (2000), p. 117.
25
Ivi, p. 25.
18
311
�Caterina Resta
formula «“impossibile fenomenologia”»26 e «fenomenologia impossibile»27. François-David
Sebbah, infine, ha segnalato come, pur iscrivendosi nell’asse della fenomenologia, quella di Derrida
rappresenti un «eccesso» che ne forza i limiti28.
In ogni caso, tuttavia, è nell’alveo della fenomenologia che la decostruzione andrebbe collocata.
Lo stesso Derrida, del resto, com’è nel suo stile, non ha evitato di alimentare in qualche modo
questa ipotesi, ribadendo in ogni occasione il suo “debito” nei confronti della fenomenologia.
Vale allora la pena lasciare la parola allo stesso Derrida, per comprendere meglio, almeno dal
suo punto di vista, in quale modo si lascerebbe iscrivere nel suo cammino di pensiero l’iniziale
apprendistato fenomenologico. Uno dei testi in cui emerge con maggiore nitidezza il senso
complessivo di questo incontro, la sua “necessità”, dovuta alla contingenza culturale dell’epoca,
come pure le ragioni della presa di distanza, è il discorso, piuttosto irrituale per la circostanza, che
Derrida “osò” pronunciare in occasione della soutenance per il Doctorat d’État (equivalente al
nostro ordinariato) il 2 giugno del 1980, alla Sorbona, davanti ad una commissione presieduta da de
Gandillac e composta, tra gli altri, da Aubenque e Levinas29. Già filosofo di fama internazionale,
Derrida in questa circostanza delinea quello che sino a quel momento è stato il suo percorso,
soffermandosi in modo particolare sull’iniziale confronto con la fenomenologia husserliana. Di
questa importante testimonianza, che ci restituisce una preziosa auto-interpretazione e che offre utili
spunti per comprendere da dove, da quali domande e da quali esigenze a suo tempo prese le mosse
la decostruzione, segnalerò solo qualche passaggio particolarmente significativo. Derrida ricorda
come inizialmente il suo interesse prioritario e più marcato fosse rivolto alla Letteratura e alla
scrittura letteraria e che il suo progetto di tesi, concordato con Hyppolite intorno al 1957, recava lo
stravagante titolo L’idéalité de l’objet littéraire30. L’intento era quello di «piegare, più o meno
violentemente, le tecniche della fenomenologia trascendentale all’elaborazione di una nuova teoria
della letteratura»31. Erano le questioni relative alla scrittura e all’iscrizione quelle che spingevano
Derrida a servirsi della fenomenologia per una loro problematizzazione32. Del resto, come ancora
ricorda Derrida, ricorrere alla fenomenologia husserliana era scelta quasi obbligata per i giovani
filosofi francesi di quella generazione e aggiunge: «La vedo ancora oggi, in altro modo, come una
disciplina di incomparabile rigore»33. Il rigore del metodo fenomenologico: è soprattutto questo
aspetto quello che Derrida ha ripetutamente messo in evidenza circa il suo rapporto con la
26
Rovatti (1996), p. X.
Ivi, p. XI.
28
Sebbah (2001). In questa direzione anche Vergani (2000), p. 36: «La fenomenologia dell’impossibile è il tentativo
di forzare il limite di ciò che è descrivibile o dicibile nell’orizzonte fenomenologico».
29
Sulle circostanze che convinsero Derrida, nonostante la sua iniziale riluttanza, a sostenere questa prova,
preliminare alla sua chiamata a ricoprire la cattedra che era stata di Paul Ricoeur, a Nanterre, come anche da
quest’ultimo auspicato, si veda Peeters (2010), pp. 389-392 e 431-432. La soutenance ebbe esito positivo, ma,
successivamente, a Nanterre fu chiamato Georges Labica, studioso di Hegel e Marx. Questo ennesimo rifiuto da parte
del mondo accademico francese segnerà la fine delle ambizioni universitarie di Derrida, che sarà comunque chiamato,
nel dicembre del 1983, a ricoprire il ruolo di Direttore di studi nella prestigiosa École des Hautes Études en Sciences
Sociales, ove rimarrà fino alla morte.
30
In relazione al rapporto con la fenomenologia, segnalo un passaggio non privo di provocatoria ironia, considerata
la circostanza “accademica”. Dopo aver reso omaggio a Hyppolite, Derrida ricorda come nel 1966, durante un colloquio
negli Stati Uniti al quale partecipavano entrambi, Hyppolite, che pure non gli aveva mai fatto mancare il suo appoggio e
la sua stima, gli disse: «Io non vedo veramente dove lei vada» (Derrida, 1999, p. 228). Derrida riferisce che, all’incirca,
la sua risposta dovette essere questa: «Se io vedessi chiaramente, e in anticipo, dove vado, credo di sicuro che non farei
un passo in più per recarmici» (ibidem). Di fronte alla commissione che sta esaminando la sua produzione scientifica,
Derrida rievoca questo episodio e così lo commenta, seminando, probabilmente, in più d’uno degli astanti sconcerto e
disorientamento: «Ricordandomi oggi questa risposta, io non sono ben sicuro di comprenderla, ma essa voleva
certamente dire che non vedo mai dove vado, né lo so, e che dunque in questa misura, quella in cui io so, non è sicuro
che abbia mai fatto un passo o detto qualche cosa» (ibidem). Una dichiarazione che attesta, al di là di ogni altra
considerazione, il desiderio di “rompere” con quel privilegio del vedere-sapere che marca, fin dal suo esordio, tutta la
storia della filosofia e che viene rilanciato, da ultimo, dalla fenomenologia.
31
Ibidem.
32
«Curiosamente, la fenomenologia trascendentale ha potuto aiutarmi, per un primo tempo, ad acuire alcune di
queste questioni» (ivi, p. 229).
33
Ibidem.
27
�Jacques Derrida e il non fenomenologico
fenomenologia, un riconoscimento rivolto più ad un metodo, ad una tecnica utile a forgiare il
pensiero, che ad una serie di contenuti e, ancor meno, ad una corrente filosofica all’interno della
quale collocarsi, seppure in modo non ortodosso ed ereticale. Dopo aver ricordato la significativa
mediazione di Tran-Duc-Thao e di Fink, Derrida, riferendosi ai suoi scritti tra il 1963 e il 1968,
sostiene che non era per nulla sua intenzione costruire attraverso di essi un “sistema”,
considerandoli piuttosto, nel loro insieme, come «una sorta di dispositivo strategico aperto, sul suo
stesso abisso, un sistema non chiuso, non recintabile e non totalmente formalizzabile di regole di
lettura, di interpretazione, di scrittura»34. Questa strategia, destinata a prendere il nome di
“decostruzione”, era soprattutto rivolta a problematizzare lo strutturalismo allora dominante in tutti
i campi delle scienze umane.
Ancora, in una serie di interviste radiofoniche trasmesse da France Culture e risalenti alla fine
degli anni Novanta, Derrida ribadisce quanto già affermato in occasione della soutenance del
Doctorat d’État, rammentando come, agli inizi degli anni Cinquanta, non fosse interessato tanto alla
fenomenologia nella declinazione introdotta in Francia da Sartre e da Merleau-Ponty, quanto ai
problemi da essa suscitati nel campo della scienza e dell’epistemologia e, accanto a questi, alla
questione della scrittura: «la domanda che continuava a interessarmi: l’iscrizione letteraria»35. Nel
panorama culturale dominato dallo strutturalismo, Derrida non nasconde le proprie riserve nei
confronti di questo “paradigma” divenuto allora egemone in tutte le scienze umane e parla di una
«approvazione diffidente»36. All’intervistatore che gli chiede della sua presa di distanza dalla
fenomenologia, Derrida risponde menzionando, ancora una volta, gli aspetti formali del rigore, del
metodo e della tecnica appresi attraverso la disciplina fenomenologica e confessa quasi un senso di
colpa per aver consumato questo distacco, riaffermando comunque la propria fedeltà:
Sì, ma con una certa inquietudine, e anche una certa cattiva coscienza. Per me fin dall’inizio Husserl, la
fenomenologia, l’insegnamento della fenomenologia, sono stati una disciplina di rigore, un metodo al quale
mi sono piegato tanto più sistematicamente, freddamente, con calma, di quanto abbia sentito dell’affinità,
del pathos, della “simpatia” verso Husserl. Mi sento più vicino a Heidegger che a Husserl dal punto di vista
della tonalità esistenziale. Husserl è per me quello che mi ha insegnato una tecnica, un metodo, una
disciplina, colui che non mi ha mai abbandonato. Anche nei momenti in cui ho creduto di dover interrogare
certi presupposti di Husserl, ho cercato di farlo restando fedele alla disciplina fenomenologica37.
In un’altra intervista, di qualche anno successiva, Derrida, dopo aver riconosciuto il proprio
“debito” nei confronti della fenomenologia husserliana, ancora una volta pone l’accento soprattutto
sugli aspetti metodologici e tecnici della fenomenologia, “praticata” come un insieme di esercizi
preliminari, più che assunta teoricamente:
Husserl non è stato il mio primo amore in filosofia. Ma ha lasciato sul mio lavoro una traccia profonda.
Nulla di ciò che faccio sarebbe possibile senza la disciplina fenomenologica, senza la pratica delle riduzioni
eidetiche e trascendentali, senza l’attenzione portata ai sensi dalla fenomenalità, ecc. è come un esercizio
preliminare a qualsiasi lettura, a qualsiasi riflessione, a qualsiasi scrittura38.
Dopo questa importante attestazione, secondo una collaudata strategia, seguono tuttavia le riserve e
la presa di distanza: «Anche se, raggiunto un certo punto, credo di dover tornare a mettere in
questione i limiti di questa disciplina, i suoi principi, e il “principio dei principi” intuizionista che la
guida»39. Strettamente collegato con esso è anche il privilegio dato da Husserl al «presente
vivente», che Derrida ricorda di aver cominciato a decostruire attraverso la nozione di “traccia”:
34
Ivi, p. 231.
Derrida (2004), p. 29.
36
Ivi, p. 31.
37
Derrida (2004), p. 99.
38
Derrida (2010), pp. 27-28. Si tratta di un’intervista del 2001 rilasciata ad Antoine Spire.
39
Ivi, p. 28.
35
313
�Caterina Resta
ciò che ho tentato di elaborare sotto il nome di traccia (cioè un’esperienza della differenza temporale di un
passato senza presente o di un à-venir che non sia un futuro presente), è anche una decostruzione, senza
critica, di quest’evidenza assoluta e semplice del presente vivente, della coscienza come presente vivente,
della forma originaria del tempo (Urform) che si chiama presente vivente (lebendige Gegenwart) o di tutto
ciò che suppone la presenza del presente40.
Andrebbe dunque chiarito meglio in che senso e in che forma Derrida sarebbe rimasto “fedele” alla
fenomenologia. Come in diverse occasioni ha affermato, secondo Derrida i veri eredi41 non sono
coloro che riproducono scolasticamente i loro modelli, ma sono piuttosto coloro che «hanno rotto
con l’origine, il padre, il testatore, lo scrittore o il filosofo abbastanza per andare con il proprio
movimento a firmare o controfirmare la loro eredità. Contro-firmare, significa firmare altra cosa, la
stessa cosa e altra cosa per far avvenire altra cosa. La controfirma presuppone per principio una
libertà assoluta»42. Questa assoluta libertà presuppone appunto la possibilità di “fedele infedeltà”.
Anzi, è solo a partire da una possibile infedeltà che si può “assumere” un’eredità «per farla andare
altrove, per farla respirare diversamente. […] Non si può auspicare un erede che non inventi
l’eredità, che non la porti altrove, nella fedeltà. Una fedeltà infedele»43, una fedeltà che
necessariamente deve rompere con il Padre o il Maestro, deve tradire e riconoscersi in più d’una
discendenza e filiazione:
appartengo a un grande numero di filiazioni. […] Questo mi dà anche grande libertà, perché quando la
filiazione è molteplice, si gioca l’uno contro l’altro o l’uno senza l’altro e si ritorna. […] Credo che una
filiazione sia sempre molteplice. Una filiazione unica non è una filiazione. Più o meno molteplice, più o meno
ingarbugliata; vi sono, tuttavia, sempre più di un padre e più di una madre.44
Se Derrida può sostenere che le “contestazioni” da lui rivolte alla fenomenologia non vanno assunte
come «una contestazione della fenomenologia stessa»45, ma vengono avanzate «sempre in nome di
qualcosa che mi appare invincibile nell’esigenza fenomenologica»46, ciò è sufficiente per affermare
un’appartenenza, per quanto sui generis, a questa corrente di pensiero? Credo proprio di no.
Ritengo piuttosto che, al di là di una certa enfasi, talora riscontrabile in affermazioni come questa, e
di una certa idiosincrasia, in generale, nei confronti di ogni contrap-posizione o “critica”, la formula
che forse meglio descrive la complessità di questo rapporto sia la seguente, impiegata dallo stesso
Derrida: «A partire da e contro Husserl. E da questo punto di vista la fenomenologia è sempre la
risorsa della decostruzione, poiché permette di sbarazzarsi delle sedimentazioni speculative e
teoriche, dei presupposti filosofici. È dunque sempre in un certo qual modo in nome di una
descrizione più esigente che si può mettere in questione questa o quest’altra tesi filosofica legata
alla fenomenologia»47. A partire da la fenomenologia husserliana significa servirsene per forgiare e
affinare le proprie armi, metterla al servizio della decostruzione, per sgomberare il campo dalle
macerie speculative; contro Husserl significa invece che la fenomenologia è un sentiero interrotto e
da interrompere, che occorre essere più esigenti, mostrarne i limiti e spingersi, oltre di essa, in
dimensioni del pensiero per essa inaccessibili. Lo stesso Husserl, del resto, era consapevole di
urtare talvolta contro un limite insuperabile:
Husserl ha dovuto riconoscere che nell’esperienza del tempo e nell’esperienza dell’altro, il suo “principio”
dei principi, l’accesso intuitivo alla cosa stessa “in persona” era messo in scacco. Per esempio, l’accesso
all’alter-ego non si dà in nessuna intuizione originaria, solo in un’analogia […]. Tutte le “infedeltà”
all’ortodossia fenomenologica sono passate per questa breccia che fu Husserl stesso ad aprire 48.
40
Ibidem.
Per una più approfondita trattazione di questo tema, mi permetto di rinviare a Resta (2003), II cap.
42
Derrida (2004), pp. 74-75.
43
Ivi, p. 75.
44
Ivi, pp. 75-76.
45
Ivi, p. 102.
46
Ibidem.
47
Ivi, p. 95.
48
Derrida (2010), p. 29.
41
�Jacques Derrida e il non fenomenologico
Ma, d’altra parte, proprio quando Husserl constata che la fenomenologia non può spingersi oltre ed
è costretta a segnare pervicacemente il passo di fronte a queste aporie, ciò non lo induce ad
arretrare, ad arrendersi di fronte allo scacco e al fallimento. Con straordinaria tenacia che rasenta
quasi l’eroismo, egli procede fin dove è possibile, indicando il problema rimasto irrisolto, come
sottolinea con ammirazione Derrida:
Quello che è ammirevole in questo filosofo è che, davanti a queste difficoltà apparentemente insuperabili,
non rinuncia né si rassegna, ma cerca di stringere scrupolosamente la sua analisi mantenendo per più tempo
possibile, eroicamente, la sua assiomatica e la sua metodologia e segnalando in esse i luoghi del limite o del
fallimento, della necessaria ristrutturazione. E in questo c’è un esempio rispettabile di responsabilità
filosofica49.
2. La decostruzione della fenomenologia in nome del non fenomenologico
La decostruzione, tuttavia, è una strategia completamente diversa da una “ristrutturazione” interna
alla fenomenologia. Dove la fenomenologia non può che registrare il proprio scacco, dove nulla più
si può dare a vedere o si mostra, quando persino il gioco del visibile e dell’invisibile, dell’apparire e
dello sparire, come dell’apparente e dell’inapparente cedono il passo a quello che Derrida chiama il
«segreto assoluto», in questa notte senza luna e senza stelle la decostruzione intende, ancor più
coraggiosamente, muovere alla cieca i propri passi, senza vedere, senza sapere dove andare, senza
alcuna possibile pre-visione.
Il segreto assoluto – la morte – segna dunque il limite insormontabile della fenomenologia che,
in quanto pensiero del presente vivente, semplicemente non può che ignorarlo:
Il tema della morte, ma di una morte che non appare mai in quanto tale, segna forse appunto il limite del
progetto fenomenologico. Va detto – ed è anche un Leit-motiv di tutto ciò che ho scritto su Husserl – che la
fenomenologia trascendentale di Husserl è una filosofia della vita, del presente vivente, non direi un
vitalismo. Nondimeno, Husserl associa costantemente la nozione di vita all’esperienza della coscienza:
l’ego è un ego vivente, e in un certo modo la morte non ha posto nella fenomenologia in quanto tale50.
La decostruzione, d’altra parte, non intende “superare” questo limite; al contrario, lo ritiene
assolutamente insormontabile. Se la fenomenologia è un pensiero della vita che esorcizza la morte,
la decostruzione intende essere un pensiero che non rimuove la morte, che disocculta la différance
che attraversa la vita e non le consente di coincidere mai con se stessa; un altro modo per nominare
l’impurità dell’origine, la sua originaria contaminazione.
Se è vero che la fenomenologia, in quanto istanza del trascendentale, dell’evidenza,
dell’intuizione, della presenza, della purezza dell’origine e della vita è precisamente quanto
alimenta la decostruzione, la sua maggiore e più duratura risorsa, ciò accade in quanto la
decostruzione è innanzitutto decostruzione della fenomenologia e in questo incessante lavoro
decostruttivo delle sue istanze consiste e si consuma la sua fedele infedeltà, facendo leva sui
momenti in cui l’intuizionismo fenomenologico mostra il suo scacco, come accade nella
impossibile fenomenologia del tempo, della relazione con l’altro o della morte51. Se quest’ultima
non ha posto nella fenomenologia, la decostruzione intende, al contrario, ospitare la morte nella vita
e non a caso un certo pensiero de «la vita la morte», ossia dell’intreccio inestricabile tra vita e morte
è, come abbiamo detto, il filo conduttore più tenace di tutto il pensiero di Derrida.
Erede della fenomenologia, la decostruzione lo è, dunque, in primo luogo e principalmente, in
quanto decostruzione della fenomenologia in nome del non fenomenologico. Ecco perché
espressioni come “fenomenologia dell’impossibile”, “iperfenomenologico”, “fenomenologia della
contaminazione”, “fenomenologia dell’inapparente”, “sospensione della fenomenologia”, “eccesso
49
Ibidem.
Derrida (2004), p. 96.
51
Cfr. ivi, p. 100.
50
315
�Caterina Resta
della fenomenologia”, “eresia fenomenologica” tradiscono, a mio avviso, un malcelato desiderio di
riappropriazione destinato a fallire. Il pensiero della différance è un pensiero del nonfenomenologico e perfino del contro-fenomenologico, nonostante i continui tentativi, da più parti,
di ricondurlo nell’alveo della fenomenologia e della sua eredità. Il corpo a corpo con Husserl, in cui
si impegna nelle sue opere di esordio, serve a Derrida per prendere definitivamente congedo da
questo pensiero in cui la metafisica della presenza si “compie”. Ciò che più lo interessa è saggiare il
limite del fenomenologico, sorprendere la fenomenologia nel suo scacco, assistere al suo fallimento,
alle prese con quanto si dà senza apparire, senza mai essere presente. Quello che Derrida chiama
«segreto» allude al non-fenomenologico, e il «gusto del segreto» non andrebbe inteso nel senso
“debole” di una mera preferenza, ma nel senso forte di un desiderio, anzi di una folle passione,
quella stessa che alimenta la decostruzione. Si può dire, in un certo senso, che essa non si sia mai
occupata di nient’altro. Che si tratti del tempo o della morte, dell’altro come tout autre, della
giustizia al di là del diritto o della democrazia a venire, del dono o del perdono, la decostruzione di
Derrida si è sempre voluta spingere oltre il fenomenologico, «al di là delle apparenze»52 e
dell’apparire, non per catturare un “noumeno” o per carpire una presunta inaccessibile “sostanza”,
né, tanto meno, per svelarla, rivelarla, portarla alla luce, ma per mostrare, senza che nulla si possa
dare a vedere, che l’accadere non può essere inteso come un presentarsi di qualcosa a qualcuno, a
una coscienza che possa fare esperienza di una qualche datità.
Se la morte è certamente il “paradigma” del non-fenomenologico per eccellenza, il dono53, forse,
costituisce la figura più esemplare di un evento54 inapparente, il cui paradossale carattere consiste,
per Derrida, in un dare-donare senza dato, che perciò si sottrae a ogni possibile fenomenologia e
appropriazione. È nota, ed ha anche suscitato un vivace dibattito55, la tesi paradossale di Derrida: il
dono, se ce n’è, ossia se accade, «interrompe l’economia»56, ossia rompe il circolo dell’oiko-nomia,
della legge della casa e del ritorno a casa, quel circolo, descritto da Mauss nel suo celebre Saggio
sul dono57, del dare, prendere, restituire, il circolo del debito, del credito, del calcolo, della
restituzione e della riappropriazione. Per questo Derrida sostiene che «un dono potrebbe essere
possibile, può aversi dono, solo nell’istante in cui un’effrazione avrà luogo nel circolo»58, il che
implica, per un verso, il suo carattere aneconomico e, per l’altro, una lacerazione del tempo,
un’anacronia. Il dono, tuttavia, non solo spezza il circolo economico e interrompe il continuum
temporale; esso “rompe” anche quella circolarità, secondo la quale qualcuno ha l’intenzione di
donare e dona qualcosa a qualcun altro, che la riceve e che si sente in obbligo di ricambiare. E
questa “restituzione” comincia ancor prima che l’altro “restituisca” concretamente con un controdono: comincia già a partire dal sentirsi in debito per quanto si è ricevuto e nella “gratitudine” nei
confronti del donatore. Così come, da parte di quest’ultimo, la “restituzione” è già in agguato
nell’auto-gratificazione con la quale ci si compiace narcisisticamente della propria generosità59.
Affinché si dia dono, è dunque necessaria la paradossale circostanza che il dono non venga
“riconosciuto” come tale: «Il dono come dono dovrebbe non apparire come dono: né al donatario,
né al donatore. Esso può essere dono come dono solo non essendo presente come dono. […] La sua
stessa apparenza, il semplice fenomeno del dono, lo annulla come dono»60.
52
Cfr. Derrida (2010).
Il tema del dono viene ampiamente trattato soprattutto in Derrida (1996) e Derrida (2002).
54
Ancor prima che sul piano socio-antropologico ed etico, per Derrida indagare lo statuto del dono ha una portata
ontologica, nella direzione heideggeriana di un darsi-donarsi dell’essere stesso come evento impresentabile – e dunque
anche inappropriabile (Ereignis-Enteignis) –, al di là del presente e della presenza: cfr. Heidegger (1980).
55
Di particolare interesse Caputo - Scanlon (eds.) (2012). A fronte della copiosa bibliografia, si vedano almeno:
Schrift (ed.) (1997), Labate (2004), Bauer (2012), Hénaff (2012). Sul confronto diretto tra Derrida e Marion a proposito
del dono: Marion (2001 e 2008), Horner (2001), Tarditi (2008), Alvis (2016).
56
Derrida (1996), p. 8.
57
Mauss (2002).
58
Derrida (1996), p. 11.
59
Osserva Derrida: «Affinché ci sia dono, non deve esserci reciprocità, ritorno, scambio, contro-dono né debito.
[…] Esso si annulla ogni volta che c’è restituzione o contro-dono» (Derrida, 1996, p. 14).
60
Ivi, p. 16.
53
�Jacques Derrida e il non fenomenologico
Le stesse condizioni di possibilità del dono sono dunque le condizioni della sua impossibilità; di
qui l’affermazione paradossale, frequentemente fraintesa: «il dono è l’impossibile» 61. Il che non
significa affatto negare la possibilità del dono, bensì sottolineare come il dono sia la figura stessa
dell’impossibile, di una impossibile fenomenologia. Il dono, se ce n’è, accade senza lasciarsi vedere,
senza presentarsi, senza apparire, «nella misura in cui mai lo incontriamo, mai lo conosciamo, mai
lo verifichiamo, mai lo sperimentiamo nella sua esistenza presente o nel suo fenomeno. Il dono
stesso […] non si confonderà mai con la presenza del suo fenomeno»62. Nell’istante in cui appare, il
dono sparisce, attestando il “fallimento”, lo scacco, il limite insormontabile non solo della
fenomenologia, ma del fenomenologico in quanto tale: proprio per questo nessuna fenomenologia
del dono è possibile. Il dono non si presenta: «affinché ci sia dono, è necessario che il dono
nemmeno appaia, che non sia percepito come dono»63, sono necessarie, come sue condizioni impossibili, «l’inapparenza, la non-fenomenicità, la non-percezione, la non-conservazione»64, un
«oblio assoluto»65, così radicale da non potersi neppure configurare come una rimozione inconscia.
E questo oblio riguarda tanto il donatore che il donatario. Derrida insistentemente afferma:
Il dono non deve nemmeno apparire o significare, consciamente o inconsciamente, come dono per i
donatori, soggetti individuali o collettivi. Dal momento in cui il dono apparisse come dono, come tale,
come ciò che è, nel suo fenomeno, nel suo senso e nella sua essenza, esso sarebbe preso in una struttura
simbolica, sacrificale o economica che annullerebbe il dono nel circolo rituale del debito66.
Dovrebbe a questo punto risultare più comprensibile in che senso Derrida parli di «impossibilità
fenomenologica»67 a proposito del dono, e di come la sua non fenomenicità, l’«oblio assoluto» che
ne è la condizione di (im)possibilità, rinvii a quel «segreto assoluto» che nomina il limite del
fenomenologico sporgendo sul non fenomenologico: irriducibile al sapere, come al vedere, questo
segreto si sottrae radicalmente a ogni possibile fenomenologia, oppone, come la morte, che ne è la
figura esemplare, «una resistenza radicale alla luce della fenomenicità, una resistenza
irreversibile»68, che si rifiuta alla presentazione. Pertanto, «questo segreto non è fenomenalizzabile.
Né fenomenale né noumenale»69. Eterogeneo al nascosto, all’oscurità, al notturno, persino
all’invisibile e al non-manifesto, nella misura in cui ciascuno di questi termini rinvia, per negazione,
al suo contrario, questo segreto assoluto non è svelabile né riconducibile al gioco di velamento e
svelamento della verità [a-letheia]: «La sua non-fenomenalità è senza rapporto, neppure negativo,
con la fenomenalità. Il suo riservarsi non è più dell’ordine dell’intimità che si ama dire segreta, di
questa prossimità o appropriatezza che aspira o ispira tanti discorsi profondi (il Geheimnis o, ancor
più ricco, l’inespugnabile Unheimliche)»70.
61
Ivi, p. 9.
Ivi, p. 31.
63
Ivi, p. 18.
64
Ibidem.
65
Ivi, p. 19.
66
Ivi, p. 25.
67
Ivi, p. 123. Anche in altro contesto Derrida è tornato a ribadire in modo inequivocabile il carattere nonfenomenologico del dono e il suo sottrarsi ad una ontologia intesa come metafisica della presenza: «Qui si tratta di
pensare una cosa che non è una cosa, e che sotto il nome di dono non può essere né conosciuta né fenomenizzata. La
fenomenizzazione del dono lo annulla, dunque non c’è fenomenicità, non c’è fenomenologia, non c’è ontologia (il
dono non è un presente, un ente presente). Sfidando l’ontologia e la fenomenologia, sfida la dialettica. È un dono
che non dovrà avere niente da spartire con quanto in filosofia si chiama “dato”, con ciò che è presente, che è qui, e
che l’intuizione temporale o spaziale può ricevere come contenuto, come fenomeno» (Derrida - Ferraris, 1997, p.
31).
68
Derrida - Ferraris (1997), p. 51. Per un’analisi più approfondita dell’importante ruolo giocato dal segreto nel
pensiero di Derrida, mi permetto di rinviare a Resta (2016), I cap.: Il segreto della decostruzione.
69
Derrida (1997d), p. 119.
70
Ivi, p. 120. Per un confronto tra il Geheimnis, di cui in più occasioni parla Heidegger, e il «segreto assoluto» di
Derrida, mi permetto di rimandare a Resta (1996), pp. 112-119.
62
317
�Caterina Resta
In ultima istanza, «il segreto è l’ultima parola del dono che è l’ultima parola del segreto»71;
entrambi alludono alla morte, a quell’evento inappropriabile, impresentabile, inanticipabile
nonostante ogni pre-corrimento [Vorlaufen]. Questa morte incontro alla quale corriamo come ciechi
e che non si lascia né vedere né toccare, che si dona al di là di ogni possibile fenomenologia, questa
«morte che non appare mai in quanto tale, segna forse il limite del progetto fenomenologico […],
non ha posto nella fenomenologia in quanto tale»72. Pensiero di una vita che trema sapendosi
interrotta in ogni istante dalla morte, la decostruzione ha il «gusto del segreto», del non
fenomenologico non perché prediliga l’esoterico, ma solo perché intende assumere la morte come
limite insuperabile che nomina la finitezza e l’unicità di ogni esistente, il cui segreto resta
inaccessibile: «Una singolarità è per essenza nel segreto [au secret]»73, così come «altri [autrui] è
segreto perché è altro»74. È per questo che, in ascolto di Levinas, Derrida ripetutamente afferma:
«ogni altro è tutt’altro [tout autre est tout autre]. […] Ciascun altro, ogni altro [tout autre] è
infinitamente altro nella sua singolarità assoluta, inaccessibile, solitaria, trascendente, non
manifesta, non presente originariamente al mio ego […]. Ogni altro [tout autre] (nel senso di
ciascun altro) è tutt’altro [tout autre] (assolutamente altro)»75 e nessuna fenomenologia può avere
accesso a questo segreto che resiste nella sua inviolabilità.
Non la fenomenologia, ma il non-fenomenologico è allora il più inconfessabile desiderio della
decostruzione, la sua passione più segreta.
Bibliografia
Alvis, J. (2016), Marion and Derrida on The Gift and Desire: Debating the Generosity of Things,
Springer, Cham-Dordrecht-Heidelberg-London-New York.
Bauer, K. (2012), Einander zu erkennen geben. Das Selbst zwischen Erkenntnis und Gabe, Alber,
Freiburg-München.
Bernet, R. (1994), La vie du Sujet. Recherches sur l’interprétation de Husserl dans la
phénoménologie, PUF, Paris.
Bernet, R. (2008), La voie et le phénomène, in Crépon, M-Worms, F. (sous la dir.), Derrida, la
tradition de la philosophie, Galilée, Paris, pp. 65-85.
Blanchot, M. (1990), La scrittura del disastro, trad. it. e cura di F. Sossi, SE, Milano.
Caputo, J. D.-Scanlon, M. J. (Eds.) (2012), Dio, il dono e il postmoderno. Fenomenologia e
religione, trad. it. a cura di L. Astore et al., Mimesis, Milano-Udine.
Costa, V. (1992), La fenomenologia della contaminazione, in J. Derrida, Il problema della genesi
nella filosofia di Husserl, trad. it. e cura di V. Costa, Jaca Book, Milano, pp. 7-43.
Costa, V. (1996), La generazione della forma: la fenomenologia e il problema della genesi in
Husserl e in Derrida, Jaca Book, Milano.
Costa, V. (1997), Volerne sapere. Intenzionalità e produzione del significato, postfazione a J.
Derrida, La voce e il fenomeno, trad. it. e cura di G. Dalmasso, Jaca Book, Milano, pp. 147-173.
Costa, V. (2016), Dal trascendentale al differire, post-fazione a J. Derrida, La fenomenologia e la
chiusura della metafisica. Introduzione al pensiero di Husserl, trad. it. e cura di V. Perego, La
Scuola, Brescia, pp. 85-96.
Courtine, J.-F. (1990), Heidegger et la phénoménologie, Vrin, Paris.
Dastur, F. (2016), Déconstruction et phénoménologie: Derrida en débat avec Husserl et Heidegger,
Hermann, Paris.
Derrida, J. (1963), “Sur Phänomenologische Psychologie de E. Husserl”, Les études
philosophiques, vol. 2, pp. 203-206.
71
Derrida (2002), p. 67.
Derrida (2004), p. 96.
73
Derrida (2010), p. 49 [trad. parz. mod.].
74
Ibidem.
75
Derrida (2002), pp. 110-111.
72
�Jacques Derrida e il non fenomenologico
Derrida, J. (1964), “Sur E. Husserl’s Theory of Meaning de J.N. Monhanty”, Les études
philosophiques, vol. 4, pp. 617-619.
Derrida, J. (1971a), La scrittura e la differenza (1967), trad. it. a cura di G. Pozzi, Einaudi, Torino.
Derrida, J. (1971b), “Genesi e struttura” e la fenomenologia (1959), in La scrittura e la differenza,
trad. it. a cura di G. Pozzi, Einaudi, Torino, pp. 199-219.
Derrida, J. (1987), Introduzione a “L’origine della Geometria” di Husserl (1962), trad. it. e cura di
C. Di Martino, Jaca Book, Milano.
Derrida, J. (1992), Il problema della genesi nella filosofia di Husserl (1953-1954), trad. it. e cura di
V. Costa, Jaca Book, Milano.
Derrida, J. (1996), Donare il tempo. La falsa moneta (1991), trad. it. a cura di G. Berto, Cortina,
Milano.
Derrida, J. (19973), La voce e il fenomeno (1967), trad. it. e cura di G. Dalmasso, Jaca Book,
Milano.
Derrida, J. (1997a), Margini della filosofia (1972), trad. it. e cura di M. Iofrida, Einaudi, Torino.
Derrida, J. (1997b), La forma e il voler-dire. Nota sulla fenomenologia (1967), in Margini della
filosofia, trad. it. e cura di M. Iofrida, Einaudi, Torino, pp. 209-233.
Derrida, J. (1997c), La différance (1968), in Margini della filosofia, trad. it. e cura di M. Iofrida,
Einaudi, Torino, pp. 27-57.
Derrida, J. (1997d), Passioni. “L’offerta obliqua” (1993), trad. it. a cura di F. Garritano, in
Dalmasso G.-Garritano, F. (a cura di), Il segreto del nome. Chora, Passioni, Salvo il nome, Jaca
Book, Milano.
Derrida, J. (19982), Della grammatologia (1967), trad. it. a cura di R. Balzarotti et al., a cura di G.
Dalmasso, Jaca Book, Milano.
Derrida, J. (1999), Punteggiatura: il tempo della tesi (1980), trad. it. a cura di E. Sergio, in
Garritano F. (a cura di), Del diritto alla Filosofia, Abramo, Catanzaro.
Derrida, J. (2002), Donare la morte (1990), trad. it. a cura di L. Berta, Jaca Book, Milano.
Derrida, J. (2004), Sulla parola. Istantanee filosofiche (1997-1999), trad. it. a cura di A. Cariolato,
Nottetempo, Roma.
Derrida, J. (2007), Toccare, Jean-Luc Nancy (2000), trad. it. a cura di A. Calzolari, Marietti,
Genova.
Derrida, J. (2010), Al di là delle apparenze. L’altro è segreto perché è altro (2001), trad. it. a cura
di S. Maruzzella, Mimesis, Milano-Udine.
Derrida, J. (2016), La fenomenologia e la chiusura della metafisica. Introduzione al pensiero di
Husserl (1966), trad. it. e cura di V. Perego, La Scuola, Brescia.
Derrida, J. - Ferraris, M. (1997), «Il gusto del segreto», trad. it. a cura di M. Ferraris, Laterza,
Roma-Bari.
Di Martino, C. (1987), Derrida all’origine, trad. it. e cura di C. Di Martino, in J. Derrida,
Introduzione a “L’origine della Geometria” di Husserl, Jaca Book, Milano, pp. 11-68.
Di Martino, C. (2001), Oltre il segno. Derrida e l’esperienza dell’impossibile, Angeli, Milano.
Heidegger, M. (1980), Tempo ed essere, trad. it. a cura di E. Mazzarella, Guida, Napoli.
Heidegger, M. (1992), Seminario di Zähringen 1973, in Seminari, trad. it. a cura di M. Bonola,
Adelphi, Milano.
Hénaff, M. (2012), Le don des philosophes, Seuil, Paris.
Horner, R. (2001), Rethinking God as Gift. Marion, Derrida and the Limits of Phenomenology,
Fordham University Press, New York.
Houillon, V. (2002), “La suspension de la phénoménologie: la déconstruction. (L’héritage ininterrompu de Levinas à Derrida)”, Rue Descartes, vol. 35, pp. 29-46.
Howells, Ch. (1998), Derrida: Deconstruction from Phenomenology to Ethics, Polity Press,
Cambridge.
319
�Caterina Resta
Labate, S. (2004), La verità buona. Senso e figure del dono nel pensiero contemporaneo, Cittadella,
Assisi.
Lawlor, L. (2002), Derrida and Husserl: The Basic Problem of Phenomenology, Indiana University
Press, Bloomington.
Marion, J.-L. (2001), Dato che. Saggio per una fenomenologia della donazione (1997), SEI, Torino.
Marion, J.-L. (2008), L’impossible et le don, in Crépon, M.-Worms, F. (sous la dir.), Derrida, la
tradition de la philosophie, Galilée, Paris, pp. 155-170.
Marion, J.-L. (2010), Riduzione e donazione. Ricerche su Husserl, Heidegger e la fenomenologia
(1989), trad. it. a cura di S. Cazzanelli, Marcianum Press, Venezia.
Marion, J.-L. (2012), Figures de phénoménologie: Husserl, Heidegger, Levinas, Henry, Derrida,
Vrin, Paris.
Marrati, P. (1998), La Genèse et la Trace. Derrida lecteur de Husserl et Heidegger, Kluwer,
Dordrecht-Boston-London.
Marrati, P. (2000), “Idéalité et différence. Derrida et l’autre Husserl”, ALTER, vol. 8: Derrida et la
phénoménologie, pp. 179-198.
Mauss, M. (2002), Saggio sul dono, trad. it. a cura di F. Zannino, Einaudi, Torino.
McKenna, W. R.-Evans, J. C. (eds.) (1995), Derrida and Phenomenology, Kluwer, DordrechtLondon.
Nobile, L. (2004), Derrida e Husserl. L’enigma del presente vivente, Siciliano, Messina.
Perego, V. (2016), Derrida e la fenomenologia come epistéme, in J. Derrida, La fenomenologia e la
chiusura della metafisica. Introduzione al pensiero di Husserl, trad. it. e cura di V. Perego, La
Scuola, Brescia, pp. 5-41.
Peeters, B. (2010), Derrida, Flammarion, Paris.
Resta, C. (1996), Il luogo e le vie. Geografie del pensiero in Martin Heidegger, Angeli, Milano.
Resta, C. (2003), L’evento dell’altro. Etica e politica in Jacques Derrida, Bollati Boringhieri,
Torino.
Resta, C. (2016), La passione dell’impossibile. Saggi su Jacques Derrida, il melangolo, Genova.
Resta, C. (2017), Bio-thanato-politica: una questione di vita e di morte, in Stimilli, E. (a cura di),
Decostruzione o biopolitica?, Quodlibet, Macerata, pp. 39-54.
Rovatti, P.A. (1996), Cercare mezzodì alle quattordici, premessa all’edizione italiana di J. Derrida,
Donare il tempo. La falsa moneta, Cortina, Milano, pp. IX-XVI.
Schrift, A.D. (Ed.) (1997), The Logic of the Gift, Routledge, London.
Sebbah, F.-D. (2001), L’épreuve de la limite: Derrida, Henry, Levinas et la phénoménologie, PUF,
Paris.
Tarditi, C. (2008), Con e oltre la fenomenologia. Le “eresie” fenomenologiche di Jacques Derrida
e Jean-Luc Marion, il melangolo, Genova.
Vergani, M. (2000), Jacques Derrida, Bruno Mondadori, Milano.
Vitale, F. (2012), La vita e la morte, in Facioni, S.-Regazzoni, S.-Vitale, F. (Eds.), Derridario.
Dizionario della decostruzione, il melangolo, Genova.
Völkner, P. (1993), Derrida und Husserl. Zur Dekonstruktion einer Philosophie der Präsenz,
Passagen, Wien.
Abstract
From its very first steps, Derrida’s thought engages a close confrontation with Husserlian
phenomenology in order to take distance from it. My thesis is that, in spite of a claimed “fidelity” to
phenomenological method, Derridian thought of différance has as its own preferential critical target
phenomenology itself, intended as thought of the living present, of presence and of evidence.
Starting from this thesis, deconstruction may be read first of all as deconstruction of
phenomenology. It shows the irreducible character of the “non-phenomenological,” which every
phenomenology tries to conceal as its own limit, as testified by Derrida’s analysis of gift and secret.
�Jacques Derrida e il non fenomenologico
These belong to the thought of sur-vival, which reveals death – the non-phenomenological par
excellence – in the heart of life.
Keywords: Derrida, Gift, Phenomenology, Secret
321
�CARLO SERRA*
Ritmo e durata fra Husserl e Bachelard
1. Forma concentriche dell’attenzione
Difficile non cogliere la complessità di temi che sollecita l’invito «Fai attenzione»: rimandando ad
un brusco mutamento nel nostro intendere il mondo, ci impone un riesame complessivo del già
esperito. Far attenzione a qualcosa può così essere un invito a riprendere una scena appena
trascorsa, per portarne al centro un aspetto, o un intreccio di dettagli, che, sulle prime, rimaneva
inavvertito: stavamo guardando qualcosa quando l’emergere di un dettaglio, o l’aprirsi di una
lacuna nella scena percettiva ci invita a guardare meglio. Il guardar meglio può consistere in un
restringimento del fuoco su questo o su quell’elemento, o nel cogliere come un nuovo aspetto entri
in rapporto col proprio contesto: operazioni simili, ma distinte fra loro, che lasciano traccia in usi
linguistici caratteristici:
Hai riconosciuto la sfumatura di quel colore? Individui un profilo comune fra due forme che si
intrecciano? Avverti come si fondono fra loro quei suoni? A forza di pensarci, mi sono ricordato
che...
Sotto la pressione di tali sollecitazioni il campo percettivo viene ripercorso, in continuità con
quanto abbiamo visto, ascoltato, sentito prima, ma con diversa tensione constatativa, tesa a rilevare
differenze, modificazioni, rispetto al quadro prima semplicemente inteso. Vi sono aspetti ambigui:
faccio attenzione ed ora qualcosa si staglia di fronte a me in modo più definito, emergendo rispetto
ad un contesto, secondo una relazione di contrasto e di continuità: il colore rosso, ad esempio,
emerge da uno sfondo bianco, è grazie a quello sfondo che viene percepito con nettezza, mentre se
fosse percepito come sfumatura nel susseguirsi dei rossi, verrebbe inteso in modo differente. Nel
mondo delle attese percettive, si aprono dunque varchi, in cui la scena attentiva, apparentemente
scissa in due, recupera tutti i nessi che galleggiano attorno alle cose in primo piano. Ancor più
interessante quanto accade sul piano memorativo: sotto la pressione del presente alcuni aspetti di
una scena o di un vissuto, vengono riattivati nel movimento verso l’individuazione di un particolare.
Vi è così un nesso nel discontinuo delle fasi (l’espressione paradossale sta al centro del problema)
in grado di far riprendere una scansione: per operare, chiede che i piani percettivi siano articolati
diversamente, dando ragione di inclusioni reciproche, e differenziazioni. Il concetto di scansione si
impone: esso determina il modo in cui prende forma un’articolazione ritmica, nella musica o nel
verso. In quei contesti, scandire significa descrivere come i rapporti fra suoni, o le partizioni
spaziali su una superficie, accadono, seguendo un ordine, o meglio, facendolo percepire. Il puntare
l’attenzione su qualcosa non significa solo lasciarlo semplicemente emergere da un contesto, ma
definire le forme attraverso cui quel raggruppamento lo lascia emergere.
Ma cosa accade nel costituirsi del diaframma, nella regione intermedia, che separa l’area isolata
dall’attenzione rispetto a quanto la circonda? In quel mobile punto di contrasto, esiste infatti una
concentricità, che differenzia rilievo e sfondo, condizionandoli reciprocamente.
Il tema che tormenta Husserl nella analisi dell’attenzione è definire le forme della concentricità
rispetto agli aspetti inclusivi da cui viene condizionata, e, soprattutto, come sorga e su cosa si
sostenga. Constatare qualcosa significa appunto praticare l’individuazione di un elemento
contestualizzandolo, rispetto a un prima e un dopo: i testi husserliani sono segnati da ritorni
ossessivi sul tema del discreto, del continuo, e sulla scansione temporale attraverso cui si disegna il
rilievo che distacca l’elemento da quanto lo circonda.
____________________________
*
Università della Calabria
Bollettino Filosofico 33 (2018): 322-334
ISSN 1593 -7178 - 00030
E-ISSN 2035 -2670
DOI 10.6093/1593-7178/5927
�Ritmo e durata fra Husserl e Bachelard
La sezione che prenderemo in considerazione è un brillante contributo giovanile, innestato su
una serie di lezioni composte successivamente: ha il valore di un completamento da svolgere, una
riflessione dal valore di un fossile, inserita in un nuovo tessuto, che dovrebbe sostenerne lettura e
interpretazione. L’innesto di un testo dentro un altro porta sempre alla formazione di ambiguità che
vanno sciolte, nella precarietà di una collazione che non si chiuderà mai con certezza: ci consola
solo che sia stato l’autore stesso ad aprire questo scenario, senza esplicitarlo fino in fondo.
Nell’avviarsi della ricerca sui fenomeni attentivi è facile individuare una tendenza di fondo, che
orienta tutta la ricerca: esplicitiamola, con le parole di Husserl:
Una coscienza unitaria si attesta attraverso gli atti individuali che si susseguono uno dopo l’altro, oppure si
erige sul loro fondamento. Realizziamo la percezione α, e poi manteniamo salda l’intenzione diretta su α,
mentre diamo vita alla percezione β. Manteniamo ancora ben salda la direzione verso β, quando
percepiamo γ. Espresso in termini logico linguistici, noi non percepiamo semplicemente α poi β e poi γ,
bensì percepiamo α ε β ε γ, percepiamo l’insieme di tutte e tre queste cose […] (esclusa la funzione del
ricordo, legata al fatto che le percezioni accadono all’interno di una struttura che è già protenzionaleritenzionale). In questo intendere, che si è concluso con la percezione di γ, possediamo dunque una
coscienza percettiva, che porta a sintesi in maniera del tutto peculiare singole percezioni effettivamente
distinte. La sintesi possiede il carattere di una percezione (ma non della percezione in senso comune),
poiché essa ha appunto un oggetto, diverso da quello delle singolarità individuali, l’insieme delle tre
1
singolarità, appunto.
L’insieme di tre singolarità, ossimoro apparente che Husserl scioglie così: nel processo percettivo di
un intero le oggettualità si fondono in un oggetto diverso, che si articola attraverso le tre percezioni
distinte, come accade per le singole note raccolte verticalmente in un accordo, o per le sfumature
cromatiche che si susseguono al variare della luce sulla superficie di un tavolo: una scena è interna
all’altra, non vi è un semplice susseguirsi di elementi semplici, ma un intreccio. Nasce una tensione
dinamica fra differenze, che si contestualizzano reciprocamente: da questo riorientamento si
sviluppa una sintesi, che scioglie le singole componenti in un processo più ampio, unitario, in cui le
percezioni si associano in una metrica comune. Sul piano temporale si perviene ad una sola
inquadratura, tra fasi distinte del medesimo processo percettivo, assimilato ad una scansione che
esibisce l’unita di ciò che appariva separato.
Il tema della concentricità prende forma perché la percezione non ha solo una logica interna, ma
una propria ritmicità di esplicitazione, di cui Husserl vuol fare questione fin dal 1898 2. È evidente
che non basta vederla operare per focalizzazioni successive, come accade per le esplicitazioni di cui
si fa carico l’atto attentivo: le esplicitazioni sono evidentemente conseguenza di un fenomeno più
profondo, che porta alla luce un criterio d’ordine nascosto, che organizza l’intreccio degli atti
percettivi. Per coglierne fino in fondo il senso, dobbiamo indagare sul tema oscuro dell’interesse,
che mette in movimento le risposte percettive al mondo, nell’unicità di un focus.
2. La riduzione all’unitario come apertura alla continuità
Husserl si logora in una ricerca attorno alla natura dell’interesse, che egli vincola al costituirsi del
processo percettivo: la tensione dell’attesa fra due colpi in una sequenza ritmica, la reazione che
collega l’intensificarsi o l’attenuarsi di un rumore rispetto al diminuire o all’aumentare della
distanza da un oggetto, l’attesa relazionale fra movimenti in un inseguimento, o il semplice scorrere
dello sguardo alle prese con l’ambiente che lo circonda, determinano strutture percettive concrete,
connesse secondo regole che vanno strecciate. Dobbiamo individuare la natura dell’interesse che
mette in movimento continuamente l’intreccio degli atti percettivi, senza la pretesa di giungere ad
un elemento primitivo, ma cogliendo la relazione strutturale, che ne garantisca l’attivazione: «Ora
questo interesse, e con intensità anche molto diverse, fa la sua comparsa spesso, se non senza
1
Husserl (2016), pp. 99-100.
Sulle vicende complesse dell’impaginato vedi le osservazioni di Scanziani pp. 18-25. Cercheremo di seguire come
un blocco unitario quanto Husserl ha raccolto in vista di una argomentazione definitiva mai raggiunta.
2
323
�Carlo Serra
eccezioni, sulla base di una percezione […]. L’interesse mi appare come un atto (un vissuto) di
quella classe che raccolgo sotto il titolo di vissuti intenzionali, ed in particolare mi sembra
accomunato agli atti del tipo dell’attendere, del desiderare, del volere e simili»3.
Nell’ambiente che la circonda, la coscienza sembra costituzionalmente attraversata da forme di
autotrascendimento, agitate dal puntare verso qualcosa che stia fuori di lei, richiamandola: in questo
senso costituisce un mondo di correlazioni, attraverso vissuti, che rispondono alle diverse
oggettualità che li attivano. L’interesse si sviluppa all’interno di questa sfera, costituita da livelli che
si intrecciano continuamente fra loro, orientando la prassi percettiva verso mete differenti4.
Il doppio livello messo in gioco dall’interesse si rende più evidente nelle esemplificazioni
musicali: ascoltiamo l’intreccio delle voci in una fuga, ora avendo di mira le relazioni spaziali fra le
note, ora le componenti timbriche del suono, ora le intersezioni ritmiche nelle durate. Vi è una
sostanziale continuità nel manifestarsi di questi aspetti, legati alla tensione interna all’ascolto, ma si
differenziano aspetti, che toccano piani analitici che si graduano fra loro: individuo l’intervallo, il
colore timbrico e le relazioni fra durate come momenti che manifestano aspetti diversi nello stesso
intero percettivo. Negli atti, caratteristicamente, vi sarà una tensione (intenzione) che corre verso
una risoluzione (riempimento), graduandosi anch’essa su scale di intensità diversa.
Husserl intende rintracciare una scansione interna all’atto, che porti alla luce il costituirsi del
piano teoretico dal piano motivazionale, senza chiudere immediatamente il discorso nel circolo fra
appagamento e mancanza, qualcosa di già costituito. Si mira così a ricostruire la funzione fondante
dell’interesse all’interno del decorso percettivo fra motivazione ed intellettualità, in un continuo
saliscendi di livelli analitici che toccano sfere diverse: per isolare tale fase dobbiamo entrare nella
discontinuità del rapporto ritmico, tenendo la presa sulla funzione unificante dell’interesse:
Sarebbe una descrizione sbagliata quella che volesse indicare la felicità rispetto all’apparire dell’oggetto
desiderato come riempimento del desiderio. Non lo sarebbe affatto se il desiderio in me non fosse più
“vivo”. Se si verifica quest’ultimo caso, allora con l’apparire di ciò che è desiderato, il desiderio si rinnova,
e si riempie nel possesso conquistato. Questa coscienza di riempimento è un vissuto di tipo del tutto nuovo,
che nella sua determinazione interna corrisponde esattamente a quella dell’atto dell’intenzione. 5
Se volessimo comprendere il senso della divaricazione che si apre fra la fenomenologia di Husserl e
l’interpretazione che ne propone Heidegger6, potremmo partire dalle differenze di metodo, e di
modalizzazione logica, su questo tema: il desiderare è un processo intenzionale in divenire, in cui
l’apparire di ciò che è desiderato ha un valore retroattivo, che modifica e stimola l’accadere del
processo, perché il vissuto riempito ha un nuovo colore, che innesta un processo di identificazione
fra il primo momento intenzionale, e ciò che lo ha soddisfatto. Ecco perché il tema del desiderio
non ha qui un valore fondativo: non è momento originario nella costituzione del senso, ma qualcosa
che si forma in un processo retto da altro.
Il piano della relazione originaria si muove su un piano teoretico conoscitivo, in cui l’oggetto
viene esplorato a seconda dei punti di vista che vengono a nutrire il movimento intenzionale. La
3
Ivi, p. 133.
Cfr. l’introduzione di Paolo Spinicci a questi testi, in particolare pp. 8-11.
5
Ivi, p.134
6
Il lettore in cerca di confronti osservi come vengano proposte le modalità del prendersi cura del mondo, il concetto
di inclinazione, e la distanza prese in analisi nel corso heideggeriano del 1921/22: la ricognizione sull’essere incline e
sulla categoria del rilucente, fino al trascinamento, viene giocata esclusivamente all’interno del punto di arrivo,
l’autosoddisfazione, e del punto di partenza, la distanza, senza che si entri nel merito delle strutture fenomenologiche
che sostengono tale arco, se non all’interno di un originario, e generalissimo, senso del mondo. Lo stesso dinanzi, la
condizione che la vita ha per incontrare se stessa, matura immediatamente dal piano meramente percettivo a quello del
chiudersi, senza coronare il compito che qui Husserl si pone, ossia cogliere le forme di costituzione dei poli da cui
prende inizio la relazione. Il nucleo del contrasto fra i due filosofi andrebbe probabilmente cercato nelle forme di
costituzione modale della correlatività: per un confronto testuale cfr. Martin Heidegger, (1990), pp. 130-137.
(Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles. Einführung in die phänomenologische Forschung, Frankfurt a.M.,
Klostermann, 1985).
4
324
�Ritmo e durata fra Husserl e Bachelard
spinta, tuttavia, arriva da un piano più interno: la fase percettiva modifica le risposte determinate
dall’interesse stesso, in un gioco di focalizzazioni successive sostenute dalla spinta che attiva il
momento percettivo.
Si apre così un’angolatura del problema tautologica, e preziosa: con finezza, il fenomenologo
spiega che ove entri in scena un interesse teoretico sulla base di una percezione, o di una sintesi di
percezioni scandite da un interesse, come accade quando guardo l’inanellarsi dei dettagli in una
fotografia, il processo assumerà la forma di un atto complesso che ha però la peculiarità di fondare
nella sua unità una molteplicità di tensioni e risoluzioni. Come ormai ci attendiamo, non si tratterà
di una somma di atti singoli, ma, diremmo noi, di una serie di atti guidata da un interesse
complessivo unitario: torna così un aspetto stilistico del pensiero husserliano, la vocazione
continuista, rispettata almeno in termini di principio.
Una scansione fatta da atti differenziati, ma motivati da un unico interesse, assume il carattere di
un ciclo ritmico, che può correre lungo differenti strati temporali, riunendo il processo non in un
disgregato di momenti separati ma in fasi, colte unitariamente.
Nel percorso percettivo si apre così una doppia strada, secondo una direzione fenomenologica
nota: le intenzioni che vengono progressivamente riempite dalla risposta, si trasformano in una
risposta che apre su nuovi aspetti, come accade, prendendoci qualche libertà rispetto alla
scrupolosissima analisi husserliana, nei disegni schematici, quando iniziamo ad unire i punti
dispersi del tracciato grafico in un profilo. Con lo smascherarsi della forma, ad ogni lato
dell’intenzione della percezione, determinata nelle apprensioni, e nelle sue apprensioni parziali,
corrisponde un lato nella intenzione dell’interesse, in un processo di continua riapertura del piano
del possibile, che scandisce ormai processi motivazionali sensibilmente diversi, articolati secondo
un modo di intendere unitario: l’unitario e il continuo, per quanto possa apparire paradossale, si
costituiscono assieme.
3. Affacciarsi sul processo di scansione
La logica inclusiva, che determina la concatenazione nel processo attentivo, si orienta sempre verso
il pieno, secondo rapporti di implicazione reciproca, che creano attesa rispetto al vuoto, che
punteggia il susseguirsi dei movimenti intenzionali: così il profilo qualitativo dell’interesse unitario
coincide con una forma che si imbeve di materia, secondo la regola per cui nel dipanarsi del
decorso delle percezioni, l’interesse sembra tanto guadagnare quanto perdere e le intenzioni
trapassano in riempimenti, i riempimenti in intenzioni. Sono formule che possono apparire oscure, e
che invece danno ragione del processo per cui ogni aspetto di un oggetto che cade sotto la lente
dell’interesse, non solo riempie un atto intenzionale, ma diventa anche il tema per un riempimento
successivo. Una percezione cromatica si riempie, ad esempio, di un contenuto intenzionale, il colore
rosso, ad esempio, per poi fungere da sostrato per una diversa esplorazione, che ne voglia, ad
esempio, determinare la sfumatura. Il dito scorre su una superficie ruvida, e la grana della materia
sollecita la percezione dell’attrito, modulandone la densità puntiforme in un continuum che scorre.
L’analisi fenomenologica punta gradualmente verso la comprensione di un fenomeno intensivo,
il variare dell’intensità nel processo percettivo: per poter cogliere il modo della variazione,
dobbiamo individuare la forma in cui venga scandito l’arco fra riempimento ed intenzione, per poter
poi definire il carattere di intensità che si ripercuote sull’intero. Husserl si affida ad un
procedimento analogico, basato ancora sulla concentricità delle focalizzazioni nel fenomeno
unitario, in cui singole oggettualità vengano assorbite come momenti: la situazione trova un
modello nella percezione di un complesso sonoro, ove ogni suono differente contribuisca con la
propria intensità al carattere complessivo dell’intensità del gruppo: i suoni hanno ciascuno una
propria intensità, ma vengono percepiti in modo diffuso come un complesso di intensità
determinata. La percezione coglie quindi nuclei sonori, in cui tutte le gradazioni si fondono
assieme.
Allo stesso modo, nel processo fra intenzione e riempimento le intensità dei singoli cicli si
fondono assieme, perché determinate dall’intensità dell’interesse che va mettendole a fuoco. Inoltre,
325
�Carlo Serra
nel continuo dislocarsi del focus e dei suoi orli, il processo attentivo tollererà lacune o discontinuità:
in mancanza di una risposta, (aspetto il tuono dopo il fulmine, ma il tuono non viene, per mille
ragioni, ascoltato), la concatenazione non prende forma, o si interrompe. Nel caso della forma di
insaturazione, tuttavia, ciò che agita il processo intenzionale rimane pur sempre interesse, magari
colto nella ricerca di un senso, che non arriva. Husserl osserva, con profondità notevole, che,
proprio per questi motivi l’interesse non coincide né con il desiderio, né con l’attesa (altra
differenza fondamentale dai geniali esistenziali di Essere e Tempo), ma che è sostanzialmente
libero, e in grado di tollerare variazioni radicali.
Possiamo così scendere all’interno della scansione, per cogliere la natura della relazione fra atti e
qualità dei contenuti, un passaggio indispensabile per comprendere lo snodo più delicato del
problema, come emerga l’innesco fra atto di interesse e lato percettivo. Le argomentazioni di
Husserl assumono ora un carattere che può ricordare la pervicacia ontologica del conatus
spinoziano, o il movimento desiderante della Volontà schopenhaueriana, ma lo stile analitico che le
percorre segna una differenza invalicabile, rovesciando i termini della questione:
Proprio come ciò che ha per noi valore, ma è già in nostro possesso, non ci soddisfa nemmeno
lontanamente, quanto ci tormenta la deprivazione di ciò che ancora ci manca […] allo stesso modo prevale
all’inizio l’intensità delle intenzioni che sono state suscitate per prime mentre nel corso delle percezioni
prende il sopravvento l’intensità dei loro riempimenti. Tra le intenzioni che vengono suscitate ad ogni
nuovo passo, un gruppo si riferisce a momenti oggettuali rispetto a cui, appunto, l’interesse si è appena
appagato; un altro gruppo di intenzioni si riferisce a quei momenti che devono offrirsi per la prima volta al
percepire. Questi ultimi sono senz’altro i privilegiati: il nuovo “eccita” l’interesse, ed è per questo che
parliamo di curiosità, di sete del nuovo [Neugier]. Lo stimolo consiste qui in un aumento dell’intensità che
conferisce all’intenzione corrispondente un peso più rilevante nell’interesse totale, e questo significa che
esso determina maggiormente il suo carattere complessivo.7
La discussione brentaniana, che giunge sino a Stumpf, sul tema del piacere cognitivo aristotelico si
fa certamente avvertire nelle incrostazioni linguistiche dell’argomentazione, ma l’esito cui si
perviene sovverte completamente quel modello. Per comprendere come dar ragione degli
incrementi di intensità interni all’interesse, dobbiamo puntare descrittivamente alla fase di trapasso
tra nuove e vecchie percezioni, trascinata dalla sete del nuovo: qui, il rinforzarsi della tensione
pervade l’andamento del processo, quando passiamo dalla saturazione dell’interesse attraverso il
lato noto di qualcosa all’insaturazione legata all’apparire di una intenzione volta verso ciò che si
affaccia all’attenzione per la prima volta. Husserl parla di atti fusi fra loro, non separabili, ma è la
retroattività della funzione dell’interesse, che brucia il nuovo, che si lascia guidare dagli incrementi
differenziali di intensità. La discontinuità che li rende scandibili, è dunque apparente, perché la
forma del processo interno al percepire è un continuo percorrere la soglia, nello scivolamento dal
noto all’appena arrivato. Questo doppio movimento ha tutti i caratteri di una continuità avanzante,
ed ha un valore pervasivo, del tutto originale.
Nel risuonare dell’espressione prima volta, emerge naturalmente una polemica verso Hume, e la
tradizione associazionista, ma essa copre qualcosa di meno scontato: se non esiste storicamente una
prima volta della percezione, obliata e tessuta assieme da abitudini pregresse, vi è però una
funzione di novità, di prima apertura, interna ad ogni processo percettivo, una eccitazione che, è il
caso di dirlo, protende verso il contenuto nuovo, lo articola attraverso una serie di atti che registrano
un picco di intensità, legato alla sorpresa per l’inaspettato, dentro al regime di attese mosse dalla
dimensione di una fruizione irrefrenabile 8. Difficile non cogliere la peculiarità della relazione
temporale, appena tematizzata e in cerca di sviluppo, ma che si stende fra i contenuti percettivi, e,
tramite la trasversalità dell’interesse, costruisce un arco in cui i contenuti appena passati e quelli
7
Husserl (2016), p. 137.
Il tema si lega, naturalmente, alla ricerca che Husserl svilupperà nell’ambito del rapporto fra percezione dell’unità
nell’articolarsi dei suoi profili espliciti e nascosti. Una bella ricostruzione ne viene offerta da Michela Summa nel
suggestivo Summa (2014), pp. 200-207.
8
326
�Ritmo e durata fra Husserl e Bachelard
incombenti si stringono fra loro: approdiamo, finalmente, alle spalle del rapporto fra interesse e
percezione, nella logica costitutiva delle sue condizioni di possibilità. Tali aspetti prenderanno
consistenza nell’ultimo Husserl, portando all’elaborazione della nozione di orizzonte.
Lo scivolamento nel processo incrementale dell’intensità è fenomeno ritmico, che si salda in un
continuo relazionale: le nuove intenzioni trascinano verso di sé sulla base del già percepito,
svelando quanto l’atteggiamento dell’interesse sia preliminare allo stesso piano intenzionale. Forse
l’espressione stimolo può sembrare dissonante, rimandando al terreno di una psicologia empirica
ma se Husserl avesse usato l’espressione Erlebnis, così analoga al Cogitatum cartesiano, si sarebbe
spinto oltre la regione appena dissodata, che sostiene l’affacciarsi dei vissuti, rispetto allo stesso
piano dei sentimenti. La difficoltà si scioglie pensando che Husserl intenda qui lo stimolo come
pura variante incrementale, domanda che spinge verso qualcosa, una forza che modifica, trasforma
il senso di quanto ora percepito, rispetto a ciò che è appena passato.
I momenti che devono offrirsi come nuovi al percepire sono i costituenti degli indici qualitativi
di variazione di intensità: questo implica che il desiderio si costituisca dopo l’interesse. Dato questo
modello, i sentimenti entreranno nel processo, come motori interni, capaci di guidare il colore
dell’interesse verso le cose. Essi divengono le sorgenti del processo stesso, determinando
atteggiamenti e stati psicologici: ne deriva che l’aver interesse per qualcosa è un’espressione
modale, relazionale, collocata trasversalmente dietro a tutto il piano dell’esperienza.
Altra conseguenza, essenziale: siamo abituati a vedere l’intensità come un modo di incremento o
decremento di qualcosa che viene isolato, e definito, secondo una logica del più e del meno. Nel
momento in cui Husserl la colloca all’interno della sete di nuovo, permettendole di accompagnare
in uscita ciò che è già noto, l’intensità, come lo stimolo, diventa modificazione qualitativa, la cui
incrementalità modifica la natura degli atti.
Entrando nella finestra della scansione, il piacere del ritmo si consolida nel gusto per una
discontinuità apparente, che proietta le attese percettive dal passato al futuro: l’atteggiamento di
apertura e condizionamento ambientale determinato dalla sete di nuovo può stabilizzarsi e chiudersi
nei momenti di equilibrio e di possesso dello spazio circostante in un presente statico, in cui non vi
sia più nulla da scoprire: ma anche in un contesto appiattito dall’abitudine, la tendenza ritmica, con
il suo movimento proiettivo, permane, pronta a riattivarsi nel caso delle trasformazione delle
condizioni di contesto. Molla interna, che dilaga pervasivamente in tutti gli atti di coscienza, essa si
rivela un implacabile motore che sovraintende tutti i rivolgimenti intenzionali che ci legano al
mondo.
Di qui le conclusioni di Husserl, sofisticate nell’illuminare, in forma diversa, percorsi
ampiamente consaputi: non solo l’interesse condiziona implacabilmente il percepire, dalle forme
meno articolate alle più evolute, dando unità di scansione ai molteplici atteggiamenti intenzionali
che ci legano al mondo ma, se lo stesso oggetto può prestarsi a molteplici rapporti di interesse, che
trapassano continuamente l’uno nell’altro, è possibile parlare di un interesse unico che si dispiega
attraverso essi, e tocca tutti i piani di costituzione del processo intenzionale. L’impulso è unico, e
sostiene, di fatto, tutte le modalizzazioni.
Il permanere di un polo identitario, dal colore spinoziano, che trapassa nei singoli atti, abitandoli
dall’interno, garantisce una ideale continuità di scansione, una coerenza originaria nella forma
dell’accadere delle differenze, delle unità di interesse che idealmente si coappartengono. È un
passaggio che rovescia drasticamente il senso del percettivo, inteso su un piano motivazionale, che
guida la soggettività nei confronti dei lati del mondo che le vengono incontro.
inoltre, così come vari oggetti si uniscono assieme in unità obbiettive sempre più comprensive, così anche
gli interessi si organizzano in unità di interesse più ampie. Il movimento di osservare in un unico nesso di
esperienza molteplici oggetti è abbracciato e governato dalla “unità dell’interesse” che è, a sua volta,
un’unità organizzata di interessi particolari, i quali a loro volta si presentano come un complesso delle unità
di interesse che si co-appartengono.9
9
Ivi, p. 138-139.
327
�Carlo Serra
L’unico nesso di esperienza sembra essere gestito dalla pulsazione dell’unità di interesse, una
serializzazione di una pluralità di atti che puntano ad interessi particolari che però si coappartengono, come quando lo sguardo, insegue un raggruppamento di punti, il cui intervallo,
rarefacendosi, viene addensandosi in un segmento. L’interesse copre già un intreccio ritenzionaleprotenzionale, per quanto imperfettamente formulato: forse qui giace la molla che muove Husserl al
recupero di queste vecchie aperture del problema, nella nuova finestra legata alle lezioni del 19041905.
4. Gaston Bachelard: dalla continuità al riposo
Accostare un Husserl, ancora legato al periodo giovanile, al Gaston Bachelard di Dialettica della
Durata non è agevole: il filosofo francese negli anni trenta non è ancora interessato a un piano
fenomenologico, anche se i contatti interni fra la sua speculazione e quel pensiero sono ricchi, e
facilmente avvertibili. Riteniamo, tuttavia, che un breve confronto con la tradizione fenomenologica
sul tema del ritmo, e dell’interesse, possa risultare stimolante, per comprendere le peculiarità del
suo modo di intendere il tema temporale.
La discussione sul ritmo prende forma nella fase surrazionalista del suo pensiero, con la densità
concettuale de La dialectique de la durée (1936): nel lavoro, destinato a lasciare un’eco durevole
sugli studi di etnomusicologia, il problema viene affrontato sul piano metafisico, su quello di una
sua germinazione nella ricostruzione psicologica dei vissuti, utilizzando un registro che non
disdegna aperture sulle forme retoriche, sugli schemi logici attraverso cui costruiamo una funzione
concettuale, sul frazionarsi del tempo in musica fino alla costituzione testurale della materia che ci
circonda.
La materia, che Bachelard legge attraverso le riflessioni di Pinheiro dos Santos, è dissonanza
ritmica, un coagularsi di consistenze sostenute da ritmi diversi, in una cacofonia di vibrazioni:
catturata nello spasmo, la materialità sembra in attesa di un mago che, riaccordandone i ritmi, la
riconsegni al puro vibrare. La fisica ondulatoria, con i suoi richiami all’acustico, assumerà così la
valenza di un mito fondazionale, perché coglie una tematica metafisica, secondo un altro punto di
vista.
Seguendo così lo schema di un trattato filosofico sui generis, che muove dall’astratto verso il
concreto, Bachelard disegna la via ad una metafisica del ritmo, dialetticamente legata al discorso sul
continuo bergsoniano, all’insegna di una sistematica rivendicazione del carattere fratto, discontinuo,
dell’esperienza. Il tempo non si assimila al colare del divenire, ma al costituirsi di una
sovrapposizione di strati che entrano in legame armonico tra loro: al farsi di tali articolazioni
partecipano atteggiamenti motivazionali, collegati fra loro dal contenuto rappresentativo
dell’oggetto di coscienza. Il corpo a corpo dialettico con il bergsonismo articolerà su quattro piani
distinti di discussione: la centralità del concetto contro l’intuizione, la passività contro l’attività, il
riposo contro l’azione, la funzione salvifica del vuoto rispetto alla costipazione del pieno.
Nell’introduzione al testo10, Bachelard enuncia con limpidezza la tesi che ne sostiene la trama
argomentativa: la continuità psichica non è una continuità data, ma un’opera.
Un’opera che costruisce una continuità ha perciò il carattere di un perpetuo iniziar di nuovo,
intervallato dal riposo: i due atteggiamenti sono in dialettica ritmica, in cui pause cariche di tensione
si alternano all’azione, in un frantumarsi che sta agli antipodi del continuo rinnovarsi nel divenire
bergsoniano. Lo stesso mondo dell’attività della coscienza si organizza grazie a pause, perché lo
scorrere della durata si incaglia nelle intermittenze temporali fra atti intellettivi che si alternano fra
loro secondo un regime tensivo di pieno e di vuoto.
Tale lavorio si manifesta nei modi di essere della soggettività: si pensi a quanto accade quando
mentiamo consapevolmente, ponendo attenzione a non rompere la coerenza fittizia che copre la non
veridicità delle nostre affermazioni, oppure quando, al mutare dell’andamento di una situazione,
10
Bachelard (2010), pp.50-51.
328
�Ritmo e durata fra Husserl e Bachelard
immaginiamo nuovi esiti possibili, riorganizzando il campo delle nostre previsioni, attraverso una
serie di disgiunzioni.
Si isolano forme di segmentazione dell’esperienza: il filosofo bachelardiano si sofferma su stasi
e vuoti promettenti, che periodizzino la dimensione psicologica della durata. Il divenire si esprime
attraverso il connettersi di elementi tenuti assieme da un ritmo specifico, e raccordati ex post,
sollecitando l’illusione di una continuità.
L’esito di un simile atteggiamento teoretico, eminentemente qualitativo, mette capo ad una
metafisica del ritmo, che aritmetizza la durata bergsoniana, allo scopo di differenziarne quei portati
concettuali, che Bergson stesso rifiuta: si mira così a rintracciare il costituirsi di una mappatura
delle relazioni strutturali, fra alternarsi degli stati di coscienza e stratificazioni temporali,
qualitativamente differenziabili, rispetto al sorgere e al tramontare degli atti stessi.
5. La tensione nelle cesure
La durata e l’idea di rinnovamento continuo, che caratterizzano la filosofia bergsoniana, vanno
importati all’interno del nuovo quadro di riferimento, agitato dal tema del discreto. Bachelard mira
agli interstizi, che si nascondono nella continuità degli atti: come la veglia segue alla notte, così
ogni processo psicologico è una graduazione, un avvicinarsi fra limiti, che danno l’impressione di
una continuità. L’idea di una multidimensionalità del tempo, di uno spessore che si formi grazie a
diversi livelli di temporalità che si condensano nei vissuti influenza profondamente Bachelard, e
trova terreno fertile nell’analisi delle forme psichiche.
Bachelard entra nel tema dello psichismo, raccogliendo un repertorio imponente, che corre fra
Hegel e Minkowski. Per cogliere analogie e differenze con Husserl ci sembra interessante
rintracciare un esempio, in cui emergano attenzione e intensità, che nel filosofo tedesco si
affiancavano, all’interno dell’atto percettivo nella tensione dell’interesse verso il nuovo. Bachelard
le affianca nella analisi dell’atteggiamento di finzione: nella finzione, siamo immersi in un continuo
regime attentivo, che deve sovrapporsi alla dimensione quotidiana del vivere, per tutelare la
coerenza nella falsità.
Consideriamo un atteggiamento intellettivo in cui i periodi di inibizione sono numerosi e in cui le azioni
veramente positive sono assai rare. Per esempio, esaminiamo il tessuto temporale della finzione, e
rendiamoci conto che questo tessuto non è già più incollato alla trama continua della vita: la finzione è già
una sovrapposizione temporale. Alla prima osservazione, non si può non essere colpiti dal tessuto lacunoso
della finzione. Non si riesce ad immaginare una finzione continua […]. C’è, nella finzione, un’applicazione
riflessa del principio di ragion necessaria e sufficiente che fa sì che si cerchi di equilibrare le inibizioni e le
azioni. La finzione restringe le espansioni naturali, le accorcia; ha per forza minore intensità di un
sentimento, va da sé. Senza dubbio la finzione tende a compensare il numero con l’intensità. Rafforza certi
tratti, ingrandisce certe finezze. Dà costanza e rigore ad atteggiamenti che sono più mobili e più flessibili.
In breve, il tessuto temporale della finzione è insieme lacunoso e accidentato11.
Bachelard coglie tratti comuni fra osservazioni psicologiche, strati ontologici e forme narrative del
letterario: attraverso la finzione, due differenti forme di durata, e due stili del vivente, si
sovrappongono nella medesima soggettività. La trama continua della vita viene compressa, e
raggelato, dall’emergere di una divaricazione. La doppiezza non è sistematica, non si può mentire
continuamente, nemmeno a se stessi: si mente in forma intermittente, facendo attenzione a
raccordare le lacunosità che si aprono per garantire una continuità interna di scopi e coerenze. La
continuità è prodotto di una fratturazione, in cerca di punti di sutura fra una menzogna e l’altra,
mentre l’attenzione ricostruisce percorsi plausibili, su cui essa possa appoggiarsi. Se la temporalità
è ingranaggio in movimento, o disegno ritmico, allora ogni esperienza temporale sarà scarto fra
esitazione e scelta, in cui l’arresto peserà quanto il movimento.
11
Ivi, pp. 264-267.
329
�Carlo Serra
Nascono, inevitabilmente, paradossi: nella durata, si disegna un segmento temporale che ha
curioso valore retroattivo, perché costretto a guardare indietro mentre progetta in avanti.
All’immediatezza del vitale si contrappone la riflessività, perché fingere bene implica
un’impressione di continuità imposta a ciò che è essenzialmente discontinuo, incorporando il tempo
della finzione a quello dell’io, al tempo della sincerità, portando ad essere raggirati dal proprio
raggiro, ora fondendo quanto sta sopra con quello che sta sotto, ora inserendo frammenti di tessuto
artificiale che ingolfano ciò che scorre spontaneo. Nella temporalità dell’esperienza ogni
intermittenza entra in rapporto polifonico con un nuovo strato che sta iniziando, garantendo un
tratto comune, o un limite di convergenza fra orizzonti temporali diversificate.
La tessitura del reale è un collegarsi fra strutture ritmiche, che pur separate, corrono una verso
l’altra, per trovare un appoggio reciproco: il rinnovarsi sta nell’orlo di questa transizione, e più che
a una spinta, somiglia un confine labile, che scorre fra la fine di un atto, e il successivo.
Difficile non rilevare che il livello delle analisi bachelardiane si volge al costituirsi di piani
d’esperienza estremamente sofisticati: ciò implica un proliferare di stratificazioni, perché
nell’approccio ritmologico basato sulla discontinuità ci si appoggia sempre sullo strato già formato,
studiandone la geologia a consolidamento già avvenuto, come accade quando sovrapponiamo la
menzogna ad un’esperienza originale, e da questa sopraelevazione, guardiamo sotto. La continuità,
regolata dal principio di ragion sufficiente, sussistente e necessario, si spezzerà infallibilmente
perché chi mente sa di mentire, di mentire al quadrato o al cubo: l’auto-osservazione dei personaggi
di Dostoevskij, diventa ora funzione concettuale che soppesa vissuti e durate, in un sapido
precorrimento dei personaggi concettuali che vivono la filosofia deleuziana.
La trama della realtà risulta retta dal respiro interiore di una coscienza che trattiene un tessuto
che va continuamente spezzandosi. Passato e futuro entrano in un regime di concatenazione
continua, con uno slargamento dell’uno sull’altro, in un senso affine, ma irrimediabilmente lontano
anche da quello husserliano: qui infatti esiste un’armonia di tensioni che si risolvono nella cesura,
nella interruzione, non nell’apertura del presente come concatenazione fluida.
L’aspetto qualitativo delle trasformazioni del mondo assume l’andamento di un processo
dialettico che connette fra loro le stratificazioni d’ogni atto d’esperienza, rispetto ai sottoritmi che
ne costituiscono i toni cromatici, come già accade nel capitolo che contrappone détente a néant,
letteralmente la distensione12 al nulla. Le parole in mano ai filosofi non sono mai innocenti: détente
è un gesto di allentamento, ma può indicare uno scatto o addirittura un grilletto. Il riposo non è un
abbandono alla pienezza della stasi, ma ad un momento di rilassamento all’interno di un ciclo
ritmico, in cui si freme nell’attesa, cercando tensione nella riapertura del ciclo stesso, come accade
per il silenzio fra i colpi di un percussionista.
È difficile negare che simili espressioni sembrano dialogare con le funzioni strutturali che
tensione ed elasticità sviluppano nel mondo umano e sociale che si articola nel comico, secondo
Bergson: ma se nel Saggio sul significato del comico ogni forma di sensibilità e di identificazione
blocca il meccanismo sdrammatizzante della risata, in Bachelard le stasi temporali e le messe a
distanza dallo scorrere della vita ci costituiscono, dall’interno, come soggetti.
6. Affacciarsi sulla durata: ri-conoscere e attesa
Nel mondo dell’esperienza, vi sono oggetti che mettono il filosofo in crisi, o lo esaltano, oltre i
limiti della ragionevolezza: il tema della melodia sembra fatto apposta per far fibrillare le sue
categorie conoscitive, con buone ragioni. Sappiamo che cos’è, ma non riusciamo a definirla: ne
12
Nella sua bella traduzione de La dialectique de la durée, apprezzabile da moltissimi punti di vista, vista la
scivolosità di un testo che si frammenta su molti registri interconnessi, Domenica Mollica ricorre, per détent,
all’espressione allentamento, scelta fine, perché coglie con precisione il carattere di stasi metafisica che Bachelard
contrappone al rinnovarsi bergsoniano (pp. 59 e ss.). Preferiamo, tuttavia, tradurre détente distensione, perché il
distendersi è diverso dall’allentarsi, più vicino al risultato di una forza elastica che modifica un assetto dato e perciò più
risonante con le intermittenze della tensione ritmica, avvertibili nel testo.
330
�Ritmo e durata fra Husserl e Bachelard
riconosciamo la funzione, indicandola a colpo sicuro, ma come accada che un gruppo di altezze,
poste secondo rapporti variabili, venga subito riconosciuto come nucleo, non è semplice a dirsi.
Bachelard affronta la melodia, su cui Bergson e Husserl hanno dispiegato la propria visione del
tempo, partendo da un piano che riattiva il tema dell’attenzione: come riusciamo a riconoscere
qualcosa che si dà, un istante dopo l’altro, ma a cui viene attribuito, con sicurezza, un carattere
unitario? Dietro a tale quesito, se ne cela uno più inquietante: che proprietà possono avere gli
oggetti, per divenire metafore di un concetto sfuggente come quello di durata? Intendere la melodia
come metafora della durata, o come un essere vivente, come fa il filosofo bergsoniano, sembra
inquadrarne l’essenza all’interno di un metodo che incrocia immagini per far emergere un concetto.
Si vorrebbe passare, osserva Bachelard dalla durata bianca e astratta, in cui si allineerebbero le
possibilità semplici dell’essere, alla durata vissuta, sentita, amata, cantata, romanzata13.
Tali espressioni non sono velate da ironia: la durata, negli esempi bergsoniani, si colora di forme
incarnate, vissute, sentite, metaforizzate, al netto di una impossibilità di traduzione concettuale non
sostenuta da immagini. Nella durata bergsoniana la fluidità fra immagine e concetto ha come esito
un incantamento, una trasognanza14, o meglio ancora, una promessa: il filosofo bergsoniano colloca
ciò che deve dimostrare su un orizzonte che trapassa continuamente le ossificazioni concettuali,
volgendosi verso un divenire che lascia un’eco affettiva. Il problema non è l’uso dell’immagine, il
testo di Bachelard ne è pieno, ma teme lo sprofondamento bergsoniano in una concettualità
immaginosa che non riesca ad affidarsi a un pensiero discretizzato. Un aderire così viscerale,
incappa in un problema insolubile: l’esperienza non basta a se stessa perché non spiega in che modo
la melodia si costituisca nel tempo.
La melodia gioca dialetticamente con se stessa, si perde per ritrovarsi: sa che si assimilerà al suo tema
iniziale. Essa ci offre in questo modo non una vera durata, ma l’illusione di una durata. Per certi aspetti la
melodia è una perfidia temporale. Ci prometteva un divenire, ci tiene fermi nello stato. Portandoci alla sua
origine, ci dà l’impressione che avremmo dovuto prevedere il suo corso… La sua origine, svelata per
induzione, è come la sua continuità, un valore di composizione15.
Bachelard sviluppa una apertura spiazzante e quasi gestaltica: la melodia tonale non scorre, risuona
di aspetti che ricordano il ritenzionale, bloccandoci nel suo comporsi come forma. L’origine svelata
per induzione, o la scoperta del carattere compositivo della melodia sono immagini della
artificialità, della distanza dal flusso vitale: è come se il senso della raffigurazione avesse bisogno
del passato, per prendere consistenza, mentre il carattere di scorrimento del suono si blocca per
chiudersi nella forma nel riconoscimento.
La melodia si costituisce nell’inanellarsi delle altezze ma trapassare fra nuclei discreti è
fragilissimo: basta un’esitazione per perdere il senso dell’intero. Non siamo di fronte ad
un’osservazione psicologica, ma a un fatto strutturale: basta una pausa mal posta, perché la
cantabilità del melodico si spezzi, perda la fluidità del salto tra una nota e l’altra. Dietro a tale
constatazione, vi è il senso di una inversione temporale: nel trapassare fra altezze diverse, l’unità
viene colta alla fine, e proiettata retroattivamente sull’intero processo sonoro. È un riconoscimento
che accade nel riposo, nella pausa, e Bachelard lo dice con particolare appropriatezza, quando
spiega che, nella melodia, il riconoscere accade prima del conoscere: riconosciamo la melodia
proiettando la sua funzione tematica a forma conclusa. Pregnante questa osservazione: «Mai infatti
l’attesa è così chiaramente negativa come in musica: questa attesa, in effetti, diventerà cosciente,
solo se la frase intesa si ripete»16.
La ripetizione determina il riconoscimento della funzione: l’attesa nasce con una
riorganizzazione del campo percettivo, e, con essa, la durata come discretezza. Emerge così come
13
Bachelard, (2010), pp. 285-286.
Ibidem.
15
Ivi, pp. 290-291.
16
Ivi, pp. 292-293.
14
331
�Carlo Serra
specifica qualità dei flussi temporali nel continuo, la striatura, secondo un’espressione che ricorda
Boulez. Le striature sono penisole, chiazze continue, che scivolano bloccandosi nel discontinuo. La
striatura porta infatti dentro di sé la continuità, è sfumare di gradazioni, ma ha un difetto terribile,
per il continuista ad oltranza: viene localizzata, e si blocca. Ci si scivola dentro, ma essa si gradua
fino all’arresto, per poi riprendere. Ha il carattere di una differenziazione tratteggiata, che cancella
l’idea di sfumatura interrotta: più che a un fiume che scorre, assomiglia al placido ristagnare della
pozza d’acqua. Il piano di costituzione più originario della temporalità è un susseguirsi di raccordi.
7. Ritmo come architettura del periodo
La dialettica fra la melodia e le nostre aspettative, offre la sponda a due considerazioni: la prima è
che, malgrado tutto, nel testo di Bachelard permanga una profonda continuità con le intuizioni
bergsoniane. La dialettica della durata modella consapevolmente i profili delle categorie temporali
su elementi materico spaziali, rimanendo nel gorgo del pensiero bergsoniano da cui desidera uscire:
si ricostruisce la vita della coscienza dentro all’esperienza, livello per livello, guardandosi bene
dall’uscire da una discretezza che protegge dallo slabbramento del flusso.
La seconda osservazione è che il carattere discontinuo del suono lo consegna ad una precarietà
ontologica: l’ascolto, che si appoggia al riconoscimento progressivo dei suoni che formano il
disegno melodico deve accettare il loro trapassare nel silenzio, la loro intrinseca finitezza. Il suono
singolo è dunque elemento instabile, che andrà incapsulato dentro a forme ritmiche, per conservarsi
come un nucleo nel processo di saturazione delle loro fratture.
Tutto ciò offre utili indicazioni rispetto al tema della filosofia del riposo: nella precarietà del
reale e della sua consistenza ontologica, l’individuazione della regola costruttiva della
sovrapposizione temporale e dei limiti intrinseci al concetto di durata, protegge le forme
d’esistenza. La passività, l’accettazione dell’intermittenza sono il riconoscimento del portato
metafisico dei limiti conoscitivi dell’esperienza: allo scarto istantaneo, al movimento imprevisto,
legato alla dialettica della durata, corrisponde la via salvifica del riconoscimento ritmico, che può
spegnersi, fino al riposo ed alla stasi. Se in Bergson il linguaggio e le sue concettualizzazioni vanno
poste in mora, perché discretizzazioni spaziali, in una filosofia del ritmo come quella proposta ne
La Dialettica della durata, esse diventano le unità preposte a cogliere la fusione fra discreti, nella
quale ci immerge l’esperienza temporale della durata.
Infine, ogni elemento semplice vive nella forza del raggruppamento in cui occorre, non ha valore
autonomo, come accade in una catena argomentativa, in cui ogni snodo prepara al successivo: in
quel processo, è il raccordo che decide del valore dell’elemento inscritto, come quando ascoltiamo
una storia o una menzogna. L’elemento acquista pregnanza nella connessione e nella funzione
unitaria che sostiene la catena, non ha mai valore autonomo, aspetto che emerge anche in una
bellissima conferenza del 1932 su Spinoza, da poco tradotta in Italia:
La questione essenziale mi sembra la seguente: in quale maniera le idee semplici possono essere la causa di
relazioni e, a favore di questa messa in relazione, in che maniera delle idee semplici, alle quali
corrispondono degli oggetti semplici, possono suggerire delle relazioni sperimentali? Se si vogliono
arricchire i dintorni dell’idea semplice, si deve acconsentire ad abbandonare ciò che la rende pura per
attaccarsi a ciò che la completa; si deve riavvicinarla a una serie di altre idee semplici per liberarne una
filiazione, in breve, leggere il complesso nel semplice. Ora la forza d’insinuazione della ragione nei
confronti del reale è tale che questo paradosso non è raro all’interno della storia della Fisica matematica. Se
ne trovavano numerosi esempi nella crescita delle dottrine relativiste; queste dottrine forniscono dei veri
strumenti di scoperta.17
Nell’analisi dell’idea il punto d’arrivo non è il feticcio dell’idea semplice, dell’elemento ultimo ma
al contrario, la possibilità delle idee di articolarsi in un reticolo, la loro possibilità di scandire
complessità, persino nelle fratture dei paradigmi scientifici. La complessità di un metodo
17
Bachelard (2016), p.104.
332
�Ritmo e durata fra Husserl e Bachelard
sperimentale consiste nella capacità di porre in parallelismo strutture che trattino lo stesso oggetto,
frammentandone la prospettiva. L’idea semplice riverbera negli sguardi fratti, che l’hanno letta e
collocata in architetture diverse, in una dialettica della complementarità: in fondo, è una
stratificazione che assume senso più per la propria posizione che per la propria consistenza.
8. Tratti per un confronto
Alle volte i filosofi vedono la stessa cosa, intendendone il senso in modo opposto: un’utile cartina al
tornasole, per cogliere la specificità di due forme di pensiero. Tra i due filosofi resta comune l’idea
che l’ora, il presente si estendano, volgendosi in più direzioni ma se in Husserl esiste un vettore
temporale, il presente, che percorre l’opposizione fra passato e futuro, nella dialettica protoritenzionale, nella ritmo-analisi di Bachelard gli istanti creano ganci, che condensano una pluralità
di linee interconnesse. In Husserl l’istante diventa intervallo, in Bachelard il ritmo dà forma a nuclei
separati, raccordandoli.
In Husserl il singolo istante si estende, diventa intervallo, ponte, mentre in Bachelard una
concatenazione d’istanti, che hanno la consistenza di un punto, si sommano fra loro creando un
periodizzare in cui le lacune si saturano, saltando di strato in strato. Nel filosofo francese la mancata
tematizzazione della funzione costruttiva del contenuto immanente all’atto di coscienza, ci allontana
dall’immagine del decorso melodico husserliano, dal proiettarsi del presente contemporaneamente
verso il passato ed il futuro, in un concatenamento fluido. Bachelard vede il presente come
susseguirsi di istanti puntuali, in cui ogni atomo temporale occupa un luogo determinato dalla
architettura interna della fase ritmica. È una differenza qualitativa rilevante in una struttura
concettuale percorsa da mille analogie, nell’idea comune di un nesso, continuamente interrotto e
ripreso: il frazionarsi dei contenuti nel tempo bachelardiano, veicolato dalla forma ritmica, in
Husserl viene trasceso perché la continuità fra contenuti si lega al tendersi dell’istante in direzioni
temporali opposte.
Anche sul tema degli stati di coscienza, i metodi si divaricano: laddove un filosofo husserliano,
andrebbe a cercare la continuità dell’interesse, che tiene la presa sulle forme della motivazione,
saltando dietro alle spalle del meccanismo finzionale, Bachelard sottolinea l’aprirsi dei vuoti nelle
pulsazioni interne: la dialettica della durata esplora dall’alto quanto un fenomenologo vorrebbe
scorgere dalla radice, sottolineando il frantumarsi della linea temporale in segmenti che si
sovrappongono, continuandosi, più che ad una graduazione continua del trascorrere del tempo.
Nel confronto fra i due autori, ci sembra che il peso della lacuna sia il valore differenziale di cui
Bachelard rivendica orgogliosamente senso e valore: sintomo vistoso di tale risvolto è l’insistenza
sul periodo come unificazione, che collega e omogenizza fasi indipendenti, creando l’apparenza di
un divenire unitario. Al cuore della costruzione sta quindi l’intermittenza della pulsazione, vista
come frattura, anziché tensione al continuo.
Confrontando i due filosofi, assistiamo ad un profondo divergere fra la forma dell’attimo e la
funzione del trascorrere: non è paradossale che i due approcci approdino in modo dissonante ai
concetti di materia e stratificazione, intese come un rapprendersi di una lacerazione in un residuo,
che simula un continuo (Bachelard) e come un sostrato, che si offra sempre nuovo, nella continuità
della costituzione (Husserl). Il senso di una filosofia del riposo consiste nel rintracciare la
sedimentazione del frammento, contemplarle, guardandone le cicatrizzazioni: una visione geniale
del tempo, che non teme di rivendicare la funzione spaziale del fotogramma nella fluidità temporale
del montaggio. Cancellata la protenzionalità, saranno gli ingranaggi ritmici, disposti su strati
temporali differenziati, a permettere il movimento melodico nel tempo, in un continuo raccordarsi
di funzioni interrotte e riprese.
Bibliografia
Testi citati nel saggio
Bachelard, G. (2010), La dialettica della durata, trad. it. a cura di D. Mollica, Bompiani, Milano.
333
�Carlo Serra
Bachelard, G. (2016), Metafisica della Matematica, a cura di C. Alunni e G. Ienna, Castelvecchi,
Roma.
Heidegger, M. (1990), Interpretazioni fenomenologiche di Aristotele. Introduzione alla ricerca
fenomenologica, a cura di E. Mazzarella, Guida, Napoli.
Husserl, E. (2016), Percezione e attenzione, a cura di A. Scanziani e P. Spinicci, Mimesis, Milano.
Summa, M. (2014) Spatio-Temporal Intertwining. Husserl’s Trascendental Aesthetic, Springer
Verlag, Berlin-Heidelberg.
Letture Consigliate
AA. VV. (2004), Ri-cominciare. Percorsi e attualità nell’opera di Gaston Bachelard, Jaca Book,
Milano.
Bongiorno, F. (2018), La linea del tempo. Coscienza, percezione e memoria tra Bergson e Husserl,
Inschibboleth Edizioni, Roma.
Cicero, V. (2007), Istante durata ritmo. Il tempo nell'epistemologia surrazionalista di Bachelard,
Vita e Pensiero, Milano.
Corbier, C. (2012), “Bachelard, Bergson, Emmanuel: Mélodie: Rythme e durée”, Archives de
Philosophie, vol. 75, n. 2, pp. 291-310.
Hashizume, K. (2009), “Bachelard’s Theory of Time. Missing link between Science and Art,
Aesthetics, vol. 13, 2009, pp. 1-9.
Norris, C. (2000), “Structure and Genesis in Scientific Theory: Husserl, Bachelard, Derrida”,
British Journal for the History of Philosophy, vol. 8, n. 1, pp 107–139.
Schuhmann, K. (2004), Intentionalität und intentionaler Gegenstand beim frühen Husserl, in
Leijenhorst, C.-Steenbakkers, P. (Eds.), Selected Papers on Phenomenology, Kluwer Academic
Publishers, New York, Dordrecht, pp. 119-136.
Abstract
Inside phenomenological research, the concepts of present time and instant are characterized by a
troubled dialectic: for Husserl the present flows, widening both towards the past and the future, like
the Heraclitean bowstring which stretches between two dimensions. Gaston Bachelard, on the
contrary, is the thinker of discreteness, in which the temporal continuum is linked to the reciprocal
differentiation of instants in duration. Therefore, the conceptions of time of these philosophers seem
to be opposed to one another. However, within these two modalities of scansion, we meet a
common thread, which underlies both interpretations and allows for their convergence on the
perceptual content. We will focus, on the one hand, on the process through which the position
acquires its shape within Bachelard’s La dialectique de la durée (1936), and, on the other hand, on
Husserl’s treatment of the way in which one aspect of the thing emerges above the others in his
writings on attention (1904-1905).
Keywords: Rhythm, Phase, Instant, Lacuna
334
�Pubblicata nel mese di dicembre del 2018
www.bollettinofilosofico.unina.it
I contributi presenti nella rivista sono stati sottoposti a double peer review
�
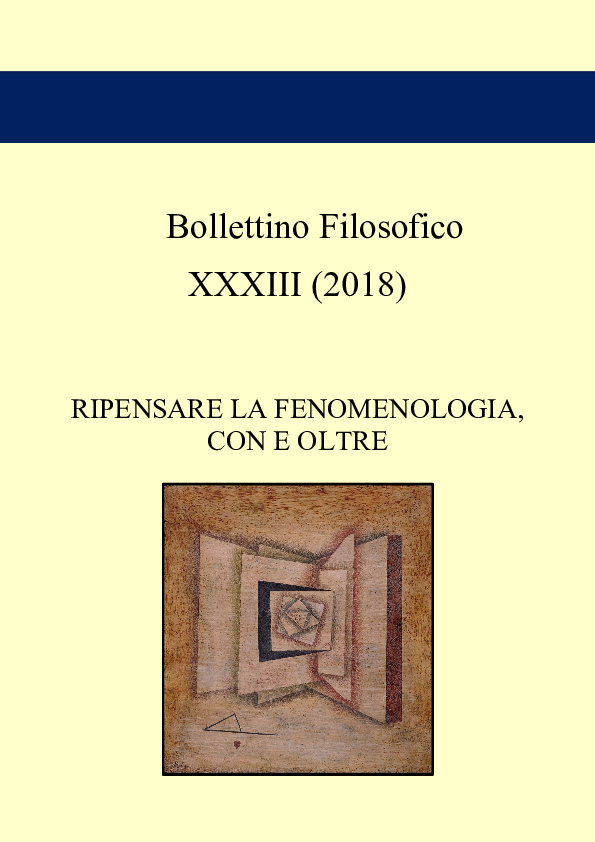
 francesca de vecchi
francesca de vecchi