ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
SCUOLA DI LINGUE E LETTERATURE, TRADUZIONE E INTERPRETAZIONE
Corso di studio in Lingue e Letterature straniere
ESPERIENZE DI ETNOFILOLOGIA:
LESSICO E RITUALI DELLE GUARITRICI TRADIZIONALI DELL’APPENNINO ABRUZZESE
Immagini stabili in perenne trasformazione
Prova finale in:
Filologia romanza
Relatore Presentata da
Prof. Francesco Benozzo Marianna Fangio
Sessione: II
Anno accademico: 2017/2018
�
�
INDICE
Introduzione 3
CAPITOLO 1 5
L’ETNOFILOLOGIA: COME NASCE, COS’È E DI COSA SI OCCUPA 5
1.1 La teoria dell’Umanesimo 5
1.2 L’etnofilologia: di cosa si occupa? 6
CAPITOLO 2 8
UN’ESPERIENZA DI ETNOFILOLOGIA 8
2.1 Contro cosa lottare 8
2.2 Dalla teoria alla pratica 9
CAPITOLO 3 12
LE GUARITRICI TRADIZIONALI DELL’APPENNINO ABRUZZESE 12
3.1 Alla ricerca delle proprie origini 12
3.2 incantare vs. arsanà 16
CAPITOLO 4 18
IL SUSSURRO MAGICO: GLI ORIZZONTI CERIMONIALI TRA SICILIA E ABRUZZO 18
4.1 Il senso pratico delle formule rituali 18
4.2 Scongiuri curativi 19
4.3 Struttura degli scongiuri curativi 24
4.4 Focus sul nucleo narrativo: l’historiola 27
4.5 Atti linguistici e pratiche discorsive 27
CAPITOLO 5 30
MALI E MALESSERI: ALLA RICERCA DELLE ORIGINI 30
5.1 Fuoco di Sant’Antonio 30
5.2 Erisipela (“resibla”) 32
5.4 Santa Lucia curatrice 38
CAPITOLO 6 40
LA TEORIA DELLA CONTINUITÀ PALEOLITICA 40
6.1 Il “tradizionarsi” delle tradizioni 40
6.2 La Teoria della Continuità Paleolitica 41
Conclusione 44
Ringraziamenti: 46
Bibliografia 47
Introduzione
“Niente può essere conosciuto con certezza, incluso il fatto che niente può essere conosciuto con certezza”
È seguendo la pista aperta da questa constatazione del filosofo newyorkese Richard Rorty che ho scelto di avventurarmi nell’intricata foresta filologica.
Con molta curiosità e spinta dal richiamo verso ciò che è inesplorato ho deciso, infatti, di armarmi di calma, pazienza e dedizione per, nelle parole di Benozzo, “assomigliare ad un viaggiatore irrequieto” (Benozzo, 2012). In quest’ottica la filologia viene intesa come “un modo di percorrere il territorio che ha a che fare con la camminata, con i passi, con il freddo e il caldo” ; cioè una filologia che vuole andare alla scoperta di nuovi volti, parole, odori e non di concetto o teorie, e per questo concepita come indisciplina.
Contrapponendomi a un’idea di tradizione vista come un repertorio, patrimonio e “verità del passato” e, al contrario, intendendola come un paesaggio in continua trasformazione, ho operato la scelta di entrare a far parte di una filologia che è anche un apprendistato a sentirsi parte attiva della “tradizione che si tradiziona” (Benozzo, 2010).
Per l’emozione dell’incontro con i testi, con le parole, con le persone, per prendere le distanze da una filologia nata come “scienza umanistica”, che orgogliosamente difende i propri manufatti finendo col rivelarsi decontestualizzata e antiquaria, e per testimoniare la mia concezione della filologia intesa come “scienza sociale”, ho deciso di seguire i passi di chi è possibile definire come “etnofilologo”.
A tal fine illustrerò, in un primo momento, che cosa si intende per “etnofilologia” e in che modo questa nuova disciplina si inserisce a pieno nel complesso universo contemporaneo, il quale deve quotidianamente confrontarsi con le molteplici tradizioni che convivono in un mondo che si rivela più vasto ma, al tempo stesso, rimpicciolito. In un secondo momento, seguendo il metodo di lavoro adoperato da Benozzo durante alcune inchieste sul campo in merito alla tradizione delle guaritrici tradizionali appartenenti alla cosiddetta “medicina popolare”, mostrerò le ricerche che ho personalmente condotto in una piccola provincia montana dell’Appennino abruzzese e le analizzerò sulla base di altre indagini in merito a simili formule rituali magico-religiose, realizzate da Pier Luigi Josè Mannella, nell’area siciliana. Infine, per concludere, spiegherò in che modo la mia investigazione può servire come ulteriore testimonianza per dimostrare la validità della Teoria della Continuità Paleolitica sulle origini delle lingue indeuropee, elaborata per la prima volta da Mario Alinei nel 1996.
Alinei, M. 1996-2000 Origini delle lingue d’Europa, vol. I, La teoria della continuità, vol. II. Bologna, Il Mulino
�
CAPITOLO 1
L’ETNOFILOLOGIA: COME NASCE, COS’È E DI COSA SI OCCUPA
1.1 La teoria dell’Umanesimo
Nel saggio Antropologia strutturale del 1973, l’antropologo francese Lévi-Strauss ha individuato l’esistenza di tre umanesimi. In linea con questa teoria, il primo umanesimo corrisponderebbe alla riscoperta dell’antichità (nel Rinascimento), il secondo (tra Settecento e Ottocento) alle frontiere aperte dalle grandi esplorazioni geografiche e il terzo (a partire dal primo Novecento) all’incontro con le civiltà primitive studiate dagli etnologi dell’epoca. Strauss ha messo in primo piano il carattere strutturale dei fenomeni sociali e oggetto della sua polemica sono state soprattutto le scienze umane, là dove esse fondano i diritti dell' uomo in base al carattere unico e privilegiato di una specie vivente, quella umana, anziché vedere in tale carattere un caso particolare dei diritti di tutte le specie. Alle scienze umane, il grande antropologo oppone una visione dell' uomo che pone l' altro prima dell' io e una concezione dell' umanità che, prima degli uomini, pone la vita.
Come conseguenza di tale teoria e all’interno della progressiva presa di coscienza da parte dell’uomo delle proprie estensioni geografiche e storiche, credo sia coerente (e necessario) stabilire la nascita di un nuovo umanesimo. Un umanesimo che è in grado di misurarsi con la complessità e con l’incertezza delle società contemporanee, con la pluralità delle tradizioni che convivono in un mondo diventato sconfinato ma che, allo stesso tempo, è anche vertiginosamente rimpicciolito.
Questo umanesimo contemporaneo è ciò che, nell’accezione di Benozzo, si definisce come “quarto umanesimo” (Benozzo, 2010). Esso non esclude e, anzi, deve necessariamente confrontarsi con le indagini della biologia della cultura e con le nuove prospettive aperte in questi anni dalle teorie neo-evoluzionistiche e neo-darwiniane. “Un umanesimo che incontra luoghi, volti ignoti e voci prima che parole scritte. Individui prima che comunità” (Benozzo, 2012).
�
1.2 L’etnofilologia: di cosa si occupa?
La svolta della filologia all’interno del quarto umanesimo coincide con il passaggio da un’antica e limitativa visione della filologia come “scienza umanistica” alla più coerente concezione di una filologia intesa come “scienza sociale”, cioè come disponibilità all’altro.
Più specificatamente la filologia classica, che negli ultimi anni si è autodefinita “filologia formale”, ha mostrato una totale indifferenza per il dibattito. Un dibattito che riguarda in particolare tre aspetti: uno di tipo linguistico (a proposito della provenienza e diffusione delle lingue europee); uno di tipo metodologico (in base al quale i filologi continuano a considerare la documentazione scritta come un vero e proprio inizio, come una forma originale e in qualche modo databile di un fenomeno); l’ultimo di tipo contenutistico, poiché riguarda la materia stessa degli studi filologici (l’antropologia e l’etnologia, infatti, hanno ampiamente dimostrato che tutti i popoli della terra conoscono e hanno conosciuto tradizioni di canti orali di cui non ha alcun senso cercare una prova in attestazioni scritte e per i quali è necessario superare la rigida dicotomia orale vs. scritto, dal momento che “scritto” non si contrappone a “orale” come a un suo contrario, ma a una moltitudine di situazioni: “orale”, “gestuale”, “iconografico” ecc.)
In risposta a tutti questi problemi, l’etnofilologia che sto provando a descrivere mira a coniugare i propri principi e i propri metodi con quelli dell’etnolinguistica (nella formulazione di Giorgio Raimondo Cardona) e dell’etnopragmatica (nel senso descritto da Alessandro Duranti). Per quanto riguarda l’etnolinguistica, Cardona afferma che essa è: “ lo studio del campo delimitato dall’intersezione di lingua, pensiero e cultura, e quindi delle loro influenze reciproche, delle rappresentazioni che nell’un piano si danno dell’altro, dei sistemi di categorie, degli aspetti linguistici dell’etnoscienza” (Cardona, 1988). Per etnopragmatica, invece, va inteso “uno studio della comunicazione che, integrando i metodi etnografici con i metodi d’analisi del discorso, documenta i diversi modi in cui il linguaggio fa differenza tra le persone e rende possibile un particolare tipo di socialità, che caratterizza l’essere-nel-mondo dell’homo sapiens” (Duranti, 2007).
Di conseguenza, nella proposta di Benozzo, l’etnofilologia consiste nella ricerca di un metodo per interpretare i reperti testuali e i documenti antichi prima di tutto come esperienze di comunicazione tra esseri umani (e non come testi che vivono in relazione con altri testi).
“Etno” in “etnofilologia” vuol dire indicare la necessità di un ritorno allo studio delle civiltà a partire dai reperti testuali e verbali. Intesa in questo modo, l’etnofilologia rinuncia, contrariamente alla filologia tradizionale, a una definizione aprioristica del proprio campo di studio e a una preselezione del tipo di documenti da analizzare: oltre ai manoscritti, infatti, sono di sua pertinenza tutti quei reperti (di tipo orale, onomastico, folklorico, gestuale, iconografico, archeologico, materiale, ecc.) che si configurano come codificazioni formali e mnemotecniche di immagini, parole e credenze analizzabili da un punto di vista cognitivo.
Per concludere questo capitolo, quindi, una filologia inquadrata come “scienza sociale”è una filologia collocata in un sistema di riferimento che ha come primo riconoscimento la realtà in cui si trovano le tracce, i testi, le idee di cui si occupa. Lo ha detto chiaramente anche un altro filologo romanzo: “ A noi si presentano in prima istanza il linguaggio e le forme, ed è compito nostro analizzarli. […] Ma non dobbiamo mai scordare a cosa serve tutto ciò: a capire, a interpretare, a fare insomma opera di storici. […] Perché la letteratura non vive di vita propria: trae alimento dalla realtà e fornisce strumenti per interpretare la realtà. Se ci fermiamo alle tradizioni letterarie (da letteratura a letteratura) che pure sono importanti; se ci fermiamo all’intertestualità, alle forme, alle strutture, allo stile, alla retorica, non forniamo a noi stessi e ai nostri allievi […] strumenti per capire la realtà: la realtà del passato, la realtà che sta nella nostra memoria […], la realtà in cui viviamo, la realtà che ci aspetta” (Fassò, 2004).
Ho deciso, quindi, di intraprendere la mia ricerca all’interno di una filologia intesa come scienza sociale perché, in questa prospettiva, le possibilità di azione sono innumerevoli. Perché l’etnofilologia rivendica un coinvolgimento di fondo nel suo modo di approssimarsi a ciò di cui si occupa e accetta di vivere la complessità e le contraddizioni che l’incontro con i testi, i reperti e le tradizioni implicano costantemente. Perché l’etnofilologia concepisce lo studio di una tradizione e dei testi che la trasmettono anzitutto come un incontro con l’altro, sottolineando una dimensione umana, emotiva e partecipante dei suoi metodi.
�
CAPITOLO 2
UN’ESPERIENZA DI ETNOFILOLOGIA
2.1 Contro cosa lottare
In Etnofilologia Benozzo afferma che l’errore più grave della filologia odierna è radicato all’interno di un’errata percezione della cultura, in base alla quale “si identificano i testi scritti che possediamo con la «letteratura» dell’epoca a cui essi appartengono, e gli intellettuali […] che materialmente approntarono tali fonti con i poeti, gli autori […] di quel mondo. Parallelo e connaturato a questo errore è quello che continua a identificare la letteratura con la cultura e l’oralità con l’analfabetismo, secondo il quale la scrittura rappresenta sempre un punto di arrivo e l’oralità una fase precedente, e pensando in definitiva che la lingua parlata e le sue tradizioni trovino un vero compimento soltanto quando diventano (finalmente) espressioni della cultura scritta” (Benozzo, 2010).
Al contrario, l’esistenza di testi scritti in quanto tali dovrebbe far riflettere sull’esistenza di ceti «subalterni», di culture nascoste ben più longeve, che naturalmente non cessano di esistere solo per il fatto che una lingua scritta comincia a essere attestata (e anzi, al contrario, cominciano a esistere ufficialmente solo allora). In quest’ottica, tutti i fenomeni che appartengono alla stratigrafia complessa di ogni tradizione, e cioè quei processi di continuità, sincretismo, trasformazione, adattamento, rivestimento e riattualizzazione sempre osservabili nell’evoluzione dei sistemi culturali, possono essere concepiti come procedimenti di riciclaggio tipici di ogni processo cognitivo-evolutivo.
Partendo da questo presupposto, Benozzo decide di condurre le proprie indagini concependo i documenti scritti come “una traccia della risonanza tra memoria e narrazione, tra immaginazione e credenza, tra determinati strumenti espressivi e i modi in cui essi «si tradizionano» in uno specifico territorio” e intendendo la tradizione come la forma viva e vitale di immagini stabili ma in continua trasformazione (una trasformazione ripercorribile da un punto di vista morfologico, tematico, ideologico e neurologico). (Benozzo, 2007)
Di conseguenza, studiando i processi di “tradizionamento” in questa prospettiva, tutti i fenomeni normalmente detti di cristianizzazione (culti relativi a divinità locali o a parti del territorio, credenze, rituali di guarigione, etc.) non possono più essere visti come “travestimenti” di una cultura pagana, né come semplici “sincretismi” ma, al contrario, come risultato di una cultura precristiana, antecedente, senza la quale la cultura cristiana non potrebbe esistere.
2.2 Dalla teoria alla pratica
Durante gli anni in cui si dedicava ad alcune inchieste sul campo nelle zone rurali dell’Emilia occidentale, Benozzo si è accorto dell’esistenza, ancora vitale, di una tradizione di guaritrici appartenenti al vasto mondo della “medicina popolare”. Così, se fino a quel momento le indagini sul mondo dei guaritori e delle guaritrici tradizionali si erano concentrate sugli aspetti di antagonismo e concorrenza rispetto al medico ordinario moderno, sulla patologia psichiatrica dei pazienti che ancora oggi si rivolgono a certi tipi di cure e sulla diversa nozione di malattia intesa dai diversi tipi di medicina che se ne occupano; nell’ottica etnofilologica Benozzo ha trovato più interessante analizzare alcune procedure relative al rituale vero e proprio messo in atto durante le guarigioni. È a questo livello, infatti, che si può riconoscere un esempio di quell’inscindibile unità di parola, gesto e memoria che caratterizza larga parte dei fenomeni appartenenti agli strati di cultura tradizionale ancora ben radicati nella società contemporanea.
In particolare, le ricerche di Benozzo sono avvenute nel comune di San Cesario sul Panaro (in provincia di Modena), dove la medichessa tradizionale prende generalmente il nome di stariòuna. Tuttavia, per alcuni informatori del luogo, la stariòuna è solo la guaritrice con poteri malefici, cioè colei che è in grado di procurare il malocchio e, per questo, le guaritrici benefiche sono da essi chiamate dànni chi fàn i sgnadùri (cioè “donne che fanno le segnature”) o dànni chi sugne (cioè “donne che segnano”). Inoltre, un altro termine registrato è stròlga (“astrologa”), il quale comprende anche le “fattucchiere” ambulanti non italiane. Infine, anche se più rara, è presente la voce vòtra (“essere ispirato, essere posseduto”).
La pratica di guarigione messa in atto (e consistente in un’imposizione delle mani accompagnata da segni tracciati sulla parte malata e da una specie di litania cantilenata) è detta, in generale, sgnadùra (“segnatura”), mentre il termine più tecnico per indicare la “segnatura” è avérta (“apertura”). È importante notare, per le conclusioni su cui vertono le indagini di Benozzo e le mie, che lo stesso significato “aperta” o “apertura” è presente in pratiche di medicina popolare di area diversa, come la Galizia o il Galles centrale. Sembra cioè trattarsi di un termine usato in una vasta area, il cui significato si potrebbe collegare all’uso evidentemente più arcaico rispetto alla semplice imposizione di “aprire” la parte di corpo affetta da malattia. Anche perché, tra l’altro, il lat. signum (“segno”, da cui signatura > segnatura) è legato ad un altro termine latino: secare (cioè “tagliare”). Entrambi i termini (avérta e sgnadura) potrebbero, quindi, originariamente significare la stessa cosa, vale a dire “taglio, apertura”.
È da riscontrare, inoltre, l’importanza fondamentale delle formule cantilenate all’interno del rituale. Esse, non a caso, sono le uniche a restare ignote allo stesso beneficiario, dal momento che viene sussurrata a bassa voce, spesso facendo un giro intorno al paziente, e in seguito “segnandone” la parte malata con le mani o oggetti particolari [rif. (Benozzo, 2010)]
Per ultimo, Benozzo rileva anche l’uso del metallo, e specialmente del ferro, nei rituali di guarigione. Il metallo, infatti, viene considerato un elemento magico-terapeutico anche in altre varie parti d’Europa ed è citato nel primo documento in lingua occitanica attualmente noto (della seconda metà del X secolo).
Da questi e da altri dati relativi ai gesti del rituale terapeutico messo in atto dalle curatrici, insieme al processo di iniziazione e all’uso attestato di amuleti scritti, Benozzo evince l’appartenenza dello stesso rituale a una tradizione per molti versi accostabile a quella delle civiltà a cultura sciamanica.
Di conseguenza, grazie all’importanza fondamentale data ai testi e ai reperti, intesi al tempo stesso come tramite e come traccia e in linea con i principi etnofilologici precedentemente descritti, è lo stesso contesto di ricerca intrapreso da Benozzo a configurarsi, necessariamente, come un contesto dinamico, non predeterminato. All’interno di quest’ultimo, infatti, le ricerche etnofilologiche si espandono con l’espandersi delle conoscenze e delle domande che tali ricerche portano e pongono perché, come afferma Duranti: “Più pensiamo a una situazione, più si allarga la gamma di elementi potenzialmente rilevanti (col passare del tempo, nell’esaminare un atto comunicativo cerchiamo di immaginarci contesti diversi, possibili elementi che possano illuminare la nostra interpretazione” (Duranti, 2007).
Da quest’apertura è nata la mia curiosità per indagare alcune tra le ancora vigenti pratiche di guarigione tradizionale realizzate nel piccolo comune di Castiglione Messer Marino, sull’Appennino abruzzese, di cui mio padre è originario.
�
CAPITOLO 3
LE GUARITRICI TRADIZIONALI DELL’APPENNINO ABRUZZESE
3.1 Alla ricerca delle proprie origini
Durante i miei brevi periodi di permanenza estiva realizzati nel corso dell’infanzia nel piccolo comune di Castiglione Messer Marino (in provincia di Chieti, Abruzzo) più volte mi è capitato di conoscere signore che si raccomandavano con me e con mio padre che portassi sempre con orgoglio il mio nome: Marianna.
Marianna era infatti il nome della mia bisnonna che, stando alle testimonianze dei più anziani abitanti di Castiglione e di mio padre stesso, era la donna alla quale ci si rivolgeva ogni volta che qualcuno era affetto da un dolore fisico, causato da una distorsione o rottura delle ossa, oltre ad essere anche l’unica ostetrica del paese.
Per questo, mossa dalla curiosità (e, oserei dire, anche da una certa responsabilità nei confronti delle mie origini) ho deciso di conoscere meglio la tradizione delle guaritrici appartenenti al complesso mondo della “medicina popolare” propria del comune abruzzese.
Nell’estate del 2017 mi sono quindi recata a Castiglione e ho intervistato due anziane signore che ancora oggi praticano forme di guarigione magico-terapeutiche.
Nell’area abruzzese di nostro interesse la medichessa tradizionale non ha un nome generico, come è stato rilevato nell’area modenese, dal momento che ogni guaritrice ha un soprannome specifico che viene dato loro dagli altri abitanti del paese in base alla famiglia di provenienza.
La pratica di guarigione invece, come nella provincia modenese, consiste in un’imposizione delle mani accompagnata da segni tracciati sulla parte malata e da una specie di litania cantilenata. In particolare, in Abruzzo la pratica di guarigione si identifica con il verbo incantare (dal latino canto variante di cano, “cantare”, e intensivo di cànere, “cantare in versi” ed anche “vaticinare, fare incantesimi”, per la stessa relazione d’idee per la quale il latino carmen, “canzone”, ebbe pure il senso di formula magica, in quanto appunto gli indovini e i fattucchieri si servivano del canto e di versi numerati nelle loro predizioni e nei loro incantesimi). (Vocabolario etimologico della lingua italiana, 2004)
Infatti, il rapporto tra canto e magia è universale ed è ben documentato nelle concezioni popolari e nei dialetti. Come fanno notare Alinei e Benozzo: “Basta pensare che in tutti i dialetti d’Europa esistono verbi e nomi che significano tanto “cantare, comporre un canto” quanto “guarire, guarigione”, e parole che significano tanto “poeta, cantore” quanto “guaritore”. (Per esempio: in alta Italia, nell’Isola di Skye della Scozia settentrionale, nei dialetti del Galles centrale, nel ladino dolomitico e in alcune varianti del siciliano).
Inoltre, alla documentazione dei dialetti si può affiancare quella delle lingue attestate in forma scritta già anticamente: basta pensare al sanscrito bhisaj, “poeta”, e “guaritore, medico”; al gotico gođi, “sacerdote” e “cantore”; all’islandese antico ríta, “incidere, scrivere” ma anche “segnare magicamente, guarire”. Siamo di fronte, quindi, a parole, e cioè concezioni, nate in un contesto molto arcaico, in cui esistevano figure di professionisti della parola, in tutto simili agli sciamani delle società tradizionali, che attraverso l’uso della parola poetica e del canto esercitavano un potere terapeutico e facevano incantesimi. (Alinei & Benozzo, 2015)
Fornisco adesso alcuni dati in merito alle due guaritrici e alle forme delle pratiche di guarigione:
Entrambe sono nate nel comune di Castiglione Messer Marino.
In entrambi i casi si tratta di persone coniugate (e in entrambi i casi il coniuge è defunto, evento che ha causato un aumento delle richieste delle loro pratiche di guarigione da parte dei clienti).
In entrambi i casi si tratta di persone non scolarizzate.
Le abitazioni nelle quali si svolgono le pratiche di guarigione sono le stesse nelle quali le operatrici vivono abitualmente.
In nessuno dei due casi, contrariamente all’area modenese, le guaritrici hanno appreso le tecniche e le forme di guarigione dai parenti, in quanto entrambe ammettono di essere state ispirate da Dio.
Le due persone si conoscono tra di loro e ognuna sa che l’altra esercita a sua volta gli incantesimi ma non hanno mai scambiato informazioni relative alla propria attività di guaritrici.
In entrambi i casi si tratta di operatrici che intervengono per guarire tipologie patologiche precise: sciatica, ascessi, congiuntivite, colite, “fuoco di S. Antonio” ma mai slogature o rotture di ossa (mi soffermerò su questo particolare più avanti).
Entrambe sono in grado di togliere il malocchio.
Entrambe non accettano né richiedono alcuna forma di pagamento.
In nessuno dei due casi è stato dichiarato un rapporto di conflittualità o di ostilità con i medici ordinari “ufficiali”: la loro attività è semplicemente sentita come un “dono trasmesso” relativo ad alcune tipologie patologiche.
Entrambe ammettono di aver ricevuto leggere forme di ostilità da parte dei sacerdoti mentre, al contrario, entrambe si dichiarano credenti.
In nessuno dei due casi ho riscontrato particolare diffidenza da parte delle guaritrici nei miei confronti e si sono mostrate disponibili di fronte alle mie richieste d’informazioni.
La lingua di comunicazione tra me e le guaritrici è stata il dialetto (e, per questo, non conoscendolo ho utilizzato mio padre come intermediario).
Dalle mie interviste risulta che le formule cantilenate sono una parte fondamentale del rituale e, nello specifico, sono riuscita a trascrivere le seguenti cinque:
Per curare il “fuoco di S. Antonio” (in dialetto: serpentina)
“Carogna serpentina, tu gualani perché non ‘ari?”
“non posso, tengo la serpentina”
“perché non ti guarisci?”
“il perché non so”
“‘nsogna di porcina, vattene via serpentina”
(Durante la recitazione la guaritrice immerge tre pugni di sale nella sugna di tre maiali diversi, cotta in tre camini diversi).
Per prevenire l’infezione quando qualcuno si taglia
Noi siamo tre frati, ben feriti e ben tagliati
andando per la via incontrammo Gesù, Giuseppe e Maria
dissero: “dove andate cari frati?”
“andiamo sul monte Abate per curare nostro frate”
“se per cenare non tenete pagamento, non pigliate”
(La formula si ripete per tre volte).
Per curare gli ascessi (in dialetto: resibla)
Quando Cristo andava camminando per il mondo, incontra la resibla pe’ la via
“tu resibla che vai cercando?”
“vado trovando la carne umana per farla abbaiare come un cane”
“non mi uccidere, non mi gettare al mare, una bella orazione ti voglio ‘mbarare”
(Durante la recitazione la guaritrice utilizza una piuma di gallina nera e l’olio di una lampada. L’orazione si ripete per tre sere consecutive e, ciascuna sera, per nove volte consecutive. La guaritrice “incanta” sia in luna calante che in luna crescente).
Per togliere il malocchio
“Malocc’ malucchiato,
due occhi t’ha adocchiato
tre santi t’ha aiutato
nun si trova chiù bel canto
Padre, Figlio e Spirito Santo”
(Durante la recitazione la guaritrice lascia cadere delle gocce d’olio su una bacinella piena d’acqua: se le gocce d’olio si allargano, il paziente ha il malocchio, altrimenti non è malocchio e occorre cercare un’altra causa del male. Nel caso in cui il paziente sia affetto da malocchio, la guaritrice ripete la formula per tre volte: la prima volta immergendo prima anche una fede e, la seconda volta, un paio di forbici).
Per guarire la congiuntivite (in dialetto: malaventura)
“Passat’ Santa Lucia pe’ la via
Santa Lucia disse:” che si fat?”
“m’è iuta ‘na fruscia à l’ucchi”
“tull la fede d’argint e chist’ mal nun pozz esse’ niente”
(Durante la recitazione la guaritrice gira nove volte la fede intorno all’occhio malato. La formula si ripete per tre giorni consecutivi).
Come si può notare, tra gli elementi utilizzati si annoverano: la sugna di maiale (nsogna), le penne di gallina, l’olio, l’acqua, il ferro e la fede nuziale.
A questo punto, in seguito alle premesse e agli esempi fatti, mi permetto di avanzare l’ipotesi che, come afferma Benozzo, “le considerazioni sul rituale delle guaritrici […] si iscrivono a pieno titolo nella visione di una continuità sciamanica” (Benozzo, 2010) Per questo, in base alle risultanze della comparazione appena compiuta, diventa doveroso inquadrare in questo orizzonte la figura della guaritrice tradizionale, specificando che le prerogative magico-religiose che si trovavano originariamente unite in un’unica figura polivalente di professionista della parola si sono suddivise e sono sopravvissute diventando funzioni specifiche indissolubilmente legate a operatori-operatrici specifici e differenziati.
È dunque plausibile che: “ lo studio dei costumi e delle pratiche mediche dei popoli primitivi e lo studio della medicina popolare ci fanno risalire col pensiero alle pratiche mediche dell’antichità e sono le fonti più sicure che possono darci, per analogia, un quadro di quella che è stata la medicina nella preistoria” (Latronico, 1956)
3.2 incantare vs. arsanà
Torno ora brevemente sul tipo di patologia curata dalle due guaritrici intervistate. Entrambe, infatti, hanno tenuto a sottolineare che non si sono mai occupate (e ammettono di non essere in grado di farlo) della guarigione di distorsioni o rotture di ossa. Tale ruolo era infatti svolto, a Castiglione, dalla mia bisnonna Marianna, più comunemente conosciuta con il soprannome di “la mammina”, per l’importante ruolo di essere anche l’unica levatrice del paese.
Le due guaritrici mi raccontano che Marianna era in grado di massaggiare le ossa e capire se fossero rotte o slogate. In particolare, nel caso in cui le ossa fossero state slogate, Marianna sapeva massaggiare la parte indolenzita in modo da ridurre il dolore; mentre nel caso di ossa rotte procedeva all’ingessatura, realizzata con acqua, gesso e cotone.
Ciò che più colpisce di tale ruolo, diverso e separato da quello delle guaritrici tradizionali, è l’uso di un verbo differente per identificare la cura: arsanà. Il verbo arsanà (dal latino sanare, cioè “guarire un male fisico”) infatti si utilizza nei casi in cui alla guaritrice si riconoscono particolari doti nell’arte di curare attraverso le mani, dove la pratica di guarigione avviene in silenzio, senza l’utilizzo di formule cantilenate e, quindi, dove il verbo incantare (“cantare in versi, fare incantesimi”) risulta fuori luogo.
Questa distinzione dovrebbe testimoniare e far concludere che i dialetti pre-esistono al latino e trovano le loro origini in epoche preistoriche e pre-romane. È proprio nei dialetti, infatti, che si riscontrano tracce di antiche concezioni preistoriche, dove alcune parole rimandano ai sistemi di caccia e raccolta del Paleolitico, altre alle principali attività economiche del Neolitico e altre ancora alla religione precristiana, l’unica in grado di dare spiegazioni, in termini magici, a eventi a quell’epoca incomprensibili come, nel nostro caso, le malattie.
Occorre concludere quindi che, come accade per le leggende tramandate oralmente da millenni, che sono molto più arcaiche delle letterature tramandatesi in forma scritta, le lingue non scritte sono molto più antiche di quelle scritte. L’unica differenza tra la parola latina (che tradizionalmente la linguistica considera come la lingua originaria di tutte le lingue “romanze”) e quella italiana sta nel fatto che quella latina è stata scritta in epoca antica, per la presenza di un gruppo dominante che possedeva la scrittura, mentre quella italiana è rimasta una parola solo pronunciata, ma non per questo non antica quanto quella latina. Ecco perché le lingue tradizionalmente dette “romanze” vanno considerate come continuazioni di lingue affini al latino preromano, e non come parlate nate dal latino di Roma.
Una visione moderna della nascita delle parole ci costringe pertanto a confrontarci con il nostro passato, spesso anche remoto, e con l’eredità che abbiamo ricevuto dai nostri antenati più antichi, spesso del tutto sconosciuta, inaspettata e sorprendente.
�
CAPITOLO 4
IL SUSSURRO MAGICO: GLI ORIZZONTI CERIMONIALI TRA SICILIA E ABRUZZO
4.1 Il senso pratico delle formule rituali
Il sussurro magico di Pier Luigi Josè Mannella interviene in un settore di studi etnografici regionali riguardanti la Sicilia e si rivolge espressamente alle preghiere di tradizione orale popolare, tra cui sono collocabili anche i recitativi rituali da me precedentemente riportati.
Nella sua opera, Mannella riconosce il debito con i ricercatori precedenti (come Giuseppe Pitrè e Giuseppe Bonomo) ma decide di intensificare la retrospettiva verso testimonianze dell’antichità mediterranea. Infatti, grazie agli sviluppi delle ricerche etnografiche, linguistiche e archeologiche avvenute in Sicilia, unite a diverse frequentazioni sul terreno, lo studioso si rivela in grado di elaborare una propria raccolta di orazioni propiziatorie e apotropaiche, dette anche scongiuri.
In questo modo Mannella realizza che la filologia dei testi orali non può essere concepita sul modello di quelli scritti; che differenti sono le dinamiche di elaborazione e trasmissione; che in ambito cerimoniale si affermano specifici condizionamenti delle norme esecutive, ed è conscio del peso assunto dalle competenze mnemoniche dei testimoni e dei possibili errori di ricezione e restituzione.
In quest’ottica, quindi, il punto di partenza di Mannella si rivela in linea con i principi etnofilologici da me precedentemente esposti ed è fondamentale per la direzione della ricerca che sto realizzando, in quanto riguarda proprio le difformità e le incongruenze presenti nelle versioni di una stessa orazione tramandate oralmente. Abituati come siamo alla stabile individuazione dei testi scritti, sempre controllabili e verificabili, diventa necessario chiedersi: in uno scongiuro documentato in modi sempre diversi o solo parzialmente convergenti, cosa può essere considerato variabile, incidentale, e cosa strutturale, identificante? E ciò che è strutturale lo è per lo più nella dimensione performativa del rito o influisce anche nella fisionomia testuale delle parole recitate? Spiegazioni di queste presunte anomalie sono state ipotizzate in varie direzioni e molte sono richiamate da Mannella, ma due hanno prevalso sul resto:
Gli scongiuri popolari sono relitti linguistici ormai senza significato uniforme: essi registrano il graduale disfacimento e la confusione dei testi antecedenti, con sparizione irreversibile dell’intento originario; degradazione che coinvolge le attività cerimoniali ancora operative e dunque, per proprietà transitiva, la dimensione esistenziale di chi le pratica (soprattutto donne). Da qui una nutrita collezione di giudizi liquidatori, spesso misogini.
Gli scongiuri popolari, malgrado le trasformazioni connaturate all’oralità religiosa, mantengono significati coerenti con il senso delle pratiche rituali: il riflesso testuale di quest’ultimo, si deve cercare non solo nelle singole proposizioni versificate, ma anche e soprattutto nei raggruppamenti formulari con cui quelle proposizioni si dispongono nella concreta scansione recitativa. L’esecuzione di queste preghiere avviene attraverso sequenze di brani o nuclei che svolgono diverse funzioni comunicative. Anche quando qualche frammento si perde, o è frainteso, il brano complessivo conserva una sua tenuta enunciativa e la persona che recita mantiene la convinzione, tutta devozionale, di eseguire sempre la stessa orazione.
Alla ricerca del significato delle preghiere sussurrate, dopo averle opportunamente riconfigurate nel particolare contesto d’enunciazione, occorre dunque misurarsi con la particolare concordanza tra le loro parti funzionali: funzionali alla recita, funzionali al rito, al senso pratico del rito e delle sua appropriatezza devozionale.
Inserendo la mia ricerca all’interno di queste considerazioni, grazie alla tenacia da filologo di frontiera di Mannella, un po’ linguista storico un po’ etnografo della sincronia, è possibile esporre una lettura morfologico-formulare del nostro repertorio di studi.
4.2 Scongiuri curativi
Rispetto ad altri documenti etnolinguistici, gli scongiuri del sud Italia sono stati poco raccolti e indagati. Questo è avvenuto soprattutto per la loro complessità di ordine semantico e in particolare per la segretezza e i vincoli che ne caratterizzano la trasmissione insieme al pregiudizio antisuperstizioso dello scientismo positivista che, tra Ottocento e inizi Novecento, ha influenzato studiosi e cultori di tradizioni popolari. Essi hanno, infatti, preferito raccogliere proverbi, canti leggende, usi, costumi, fruibili pubblicamente, piuttosto che misurarsi con la difficoltà di molte pratiche rituali che includevano l’esecuzione di scongiuri. Alcuni di questi possono quindi trovarsi sparsi in testi su “superstizioni”, “pregiudizi” e “medicina popolare”.
Al contrario, Mannella decide di indirizzare le proprie ricerche su un piano diverso e, nel suo libro, ricorda che “ nel Meridione italiano, gli incantesimi di guarigione sono in uno da moltissimo tempo e documentati fin dall’antichità precristiana. Alcuni scongiuri medievali si trovano scritti in calce o ai margini delle pagine di manoscritti che solitamente trattano di ricette e cure contro le malattie. […] Numerose sono poi le condanne attuate dalla Chiesa, soprattutto nell’età della Controriforma, quando diventa ancora di più importante tutelare l’integrità teologica delle Sacre Scritture usurpata per finalità considerate disoneste. Tuttavia, nonostante ciò, questi manoscritti medievali sono stati trovati nelle biblioteche dei conventi, su codici scritti proprio da monaci come promemoria, per loro stessi e per altri che li avrebbero letti, magari alla ricerca di una terapia idonea a fermare una data malattia” (Mannella, 2015).
A questo punto, aiutandoci con le ricerche e le analisi realizzate da Mannella stesso nel contesto siciliano e facendo riferimento alle formule curative da me precedentemente riportate, è possibile definire lo scongiuro terapeutico come un’orazione reattiva o preventiva e, a volte, anche divinatoria. Reattiva quando ha una funzione curativa impostata su difesa-offesa e usata da un guaritore su un paziente vittima di un’entità-malattia e per cacciare dunque quest’ultima. Preventiva quando svolge una funzione che potremmo definire “prefascinante” e ha il compito di scongiurare l’esito negativo che potrebbe avere un avvenimento. Infine divinatoria perché, spesso, l’esecuzione di uno scongiuro contribuisce anche a diagnosticare l’entità o tipologia del danno (se è ad esempio riferibile a malocchio o fattura) e l’identità dell’antagonista: sesso, età, caratteristiche fisiche, sociali, relazioni amicali, parentali o di vicinato con la vittima.
Lo scongiuro è finalizzato, in primo luogo, all’allontanamento o all’annientamento di un male interpretato sottoforma di malattia, depressione, avvenimenti meteorici (la perdita del raccolto, tempeste, etc.) o un animale potenzialmente letale. Inoltre, molte malattie, come nel caso del malocchio, non sono ritenute di origine naturale e possono essere l’effetto di un’azione malefica proveniente da volontà o involontarietà umana: da una persona invidiosa e/o cattiva tramite il suo sguardo o parola, più o meno coscienti; di una “magheria” se l’agente è un “mago” o una “maga”; un’entità soprannaturale incontrata per caso (quando cioè la vittima s’imbatte in uno spirito malefico che si trova a passare), inviata da qualche esercente cerimoniale o sopraggiunta adirata e offesa perché non si è osservata la prassi rituale o ancora da esseri insidiosi come streghe, fantasmi e anime dei morti.
Si crede, infatti, che un demone patogeno possa agire perché invocato da un operatore che possiede particolari poteri tali da chiamarlo al suo volere, aprendo così un passaggio tra l’umano e il soprannaturale, permettendo l’incontro, la visione, l’interiorizzazione del male; o perché indotto, coscientemente o inconsciamente, dal pensiero di una persona invidiosa, tramite il malocchio o la maledizione; o più semplicemente in quanto lo s’incontra o si entra in contatto con esso. Tutto ciò provoca uno scotimento che agisce su uno stato di quiete, trasformandolo in caos. Secondo una diffusa tradizione popolare il demone agente coincide col male provocato. Esso, per insinuarsi nell’uomo portando uno o più malesseri, può approfittare dello status di debolezza, ricettività e permeabilità dell’individuo. Il malocchio crea, quindi, una situazione ideale di passaggio del male dall’occhio invidioso alla vittima, mettendo in moto il processo di trasmissione male-vittima.
Tuttavia, la casualità non contraddice la causalità: la drammatizzazione, la finzione, l’interpretazione o la semplice nominazione possono pericolosamente trasformarsi in realtà tramite simpatia, omeopatia o trasposizione dall’agente all’oggetto per mezzo dell’incontro con l’elemento demonico. Nominare il demone-malattia, infatti, significa chiamarlo, crearlo, dargli vita, materializzarlo. In un contesto del genere la parola: a) diventa elemento performativo centrale della prassi cerimoniale; b) ha un’efficacia operativa nel caso di maledizioni e formule brevi che non pretendono un’azione rituale per offendere o difendere; c) è creativa in quanto la sola nominazione configura l’invocato, gli dà vita, lo mette in moto o lo caccia; d) è attiva dato che ciò che si dice si obiettiva per effetto simpatico; e) è curativa, come mostrano gli scongiuri presi ad esempio, con i quali si crede di guarire gli ammalati tramite soltanto la recitazione di formule.
In particolare nel pensiero antico, nelle orazioni e nei cerimoniali terapeutici è insita l’idea che la parola di un taumaturgo invocato sia un potente rimedio ai mali. Alla sua bocca sono affidati messaggi istruttivi, gli ingredienti e la modalità di cura di quel male specifico.
Così, il discorso rituale, avendo questo “potere”, si distingue dagli altri discorsi e si presenta più enigmatico e contorto, arrivando al non sense nelle invocazioni ai demoni e a essere impercettibili a causa del susurrus magicus. È come se la lingua umana adottasse un registro linguistico altro, che nella realtà ordinaria è incomprensibile ma che tale non è ai demoni o agli esseri ultraterreni che intendono il logos pronunciato durante la cerimonia.
Fondamentale per la nostra ricerca, e tornando sul tema delle difformità tra le orazioni di cui parlavamo nella presentazione del libro di Mannella, è il fatto che lo studioso sottolinei che molti scongiuri recitati oggi contro vari demoni sono il risultato di un’evoluzione, una trasformazione di tipo linguistico, religioso, culturale di archetipi antichi, spesso precristiani. Infatti, sfogliando le grandi opere del passato, emerge quanto forte sia stata la credenza riguardo all’efficacia degli scongiuri per curare le malattie. “Plinio si chiedeva se ciò fosse vero, riportando la tradizione omerica dove Ulisse ristagnò il sangue che gli scorreva da una ferita per mezzo di incanti; Teofrasto dice che con gli scongiuri si cura la sciatica; per Catone ne esistono di certi che fanno tornare le membra smosse al loro posto; Varrone conosce quelli contro la podagra e Cesare ne recitava uno tre volte per scongiurare le cadute” (Mannella, 2015)
In seguito, prima del Positivismo (e dell’era scientifica che ha propagato e propagandato un pensiero eziologico differente che vede, nella “causalità empirica e ordinata” della natura in cui vive l’uomo, il motivo di ogni ingerenza malefica, affermando un determinismo ambientale-naturale) nemmeno la Chiesa era riuscita a modificare le persistenze precristiane che vedevano nella malattia una giusta punizione divina al cattivo comportamento del devoto nei confronti delle regole della religione ufficiale. La Chiesa medievale da un lato ostacolava e vietava pratiche e credenze di tipo magico, dall’altro incoraggiava una correlata concezione cerimoniale, stando ai successi e adepti che si ebbero, in quel periodo, in seno alla Chiesa stessa. Negli scongiuri popolari, infatti, coesistono rappresentazioni e/o personificazioni demoniche della malattia unitamente a particolari figure di santità liturgiche.
A questo punto, entrando più nel dettaglio, attraverso l’analisi degli etnotesti terapeutici e aiutata dal confronto con le ricerche realizzate da Mannella nel territorio siciliano, è possibile far emergere alcune tipologie specifiche contro diversi mali fisici e nuclei di orazioni che ricorrono in innumerevoli scongiuri. Particolarmente ricorrente appare una tipologia di scongiuro con historiola che ha una struttura tripartita costituita da:
un nucleo introduttivo-invocativo nel quale, oltre all’invocazione delle “divinità” risolutive, si ritrovano spesso liste o elenchi dove si nomina il male e ciò che esso provoca al malato;
un nucleo centrale-narrativo, che può essere costituito da: un’ historiola mitologica dialogata, in cui un santo viene ostacolato da un male-demone (antagonista) che lo mette in crisi (danno-malattia), procurandogli uno stato patologico e quindi soccorso da un’entità più potente (aiutante taumaturgo) che risolve la crisi; o da una historiola monologata in cui si narra di un taumaturgo che viene da lontano per istituire il rito curativo; oppure ancora da un’ historiola autodiegetica in cui l’officiante narratore-protagonista si proietta nel tempo e nello spazio dell’evento mitico rivivendo l’accaduto leggendario in prima persona, rapportandosi col demone-malattia e/o il taumaturgo senza subirne danni in quanto l’incontro è mediato dal rito e dallo scongiuro;
un nucleo conclusivo risolutivo-istitutivo spesso completo della descrizione del rituale, del formulario esecutivo vero e proprio e dell’invocazione finale che chiude il cerchio aperto con la stessa o opposta invocazione iniziale.
Lo scongiuro, trasmettendo il cerimoniale risolutivo, si presenta come “ingrediente” indispensabile per la realizzazione di un antidoto contro quella malattia per cui viene recitato e trasmesso.
La potenza dell’orazione consiste nella sua capacità di connettere, attraverso l’historiola, il mondo di oggi col tempo della storiella raccontata attualizzando quel momento mitico. La forza tecnico-operativa del rito sta proprio nel collegamento spazio-temporale col mondo del mito: come in un tempo molto antico una divinità risolse il dilemma di un santo, soccorrendolo, così anche oggi deve risolvere l’analogo dilemma dell’ammalato N.N.
4.3 Struttura degli scongiuri curativi
Come già affermato, gli scongiuri con nucleo narrativo (historiola) sono documentati in tutta l’antichità e testimoniati in varie culture del passato. A questo proposito, Mannella ne da un’adeguata strutturazione tipologica, prevedendo una distinzione tra: 1) scongiuri con/senza historiola; 2) scongiuri con historiola dialogata/monologata; 3) scongiuri per protagonista (protagonista taumaturgo, protagonista vittima, protagonista curatrice, protagonista malattia).
Nello specifico, dall’analisi degli scongiuri curativi dell’Italia meridionale, s’individuano principalmente: un formulario invocativo (in cui sono denominati santi e dei, con o senza i loro poteri esplicitati); un formulario apotropaico (costituito dalle frasi di cacciata del male); un formulario espositivo (elenchi di ingredienti, parti del corpo, malattie); un formulario narrativo (historiola) e un formulario regolativo che racchiude i consigli e le norme risolutive dettate dal taumaturgo.
Gli scongiuri narrativi sono la tipologia più diffusa e comprendono la cura di diverse malattie. I testi con historiola si distinguono a loro volta in scongiuri con historiola dialogata (con due o tre personaggi) e scongiuri con historiola monologata (narrazioni in terza persona che raccontano il protagonista come risolutivo/istitutivo e iniziano con l’arrivo di questo santo che porta la cura).
Dall’analisi delle orazioni terapeutiche si possono trovare santi affetti da un malanno che vengono guariti dal soccorso offerto da un’altra entità più potente e santi che provengono da lontano per fondare una cura. Gli scongiuri narrativi si dividono, quindi, in due tipi: uno in cui il santo sta male e viene aiutato attraverso la fondazione del cerimoniale curativo; l’altro che ha per protagonista un santo in veste di pellegrino che giunge per istituire la terapia contro il male.
Inoltre è possibile distinguere, all’interno dei singoli scongiuri narrativi, tre nuclei che ne costituiscono la struttura ricorrente:
nucleo iniziale o introduttivo, che apre lo scongiuro e include le invocazioni degli esseri potenti, le formule di allontanamento del male ed elenca i danni che questo ha provocato al paziente o le parti del corpo colpite;
nucleo centrale o narrativo identificato con l’historiola;
nucleo finale o istitutivo, completo di formule da pronunciare e di ingredienti da usare; esso ha inoltre la funzione di chiusura dello scongiuro e include le invocazioni degli esseri potenti insieme alle formule di cacciata-allontanamento del male.
Come è possibile notare da tale struttura tripartita, il nucleo iniziale e il nucleo finale sono legati da una forza che possiamo definire come “fenomeno circolare”. Entrambi, infatti, sono costituiti dall’invocazione alle entità supreme, dalle formule di cacciata del male e da diversi elenchi. Mannella afferma, infatti, che “quello circolare è un fenomeno che normalmente apre e chiude uno scongiuro all’interno di un circolo invocativo-formulativo, racchiudendo al centro il nucleo narrativo, come attestato nei documenti più antichi. […] Nello specifico, questo legame circolare è da intendersi come una macrosequenza con funzione di cornice, strutturata su invocazioni e formule oppositive d’apertura/chiusura spesso contrapposte a livello sintattico, lessicale e/o semantico” (Mannella, 2015)
Il nucleo introduttivo è quello più soggetto a spostamenti ed elisioni, tant’è che spesso non è presente o si trova esplicitato o assorbito nella parte finale. Esso è particolarmente esposto alla forza centrifuga della recitazione che tende a collegarlo alla parte finale, formata da invocazioni e nominazioni di santi/divinità preposti alla cura del male. La recitazione circolare degli scongiuri si effettua tramite la loro ripetizione, quasi sempre triplice. Durante la recitazione dell’officiante, la parte finale dello scongiuro, recitato per la prima volta, si trova a precedere la parte iniziale della seconda, e così via. Nella memoria del curatore, di conseguenza, può avvenire uno scambio tra le varie parti dello scongiuro che tende, spesso, a esordire col nucleo narrativo o a metà dialogo. Le parti del nucleo introduttivo tendono dunque a scomparire perché, durante la triplice ripetizione, le sequenze iniziali e finali, talmente simili tra loro, si sovrappongono. La recitazione circolare, ripetuta tre volte, tende a unire ogni finale all’introduzione successiva, tanto che gli scongiuri si presentano spesso inizianti con la storiella, seguiti dal finale e conclusi dall’introduzione.
Comunemente, il nucleo introduttivo esordisce con l’invocazione alle entità taumaturgiche più importanti del culto cristiano, in particolare alla Trinità. Soprattutto negli scongiuri più antichi appare evidente che le formule di apertura coincidano spesso con quelle di chiusura; l’invocazione nominativa (In nomine Patri et Filii et Spritirus Sancti) si presenta infatti all’inizio e/o alla fine dello scongiuro. (Esemplare di una cospicua quantità di scongiuri altomedievale che iniziano e finiscono in questo modo è quello contro il malocchio, come è possibile notare anche dagli esempi da me riportati).
La nominazione anche di una sola entità taumaturgica risulta indispensabile presenza negli scongiuri, tanto che in alcuni di essi è specificato che basta la sola nominazione per annullare il male. Il nome dell’entità sacra si configura quale antidoto contro il male/demone: entrambi sono presenti nella parte introduttiva dell’orazione, elencati con i poteri, i danni e le possibili manovre linguistico-cerimoniali e curative. L’invocazione iniziale alle divinità può presentarsi completa dei poteri attribuiti a loro e ai quali si fa voto per risolvere il male. I poteri sono chiamati con termini astratti che evocano figure dell’immaginario religioso medievale, alcuni di provenienza pre-cristiana (quali Potenza, Sapienza, Eternità, Virtù, Purezza, Verginità, tutte ritenute forze in grado di debellare il male).
La condanna del male, però, può non essere presente all’inizio dove, il più delle volte, sono elencati solamente i disturbi procurati al paziente: come risulta dalle mie ricerche e da quelle di Mannella, una costante comune a quasi tutti gli scongiuri meridionali è proprio la parte finale; sia essa l’ultima parte dell’ultimo verso, l’intero verso finale o il penultimo, se è seguito dall’invocazione ai santi è sempre una formula di condanna e allontanamento del male, il nome del quale però, a differenza che nell’introduzione, quasi mai è ripetuto due volte.
Nella parte introduttiva delle orazioni, invece, le espressioni che nominano il male sono quasi sempre ripetute due volte. Questa duplicazione nominativa è una caratteristica delle formule risalenti all’Antichità ed è figlia dei lunghi elenchi di nomi e titoli divini e demonici, evocati a fini incantatori o profilattici, che caratterizzano antichi formulari detti in greco ephesia grammata (perché si trovavano incisi sulle statue di Artemide ed Efeso) e in latino onomata barbarica o voces magicae.
Concentrandoci a questo punto sul nucleo finale, esso è stato anche detto “istitutivo” perché istituisce la prassi terapeutica enunciata dal personaggio taumaturgo con espressioni del tipo “una bella orazione ti voglio ‘mbarare”(vedi rito per curare gli ascessi). Il nucleo istitutivo ha carattere regolativo-prescrittivo in quanto comprende la descrizione delle tecniche operative previste dalla prassi mitico-cerimoniale: il guaritore deve agire ritualmente così come la Madonna o Gesù consigliarono di dire e fare a un martire tanto tempo fa. Esso, inoltre, è connesso strutturalmente all’historiola, in quanto si compone degli accorgimenti dettati dalla Madonna o da Gesù, e al nucleo conclusivo dove emergono le espressioni di cacciata del male e i nomi completi dei potenti aiutanti.
4.4 Focus sul nucleo narrativo: l’historiola
La presenza del nucleo narrativo negli scongiuri contro un male determina la presenza del mito nel rito. L’historiola, infatti, tramanda il racconto antico in cui il male è stato risolto una prima volta, esplicita l’avvenimento mitico accaduto in illo tempore e riattualizza, attraverso quella storia paradigmatica, la risoluzione terapeutica.
I personaggi principali di uno scongiuro sono solitamente tre, i quali, in corrispondenza del ruolo assolvono funzioni specifiche: il santo risolutore, la vittima e la malattia, personificata attraverso una o più entità demoniche. I tre personaggi spesso appaiono insieme, tanto che in una historiola è sempre presente un personaggio taumaturgico, una vittima e un antagonista (la malattia e/o il demone) intrecciati all’interno di una precisa trama narrativa. Lo scopo della vittima è trovare l’anticausa, l’antidoto, il rimedio per eliminare l’antagonista e questa soluzione si offre nella figura del personaggio risolutivo. Così, anche nella realtà delle persone interessate all’avvenimento-rito, si ricostituisce la triade tra soggetto risolutivo nella figura dell’officiante, vittima quale paziente sottoposto al rito e, infine, malattia in qualità di antagonista da annientare. La malattia, il male da debellare, si presenta come animato e vivente, materializzatosi nel cerimoniale attraverso l’uso di un oggetto che funga da succedaneo (come, ad esempio, l’olio nel rituale antimalocchio).
4.5 Atti linguistici e pratiche discorsive
La bocca è uno dei varchi di passaggio dall’interno all’esterno del corpo umano. La sua funzione negli atti rituali correlati agli scongiuri sono pertanto fondamentali. Tra le più importanti ricordiamo la parola. Mannella, a questo proposito, fa notare che: “Esempio di guaritore paradigmatico e possibile erede di tradizioni esorcistiche di ambiente giudaico-apocalittico, Gesù guarisce i malati e caccia i demoni attraverso il potere della sua parola e l’imposizione delle mani. La parola e le mani sono gli stessi mezzi che conferisce agli apostoli, purché operino nel suo Nome e con grandissima fede (cfr. Mt 10,1 ; Mc 16, 17)” (Mannella, 2015)
Tuttavia, nonostante quasi tutti gli scongiuri riportino nel loro contenuto soggetti, avvenimenti, date liturgiche ed espressioni di matrice cristiana quali versi e frasi appartenenti alle preghiere ufficiali e alle Sacre Scritture, molte hanno un’origine precristiana. In essi si sono mantenute espressioni più arcaiche dovute prevalentemente alla conservatività del rito che, per essere efficace, deve mantenersi coerente ai dettami tradizionali. A tal proposito, Mannella riporta il racconto degli esorcisti e di San Paolo nel Nuovo Testamento: “Dio faceva molti miracoli attraverso San Paolo, tanto che venivano applicati sui malati grembiuli, fascette e fazzoletti che erano stati a contatto col Santo. Vi erano alcuni esorcisti giudei, a Efeso, che praticavano le loro arti girovagando e pretendevano di scacciare gli spiriti cattivi dai corpi degli indemoniati usando il nome di Gesù. Ma uno spirito cattivo che gli esorcisti disturbavano dicendo: “Vi scongiuro per quel Gesù che Paolo predica”, riconoscendo Gesù e Paolo, disse di non conoscere loro e prese a pestarli. Da lì furono messi al rogo moltissimi libri e prontuari cerimoniali (cfr. At 19,11-20). L’uso del nome di Gesù e quello di San Paolo in riti per scacciare i demoni, dunque, si diffuse addirittura mentre erano ancora in vita. A loro sono stati adattati, di conseguenza, parole e riti preesistenti” (Mannella, 2015).
Inoltre, al pari delle più importanti religioni misteriche, le pratiche rituali popolari connesse a molti scongiuri sono segrete e, se trasmesse, sottoposte a rigorosi vincoli, tabù e accorgimenti.
Per concludere, quindi, come ogni atto linguistico nasce dal potenziale espressivo e comunicativo di una lingua ed è diverso in dipendenza da ciò che si vuole comunicare, così la formulazione rituale ha una specifica e particolare modalità di espressione che la rende unica per contenuto, modo espositivo, timbro e sintassi. Dalle testimonianze di Mannella e dalle mie emerge, di conseguenza, che gli scongiuri medicinali:
sono utilizzati da officianti in possesso della capacità di guarire tramite la conoscenza di riti e formule;
devono essere tenuti segreti e non possono essere divulgati;
sono costituiti anche da parole appartenenti alle preghiere canoniche, alle Sacre Scritture, ai riti, ai soggetti della religione ufficiale, sincreticamente connesse ad altre religioni di origine diversa o più antica;
contengono numeri, elenchi-liste di nomi ritenuti carichi di potenza operativa;
contengono parole incomprensibili (chiamate anticamente ephesia grammata o voces magicae) che appaiono come camuffamenti di nomi divini indicibili;
sono recitati mentre si opera manualmente su elementi e ingredienti naturali (acqua, fuoco, sale, vegetali, animali) da terapeuti che, per quanto credenti, possiedono particolari poteri elaborati con strumenti specifici e agiscono per mezzo di pratiche diverse (massaggi, croci, segni vari);
sono recitati in maniera sussurrata (ciò che un tempo era chiamato susurrus magicus), mormorata tra i denti in modo da non comprendersi.
Ed è proprio a partire da una di queste caratteristiche peculiari, cioè la segretezza, insieme all’ostinata tendenza al mantenimento dell’archetipo originale che è stata possibile la trasmissione di termini arcaici, ormai desueti, o di strane parole nate dalla fusione di lessemi non più compresi. Gli stessi termini che hanno mosso la mia curiosità e mi hanno permesso di intraprendere tali ricerche nell’Appennino abruzzese.
�
CAPITOLO 5
MALI E MALESSERI: ALLA RICERCA DELLE ORIGINI
In alcuni capitoli de Il sussurro magico, Mannella concentra la propria ricerca sull’origine di alcuni mali particolari attraverso l’analisi morfologico-formulare dei relativi scongiuri registrati in area siciliana. Aiutandomi con i dati riportati dallo studioso, ho deciso quindi di analizzare approfonditamente i dati della mia ricerca attraverso la messa in evidenza di analogie, a livello morfologico e rituale, delle stesse malattie riscontrate anche in territorio abruzzese.
5.1 Fuoco di Sant’Antonio
Un tempo, colui che era affetto dal fuoco di Sant’Antonio era ritenuto e trattato come un essere impuro, impossessato dagli spiriti maligni. Il Focu di Sant’Antoniu o Focu sagru, in Sicilia, si combatte con scongiuri che invocano lo stesso santo. In particolare sul Fuoco di Sant’Antonio come herpes zoster (il morbo più comune e innocuo) sono state raccolte da Mannella due orazioni che hanno lo stesso protagonista: Santa Carunìa. Nella prima variante, molto corrotta, Santa Caronia, mentre correi via dai campi invasi dalle fiamme, incontra Nostro Signore. Il Signore, dopo averle consigliato di recitare lo scongiuro, sputa sul fuoco, spegnendolo. Nella seconda variante l’historiola è diversa: Santa Caronia è presentata mentre compie un’azione comune, fare il pane, ma in un giorno sacro, la domenica, in cui è vietato in genere lavorare e, in particolare, nessuno avrebbe mai fatto il pane di domenica: era tabù. Qui non si capisce se a sputare sul forno sia la stessa Caronìa, la Vergine o Cristo; tuttavia con questa azione viene imbrattato il volto di Caronìa.
Santa Caronìa in questo caso è vista in qualità di entità-malattia, colta mentre sta cuocendo col suo fuoco il pane, metaforicamente l’ammalato. Per questo bisogna vedere nell’azione di sputare sul fuoco, proprio come nel precedente, un atto volto alla risoluzione del danno.
Il dubbio che sorge a questo punto è: chi è Santa Carunìa? Ha qualche correlazione col termine “carogna” con il quale inizia la formula rituale registrata nel comune abruzzese di Castiglione per curare il Fuoco di Sant’Antonio? Santa Carunìa, come tante altre entità, è infatti assente dal corollario religioso ufficiale e non è riscontrata come santa da nessun’altra parte, segno che il nome tramanda un’entità venerata o chiamata ormai soltanto in questi due scongiuri, generi privilegiati a mantenere vivi per secoli nomi desueti o dimenticati, a cui si associa spesso il titolo di Santo ma solo per identificarlo come essere potente.
Carunìa, tuttavia, è anche il nome di un paese e di un bosco dei Nebrodi (catena montuosa della Sicilia settentrionale), tant’è che i monti boscosi della zona sono chiamati “le Caronie”. Il nome potrebbe derivare da un termine greco con cui si indicano i luoghi che, per la presenza di esalazioni sulfuree, gassose, spelonche e anfratti, erano ricondotte a zone di passaggio per l’aldilà, abitate da demoni e spiriti. Dal latino spiritus proviene spiracula, gli “anfratti ipogei che emanano gas”, che esalano pestifera spiritus. Da questi luoghi sembra provenire il tardo latino Caronia col significato di “cadavere” e dal quale si origina l’italiano carogna; termine che, appunto, ritroviamo nell’incipit del rituale abruzzese per curare il Fuoco di Sant’Antonio.
È probabile che il nome di Caronìa sia l’epiteto informale di un demone femminile apportatore di malesseri, combattuta da scongiuri analoghi a quelli a cui si è fatto riferimento. (Per approfondimenti vedi: Mannella, 2015).
Inoltre, come il nome suggerisce, a Sant’Antonio si attribuivano le doti di spegnere il fuoco malefico, così come un tempo aveva cacciato i demoni che, secondo la tradizione popolare del comune di Ciminna, in Sicilia, gli si erano presentati in varie forme animalesche, soprattutto quella del maiale, che appariva nero sulla bara processionale perché incendiato dal fuoco del Santo. In questo modo giustificavano quelli di Ciminna l’onnipresenza del porco accanto a questo Santo e così è possibile giustificare anche l’uso della sugna di tre maiali diversi previsto dal rituale abruzzese per la cura dello stesso male.
Non è un paradosso tutto ciò solo se si considera che il Santo è sopravvenuto a una precedente entità infernale, padrona di demoni. È noto per l’antico significato di questo animale, documentato anche in Sicilia, dove accompagna divinità infere: il porcellino è un animale simbolico, se non l’animale per eccellenza, di Persefone-Demetra, raffigurata con in mano un maialino in numerose statuette provenienti da varie zone della Sicilia.
Per concludere, il legame di Sant’Antonio col fuoco è molto stretto non solo in Sicilia, se si considera che “fuoco di Sant’Antonio” è la denominazione italiana comune dell’herpes zoster; insieme all’onnipresenza della figura del maiale, riscontrabile anche in altre zone d’Italia. Infatti, i Sardi tramandano una novella che fa di questo Santo un secondo Prometeo e i Napoletani lo chiamano Sant’Antuono de lo fuoco, lo raffigurano nell’atto di castigare col fuoco un ladro e lo considerano protettore degli incendi. Analogamente all’area abruzzese, infatti, anche i Partenopei curavano le ustioni col grasso di maiale.
5.2 Erisipela (“resibla”)
La formula rituale contro il male che in dialetto abruzzese è denominato resibla, si inserisce all’interno di una categoria che Mannella definisce “categoria C”.
Gli scongiuri di categoria C interessano numerose e svariate cure per disparati malesseri ma hanno una struttura ricorrente che prescinde dal male che cura. La struttura, infatti, è sempre la stessa: essa è caratterizzata da una historiola dialogata in cui il protagonista è lo spirito-malattia che viene al mondo per fare del male agli uomini. A questo punto, il demone che procura la malattia incontra il santo risolutore, solitamente Cristo, e tra i due si crea un dialogo. In un primo momento Cristo gli chiede cosa faccia e poi lo condanna e lo caccia attraverso vari formulari.
È interessante notare, per la nostra indagine, che tutte queste parti tipiche della categoria C si rintracciano anche in antichissimi scongiuri babilonesi, come in certe lezioni dello scongiuro Marduk-Ea:”Lo spirito demone Udug sta infettando le tranquille vie, viene da un posto misterioso, sconvolgendo le strade... I demoni Dimme e Dima che spruzzano malattie interne e stenosi, infermità, mal di testa, e il demone Ala che protegge il malato, scuotevano come una tempesta l’uomo sconvolto e lo cospargevano di fiele… La vittima perdeva progressivamente la sua vitalità… non poteva più mangiare, né bere…”. Interviene così Asalluhi che va dal padre Ea a chiedere aiuto e dialoga con lui.
Come abbiamo già ricordato, negli scongiuri di categoria C il dialogo tra Cristo e il Male si attua attraverso il modulo domanda-risposta e si conclude con la condanna alla malattia da parte di Cristo tramite l’uso dell’imperativo o dell’indicativo, solitamente un’apostrophé (cioè la condanna del male tramite l’uso verbale della prima persona che si riferisce a una seconda persona esplicitata), introdotta da veri e propri comandi coercitivi.
Tuttavia, all’interno dello scongiuro abruzzese da me riportato, la condanna del male da parte di Cristo sembra mancare, o meglio, è presente solo implicitamente. La malattia, infatti, risponde e si difende dalla tacita condanna di Cristo rispondendo: “non mi uccidere, non mi gettare al mare”.
Come nel caso del “fenomeno circolare” di cui abbiamo precedentemente parlato, Mannella ricorda che, nella trasmissione degli scongiuri, gli errori di trasferimento possono essere frequenti. In particolare: “Anche se sono state individuate determinate categorie, accumunate dalla stessa struttura, lo scongiuro non si presenta sempre completo nelle sue parti, né terminologicamente corretto. Gli scongiuri sono elaborazioni a sfondo cerimoniale molto antiche: alcuni, anche se portatori di motivi ed entità cristiane, risalgono a fasi precedenti ed è notevole la variazione che possono subire di generazione in generazione. La metamorfosi di uno scongiuro è dovuta a vari motivi, ma sempre per cause inconsapevoli, giacché è regola imprescindibile che non può essere cambiato né si può sbagliare quando si recita. Questa forzatura lo rende più aderente all’originale, dato che lo scongiuratore, conoscitore del testo, se vuole che sia efficace, non può cambiarlo. Se a ciò aggiungiamo gli altri vincoli legati alla trasmissione, si nota che queste sequenze verbali sono giunte fino ad oggi accumulando “errori” singolari, diversi da tutti gli altri generi di oralità popolare. Per questi fattori e vincoli, si parla di errori che spesso tramandano una serie di espressioni ormai del tutto prive di senso. L’origine di questo non-sense non è dovuto soltanto alla materia ma rimanda al rispetto del suono e del ritmo, osservato da chi detiene questo sapere, anche a discapito di contenuto e senso” (Mannella, 2015).
Nel nostro caso, quindi, è possibile parlare di un semplice errore di trasmissione perché Mannella riporta le testimonianze di varie formule rituali contro l’erisipela, riscontrate in Abruzzo e in Molise, in cui Cristo caccia il male attraverso un esplicito riferimento al mare, cioè con l’uso dell’espressione: “vai a’ mmare!” o “buttati in mare!”
Lo stesso studioso riferisce, inoltre, che simili scongiuri sono stati raccolti anche a Valencia e in Galizia.
Per concludere, occorre sottolineare che sono noti, riguardo alla categoria C, gli scongiuri meridionali contro l’erisipela (“resibla” in dialetto abruzzese), simbolo dell’ipostasi di una malattia in un demone. Essa, infatti, era vista come uno spirito maligno che si attacca al viso o a qualunque parte del corpo. L’erisipela, in effetti, ben si presta a questa interpretazione, dato che anticamente mieteva numerose vittime, soprattutto tra anziani e bambini. È una malattia infettiva e contagiosa caratterizzata da arrossamento ed infiammazione della pelle e delle mucose. È causata dall’infezione batterica di lacerazioni, ferite e punture di insetti e, dato l’esito letale che questi arrossamenti potevano avere, ogni volta che apparivano simili escoriazioni si scongiuravano proprio perché se ne temeva lo sviluppo degenerativo, non conoscendone la cura.
5.3 Malocchio
Conosciuto fin dall’antichità nelle civiltà mediterranee, il malocchio fu il mezzo utilizzato da Medea per sconfiggere Talos, il mostro di Creta, e da Medusa, contro chi la guardava negli occhi; potere che perdurerà anche dopo la sua morte. Inoltre, Apuleio considera l’epidemia che falcia il bestiame di Democare procurata dagli occhi cattivi dell’Invidia (in-videre: guardare contro, lanciare malocchi) che “ovunque giunga schiaccia col piede i fiori, rinsecchisce le erbe, divelle le sommità dei papaveri e col suo fiato avvelena popoli, città e case”
Presente in moltissime culture antiche e tuttora diffusa, la credenza nel malocchio è l’interpretazione simbolica di un male attribuito a uno sguardo cattivo, volontario o involontario. Esso nasce dal sospetto di un pensiero malevolo trasmesso attraverso gli occhi e depositato su ciò che questi guardano, siano essi persone o beni di una persona. Subisce il malocchio la persona invidiata da parte dell’invidioso o il bene invidiato che appartiene alla vittima.
Anche lo sguardo di un demone, un mostro, un animale può ammaliare un uomo. Il malocchio può essere infatti attribuito anche a: basilisco, lupo, donnola, vipera, etc. L’incontro con uno spirito maligno, vissuto come dramma e inteso come pericolosissimo, deve essere scongiurato, così come fa il guardiano del defunto nelle Metamorfosi di Apuleio.
Oltre ai demoni animali, anche ai mostri dell’antichità poteva essere attribuito lo sguardo nefasto e distruttivo. Esemplare è l’occhio di Humbaba, il guardiano della foresta dei cedri, con tratti simili al mostro Argo dai cento occhi: come quest’ultimo, non chiude mai gli occhi e “con lo sguardo abbatte gli alberi del bosco insieme alle canne della palude”. Stesso potere hanno gli uomini Scorpione, protagonisti del poema mitologico babilonese Epopea di Gilgamesh, a custodia delle porte dei monti che separano i vivi dai morti: ”Il loro sguardo colpisce gli uomini a morte […] Quando Gilgamesh li vide si coprì gli occhi” (Epopea di Gilgamesh).
Mannella riscontra che tratti analoghi possiedono molti altri mostri e animali della fiaba popolare del sud Italia, che hanno la funzione di guardiani di tesori e di luoghi incantati; questi condividono i medesimi aspetti con molti scongiuri con cui vengono invocate le divinità, alcune volte palesi sostituzioni del dio sole o dea luna, altre volte direttamente il sole e/o la luna, perché inviino i loro spiriti messaggeri in aiuto del colpito, affinché sopraggiungano per uccidere il demone malattia.
Secondo un condiviso orizzonte di credenze, infatti, il malocchio si realizza nell’incontro tra l’invidioso e l’invidiato: il primo, attraverso il pensiero cattivo, aziona un processo mediante il potere degli occhi, favorendo un’aggressione da parte di un male che possiede lo stesso invidioso o dei demoni patogeni vaganti, direzionati da questa forza contro la vittima. In tal modo, il singolo individuo che vive una frustrazione personale, legata a un senso di abbandono, rifiuto o altro trauma della vita, è reintegrato nella normalità ammettendo l’esistenza di una causa esterna: il malocchio. Anche i mal di testa continui o altri simboli di spossatezza possono essere creduti opera del soprannaturale, attivate proprio dal malocchio.
Negli scongiuri meridionali, il male da colpire e l’azione offensiva vengono definiti in diverso modo, a seconda della zona di provenienza; uno dei più diffusi è quello letterale e, in riferimento all’area abruzzese, citeremo proprio il termine “malocc’”. In questa forma il malocchio è definito letteralmente, tuttavia Mannella riconosce che non sono rari i casi in cui questo male non sia definito così ma con termini considerati equivalenti. Tali vocaboli possono nascere non solo dallo strumento utilizzato per procurarlo, l’occhio, ma anche dal sentimento che l’ha generato: l’invidia. Esso, infatti, in Sicilia viene anche definito come malavuluntà, nvidia o picchiu.
Insieme ai modi per denominare il malocchio, anche i metodi per curarlo sono vari, ma il più diffuso, che interessa anche la zona abruzzese, si attua versando su un piatto d’acqua delle gocce d’olio e recitando un’orazione. L’atto è anche divinatorio, ha cioè una funzione diagnostica: dalle gocce d’olio, il curatore sa se è o non è in presenza del malocchio e qual è l’identità del malocchiatore.
Oltre ad una differenza di denominazione, gli scongiuro contro il malocchio abbracciano anche varie classi: quella del santo guaritore e quella del santo vittima. Quella del santo guaritore è la variante più diffusa e la stessa che è presente nell’area abruzzese. Essa è caratterizzata da un’historiola monologata in terza persona, in cui il santo guaritore è visto come venuto da un luogo lontano per trasmettere il rito di cura del suddetto male. Il protagonista è un viandante che non risulta mai affetto dal male che intende curare e sopraggiunge in qualità di taumaturgo per annientare il malocchio e istituire il rito di guarigione. Il taumaturgo è ora San Pietro, ora Nostro Signore e spesso giunge da un luogo esterno o comunque lontano. A questo proposito, è importante far riferimento all’ultima parte del XVIII libro del De Civitate Dei di Sant’Agostino, dedicata alla confutazione di alcuni versi greci di un oracolo, pronunciato da un demone venerato come un dio, in cui si dichiara che San Pietro fosse uno stregone e che avesse prolungato il tempo della religione cristiana che, nonostante le persecuzioni, la morte di Cristo e dei suoi seguaci, si ostinava a vivere ancora. Dal documento agostiniano emerge in modo chiaro che fin dagli esordi del cristianesimo, quando San Pietro era in vita, girava già voce che fosse un potente stregone. L’invocazione rituale del suo spirito e l’uso del suo nome negli scongiuri sono molto antichi. Più noto è il passo degli Atti degli Apostoli riguardo agli stregoni di Efeso, che facevano miracoli in nome di Gesù già mentre era in vita San Paolo. Ciò dimostra che Cristo e San Pietro sono evocati in cerimonie terapeutico-esorcistiche da due millenni. A loro sono riconosciuti poteri straordinari sia curativi/risolutivi, offensivi e difensivi che divinatori e appaiono in numerosi scongiuri, soprattutto medievali e in latino.
Mannella riscontra anche che San Pietro e Gesù Cristo sono protagonisti degli scongiuri contro il malocchio tanto in Abruzzo, Calabria, Sicilia quanto in Portogallo.
Tuttavia, dato che i Santi non appaiono mai insieme e si presenta esclusivamente o l’uno o l’altro, risalire all’identità prima del protagonista, se Pietro o Cristo, non è semplice. Ma ciò poco importerebbe se lo scongiuro avesse, come altri già analizzati, un’origine precristiana; sarebbe più interessante semmai in questo caso, scoprire chi sia stata l’entità sacra alla quale loro si sono sovrapposti. A questo proposito occorre far presente che, dagli studi di Mannella, emerge che stabilire una nascita cristiana di questa classe di scongiuri è in realtà impossibile ma, allo stesso modo, irrilevante ai fini dell’individuazione delle credenze che stanno alla base del rito. Infatti, a far propendere verso l’origine cristiana è il monoprotagonismo delle formule, in cui opera sempre lo stesso personaggio proveniente da un luogo specifico. Allo stesso modo, nel caso di un’origine precristiana, la sostanza non cambierebbe molto perché entrambi potrebbero significare che il protagonista proviene da molto lontano, da un luogo sconosciuto, noto solo dal nome. È come il vecchio che viene dall’India o dall’Egitto, o il santo che viene dalla Francia di altri gruppi di scongiuri: sono tutti luoghi che sarebbero potuti suonare come esotici, lontani, per certi versi misteriosi, per gli abitanti del sud Italia vissuti secoli fa. Se lo scongiuro è così antico, potrebbe risalire ad un’epoca in cui anche Roma appariva come luogo lontano. Difatti, in realtà, l’immagine offerta da tali scongiuri è quella di un taumaturgo che viene da lontano portando un ramo di palma e dell’olio per fare una fumigazione: un’immagine tipicamente pagana e precristiana.
Per concludere, nel corso delle indagini realizzate da Mannella sui riti antimalocchio, lo studioso ha individuato differenze e ricorrenze tali da definire gruppi ben precisi di varianti. In particolare, Mannella ha riscontrato che alcune delle orazioni recitate un tempo facevano parte dello stesso rito, separate da pause che lo suddividevano in più momenti. Di conseguenza, scongiuri appartenenti a categorie diverse potevano essere recitati nello stesso cerimoniale, durante i vari momenti del rito. In particolare, i quattro gruppi scongiuratori facevano capo: 1) all’historiola del benedicente; 2) ai versi dell’arcangelo Gabriele associato ai pani e ai pesci; 3) all’orazione dei tre che hanno adocchiato e tre salvato; 4) alle formule antinomiche bene-male. Questi gruppi, infatti, facevano parte del medesimo rituale che all’epoca si presentava più composito.
In merito all’area abruzzese di nostro interesse, è necessario analizzare il gruppo che tratta delle due-tre forze offensive e delle tre entità difensive che risolvono il malocchio. Come possiamo notare dalla formula da me riportata, questo è un tipo di scongiuro senza historiola, dominato dalla prima persona della curatrice che si rivolge ad una seconda persona, la quale non risponde, non parla, non partecipa. Mannella riscontra che di questo tipo di scongiuri, con due-tre forze offensive contrapposte a tre forze difensive, esistono numerose lezioni diffuse in tutta Europa. Martì I Pérez (1989: 164-165) e un secolo prima Tuchmann (1892-93: 285-287) ne hanno censite diverse, individuando la loro presenza in Grecia, Italia, Germania, Romania, varie regioni della Spagna e l’Irlanda. Infatti, la formula rituale abruzzese per curare il malocchio, che fa da esempio al gruppo legato alla numerazione, è caratterizzata da un’espressione che suona come: “un tot numero ti ha colpito, un tot numero ti ha salvato”, diffusissima tanto nel meridione italiano quanto nei paesi sopracitati. Il “tot” deriva da una diffusa varietà numerologica con la prevalenza quantitativa dei gruppi “2 adocchiano e 3 salvano” e “3 adocchiano e 3 salvano”: il primo gruppo trova logica dal fatto che gli occhi sono 2 e le figure che solitamente si invocano contro il malocchio sono le 3 figure della Trinità, spesso nominate per intero (Padre, Figlio, Spirito Santo); e dal fatto che il numero 2 infernale, offensivo, contrasta col 3 celestiale e difensivo (specificatamente, nel comune di Castiglione: “due occhi t’ha adocchiato / tre santi t’ha aiutato / nun si trova chiù bel canto / Padre, Figlio e Spirito Santo).
Il secondo motivo trova giustificazione nella logica circolare della perfetta contrapposizione numerica: 3 contro 3. Entrambe le soluzioni possibili, comunque, concordano nel considerare i taumaturghi risolutivi in numero di tre.
5.4 Santa Lucia curatrice
Nell’area abruzzese di nostro interesse, come anche in Sicilia, per curare le infiammazioni degli occhi (per esempio, la congiuntivite) si ricorre a scongiuri invocanti l’azione di Santa Lucia. Sono solitamente testi in cui avviene un dialogo tra la Santa, vittima di un male, e una figura taumaturgica. In particolare, la Santa è mostrata in un’historiola affetta da una malattia agli occhi e soccorsa dalla Madonna o da Nostro Signore, con cui interagisce tramite un dialogo.
In Sicilia Mannella riscontra che, nonostante molti degli scongiuri siano incompleti, essi sono molto simili tra loro e caratterizzati da contenuti diffusi in scongiuri medievali e anche più antichi. La Santa, infatti, si trova solitamente intesa a tessere, seduta in mezzo al mare o in camera; i consigli del taumaturgo, di solito la Madonna, indicano di recarsi nell’orto a raccogliere ingredienti (aglio, verbena, finocchio) che lo stesso ha piantato con le sue mani o calpestato coi suoi piedi.
Al contrario, nella formula cantilenata da me registrata nel comune di Castiglione, possiamo da subito segnalare due evidenti differenze: in primo luogo, la denominazione del morbo come “malaventura” (nel senso di “disgrazia, sfortuna”); in secondo luogo, la differenza riguardo i protagonisti dell’historiola. Nel rituale abruzzese, infatti, capiamo che Santa Lucia ha un dialogo con un altro personaggio ma risulta impossibile risalire alla sua identità. Inoltre, la Santa non appare nell’atto di tessere quanto, piuttosto, sembra intenta a camminare.
Riguardo all’area siciliana, Mannella rileva che Santa Lucia è presentata mentre compie un’azione femminile legata ai lavori di tessitura, che riconducono simpaticamente all’azione da compiersi sul male, come quella di tagliarlo ( la presenza delle forbici negli scongiuri e nel rito è in tal senso molto eloquente), e al contempo riconducono a figure demonologiche diffuse nel mondo antico mediterraneo: dalle tessitrici infernali, alle Moire, alle Parche. Inoltre, l’associazione tra malattie degli occhi e tessitrice non è casuale. Quello della filatura/tessitura praticato fin dall’antichità, infatti, era un tipo di lavoro che faceva deteriorare la vista a causa della cattiva illuminazione.
Se nello scongiuro abruzzese è impossibile identificare tale relazione, probabilmente a causa di errori di trasmissione e/o dimenticanze, è tuttavia importante soffermarsi sui materiali che Santa Lucia taglia e cuce: seta, oro e argento. I due metalli, rinomati per la loro durata e resistenza temporale, ricorrono negli impieghi cerimoniali, fino ad apparire esplicitati negli scongiuri curativi non soltanto siciliani. La presenza dell’argento, infatti, è da riscontrare anche nel rito abruzzese (“tull la fede d’argint”), in relazione alla fede nuziale utilizzata dalla stessa guaritrice durante il cerimoniale.
Le historiole a cui si fa riferimento appartengono alla cultura popolare del sud Italia fin dall’epoca pagana, così come i simboli e i loro significati. In quest’ottica, l’oro e l’argento si rivelano elementi sacri: con l’oro si curano varie malattie degli occhi per magia di contatto con questo elemento (in Abruzzo la congiuntivite e in Sicilia l’orzaiolo). Con l’argento, il metallo della luna, si confezionano gli ex-voto che riproducono forme di corpo e che si offrono per guarire da alcune malattie o per grazia ottenuta.
Un’altra analogia si ritrova nelle cause che possono provocare il male all’occhio, le quali possono manifestarsi in varie forme e definite con diversi nomi negli scongiuri: una cosa nell’occhio, oppure una pagliuzza (“fruscia”), una spina o una lisca, granelli di sabbia o macchie di sangue. Cause e nomi, comunque, comuni a tutto il meridione.
Per concludere, occorre soffermarsi sulla figura di Santa Lucia. In Sicilia, in Abruzzo e in altri luoghi, infatti, questa Santa ha avuto una fortuna nell’ambito della cura degli occhi che non ha paragoni con altri santi, tanto da essere diventata quasi l’unica protagonista di questi scongiuri. Tuttavia il suo legame con l’organo della vista appare “giustificato” dalla sua agiografia, che tramanda credenze precristiane e il martirio degli occhi strappati, episodio assente dalle più antiche attestazioni, quasi fosse un’aggiunta postuma, funzionale al potere taumaturgico riconosciutole. Detto ciò, l’interrogativo che si pone Mannella è: che Lucia fosse stata un tempo Lucina (la dea del parto, “colei che porta i bambini alla luce”)? Giunone, come Lucina, Fluonia, Opigena assisteva le partorienti e le erano devote le madri latine e le nuore. Questa dea acquisisce aspetti comuni alle altre grandi dee nominate, ed è ritenuta corrispettiva per ambiti, pertinenze e varie altre somiglianze. L’ipotesi di Mannella trova dunque ragion d’essere in forza del fatto che etnologi e studiosi di storia delle religioni hanno visto in Santa Lucia un continuazione del culto prestato a Lucina. Dal punto di vista fonetico, poi, Lucìa e Lucìna sono nomi quasi del tutto identici. Per di più, con specifico riferimento all’area siciliana, il culto di Santa Lucia è nato proprio a Siracusa e la Santa appare come continuatrice di dee come Artemide, anticamente molto venerata nella stessa città.
�
CAPITOLO 6
LA TEORIA DELLA CONTINUITÀ PALEOLITICA
6.1 Il “tradizionarsi” delle tradizioni
Per concludere e chiarire ancora una volta i principi che stanno alla base dell’etnofilologia, è necessario far riferimento a un’idea di cultura che, nelle parole di Duranti, si definisce come “modo di gestire la continuità della vita del gruppo di fronte alla finitezza della vita dell’individuo” Riferimento che presuppone come fondamentale il ruolo della comunicazione, importantissima “nella costruzione e nel mantenimento di qualsiasi comunità e nella gestione della vita quotidiana da parte di qualsiasi individuo” (Duranti, 2007). Essa mira a combattere la statica visione, propria della filologia classica contemporanea, della tradizione come un repertorio al quale “si attinge” o che viene di volta in volta “riattualizzato”. Da tale visione di fondo, infatti, deriva l’arbitraria suddivisione della tradizione in parti, poste tra loro in rapporti di opposizione e correlazione: tradizione “orale”, “colta”, “popolare”, “volgare”.
Al contrario, l’etnofilologia, alla quale questa mia ricerca vuole apportare un piccolo contributo, si pone come obiettivo il superamento della divisione tra cultura materiale e cultura intellettuale, arrivando a una visione unitaria in cui si riconosca che “la codificazione di entrambe è costruita secondo gli stessi criteri con cui si forma una tradizione etnolinguistica e ciò che muta è soltanto la modalità di trasmissione delle due diverse tradizioni, poiché, in genere, le tradizioni che veicolano saperi tecnico-pratici si trasmettono in prosa quotidiana e nel contatto lavorativo e individuale tra maestro e apprendista” (Costa, 2008).
Attraverso la mia ricerca, ciò che è interessante non è postulare e cercare il riaffiorare di una cultura pagana, l’affermarsi sotterraneo e frammentario di un complesso di credenze, ma verificare l’esistenza di immagini persistenti, persistenti in aspetti molteplici che si aprono continuamente al nuovo, nei conflitti tra forme sedimentate di memoria sociale e forme fluttuanti di memoria individuale. In breve, ciò che è importante è interpretare la relazione mnemonica ancora vitale tra certe immagini e certe parole, tra certe forme intese come traccia di una tradizione e le vie attraverso le quali queste immagini e queste forme sono state capaci di stabilire delle associazioni.
Al pari dell’etnolinguistica, insomma, l’etnofilologia cerca il più possibile i significati dei reperti che studia nel suo aspetto motivazionale.
In questo modo, la cultura può essere definita come un fenomeno di contagio, come lo scambio incessante cui le rappresentazioni sono sottoposte nella comunicazione quotidiana. In quest’ottica di studio della propagazione delle rappresentazioni, la concreta percezione e rappresentazione di fatti, immagini e credenze assume evidentemente un ruolo privilegiato nello studio dei processi mnemonici di confronto e di integrazione.
Per superare i termini sanciti dall’impostazione tradizionale e per tentare di collocare la discussione su un livello diverso e più complesso, è necessario partire da molto lontano, provando a integrare alcune acquisizioni della neurobiologia con quelle della paletnologia. Benozzo, infatti, fa notare che: “Se la tradizione di cui si occupano i filologi ha a che fare in primo luogo col linguaggio, è forse allora necessario tornare a riflettere proprio sul linguaggio in quanto tale: solo così si arriverà a comprendere la natura secondaria e accidentale delle lingue scritte (cioè trascritte), dei loro manufatti e dei rapporti tra questi manufatti, anche per valutare la loro importanza in modo completo e non acritico all’interno dell’evoluzione di Homo scribens” (Benozzo, 2010)
6.2 La Teoria della Continuità Paleolitica
L’unico studio di linguistica che abbia finora tentato di dimostrare, con esempi concreti, la correlazione tra sviluppo tecnologico e sviluppo linguistico nella preistoria è stato elaborato da Mario Alinei in un libro di due volumi intitolato Origini delle lingue d’Europa, di cui il primo volume è uscito nel 1996 e il secondo nel 2000 (Alinei, 1996 - 2000). Quasi contemporaneamente anche l’archeologo belga Marcel Otte aveva presentato una teoria simile (Otte 1997), alla quale ha aderito in seguito anche l’archeologo tedesco Alexander Häusler (Häusler 1998). Intorno a questa teoria, chiamata Teoria della Continuità Paleolitica, è nato un gruppo di ricerca del quale fanno parte linguisti, filologi, storici, genetisti e archeologi. Nell’affermare tale tesi, questi studiosi criticano le due principali teorie sulle origini delle lingue indoeuropee: la prima, più tradizionale, elaborata da Marija Gimbutas nel 1970, fa riferimento all’idea di una grande invasione neolitica da parte dei guerrieri kurgan; la seconda, più recente, è stata elaborata da Colin Renfrew (Archaeology and Language: the Indo-European Puzzle, 1987) e sostiene che l’inizio del Neolitico corrisponderebbe con un’invasione pacifica da parte dei primi coltivatori e il processo di diffusione dell’agricoltura coinciderebbe con il processo di diffusione delle lingue indoeuropee.
Di conseguenza, sulla base di critiche di tipo archeologico alle teorie di Gimbutas e Renfrew, gli esponenti della Teoria della Continuità Paleolitica sono stati in grado di illustrare analiticamente che gli Indoeuropei non sarebbero arrivati né dall’Ucraina come guerrieri kurgan né come coltivatori dal Medio Oriente, ma sarebbero gli eredi delle popolazioni che si trovano in Europa da sempre, cioè da quando Homo sapiens sapiens si è diffuso nei vari continenti del Vecchio Mondo, nel Paleolitico, provenendo dall’Africa.
All’interno del libro di Alinei, infatti, vengono poste in correlazione le tre macroaree preistoriche di industrie litiche ([1] Asia centrale con strumenti-ciottolo [choppers], [2] Nord Africa e Asia occidentale con i bifacciali [hand-axes], [3] Europa orientale e Asia centrale con schegge rudimentali [flake tools], insieme alla distribuzione geografica dei tre tipi fondamentali di tipologia linguistica: [1] lingue isolanti (Asia sud-orientale), [2] lingue flessive (phyla indeuropeo, cartvelico, afroasiatico), [3] lingue agglutinanti (phyla uralico, altaico, paleosiberiano)]. Questa corrispondenza genera un modello evolutivo-cronologico secondo il quale sarebbe possibile individuare quattro stadi convenzionali: 1) Homo loquens I, dagli inizi del linguaggio fino alla diaspora in Africa, con l’innovazione del bifacciale corrispondente a una lessicalizzazione di tipo flessivo; 2) Homo loquens II, culminante nel secondo balzo innovativo costituito dalle industrie di Levallois (300.000 anni fa), con una lessicalizzazione di tipo agglutinante nelle aree dove non erano arrivati i bifacciali; 3) Homo loquens III, corrispondente all’inizio degli insediamenti territoriali definitivi (dal Mesolitico fino all’inizio dell’Età dei Metalli) e caratterizzato da innovazioni linguistiche e dal raggiungimento del livello massimo di complessità sintattica; 4) Homo scribens (in Europa dall’Età del Bronzo), con l’inizio della fase linguistica attuale, dominata dalla lingua scritta.
In questo modo, la Teoria della Continuità Paleolitica riconcilia la linguistica comparata con i propri assunti evolutivi e storico-linguistici, con le acquisizioni delle ricerche più recenti della paletnologia e dell’archeologia. Essa sostiene, in sostanza, che la patria originaria degli Indeuropei sarebbe l’Africa, vale a dire la stessa di tutte le popolazioni moderne e di tutti i phyla linguistici del mondo. I più antichi insediamenti delle popolazioni indeuropee fuori dall’Africa troverebbero riscontro nei territori occupati attualmente dalle lingue indeuropee stesse: l’Europa sarebbe stata popolata, fin dalle prime datazioni indicate dalle ricerche, dagli Indeuropei insieme alle altre popolazioni non indeuropee presenti storicamente in loco (ad esempio, quelle uraliche). Il rapporto etno-linguistico preistorico tra gli Indeuropei e gli altri popoli euroasiatici sarebbe dunque una relazione di adstrato/parastrato e non di superstrato/sostrato. Infatti, dal momento che l’arrivo degli Indeuropei coinciderebbe col primo popolamento euroasiatico di Homo sapiens sapiens, il cosiddetto sostrato indo-mediterraneo non esisterebbe, come non esisterebbero popoli pre-indeuropei. Inoltre, tanto le lingue indeuropee quanto quelle non-indeuropee presenti nel territorio euroasiatico, si sarebbero già formate a partire dal Mesolitico; ogni invasione di massa nel Neolitico o nel Calcolitico sarebbe esclusa e le poche infiltrazioni locali comprovate dall’archeologia o ricostruite dalla genetica costituirebbero fattori di ibridazione e non di sostituzione.
Come possiamo notare, quindi, la Teoria della Continuità Paleolitica costringe a un radicale cambiamento della cronologia e dello scenario degli avvenimenti e obbliga a rivedere in modo altrettanto radicale la modalità dell’evoluzione linguistica nelle diverse aree linguistiche europee.
A questo punto, credo sia necessario prendere atto del fatto che, come è stato dimostrato, i dialetti recano traccia di motivazioni ben più arcaiche di quelle di molte lingue attestate anticamente in forma scritta e, in particolare, risulta evidente che le formule di guarigione che ancora oggi le guaritrici sussurrano possono essere considerate come vestigia di un uso della parola concepita al tempo stesso come strumento celebrativo, eulogistico, mantico e terapeutico. Riferendosi alla loro pratica terapeutica, infatti, è possibile parlare, seguendo la terminologia di Costa, di “tradizione etnolinguistica preistorica di tipo esoterico-iniziatico”, intendendo con questo “la trasmissione da una generazione all’altra di una somma di conoscenze articolate e strutturate connesse ad un’etnoscienza, formalizzate e trasmesse, attraverso una codificazione linguistica di tipo tassonomico” (Costa, 2007).
Mi sembra pertanto che si debba concludere che i dati etnolinguistici riportati, se coerentemente inquadrati nel Paradigma della Continuità Paleolitica, confermino di essere preziosi indizi per comprendere fenomeni di lunghissima durata altrimenti inattingibili.
�
Conclusione
Questa mia breve ricerca sul lessico e i gesti delle guaritrici tradizionali dell’Appennino abruzzese è nata con la pretesa di voler apportare un piccolo contributo a una filologia che, nell’umanesimo contemporaneo, si fa etnofilologia: cioè una scienza che, come abbiamo già affermato e riscontrato, torna alla comunità, si mette a sua disposizione e ricostruisce insieme alle persone che vi appartengono i percorsi di una tradizione.
Infatti, solo attraverso le interviste sul campo e l’analisi di alcune procedure relative al rituale vero e proprio (in questo caso messo in atto dalle medichesse tradizionali durante il processo di guarigione) è possibile riconoscere un esempio di quell’inscindibile unità di parola, gesto e memoria che caratterizza larga parte dei fenomeni appartenenti agli strati di cultura tradizionale ancora ben radicati nella nostra civiltà. Così, come conseguenza del risultato di tali indagini, le considerazioni sul rituale delle guaritrici tradizionali possono essere iscritte a pieno titolo nella visione di una “continuità sciamanica” che si riallaccia e si basa sulla Teoria della Continuità Paleolitica. Solo all’interno di questa teoria, infatti, è possibile attribuire lo sciamanismo alle culture indoeuropee e, in particolare, a ciò che Gabriele Costa ha definito proprio “sciamanismo europeo”. In seguito ad ampie ricerche, infatti, Costa conclude che “il riesame senza pregiudizi delle molte e significative testimonianze di miti e riti sciamanici nella tradizione greca, italica, celtica, germanica, iranica, indiana, anatolica, etc… consente di far emergere con chiarezza l’evidenza di una fase sciamanica preistorica originale e propria della storia etnolinguistica delle popolazioni indoeuropee, uno sciamanismo indoeuropeo le cui ultime propaggini sono ancora ben vitali nella grecità arcaica e storica” (Costa, 2008).
In breve, ciò che occorre capire è che la preistoria non dovrebbe essere concepita come passato inattingibile, ma come continuità con ciò che siamo adesso. Partendo da questo presupposto, attraverso la mia ricerca ho cercato di dimostrare, tanto a livello linguistico quanto a livello cognitivo, che la nostra civiltà non è erede di Homo sapiens sapiens, ma è sempre lei, semplicemente trasformata.
La conclusione, a questo punto, può vertere su considerazioni più ampie e, in particolar modo, sul ruolo che la filologia deve assumere nell’odierno quarto umanesimo. A seguito di queste indagini, infatti, è necessario affermare che la tradizione dovrebbe essere intesa come la forma viva e vitale di immagini stabili ma in perenne trasformazione, vale a dire “la relazione esistente, da un punto di vista mnemonico e cognitivo, tra immagini e parole che non hanno smesso di stabilire relazioni o di produrre relazioni” (Benozzo, 2010). In quest’ottica, si possono considerare anche i documenti scritti come una traccia della risonanza tra memoria e narrazione, tra immaginazione e credenza, tra determinati strumenti espressivi e i modi in cui essi “si tradizionano” in uno specifico territorio. La variabilità è dunque da cogliere a livello dell’individuo e non della specie. Di conseguenza, come afferma Benozzo: “Se si comprende che la diversità si colloca a livello degli individui e non della specie, e dunque che “il mio vicino” è diverso da me quanto lo è “il mio lontano”, può essere più facile accettare la diversità delle culture, uno dei territori di confronto fondamentali del quarto umanesimo” (ibidem).
Credo che questo tipo di considerazioni risulti utile e necessario per guardare in modo complesso alla diversità delle lingue e delle culture e per renderci conto della necessità di affidarci, nelle analisi filologiche, a metodi nei quali siano salvaguardate tanto le peculiarità degli uomini quanto quelle dei gruppi ai quali essi appartengono.
�
Ringraziamenti:
A conclusione di questo lavoro di tesi, è doveroso porre i miei più sentiti ringraziamenti alle persone che ho avuto modo di conoscere in questi anni e che mi hanno sostenuta durante tutto il mio percorso di studi, permettendomi di crescere sia dal punto di vista intellettuale che umano.
Un ringraziamento particolare va al Prof. Francesco Benozzo, per la guida competente e l’inesauribile fonte di ispirazione. La mia stima nei suoi confronti è dovuta, oltre che alla sua profonda conoscenza nel campo della filologia e dell’etnofilologia, anche alla grande umanità con la quale ha saputo incoraggiarmi durante la mia ricerca.
Un ringraziamento speciale va alla Dott.ssa Brandimarte per la pazienza, la sincerità, l’affetto e la professionalità con le quali mi ha accompagnata durante tutti i miei anni di studio.
Ringrazio l’Università di Bologna per avermi dato la possibilità di conoscere persone, amici, con cui ho condiviso i miei studi e con cui ho trascorso momenti indimenticabili, instaurando una sincera amicizia.
Ringrazio Riccardo, per l’amore e il sostegno che è riuscito a dimostrarmi quotidianamente.
Ringrazio i miei genitori, nella speranza che questo mio traguardo raggiunto sia un premio anche per loro.
�
Bibliografia
Alinei, M. (1996 - 2000). Origini delle lingue d'Europa, vol. I, La teoria della continuità, vol. II, Continuità dal Mesolitico all'età del Ferro nelle principali aree etnolinguistiche. Bologna: Il Mulino.
Alinei, M., & Benozzo, F. (2015). Dizionario etimologico-semantico della lingua italiana. Bologna: Pendragon.
Benozzo, F. (2012). Anarchia e quarto umanesimo. Bologna: Cooperativa Libraria Universitaria Editrice Bologna.
Benozzo, F. (2010). Etnofilologia. Un'introduzione. Napoli: Liguori Editore.
Benozzo, F. (2007). La tradizione smarrita. Le origini non scritte delle letterature romanze. Roma: Viella.
Cardona, G. R. (1988). Dizionario di linguistica . Roma: Armando .
Costa, G. (2008). La sirena di Archimede. Etnolinguistica comparata e tradizione preplatonica. Alessandria: Edizioni dell'Orso.
Costa, G. (2007). Pragmatica e tradizione nell'etnolinguistica. In Quaderni di semantica XXVIII (p. 203-214).
Duranti, A. (2007). Etnopragmatica. Carocci Editore.
Epopea di Gilgamesh.
Fassò, A. (2004). Verba tene, res sequantur, in P.Maninchedda (ed.), Testi e tradizioni. Le prospettive delle filologie. Atti del Seminario di Alghero (7 giugno 2003), Cagliari: Centro di Studi Filologici Sardi.
Latronico. (1956). La medicina degli antichi. Milano: Hoepli.
Mannella, P. L. (2015). Il sussurro magico. Scongiuri, malesseri e orizzonti cerimoniali in Sicilia. Palermo: Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari.
Ovidio. Metamorfosi II.
Vocabolario etimologico della lingua italiana (2004):
https://www.etimo.it/?term=incantare
31

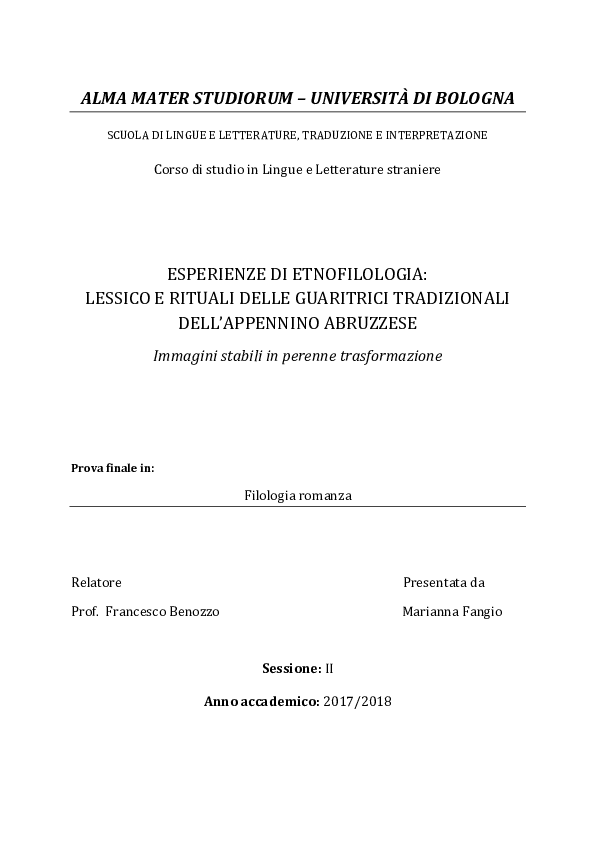
 Marianna Fangio
Marianna Fangio