Academia.edu no longer supports Internet Explorer.
To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser.
A malapena il cielo riesce ad abbracciarlo Kafka gli spazi smisurati e noialtri
A malapena il cielo riesce ad abbracciarlo Kafka gli spazi smisurati e noialtri
2023, Documenti geografici
Related Papers
As the title suggests the Brod-Kafka controversy demonstrates how difficult it is to distinguish wishful perceptions from reality-testing. The contribution investigates therefore what is here being called ways of the Vorstellung in relation to a Freudian theory of representation. In particular Vorstellungsrepräsentanz (representative of the presentation) denounces the problematic functioning of representational processes where language is involved. Dealing with ethical questions, Kafka's early production illuminates the paradox of subjectivity involved in writing. In this in-Between space (Dazwischen) language and Vorstellung (Vorstellungsrepräsentanz) are not intended to guarantee communication. This hinges upon Kafka's narrative strategies which consider living bodies as generating a dialectic of accommodation and excess not to be exhausted by ideas and schematas. Kafka's early prose Description of A Struggle as well as the strange devices he conceives while lying in bed, at rest or sleepless illustrate the point. In terms borrowed from Lacans' Seminar VII Kafka's answers along with the prose of this period denounce the limits and the deceptive origin of apperception as related to consciousness and the ego. The aesthetical dimension, intertwined with the psychogenesis of the body proper, leads to unprecedented ethical challenges. Representation does not only mediate the knowledge we consume (" ästhetische Freude " – " Apperception "), it also affects knowledge so that we assume with Kafka that representation constructs knowledge. This is also why the Bionian grid as filtering transformational device is compared to Kafka's description of himself as a lattice-workman , a trellis. The will we are willing to investigate and cope with in Kafka's semi-oneiric productions is a poetic will defying figuration. Emerging by means of stylistic and rhetorical strategies this will disconfirms any systematized mental connection aimed at classifying, explaining, understanding. The idea of Vorstellung Kafka maintains challenges our assumptions; it shows how the external world, which is generally understood as the mediation of the perceptual, is overdetermined by our emotions, unconscious desires, affections. KEYWORDS: Unconscious representation as unavailable vs apperception; “in-Between” space; the grid (Bion); “having enough of something”; pleasure principle vs aestethic enjoyment; writing process as working through of experience vs deceptive representational mechanisms Es gibt im gleichen Menschen Erkenntnisse, die bei völliger Verschiedenheit doch das gleiche Objekt haben, so daß wieder nur auf verschiedene Subjekte im gleichen Menschen rückgeschlossen werden kann Franz Kafka 1 1 «Si danno nello stesso uomo conoscimenti che, nella più compiuta dissimiglianza, hanno pur sempre l'identico oggetto sicché si può solo risalire alla presenza di diversi soggetti nel medesimo essere umano» (F. Kafka, Kritische Ausgabe. Nachgelassene Schriften und
Atti del convegno "Viaggi, itinerari, flussi umani" (Ed. Nuova cultura)
Almeno un «aldilà topografico»: Gadda legge Baudelaire2014 •
Threshold of Voices and the “Incréable”. The Work of the Negative in Kafka and Beckett. The paper proposes a comparative analysis of the question of limit in its connections with the work of the Negative (Le Travail du négatif, A. Green) in two great proses of the 20th Century: Samuel Beckett’s Company (1980) and Franz Kafka’s Der Bau (The Burrow, 1923/24). The contribution articulates in two main moments: within the specificity of a psychoanalytical approach, I reconsider the problem of the Work of the Negative in literature, discussing how, in Kafka’s and Beckett’s works, the Negative represents a radical alterity to a philosophical perspective. In a second moment of the paper, I analyse the complexity of the representational strategy of the limit in Kafka’s and Beckett’s writings, investigating thus the question of subjectivity and the relationship with an Otherness through the writing, the question of memory, its construction processes by means of writing, the work of mourning, and the development of poetics of irreducibility and unrepresentability towards an ethics of literature.
2013 •
Alessandro Anselmi Frammenti di futuro
Elogio al vuoto: uno spazio costruito al negativo2013 •
ll Vuoto ha rappresentato per Alessandro Anselmi uno strumento fondamentale per comporre le proprie architetture. Si è trattato di quell'elemento capace di unire, là dove sembrerebbe impossibile, al fine di creare una tensione, da lui tanto attesa.
2017 •
Literatura Italiana Traduzida
Rappresentazioni letterarie degli spazi smagliati del deserto: un linguaggio possibile. Absolutely nothing, di Giorgio Vasta, por Viviana VenerusoRappresentazioni letterarie degli spazi smagliati del deserto: un Absolutely nothing[1] è il resoconto dell’esperienza di attraversamento dei “deserti americani” da parte di tre compagni di viaggio, il cui ricordo è ripercorso à rebours a distanza di alcuni anni dalle sensibilità diversissime dei tre partiti insieme. A intraprendere l’avventura e stilare poi questo reportage sono lo scrittore Giorgio Vasta, Ramak Fazel (l’occhio fotografico che incastona immagini parlanti nel racconto), e Silva, fotografa e editor milanese, che si è occupata di mappare un itinerario preliminare del viaggio.
RELATED PAPERS
2018 •
Archives of Ophthalmology
Age-Related Loss of Morphologic Responses to Pilocarpine in Rhesus Monkey Ciliary Muscle1988 •
Estudios atacameños
El Reverso Del Bienestar. La Creación Del Departamento De Bienestar Social y El Reforzamiento Del Control Social en El Norte Grande a Principios De Los Años 202016 •
2015 •
Jurnal Pendidikan Bahasa
Miskonsepsi Guru pada Pemahaman Materi Bahasa Indonesia Pokok Bahasan KalimatGender a výzkum / Gender and Research
Patterns of Social Embeddedness in Later Adulthood: Gender and Other Covariates2021 •
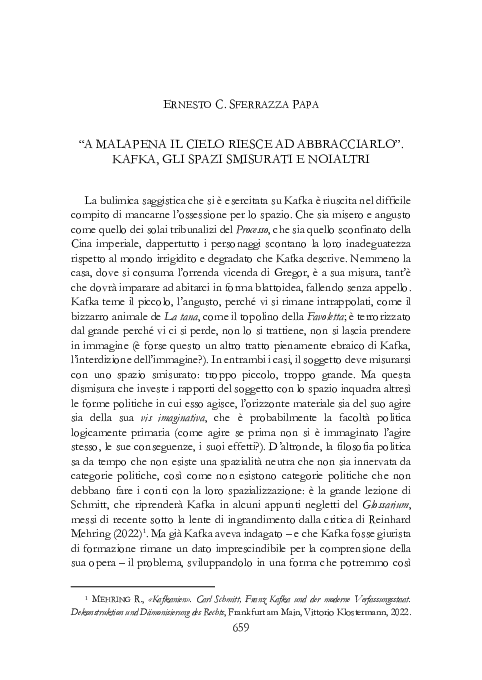
 Ernesto Calogero Sferrazza Papa
Ernesto Calogero Sferrazza Papa