Emanuele Zinato
Dipartimento di Italianistica Università di Padova
Fra narrativa e saggismo: un patto tra le generazioni
I. I fenomeni di ibridazione e di contaminazione tra generi sono argomenti a cui molti studiosi
hanno fatto riferimento per definire i tratti specifici della letteratura postmoderna, sia segnalando il
ricorso al cosiddetto double coding sia insistendo su relazioni che Genette direbbe palinsestuali (le
retoriche della citazione, dell’allusione, del pastiche e della parodia)1. Non si può negare, tuttavia,
che la contaminazione tra romanzo, autobiografia e saggio sia stata una delle strategie discorsive
più rilevanti del Modernismo. Il Novecento intero è stato descritto infatti come “secolo della
saggistica” e al contempo come il secolo che accentua una tendenza al “rimescolamento, la fusione,
la riformulazione dei generi letterari” (Berardinelli, 2002, 90). In Thomas Mann, in Robert Musil e
in Alfred Döblin, vale a dire i maggiori narratori-saggisti primonovecenteschi europei, il discorso
filosofico s’incorpora nella struttura stessa della finzione letteraria. Qualcosa di simile accade nel
Pirandello romanziere: la somma delle considerazioni argomentative finisce per sortire nel lettore lo
stesso effetto risultante dai sovrabbondanti dettagli nei testi di Proust, di Joyce o di Faulkner, con la
sensazione che non vi sia affatto plot, che nella narrazione accada ben poco.
Analogamente, nel Novecento italiano, nella generazione nata negli anni Venti (che qui
chiamerò “generazione dei Padri”, con forte riferimento alla questione dell’eredità culturale) sono
universalmente considerati narratori-saggisti Leonardo Sciascia e Italo Calvino per i loro romanzi
brevi, ibridi di narratività e di riflessione-argomentazione, come ad esempio La giornata d’uno
scrutatore (1963) o Il cavaliere e la morte (1988).
Il Calvino anteriore alla svolta combinatoria, autore de La speculazione edilizia, de La nuvola di
smog e, appunto, de La giornata d’uno scrutatore, è incline al realismo speculativo e ai riferimenti
immediati alla mutazione del miracolo economico italiano. Si tratta di un saggismo mascherato, in
cui il ragionamento rallenta il plot e contrae le coordinate spazio-temporali. Calvino stesso, in una
lettera a Mario Boselli (in “Nuova corrente”, IX, 32-33, 1964, pp. 102-106), scrisse che dentro La
nuvola di smog
1
Cfr. AA.VV., Generi letterari. Ibridismo e contaminazione, a cura di A. Sportelli, Roma-Bari: Laterza, 2001 e M.-H.
Boblet, Le roman dialogué après 1950. Poétique de l’hybridité, Paris: Champion, 2003.
1
�c’è nascosto un saggio, ma tutto cancellato, e ne restano solo rimasugli smozzicati, e anche i dialoghi
contenutistici – che potevano magari essere dei dialoghi filosofici – sono stati cancellati e se ne legge soltanto
qualche ombra di parola sotto i fregacci della gomma.
La dimensione saggistica, autobiografica e congetturale è rimasta pressoché intatta ne La
giornata d’uno scrutatore, il romanzo breve del 1963 che chiama in causa il fondamento stesso
della democrazia (il suffragio universale) ‘scrutato’, cioè osservato e straniato, da una condizionelimite (il seggio elettorale situato nel Cottolengo, casa di cura torinese che ospita deformi e
minorati). Veicoli stilistici del saggismo in questo testo sono il predominio della parentesi, come
segno esibito di cautela, di complicazione o di difficoltà a interpretare una realtà complessa, e le
frequenti digressioni, spesso dubitative. La nota in appendice del testo invita inoltre il lettore a
considerare l’opera sia come una “finzione” che permette di meditare sulla condizione umana, che
come una “testimonianza” autobiografica (l’autore fu davvero scrutatore in quel seggio torinese in
due tornate elettorali, nel 1953 e nel 1961).
Considerazioni del tutto analoghe si possono fare a proposito de Il cavaliere e la morte (1988),
opera terminale di Sciascia: un romanzo breve che congiunge narrazione trasfigurante (lo schema
del giallo), dati autobiografici (il cancro, l’esperienza del dolore fisico) e saggismo sia politico che
esistenziale (l’apologo politico sulla violenza terroristica strumentalizzata dai media, l’itinerario
della mente verso la morte, l’ars moriendi). Dal punto di vista dei generi letterari, l’Autore volle
rubricare questo suo ultimo testo come “sotie”, come fecero Gide con i Sotterranei del Vaticano e
Kundera con Lo scherzo: scherzo o satira allegorica, dunque, in forma di dialogo, che mette in
scena e sottopone al vaglio critico un mondo stupido e folle. Qui è al centro, come ne La giornata di
Calvino, un’acuminata e divagante meditazione sui limiti oscuri della biologia umana. La costante
del breve romanzo è infatti la digressione: la vicenda criminale è ridotta al minimo e continuamente
interrotta dalle meditazioni del protagonista, vero e proprio portavoce dell’autore. Il romanzo giallo
diventa in tal modo l’involucro di un romanzo-saggio testamentario e terminale, il pretesto per
formulare un congedo vigile e virile dal mondo.
Il romanzo dell’intero Novecento, insomma, si è compromesso a fondo con il saggismo e con
l’autobiografia, al punto che Proust potrebbe essere considerato più un erede di Montaigne che di
Balzac2. Non a caso, Giacomo Debenedetti parlerà proprio di Proust come di uno scrittore “il quale,
per osservare un personaggio, [...] se lo avvicina nella maniera più sicura: che era quella di
portarselo a vivere dentro di sé: di iniettarselo, di inocularselo quasi dentro il sangue” (Debenedetti,
242). Per restare alla “generazione dei Padri”, lo scrittore italiano del secondo Novecento forse più
2
Cfr. A. Berardinelli, La forma del saggio e le sue dimensioni, in Il saggio. Forme e funzioni di un genere letterario, a
c. di G. Cantarutti, L. Avellini e S. Albertazzi, Bologna: Il Mulino, 2007, p. 37.
2
�consanguineo a queste inclusioni ed estroflessioni è Paolo Volponi. Gerolamo Aspri e Bruto
Saraccini, protagonisti di Corporale (1974) e de Le mosche del capitale (1989), sono e non sono il
proprio autore, rappresentano insieme qualcosa di vissuto e di inventato. Da Memoriale a
Corporale, Volponi ha infatti sottoposto a una dura verifica finzionale il proprio lavoro industriale:
come per Ettore Schmitz, manager della ditta Veneziani, anche per il narratore-dirigente olivettiano
il rapporto fra scrittura e organizzazione produttiva sembra implicare ribellioni, scissioni e conflitti.
Volponi, a differenza di Calvino, di Pasolini e di Sciascia, non ha la vocazione del grande saggista.
La forma delle Mosche sembra tuttavia quella dello sdoppiamento fra piano della riflessione e piano
della rappresentazione. I temi saggistici di cui il libro si sostanzia sono allo stesso tempo oggetto di
mimesi letteraria e argomento di discussione saggistica fra i personaggi del romanzo: a esempio,
attraverso il coro grottesco degli oggetti industriali e, soprattutto, attraverso i dialoghi tra i ficus e il
terminale e tra la luna e il calcolatore, vere e proprie operette morali, autonomamente concepite e
montate nel tessuto del romanzo.
Infine, saggismo e autobiografia si incrociano nei testi di un altro grande scrittore, anch’egli nato
negli anni Venti: Luigi Meneghello. Nei suoi due esplosivi ibridi d’inizio degli anni Sessanta,
Libera nos a malo e Piccoli maestri, diario, autobiografia e finzione sono veicoli di un recupero
linguistico, consapevole e distanziante, comico ma non parodico, delle radici italiane premoderne e
per una narrazione non retorica della guerra civile in Italia: in entrambi i testi, infatti, un narratore
osserva se stesso agire entro le vicende di un mondo ormai lontano e trae schegge ironiche e
scintille argomentative e cognitive dalla dialettica tra culture opposte.
II. Veniamo ora alla “generazione dei Figli” e alle nuove condizioni in cui si svolge il confronto
fra scritture di finzione e saggismo nel periodo che va dagli anni Novanta a oggi. Innanzitutto
occorre precisare che, a fine secolo, più delle pratiche stilistiche autoriali, è soprattutto il mercato a
ridisegnare il sistema dei generi. Il best seller, ad esempio, diviene un transgenere che ingloba la
categoria merceologica di novità e la affianca a quella del libro “già venduto” prima ancora di
invadere il mercato editoriale. Al medesimo principio di packaging editoriale risponde la tendenza,
dominante dagli anni Novanta nel linguaggio della produzione libraria, a ripartire tutte le opere in
due super-generi: fiction e non-fiction. L’industria internazionale del libro smista i prodotti in questi
due “grandi scatoloni” con un’operazione semplificante, e non innocente, che estirpa dal concetto di
letteratura l’ibridazione tra immaginazione e reportage, la confusione tra invenzione e
argomentazione, l’andirivieni tra visionarietà e autocoscienza, vale a dire gli elementi “saggistici”
costitutivi sia del romanzo che della lirica moderna. La letteratura è inclusa in tal modo
3
�nell’onnicomprensivo campo della fiction, così vasto da comprendere anche i maggiori processi
economici in atto: con il termine fiction economy si intende infatti, il consumo di immagini e
l’allargamento della legge del valore a tutti gli aspetti del simbolico e dell’immaginario3. La
saggistica è inclusa viceversa nel settore della non-fiction. Gli ingredienti che la formula best seller
garantisce all’utente fin dal paratesto sono la sicura, accattivante consumabilità delle storie
raccontate, nella fiction; la capacità cordiale, morbida e seduttiva di passare tra le diverse discipline
senza suscitare imbarazzo o senso di inferiorità, nella non-fiction4.
Da qualche anno, tuttavia, secondo alcuni critici, in Italia, come in molti altri Paesi
dell’Occidente, stiamo assistendo a uno spostamento rispetto al campo figurale del
postmodernismo5. La costante che caratterizza questo recente fenomeno è la caduta
dell’opposizione tra fiction e non-fiction: il romanzo costeggia il diario o il reportage, tra
documentazione e denuncia, e la scrittura si presenta come testimonianza veridica, recuperando i
modi dell’autobiografia. A testimoniare su larga scala la svolta in corso, come è noto, è stato
soprattutto il best seller di Roberto Saviano Gomorra (2007), evento letterario clamoroso non solo
per il successo di vendite ma anche perché ha suscitato alla sua uscita una vera e propria contesa
categoriale: il libro si sbarazza della gabbia della fiction fondendo invenzione, testimonianza e
inchiesta. Se è stato descritto con lucidità come il fenomeno sia sostanzialmente oppositivo, per non
dire antagonistico, nei confronti dell’omologazione libraria imposta dal consumo delle immagini6,
non è stato notato viceversa che questa nuova resistenza alla forcella finzione-non-finzione avviene
soprattutto nel segno del dialogo con la generazione precedente, da cui si recupera l’autocoscienza
“in situazione” e la centralità strategica della forma saggistica: non a caso, il Pasolini “corsaro” è
per Saviano, un antecedente cui rifarsi. Ma forse, ancor più, Sciascia, con le sue forme miste di
storia e d’invenzione, costituisce un modello per un testo come Gomorra, in cui l’immaginazione
sembra aver sempre bisogno di un supporto “oggettivo” di tipo documentario che garantisca della
sua attendibilità. In una pagina di Nero su nero (1979) Sciascia affermava infatti che la letteratura
“è la più assoluta forma che la verità possa assumere”7.
Il dialogo con i “Padri” (non un omaggio citazionistico e intertestuale, ma una sofferta
assunzione di eredità) è percepito insomma da alcuni scrittori odierni come il principale antidoto
all’anestetizzazione mediatica e mercantile della scrittura letteraria: il fenomeno è presente non solo
3
Cfr. F. Carmagnola, Il consumo delle immagini. Estetica e beni simbolici nella fiction economy, Milano: Mondadori,
2006.
4
Cfr. A. Rollo I sudditi del best seller d’importazione in Tirature ’01, Milano: Il Saggiatore, 2001, pp. 96-104.
5
Cfr. G. Simonetti, Sul romanzo italiano oggi. Nuclei tematici e costanti figurali, in “Contemporanea”, 4 , 2006, pp.
55-81.
6
Cfr. C. Benedetti, Gomorra di Alberto Saviano, in “Allegoria”, n. 57, 2008, p. 173.
7
Cfr. L. Sciascia, Nero su nero, in Opere, Milano: Bompiani, 2001, 3 voll., II, p. 834.
4
�in Saviano ma anche, ad esempio, in Siti, in Affinati e nel meno noto ma assai rilevante caso di
Luigi Di Ruscio. La finta autobiografia ad elevato tasso di cinismo cognitivo di Walter Siti, infatti,
dialoga a distanza con le strategie di scrittura “celiniane” di Pasolini e di Volponi (Corporale e
Petrolio, soprattutto), la saggistica lirica ad alta tensione etica di Eraldo Affinati, ripropone la
situazione della scrittura testimoniale di Primo Levi, l’autobiografismo linguisticamente straniante
dell’espatriato Luigi Di Ruscio si pone sulla medesima lunghezza d’onda dei libri di Meneghello.
La trilogia di Siti, composta da Scuola di nudo (1994), Un dolore normale (1999) e Troppi
paradisi (2006) è, come si sa, un’autobiografia fittizia. Mentre Affinati subordina la fiction alla
non-fiction, nel senso che proclama l’autenticità etico-morale dell’esperienza, Siti enfatizza la non
veridicità dell’autobiografia. Poiché il “realismo” di tipo classico-ottocentesco è stato colonizzato
dalla produzione televisiva, che si è assunta il compito di proporre il grado-zero del realismo (il
reality), a Siti sembra necessario costruire finte confessioni, in modo da generare cortocircuiti circa
lo statuto di verità di quanto viene narrato e poter veicolare, in forme occulte, il cuore della sua
ricerca narrativa: la tragedia del desiderio umano nel nostro presente spettacolarizzato. In Scuola di
nudo le digressioni crudeli del sosia intendono soprattutto difendere il Desiderio (qui esemplato dal
nudo maschile) inteso come un’allegoria del desiderio di ciascuno di riconoscimento da parte degli
altri.
In Troppi paradisi la finzione autobiografica è più marcatamente esibita ed è conseguente al
grado estremo raggiunto dal processo di omologazione. La fittizia autobiografia, proprio perché
palese, si tramuta così in romanzo-saggio capace di fare i conti con l’incidenza della televisione
nella vita quotidiana degli italiani:
Mai, nella storia, gli esseri umani sono stati esposti così a lungo all’indistinzione tra ideale e reale: una mimesi
avvolgente, che viene a trovarti lei anziché esser tu costretto ad andare in biblioteca o al museo. Mai la gente
ha tanto parlato nei bar e nelle file per la posta, di fiction (127).
L’autofinzione di Siti, insomma, manifesta, in forme paradossali, un latente, perfino tragico
bisogno di ripristinare in tempi avversi la civile conversazione, il pensiero critico, il rifiuto dei
dogmi. Questa pulsione saggistica è resa esplicita, dopo la trilogia, dal trionfo dell’inchiesta sul
campo e del reportage: Siti decide di verificare e discutere i dati concreti della mutazione in una
borgata-tipo ne Il contagio (2008) e nella Disneyland degli emirati arabi ne Il canto del diavolo
(2009). La paternità della saggistica pasoliniana riemerge così con la forza rivelatrice d’una
negazione. Il novel contemporaneo, per raggiungere una forma qualsiasi di realismo sembra dover
affrontare in anteprima le condizioni tratteggiate in eccesso dalla scrittura autobiografico-saggistica
di Siti, le medesime messe a fuoco da Slavoj Žižek nel suo Benvenuti nel deserto del reale (2001):
5
�le scritture ibride di vero e invenzione, riflessione e finzione, costituiscono un campo di forze in
tensione rispetto all’indistinzione di virtuale e di accaduto, urtano la trasformazione di fiction in
faction, rimettono in circolo gli aspetti conturbanti del reale, fanno i conti di nuovo col vuoto e col
tragico.
III. Eraldo Affinati anziché fondarsi come Siti sulla constatazione cinica della rimozione
postmoderna del tragico, concentra tutte le sue risorse, come in Veglia d’armi (1992) dice l’Autore
stesso di Tolstoj, in una “lotta per combattere il nulla che ci assedia”. I libri di Affinati sono
pseudo-romanzeschi: si tratta in realtà di una scrittura divisa fra vocazione lirica e saggismo. Il suo
vero capolavoro è Campo del sangue (1997), un saggio-diario narrativizzato incentrato
sull’interpretazione etica dei destini umani. È la narrazione autobiografica di un pellegrinaggio, che
recupera il genere medievale dell’itinerarium mentis, da Venezia verso Auschwitz: il viandantescrittore, rallentando il proprio viaggio, non vuole banalmente commemorare quanto piuttosto
creare cortocircuiti e epifanie fra storia privata e storia del Novecento8. In Affinati è dunque al
centro il tema della memoria ma, in lui come in Primo Levi, i processi memoriali sono sempre di
natura pluripersonale: se la ricostruzione proustiana del passato origina da un’epifania del tutto
privata, per Affinati, come anche per Sebald, la memoria, anche quella privata, passa invece
attraverso un confronto intersoggettivo. È il dialogo con persone o con oggetti-testimoni, di cui il
narratore è custode, che rivivifica i cortocircuiti memoriali, non il ripiegamento narcisistico del
soggetto su di sé. La resurrezione del passato, anche individuale, è sempre legata a una comunità
memoriale.
Anche ne La città dei ragazzi (2008) Affinati si pone alcuni tra i massimi problemi del presente:
l’incontro coi migranti, la responsabilità dialogica dell’insegnamento, il problema dell’eredità
culturale e della paternità. Affinati, può attingere alla sua privata memoria solo controcorrente,
incontrando gli altri, resuscitando la figura del padre mediante un viaggio in Marocco coi suoi
allievi immigrati. La città dei ragazzi è incentrata sulla scomposizione e sul montaggio di tre
percorsi paralleli. A dare il titolo al libro è “la città dei ragazzi di Roma”, fondata nel 1953 dal
sacerdote irlandese Carrol-Abbing: una comunità basata sul principio dell’autogoverno e nata per
provvedere all’educazione di ragazzi esposti a rischi di devianza. La Fondazione un tempo ospitava
i giovani emarginati italiani, ora invece accoglie quasi esclusivamente migranti.
8
Cfr. A. Casadei, Stile e tradizione nel romanzo italiano contemporaneo, Bologna: Il Mulino, 2007, p. 217.
6
�Affinati insegna in questa comunità e può disporre in vitro dei materiali di un piccolo laboratorio
sociale: il libro indaga le vite dei suoi allievi in dialogo e in conflitto con la sua funzione di docente,
con l’istituzione che li ospita, con la cultura di provenienza e con quella di arrivo. L’autore utilizza
anche, montate nel corpo del testo, alcune delle loro scritture: inserti di italiano stentato così come
può essere quello di un parlante afghano o africano che intercetta i nostri gerghi e dialetti ben prima
delle strutture della lingua ufficiale. Nel testo compare inoltre, a intervalli, il taccuino del viaggio in
Marocco dell’insegnante con due dei suoi ragazzi, Omar e Faris, alla scoperta delle loro radici.
Infine, La città dei ragazzi propone un viaggio mentale, à rebour, anch’esso intermittente, per
riconoscere l’infanzia e l’adolescenza dello stesso docente, restituire dignità alla figura paterna e
stabilire un dialogo tra generazioni.
Affinati insomma è forse l’autore della generazione dei Figli che più di ogni altro si è posto il
problema dell’eredità culturale. Uno dei modelli de La città dei ragazzi è la Lettera a una
professoressa (1967) di don Lorenzo Milani, il saggio scritto con gli alunni della Scuola di
Barbiana, che, coi metodi dell’inchiesta sociale e della verifica dei linguaggi, ha sottoposto quattro
decenni or sono alla dura critica del radicalismo evangelico il nostro sistema educativo. Per don
Milani, la più grave ingiustizia in una società divisa tra poveri e ricchi era di ordine culturale: in un
borgo appenninico, i bocciati erano quasi esclusivamente i figli dei contadini.
Affinati cita esplicitamente don Milani (a p. 79 ) e ne condivide le premesse di tipo evangelico:
l’analisi di don Milani era però severissima, rivendicando una reale uguaglianza di possibilità e di
prospettive economiche per la maggioranza dei ragazzi condannata alla subordinazione culturale e a
uno stentato alfabetismo. I bocciati di Barbiana ponevano questioni universali in forma polemica e
eversiva: “primo, tutti sono adatti a tutte le materie”; “secondo, il problema degli altri è uguale al
mio. Sortirne tutti insieme è la politica. Sortirne da soli è l’avarizia.” Al posto di Omar e Tarif, uniti
dallo stesso destino di migranti verso l’eldorado dei consumi, c’erano Gianni e Pierino del Dottore,
irrimediabilmente divisi. Il destino di Gianni era segnato dalla sua nascita, dalle condizioni
famigliari di miseria che lo predisponevano al disinteresse verso una scuola progettata per Pierino e
che funzionava per riprodurre la distinzione fra incolti e colti, fra subalterni e classe dirigente.
Il dialogo col modello “paterno” è dunque contraddittorio: don Milani insegnava ai suoi allievi
soprattutto a non fidarsi della classe dirigente, Affinati aiuta invece i suoi scolari a guadagnare
millecinquecento euro al mese come baristi o cuochi, a non morire, a non diventare homeless. Il
radicalismo di don Milani prefigurò la contestazione del Sessantotto e influenzò la saggistica di
Franco Fortini e quella di Pasolini sui grandi temi dell’educazione, della colonizzazione culturale e
dell’omologazione. Per Affinati invece è fortissima, più che la critica sociale, l’etica della
7
�responsabilità, nella certezza che “non ci si salva da soli”: ciò si desume dalla fitta serie degli
aforismi, degli accostamenti analogici, degli interrogativi, vere spie stilistiche di una richiesta di
senso e del costante cortocircuito saggistico e poetico fra occasioni private e destini collettivi, tra
passato e presente.
L’acqua contaminata entra nelle case. L’aria è mefitica. I camion depositano le immondizie senza sosta,
perfino a tarda sera. La gente mangia, beve, vive nei rifiuti. Mi sorprendo a considerare le fattezze degli
abitanti: collo, naso, gambe, braccia, come se volessi sincerarmi della loro natura umana. Sono arrivato alla
sorgente? È questo il punto di partenza che cercavo? La fossa biologica dove tutti torneremo? (196).
IV. Luigi Di Ruscio, nato nel 1930, ha fatto a tempo ad avere, per le sue prime raccolte di versi,
le prefazioni di Fortini e di Quasimodo prima di trasferirsi, negli anni Cinquanta, in Norvegia come
operaio metalmeccanico. Si tratta quindi di un autore collocabile più nella generazione paterna che
in quella dei Figli. Tuttavia le sue prose, da Palmiro (1986, con prefazione di Antonio Porta) in poi,
risultano assai interessanti per l’odierna questione delle ibridazioni tra generi. L’ultimo Cristi
polverizzati (2009) è il memoriale narrativizzato di un emigrato marchigiano a Oslo: qui il lettore
non è chiamato a condividere una fiction ma una condizione comune all’intero genere umano. Chi
dice “io”, con le sue trovate linguistiche scoppiettanti e i suoi gioiosi paradossi, sembra voler
sfuggire a una stretta mortale, non sa e non vuole abituarsi a morire. La voce rimembrante, infatti, è
quella d’uno Charlot in delirio euforico tra i denti degli ingranaggi.
Amavo i sonetti del Belli, il momento in cui il riso è straziante, da Cervantes a Chaplin (62). Cammino con la
massima indifferenza su un tutto pronto ad esplodere […] guardo paralizzato e terrorizzato mentre il
sottoscritto tra gli orrori del mondo, inconsapevole com’è, sorride e fischietta (194).
Non si tratta di ciò che oggi comunemente si dice un “romanzo” ma piuttosto della vicenda di
una fissazione: nel senso che la scrittura vortica su se stessa e le libere associazioni non varcano
quasi mai il perimetro stretto degli anni Cinquanta italiani. La struttura del libro è circolare: il
cogitare memoriale si apre sullo shock del parto, dell’essere gettati nel mondo (“Parto difficilissimo,
spesso si nasce venendo stritolati”, “la poesia retrocede verso la prima angoscia”, 1) e si chiude con
la rappresentazione di un varco sbarrato e stritolante (“varco le soglie del mondo ed è come se fossi
in un campo minato”, 195). La situazione di chi scrive è quella di chi, espatriato e chiuso in un
remoto rifugio domestico, batte cocciutamente sui tasti prima di una vecchia Olivetti poi di una
tastiera di computer, per riportare in vita il se stesso infante e adolescente, con lo scopo di
resuscitare gli anni dal 1945 al 1957 e un luogo marchigiano preciso, Fermo, in cui tutto ciò che
doveva compiersi si è compiuto. Cristo, preannunciato dal titolo, assolve a una duplice funzione: è
emblema di un corpo straziato ed è anche stralunata figura di una resurrezione metacronica. Il titolo
rimanda inoltre, nello specifico, all’ingresso in scena di un personaggio dell’Italia precedente il
8
�“miracolo” e la mutazione: un crocefissaro meridionale, detto il Moscatritata, che transita con il
treno Lecce-Milano per vendere porta a porta nelle metropoli del Nord i suoi cristi finto-antichi “in
gesso e anche polverizzati in bronzo” (137).
La scrittura si muove a spirale, passando e ripassando per i medesimi punti. I ricordi più remoti
riguardano l’educazione scolastica e quella cattolica. Nel bel mezzo degli “splendori fascisti e
imperiali” lo scolaro Luigino osa scrivere un tema sul parto mostruoso di una gatta che, “dopo
averli cacati”, divora i figli “come fossero teste di pesce” (5). Il maestro fascista s’infuria e il tema
viene “mitragliato di segni rossi e azzurri” (17). Con l’apologo della gatta divoratrice, il piccolo Di
Ruscio narrava già allora, sfidando il maestro, una vicenda materiale di produzione e distruzione
universale ben nota alla coscienza popolare ma ignorata e svalutata dalla cultura ufficiale. Per il
maestro del regime, quei ragazzi “sbandati” sono invece “uno sbaglio, una presenza di mala natura”
(6) da colpire con una lunga canna di bambù, senza nemmeno alzarsi dalla cattedra. Accanto alla
retorica scolastica, in Cristi polverizzati, esattamente come in Libera nos a Malo di Meneghello
(anch’esso un espatriato, capace di uno sguardo straniante sulla provincia italiana), l’altro veicolo di
acculturazione e dominio è rappresentato dalla Chiesa, che penetra nelle case contadine e
nell’inconscio collettivo. Come accade per tutti i simboli dell’inconscio, anche Iddio nell’esperienza
profonda dell’infanzia, si sdoppia nel “dio tenebroso della vendetta, macabro giudice che contava
tutte le masturbazioni” (10) e nell’“iddio gioioso”, abitatore dell’azzurro, capace di “scomparire nel
magnifico nulla, nel ventre da cui è sorto” (19). La religione è in tal modo esperienza che suscita
pulsioni ambivalenti, sempre divise tra l’irrisione del potere dei papi e delle gerarchie e il
sentimento panteistico di un cosmo naturalmente poetico. Perfino il momento supremo della
comunione, sbirciato dalla privilegiata postazione del chierichetto, si può così tramutare in una festa
della carne, scoppiettante di santità materiale e di intuizioni erotiche.
Ecco i sessi nei loro umidori, sorrisi, languori, arrossamenti e ci fu quella volta che improvvisamente cadde
dalle mani del prete la particola sacra, ecco Cristo con tutta la sua carne e il suo sangue è per terra, il prete
allarga le braccia come un santo sbalordito. Da chierichetto mi riguardavo tutte quelle bocchette aperte con le
graziose linguette rosse delle ragazzette dove il sacerdote posava delicatamente la particola, la linguetta stretta
e prensile che si ritirava velocissima e la bocchetta si rinserrava leggermente indispettita (27).
Cristi polverizzati è un prezioso referto clinico e diagnostico sullo stato dell’inconscio collettivo
degli italiani, sedimentatosi proprio in quegli anni Cinquanta e oggi pressoché inattingibile perché
rimosso e oscurato dalle successive ondate modernizzatrici: gli anni Sessanta, il “miracolo”
industriale, i Settanta e gli Ottanta, tra contestazione e avvio del postmodernismo nostrano, il
presente, preda del partito-azienda. La sua lettura produce lo stesso effetto di autoriconoscimento un
po’ perturbante che si prova talvolta davanti allo specchio. Solo Di Ruscio, espatriato precocemente
a Oslo, può oggi rimemorare senza filtri né veli quell’Italia, fra fascismo, resistenza e ricostruzione,
9
�senza la quale non si può minimamente comprendere né spiegare l’Italia di oggi. Nel testo circola,
del resto, e proprio là dove la voce narrante si sdoppia, facendo appello al “graziosissimo lettore”
oppure al “sottoscritto scrivente”, l’autocoscienza della superiorità di rivelazione e verità della
scrittura testimoniale saggistico-letteraria rispetto alla mera ricostruzione storiografica:
Ma scusami, caro scrivente perché interrompi la narrazione e ti metti a baccagliare con gli storici? Il motivo è
semplicissimo, il narratore racconta il particolare, lo storico invece racconta come i fatti sono avvenuto in
generale e il generale e il particolare non si combinano mai. I testimoni oculari ne vedono e ne vedranno di
tutti i colori, lo storico invece non ha mai visto un cazzo (34).
Da dove viene all’io narrante questa ipercoscienza dei mutamenti in atto? Figlio di un muratore,
semiafabetizzato, Luigi ha avuto un rapporto intenso con i Padri: da ragazzo leggerà per pura ansia
poetica, Pavese, Gadda, Montale, Sterne e Cervantes e poi Giordano Bruno, Sarpi, Campanella,
Hegel, Croce e Gramsci. Questo vero e proprio miracolo culturale era abbastanza comune nel
dopoguerra e oggi non è più nemmeno pensabile a causa del mescolamento dei codici e della
penetrazione dei media. Il primum per Di Ruscio è la poesia (in versi e in prosa) intesa non come
lirica ma come forma di ribellione e sberleffo: in tutto il testo dominano analogie fulminanti, scarti
improvvisi, acrobazie tra pensieri e visioni. L’espatrio, la poesia, la vitalità anarchica e ribelle sono
gli antidoti che Di Ruscio impiega contro la sclerosi, la banalizzazione e l’appiattimento e che gli
permettono di dar voce a una resurrezione: a uscir dal sepolcro non è però il corpo di Cristo ma
quello dell’io poetante e l’Italia della guerra fredda, anticipazione occulta della nostra condizione
attuale.
Del tutto controcorrente in un’epoca che ha glorificato l’intreccio per predisporre la narrazione a
farsi fiction e puro intrattenimento, la scrittura di Di Ruscio non lascia spazio al plot. Eppure il
piacere del testo è immediatamente percepibile al lettore. Evidentemente occorre riconoscere che
l’intreccio non è il solo veicolo di “godibilità” testuale. Domina invece in Cristi polverizzati la
retorica dell’aversio, vale a dire la strategia saggistica della digressione permanente, adatta a
differire la conclusione, ideale per creare una moltiplicazione del tempo all’interno dell’opera, per
attivare una fuga perpetua. Così accade che in Cristi polverizzati i fatti sembrano registrati in presa
diretta mentre Domineddio, la Chiesa, il Partito, i Poeti, la Materia del cosmo, la Vitalità sessuale e
corporea, l’Orrore, i Corpi sbranati, diventano puri ritornelli, iterazioni litanianti, cadenze ritmiche.
E mentre i segretari delle Camere del lavoro, i dirigenti di Partito, i Poeti ufficiali sono visti con lo
stesso sospetto eretico con cui si guarda ai preti o ai maestri scolastici, il corpo gioioso e le pulsioni
utopiche restano l’unica bussola per orientarsi, irridere, non arrendersi, sortire dai varchi.
Non è stato compreso a sufficienza che noi italiani siamo nati lì, nelle macerie, nei dogmi della
guerra fredda, negli anni Cinquanta dell’americanizzazione e della prima irruzione di consumi e tv,
10
�nel secondo dopoguerra in cui si ripeteva in maschera la nostra millenaria vicenda subalterna,
cortigiana, inquisitoriale e gesuitica. Non è stato capito abbastanza che il nostro inconscio nazionale
è stratificato di “Iddii trini e quattrini, dell’acqua miracolosa di Lourdes, del sangue bollente di San
Gennaro” (59). Se così non fosse probabilmente non ci sarebbe stato nemmeno il recente
involgarito dominio vetero-commerciale, con le televisioni che hanno ridotto a offerta pubblicitariofinzionale ogni aspetto della vita associata. Le divagazioni poetico-saggistiche di Di Ruscio ce lo
suggeriscono, con la saggezza di un saltimbanco:
Abbiamo tanta fantasia che crediamo anche nell’incredibile, quindi immaginiamo congiure complicatissime,
guardate Berlusco come riesce a far credere di essere perseguitato dalla congiura di una giustizia di sinistra e ci
metterebbe la mano nel fuoco anche perché il Berlusco si presenta tanto bene e con tante esatte scriminature,
non può aver fatto tutto quello di cui viene accusato, ed ecco la fantasia infernale della procura di Milano e la
mancanza del diritto per i diritti (159).
Ci voleva un poeta-operaio indifeso e blasfemo, che scrive lontano dall’Italia, per ricordarci, con
una lingua ludica, diaristico-saggistica e narrativa, i nostri segreti delitti e le nostre pene. Attraverso
la scrittura di Di Ruscio come attraverso quelle di Saviano, Siti, Affinati e forse di molti altri, la
generazione dei Padri dialoga, in forme spettrali, con quelle odierne e, come nei versi di una grande
poesia di Vittorio Sereni (La spiaggia) ci consegna un’ eredità culturale non destinata a diventare
scarto o detrito inerte ma a farsi, pur nella mutazione, movimento, luce e parola.
Bibliografia
AA.VV., Generi letterari. Ibridismo e contaminazione, a cura di A. Sportelli, Roma-Bari: Laterza,
2001.
Benedetti, Carla, Gomorra di Alberto Saviano, in “Allegoria”, n. 57, 2008, p. 173.
Berardinelli, Alfonso, La forma del saggio. Definizione e attualità di un genere letterario, Venezia:
Marsilio, 2002.
Berardinelli, Alfonso, La forma del saggio e le sue dimensioni, in Il saggio. Forme e funzioni di un
genere letterario, a cura di G. Cantarutti, L. Avellini e S. Albertazzi, Bologna: Il Mulino, 2007.
Boblet, Marie-Hélène, Le roman dialogué après 1950. Poétique de l’hybridité, Paris: Champion,
2003.
Carmagnola, Fulvio, Il consumo delle immagini. Estetica e beni simbolici nella fiction economy,
Milano: Mondadori, 2006.
Casadei, Alberto, Stile e tradizione nel romanzo italiano contemporaneo, Bologna: Il Mulino, 2007.
11
�Debenedetti, Giacomo, Commemorazione di Proust, in Saggi critici, Prima serie, Milano: Il
Saggiatore, 1959.
Rollo, Alberto, I sudditi del best seller d’importazione in Tirature ’01, Milano: Il Saggiatore, 2001,
pp. 96-104.
Simonetti, Gianluigi, Sul romanzo italiano oggi. Nuclei tematici e costanti figurali, in
“Contemporanea”, 4, 2006, pp. 55-81.
12
�
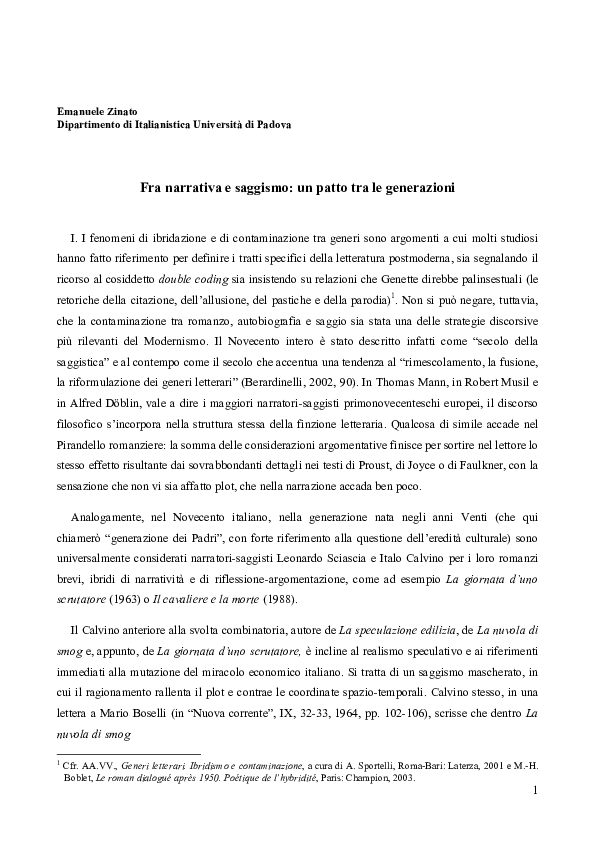
 Emanuele Zinato
Emanuele Zinato