PAOLA S. SALVATORI
RAZZA
ROMANA
Il fascio e l’alloro
Alcuni mesi prima della Marcia su Roma, quando ancora non era capo del Governo, Benito Mussolini pronunciò un discorso destinato a imprimere un segno decisivo all’imminente storia italiana.
Era il 21 aprile del 1922, anniversario del Natale di Roma, data che, circa un anno prima, era stata
scelta come la più adata a celebrare la “giornata fascista”:
“Celebrare il natale di Roma signiica celebrare il nostro tipo di civiltà, signiica esaltare la nostra
storia e la nostra razza, signiica poggiare fermamente sul passato per meglio slanciarsi verso l’avvenire. Roma e Italia sono infati due termini inscindibili. Nelle epoche grigie o tristi della nostra storia, Roma è il faro dei naviganti e degli aspetanti. […] Roma è il nostro punto di partenza e di riferimento; è il nostro simbolo o, se si vuole, il nostro mito. Noi sogniamo l’Italia romana, cioè saggia e
forte, disciplinata e imperiale. Molto di quel che fu lo spirito immortale di Roma risorge nel fascismo: romano è il Litorio, romana è la nostra organizzazione di combatimento, romano è il nostro
orgoglio e il nostro coraggio: ‘Civis romanus sum’”1.
Come è noto, proprio sul mito di Roma fu costruita una parte consistente dell’impalcatura propagandistica e culturale del nuovo regime: nel coacervo di simboli e rituali che il fascismo impose
all’Italia dopo la presa del potere2, i più pervasivi furono senza dubbio quelli legati all’antichità romana. Tra questi ultimi, il fascio litorio diventò un emblema universalmente (e immediatamente) riconoscibile come “fascista”, atraverso un radicale e impressionante stravolgimento del suo signiicato
originario3. Fu però subito evidente che i simboli legati alla romanità (ig. 68) non identiicavano
soltanto gli appartenenti alla nuova ideologia politica, bensì assurgevano a specchio dell’intera nazione: come ha scrito Andrea Giardina, “l’adozione di simboli e di riti romani, come il fascio litorio,
il saluto con la mano tesa, la marcia cadenzata […], si prestava a qualiicare eicacemente una speciicità fascista – nessun altro movimento o partito aveva quei simboli e quei riti – presentandola però,
al tempo stesso, come speciicità della nazione”4. Nella scelta di quei riti e di quei simboli, ebbero un
ruolo fondamentale gli studiosi della storia antica e, ancor di più, gli archeologi: il nesso tra antichità
e politica non si fermava dunque alla scelta di icone o di date da celebrare che fossero collegate a quel
lontano mondo, ma era sopratuto l’esito di un sistema culturale che trovava nelle discipline antichistiche una necessaria legitimazione scientiica5. Non fu dunque un caso se a studiare e ideare il
simbolo del fascio litorio fu chiamato proprio un illustre archeologo. Già alla metà di dicembre del
1922, si decise infati di coniare una nuova moneta da 2 lire nella quale fosse “inciso il fascio litorio,
simbolo di Roma antica e della nuova Italia”6 (ig. 69); poche setimane dopo, il delicato compito di
ricostruzione del simbolo che sarebbe diventato l’elemento distintivo del nuovo corso politico fu
aidato a Giacomo Boni – diretore degli scavi nel Foro Romano dal 1898 al 1911 e dal 1907 anche
di quelli del Palatino7. L’operazione fu una delle tante vicende culturali fasciste che vide protagonista
Boni, una grande personalità che all’intelligenza con cui capì l’importanza delle più avanzate tecniche dell’archeologia e del restauro univa una concezione quasi sacra della propria missione di rievocatore della romanità. Egli morì il 10 luglio del 1925 e visse dunque soltanto gli albori del nuovo
regime, ma riuscì ugualmente a individuare in esso, e nel suo duce, il momento storico propizio al
ritorno ateso della Roma antica, immaginando per quel momento così bramato una serie di liturgie
e di riti che avrebbero lasciato un’eco profonda nella propaganda degli anni successivi. Fu Boni, per
277
RomaCaput_IMP_02.indd 276-277
21/09/12 09.58
�esempio, a inventare la liturgia dell’alloro, secondo la quale ogni anno Mussolini riceveva dal diretore degli scavi del Palatino un ramo iorito di lauro raccolto in quel sito archeologico così evocativo:
la cerimonia si svolse inizialmente il 1° marzo, data che nell’antichità era legata alla celebrazione del
Natalis Martis o capodanno romuleo; a partire dal 1926, Alfonso Bartoli (successore di Boni) decise
di donare al duce il ramo di alloro ogni 28 otobre8.
Ma Boni fu anche colui che prima di altri vagheggiò scenograie e gesti che sarebbero poi diventati
vere icone politiche, issate nella storia da fotograie o copertine di giornali: è il caso della celebre
scena di Mussolini picconatore, più volte immortalato nell’atimo in cui, piccone alla mano, inaugurava lavori pubblici e sventramenti urbanistici distruggendo quanto ritenuto superluo (igg. 60-61).
Già nell’aprile del 1923 Boni aveva intuito la forza iconica di un simile ato quando, in una letera
indirizzata a un destinatario a noi sconosciuto, aveva scrito:
“A proposito della esplorazione del Lupercale, la culla della civiltà romana, non sarebbe male che un
giorno S.E. il Presidente Mussolini, in maniche di camicia nera, desse il primo colpo di piccone o
scavasse la prima palata di terra”9.
Quella che viene deinita “romanità fascista” non era composta soltanto da simboli concreti (fasci,
statue, manifesti, piture, monete) ma era anche, e sopratuto, un ateggiamento, uno “stile” di vita,
un comportamento che si poteva coagulare atorno a discorsi pubblici, a virtù evocate e invocate
(come nel caso della “disciplina”10) o, appunto, a gesti eclatanti e ripetuti come quello della distruzione del passato inessenziale e non riconducibile alla storia romana. Tuto questo era funzionale
alla realizzazione di una delle utopie fasciste più frequentemente ricorrenti nella politica culturale e
nella propaganda del tempo: la creazione dell’“uomo nuovo”11.
“I romani antichi erano razzisti ino all’inverosimile”
La rivoluzione antropologica voluta da Mussolini e dal fascismo avrebbe dovuto condurre a un nuovo tipo di italiano, che “era in parte un uomo del passato, perché teneva vivo in sé lo spirito della romanità, ma era sopratuto una creatura originale, che avrebbe reso possibile la lunghissima durata,
se non l’eternità, dell’era fascista”12. L’“uomo nuovo” avrebbe deinitivamente roto ogni ponte con
l’uomo borghese tanto odiato dalla propaganda fascista: isicamente possente e sano, avrebbe ripudiato la vita molle e agiata e riconosciuto nella disciplina il proprio principio ispiratore; sarebbe
stato un uomo “duro, forte, volitivo, guerriero, una sorta di legionario di Cesare dei tempi moderni,
per il quale nulla fosse impossibile”13. Nel corso degli anni trenta, le scelte politiche e ideologiche
adotate dal regime costruirono una forma più elaborata dentro la quale plasmare questa creatura
perfeta. In un discorso pronunciato il 25 otobre del 1938 al Consiglio nazionale del PNF14, Mussolini condensò il suo pensiero riguardo il necessario annientamento del caratere borghese di una
certa tipologia di italiano (“La borghesia è una categoria a caratere politico-morale”, sostenne il
duce15). Già l’abolizione del “Lei” e la sua sostituzione con il “Voi” come formula di cortesia16 aveva
aperto uno squarcio nello stile di vita e di pensiero borghesi. Nel discorso qui analizzato – la cui
importanza periodizzante era stata preannunciata dallo stesso Mussolini, che ne autorizzò la difusione orale ma non quella trascrita – il duce rivendicò la natura antica e romana di un altro atributo
tipico dell’“uomo nuovo”: la capacità, non scontata, di eseguire il passo romano, adotato uicialmente all’inizio del 1938 dall’esercito e poi dalla Milizia e dalle organizzazioni giovanili del PNF.
Alcuni mesi prima, Mussolini aveva afermato:
“Il passo di parata simboleggia la forza, la volontà, l’energia delle giovani generazioni litorie, che ne
sono entusiaste. È un passo che ha uno stile diicile e duro, che esige una preparazione ed un allenamento. Per questo lo vogliamo. È un passo che i sedentarî, i panciuti, i deicienti, le cosiddete mezze
cartucce non potranno mai fare. Per questo ci piace. […] fra qualche tempo lo eseguiremo alla perfezione. Perché il popolo italiano, quando vuole, sa fare tuto”17.
Il passo romano non aveva ovviamente alcuna origine romana18, ma l’invenzione dell’analogia storica aveva comunque una sua eicacia, sopratuto a causa delle sue implicazioni morali. Il 25 otobre,
dunque, Mussolini associò uicialmente e deinitivamente quella marcia cadenzata alla storia romana, vedendo in essa un indizio di “forza morale”19.
In quella stessa occasione, il duce si sofermò poi su un ulteriore elemento che avrebbe completato
la realizzazione dell’“uomo nuovo”. Si tratava, in questo caso, non di un fato atinente alla sfera
278
RomaCaput_IMP_02.indd 278-279
della forma (come nel caso della campagna per il “Voi” e della ricerca di rigore nell’esecuzione del
passo romano) bensì dell’illustrazione di un problema di ordine generale:
“Il problema razziale è per me una conquista importantissima, ed è importantissimo averlo introdotto nella storia d’Italia. I romani antichi erano razzisti ino all’inverosimile. La grande lota della Repubblica Romana fu appunto questa: sapere se la razza romana poteva aggregarsi ad altre razze. […]
Bisogna metersi in mente che noi non siamo camiti, che non siamo semiti, che non siamo mongoli.
E, allora, se non siamo nessuna di queste razze, siamo evidentemente ariani e siamo venuti dalle Alpi,
dal nord. Quindi siamo ariani di tipo mediterraneo, puri. Le invasioni barbariche dopo l’impero
erano di poca gente: i longobardi non erano più di otomila e furono assorbiti; dopo cinquant’anni
parlavano latino.
Senza risalire alle origini, ai liguri ed ai cinque o seimila anni prima di Cristo, ci limitiamo a dire che,
da almeno millecinquecento anni, le nostre genti si sono raggruppate fra di loro, ragione per cui la
loro razza è pura […]”20.
In questo discorso, Mussolini sosteneva dunque l’esistenza di una linea di continuità tra il razzismo
dell’antica Roma e quello dell’Italia contemporanea (il 1938 fu l’anno della pubblicazione del Manifesto degli scienziati razzisti e della promulgazione delle prime leggi antiebraiche), compiendo una
potente manipolazione della storia. “Quando dichiarò che i romani erano razzisti ino all’inverosimile, Mussolini inferse uno sfregio all’immagine della romanità”21: le politiche dei romani nei confronti
delle minoranze o delle popolazioni conquistate non furono infati mai ispirate a principi razziali
nell’accezione contemporanea. I romani erano stati sempre aperti all’osmosi sia con altre popolazioni,
sia con persone appartenenti a classi sociali diverse. Nell’antica Roma non erano infrequenti i matrimoni misti tra bianchi e neri, e la nascita di bambini meticci non era ostacolata né regolamentata da
leggi discriminatorie. Il caso degli ebrei era invece “più complesso perché associava l’identità etnica a
una fede monoteista che era anche Legge”22; tutavia, anche le repressioni eseguite contro gli ebrei
non ebbero le carateristiche di sterminio e di persecuzione sistematica come accadde nel corso del
XX secolo. Insomma, compiere un’analogia storica tra il presunto razzismo degli antichi romani e
quello ostentato dell’Italia fascista fu un ulteriore passo nella strumentalizzazione e falsiicazione della storia romana operata dal fascismo (si pensi alle politiche degli sventramenti urbanistici atuate a
Roma e in altre cità nel tentativo di isolare una certa idea di romanità e di antichità). Il romano “razzista ino all’inverosimile” era dunque una costruzione necessaria a conciliare il culto della romanità
con la nuova politica razziale. Era, in fondo, lo stesso romano i cui carateri si sarebbero ammassati
nell’immaginazione comune ancora per molti decenni: una igura cristallizzata nelle rappresentazioni
iconograiche e in quelle stereotipate del cinema fascista e post-fascista; un romano “manifesto della
Romanità”23, per citare un’espressione utilizzata da Roland Barthes in riferimento alle capigliature
folte e ricciolute dei romani raigurati proprio al cinema; o, come ha scrito ancora Andrea Giardina
a proposito del saluto fascista romano, “un tipo umano patologicamente segnato da un’otusa coazione, che lo porta a ripetere, persino nei saloti, una gestualità da accampamento militare”24.
Gli italiani erano tuti belli
L’eccezionalità dei comportamenti era lo specchio di quella del corpo; l’antico romano, così isicamente ritrato e moralmente deinito, ritraeva isicamente e deiniva moralmente tuto il popolo italiano.
Non solo: nella sua ricercata e bramata perfezione isica si trovava un’ulteriore dimostrazione dell’inelutabile superiorità della razza italiana rispeto alle altre. Sopratuto a partire dagli anni trenta, la propaganda sotolineò il più possibile la discendenza anche somatica dell’uomo italiano dall’uomo romano. Il più romano di tuti era ovviamente Mussolini, nel cui corpo venivano spesso riconosciute le
sembianze di un antico25, in un processo di “gloriicazione cesarea”26 che trovava nell’iconograia uno
strumento insostituibile. Le igure antitetiche erano invece quelle che nel corso degli anni trenta rappresentarono prima i rivali politici, poi le popolazioni conquistate, inine gli ebrei.
Un’idea di quanto fosse pervasiva e martellante la sollecitazione visiva della contrapposizione tra
questi due modelli di corpo (e di etica) ci può arrivare dalla letura di un romanzo che, recentemente, ha saputo ofrire un quadro fortemente evocativo della società italiana di epoca fascista: si trata
di un libro di Umberto Eco, il quale – facendo ricorso a numerosissime e variegate fonti – ha realizzato un’opera leteraria che restituisce atmosfere, odori, suoni, immagini degli anni dell’apogeo e
della caduta del regime fascista come raramente un’opera storica ha saputo fare. La misteriosa iamma
della regina Loana narra le vicende di un uomo che tenta di recuperare la perduta memoria autobio279
21/09/12 09.58
�graica atraverso l’immersione nelle stanze e nel solaio della casa di campagna in cui visse da bambino, straripante di cimeli di epoca fascista: ne scaturisce il recupero della memoria di una nazione
intera, la ricostruzione di comportamenti comuni, la rilessione sulla veridicità dell’adesione del popolo italiano al fascismo, la riletura di un regime atraverso il riaiorare delle impressioni e delle
sensazioni di un bambino (il protagonista del libro è nato nel 1931, un anno prima del suo autore).
E tra le memorie che riemergono grazie a questo viaggio tra gli oggeti, i libri e i suoni dell’Italia del
Ventennio, ci sono anche i ricordi legati alle rappresentazioni iconograiche e somatiche dei due tipi
di uomo: quello romano e quello appartenente alle razze inferiori:
“Sul libro della quarta classe, 1940-41, ed eravamo nell’autunno del primo anno di guerra, c’erano
solo storie di azioni gloriose della prima guerra mondiale, con immagini che mostravano i nostri
fanti sul Carso nudi e muscolosi come gladiatori romani. […] E la guerra in corso? Sul libro di quinta c’era piutosto una meditazione sulle diferenze razziali, con un capitoleto sugli ebrei e l’atenzione che si doveva porre a questa stirpe inida […]. Negli scatoloni avevo individuato anche alcuni
numeri di La difesa della Razza, una rivista nata nel 1938, e non so se il nonno avrebbe mai permesso che mi cadesse tra le mani (ma si sa, prima o poi ero andato a curiosare dovunque). V’erano foto
di aborigeni comparati a quelle di una scimmia, altre che mostravano il risultato mostruoso dell’incrocio tra una cinese e un europeo (ma erano fenomeni di degenerazione che pare avvenissero solo
in Francia). Si parlava bene della razza giapponese e si evidenziavano le stimmate imprescindibili
della razza inglese, donne con pappagorge, gentiluomini rubizzi col naso da alcolizzato […]. Quanto
agli ebrei veri e propri, non c’era che da scegliere: era una rassegna di nasi adunchi e barbe incolte, di
bocche porcine e sensuali coi denti sporgenti, di crani brachicefali, di zigomi segnati e occhi tristi da
Giuda gerosolimitano, di epe incontinenti di pescecani in frac, con la catena dell’orologio d’oro sul
gilè, le mani rapaci tese sulle ricchezze dei popoli proletari.
Il nonno, credo, aveva inserito tra quelle pagine una cartolina di propaganda in cui un semita ripugnante, sullo sfondo della Statua della Libertà, protendeva le mani adunche verso chi guardava. In ogni caso
ce n’era per tuti perché un’altra cartolina mostrava un negraccio ubriaco col cappello da cowboy che
ciancicava con manacce unghiute l’ombelico bianco della Venere di Milo. Il disegnatore aveva dimenticato che avevamo dichiarato guerra anche alla Grecia, e quindi che doveva importarci se quel bruto
smanazzava una ellenica mutilata, il cui marito girava in gonnellino e con il pompon sulle scarpe?
Per contrasto, la rivista mostrava i proili puri e virili della razza italica, e se Dante e alcuni condotieri non avevano proprio un naso piccolo e dirito si parlava in quei casi di ‘razza aquilina’. Se poi il richiamo alla purezza ariana dei miei compatrioti non mi avesse del tuto convinto, sul mio libro di
letura avevo una forte poesia sul Duce […] e la comparazione tra i trati maschi di Giulio Cesare e
quelli di Mussolini (che Cesare, poi, andasse a leto coi suoi legionari l’avrei saputo solo dopo, dalle
enciclopedie).
Gli italiani erano tuti belli”27 (igg. 70-72).
Nel suo mnemonico e concreto peregrinare tra i cimeli fascisti, il protagonista del romanzo di Eco si
trova quindi di fronte ad alcuni numeri della “Difesa della razza”, una rivista quindicinale che uscì per
la prima volta il 5 agosto del 193828. Diretore era Telesio Interlandi29: uomo da sempre aderente al
fascismo su posizioni estreme, considerato il giornalista di iducia del duce, è ricordato per la ferocia
delle campagne antisemite e razziste condote dalle pagine del “Tevere” prima, e della “Difesa della
razza” poi. Rivolta ai ceti medi e pensata come vetrina del razzismo italiano, quest’ultima era una rivista che, atraverso un linguaggio crudo e direto, avrebbe dovuto propagandare la superiorità della
razza italiana in un momento focale della storia del razzismo fascista: il 14 luglio di quell’anno, infatti, sul “Giornale d’Italia” era stato pubblicato il Manifesto degli scienziati razzisti (conosciuto anche
come Manifesto della razza), i cui irmatari furono resi noti pochi giorni dopo30. Il manifesto segnò
“l’avvio uiciale della politica razzista del regime, ma anche l’irruzione nella cultura italiana […] del
razzismo scientiico, biologico”31. Il programma era struturato in dieci punti, ognuno dei quali presentava un’asserzione iniziale seguita da una breve spiegazione:
“1. Le razze umane esistono. […].
2. Esistono grandi razze e piccole razze. […].
3. Il conceto di razza è un conceto puramente biologico. […].
4. La popolazione dell’Italia atuale è nella maggioranza di origine ariana e la sua civiltà ariana. […].
5. È una leggenda l’apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici. […].
280
RomaCaput_IMP_02.indd 280-281
6. Esiste ormai una pura ‘razza italiana’. […].
7. È tempo che gli italiani si proclamino rancamente razzisti. […].
8. È necessario fare una neta distinzione ra i mediterranei d’Europa (occidentali) da una parte e gli orientali e gli aricani dall’altra. […].
9. Gli ebrei non appartengono alla razza italiana. […].
10. I carateri isici e psicologici puramente europei degli italiani non devono essere alterati in nessun modo.
[…]”32.
Il manifesto fu pubblicato anche nel primo numero della “Difesa della razza”, seguito da un editoriale di Interlandi che introduceva la nuova rivista sostenendo come fosse ormai necessaria una presa
di posizione italiana di tipo razzista, poiché “un razzismo antichissimo e aggressivo, il più feroce e
delirante razzismo teologico, l’ebraismo, minaccia apertamente la società umana e tenta di asservirla
ai suoi inammissibili ini, con la complicità di popoli e di partiti miseramente corroti”33.
Inizialmente pubblicata in 140.000 copie, nell’arco di due anni la rivista vide crollare repentinamente la tiratura che, a partire dall’estate del 1940, passò a 20.000 copie (molte delle quali furono distribuite per abbonamenti o come omaggi). Il 1940 fu anche l’anno in cui venne ridoto il numero delle
pagine, evidente spia di un sostanziale fallimento del progeto iniziale. Essa rimase comunque in vita, considerata – anche durante gli anni di guerra – un ausilio importante e strategico per la propaganda di regime; cessò le pubblicazioni con la caduta del fascismo, nel giugno-luglio del 1943.
“La Difesa della razza” si caraterizzò senza dubbio per un uso spregiudicato delle immagini: l’apparato iconograico era infati atentamente rivolto a deinire una contrapposizione manichea tra la razza
ariana e le razze degeneri. I primi tre numeri si aprirono con tre copertine uguali (cambiò solamente
il colore di sfondo), al centro delle quali un fotomontaggio ritraeva tre teste di proilo (ig. 73). Si
tratava del Doriforo di Policleto, del ritrato di un semita con le carateristiche somatiche accentuate
e di una donna africana con monili locali, fotografata dall’antropologo Lidio Cipriani, uno dei irmatari del Manifesto della razza. Una spada atraversava la composizione, separando il volto del Doriforo
dagli altri due34. L’intenzione del fotomontaggio era talmente evidente che, dal quarto numero, questa
copertina fu utilizzata come logo della rivista stessa: il volto della celebre statua classica rappresentava
infati la purezza della razza ariana, la cui perfezione andava preservata da eventuali contaminazioni
con ebrei e neri. A raigurare la razza superiore, dunque, si era scelta un’immagine antica: in questo
caso essa non era stata trata dal mondo dell’arte romana, ma inaugurare la rivista uiciale del razzismo italiano con una copertina con l’immagine del Doriforo signiicava legare indissolubilmente
l’idea della razza italiana a quella del Canone policleteo e, dunque, divulgare il messaggio che nell’uomo italiano – ben distinto dal tipo umano degenere – era insita la perfezione ideale.
La necessità di salvaguardare la stirpe italica dal pericolo del meticciato era del resto continuamente
ribadita: anche in altre copertine furono opposti simboli dell’antichità classica a immagini repellenti di neri ed ebrei. Celebre è la copertina del 20 setembre del 1938, nella quale il volto di una statua
di Antinoo (personaggio storicamente associato al conceto di bellezza e perfezione estetica)35 era
deturpato da un’impronta digitale marchiata sul viso, al centro della quale spiccava una stella di Davide (ig. 74). Il numero del 20 maggio del 1939 si apriva invece con una copertina che ritraeva una
porzione della Colonna antonina sulla quale fu sovraimpressa una scrita in carateri ebraici “con
l’invito a distruggere Roma”36. Dopo l’ingresso dell’Italia in guerra, il richiamo all’antichità fu funzionale a spronare il popolo in armi: il 20 giugno del 1940, la “Difesa della razza” uscì con una copertina nella quale un grande fotomontaggio composto su tre piani raigurava una schiera di soldati
armati, sovrastati dalla statua dell’Augusto togato da via Labicana e da un braccio marmoreo che
brandiva una spada (ig. 75; immagine, quest’ultima, ricorrente nell’iconograia della rivista). La
“versione sacerdotale di Augusto, unita al gladio sguainato e al movimento dell’esercito in armi, trasmeteva un messaggio potente e drammatico: l’Italia afrontava una guerra giusta e sacrale”, e proprio per ribadire la sacralità della scelta bellica italiana si scelse un modello rasserenante dell’antico
condotiero romano, per una volta preferito a quello militaresco della statua di Prima Porta che, nel
ventennio fascista, ebbe un enorme successo37.
All’interno della rivista, un continuo bombardamento iconograico divulgava immagini strazianti di
corpi deturpati da handicap isici, menomazioni somatiche, strabismo, goniori. Questa ossessiva
atenzione rivolta al pericolo della degenerazione razziale e alla contrapposizione tra bellezza italiana e brutezza ebraico-africana era presente anche negli articoli. Il 5 luglio del 1939, per esempio, fu
pubblicato un pezzo di Umberto Caramore, intitolato La bellezza della razza italiana, che iniziava
con un richiamo alle origini romane del bellissimo popolo italiano:
281
21/09/12 09.58
�“La bellezza della razza italiana è inconfondibile per la regolarità dei trati, l’armonia anatomica, il
colore della pelle, dei capelli, l’espressione del viso, la vivacità degli occhi. Per tali carateri l’italiano
costituisce un vero e proprio tipo, la sua bellezza non è mai stata negata da alcuno, ed è l’ideale plastico delle arti romana e italiana. Di questa prerogativa non vogliamo menare vanto, ma è certo che
madre natura ha reso la nostra razza una delle più perfete, per quanto perfeto possa essere l’uomo”38.
È forse superluo ribadire che l’atenzione nei confronti della bellezza isica era anche un espediente
per avvalorare l’eccezionalità della bellezza morale della razza italiana: gli italiani erano tuti belli,
con i loro corpi plastici da antichi romani ma sopratuto con le loro virtù morali da fascisti. Per questo motivo l’autore dell’articolo sosteneva che le razze vengono inluenzate anche dalla bellezza e
che “le deformità, le malatie, il dolore ispirano infelicità, una istintiva ripugnanza, perché sono contrari alla legge della natura”. La razza italiana ha avuto il privilegio di essere dotata della bellezza e ha
quindi il “categorico dovere” di conservare “questo tesoro atavico” e di non replicare l’errore che altri
popoli hanno compiuto, per non lasciar deperire il suo segno distintivo:
“La bellezza ha bisogno di cure costanti, essendo un bene che si perde facilmente, un iore che l’aurora vede nascere, che accarezza il respiro del zeiro, che atira i raggi del sole, ma che declina e può
perire. […] I popoli che hanno dimenticato la morale e si comportano come se questa regola di vita
non li riguardasse afato, sono destinati a perire. Roma deve la sua decadenza al rilassamento dei
costumi. Soto i nostri occhi sono i segni precursori della decadenza d’altri popoli. Sono la loro debolezza isica, la diminuzione delle nascite, il disgregamento della famiglia, nucleo della razza. Ci
servano d’insegnamento”39.
Quando ormai la curva del successo del regime aveva iniziato a inclinarsi, il monito a mantenere viva
la cura nei confronti della propria stirpe trovò conforto nel vecchio topos della caduta dell’impero
romano avvenuta a causa del rilassamento dei costumi. Nella rivista non erano rari i riferimenti al
declino di Roma antica, quasi si avvertisse l’incombenza di un simile pericolo.
Del resto, il richiamo alla storia dell’antichità romana funzionava spesso da monito rispeto a ciò che
la storia coeva stava ofrendo: nel secondo numero della “Difesa della razza”, per esempio, era stato
pubblicato un lungo articolo di Cipriani tendente a dimostrare, atraverso argomentazioni scientiiche
e antropologiche, l’inferiorità degli africani e l’assoluto pericolo che si correva nel caso fossero nati
bambini meticci. Poiché “solo la razza bianca […] ha contribuito alla creazione della più alta civiltà
atuale”, al solo sospeto di rischiare un annacquamento delle proprie peculiarità “le razze europee
devono star guardinghe dagli incroci con gli Africani”40. Dopo essersi dilungato sulla presentazione di
dati riguardanti la circonferenza dei crani degli uomini bianchi (distinti tra le varie nazionalità) e degli
africani, Cipriani ricordò quali furono le motivazioni del successo dell’Italia antica:
“L’Antropologia rende palese che il decadere di molti popoli non ebbe nel passato altra causa che
quella di uno sregolato incrociarsi. Quelle Nazioni che oggi accolgono indiferentemente nel loro
seno le razze africane […] si espongono così a un danno gravissimo e irrimediabile.
Negli animali domestici, tuti sanno, la riproduzione con una razza inferiore dà sempre un prodoto
scadente. Nell’uomo non può non accadere diversamente. Solo mescolandosi due razze appartenenti allo stesso ceppo è da atendersi un prodoto talora migliore di ambedue i progenitori. Ne fornisce
buon indizio l’Italia dell’antichità. Gli stranieri arrivati erano di minore cultura rispeto agli Italici,
ma di buona razza. I loro discendenti, generati con donne italiane, contribuirono perciò alla ioritura
di genî di cui va orgoglioso il nostro rinascimento. […] In Africa non si può sperare nulla di simile.
[…] Se l’incrocio dell’uomo bianco con la donna nera è, per molti motivi, deprecabile, ancor più lo
è il viceversa. In ogni razza la donna è la depositaria più preziosa dei carateri del tipo. […] Per nessun motivo la donna bianca dovrebbe perciò distruggere il tesoro di possibilità in essa latente. Il viceversa è un obbrobrio – direi anzi una mostruosità – destinata a risolversi in un grave danno per i
popoli più civili”41.
In realtà neanche il meticciato composto da uomo bianco e donna nera poteva essere accetato, come dimostra la vicenda delle celebre canzone Facceta nera, entrata nell’immaginario colletivo come canto-simbolo dell’impresa etiopica. Scrita in romanesco nel 1935, fu poi tradota in italiano
otenendo un immenso successo. Eppure, malgrado la canzone propagandasse l’imperialismo italiano come guerra civilizzatrice, il regime la censurò proprio perché, nell’osannare la “bella abissina”
282
RomaCaput_IMP_02.indd 282-283
che sarà “Romana”, presupponeva l’unione sessuale tra i soldati bianchi italiani e le donne nere abissine42, aprendo la strada a una giustiicazione culturale del tanto temuto miscuglio di razze.
L’imperatore meticcio e il crollo della civiltà
In fondo, una direzione esplicita nella questione del meticciato sembrava averla già data, per contrasto, proprio un imperatore romano al quale pareva si dovesse addebitare l’inizio di tute le sventure
capitate all’impero di Roma e che avrebbero poi condoto al suo crollo: fu il ventiquatrenne Giorgio
Almirante a dedicare tre pagine del primo numero della “Difesa della razza” a Caracalla e al suo celebre quanto odiato edito. Il lungo articolo, intitolato L’edito di Caracalla. Un semibarbaro spiana la via
ai barbari, era corredato da due grandi fotograie dei volti marmorei di Caracalla e di Augusto43. La
prima presentava la seguente didascalia: “I trati somatici del semibarbaro Caracalla illustrano a suficienza il principale movente del suo rovinoso edito”; la fotograia era pubblicata in modo tale che
del volto, visto di proilo, venissero colte sopratuto le ombre e le spigolature, con l’incavo dell’occhio completamente inondato dal buio e la piega della guancia che, unita all’ombra pronunciata
della bocca, donava al viso un’espressione dura e inquietante. Decisamente diferente era la resa
della fotograia di Augusto: il volto era ritrato di due terzi, gli occhi erano entrambi visibili e ben illuminati, la bocca – con l’ombra appena accennata del naso – pareva sorridere. E la didascalia era, in
questo caso, totalmente rasserenante: “Augusto, che non volle contribuire all’imbarbarimento
dell’Impero rilete nel volto la nobiltà della razza italica” (questi erano gli anni in cui la sovrapposizione Augusto-Mussolini aveva trovato la sua maggior fortuna). L’impostazione dell’articolo era di
tipo didatico: Almirante introduceva il suo discorso ricordando in che modo, nelle classi ginnasiali,
i ragazzi conoscessero le cause della caduta dell’Impero romano:
“Apprendono che il famigerato 476 non segna che la conclusione di un lungo e vasto processo; apprendono che alla decadenza e al crollo dell’Impero di Roma hanno contribuito molteplici cause: la
pressione dei barbari, l’imbarbarimento dell’esercito, il iscalismo, la crisi economica, l’anarchia militare […]. Ma nulla sanno dell’unica sostanziale causa che provocò tute le altre, e con esse il crollo
della potenza romana”44.
La causa sostanziale era, per l’autore, “semplice e chiara, facilmente enunciabile e ancor più facilmente comprensibile”: si tratava infati dell’aievolirsi, “ino a scomparire, del senso della razza italica e delle sue tradizionali virtù”. Il momento di svolta di quel periodizzante processo fu proprio
l’edito del 212 d.C. col quale Caracalla aveva esteso la citadinanza romana a tuti gli abitanti dell’Impero. Nell’articolo si ripercorrono quindi le tappe che condussero a quell’infausto provvedimento,
in uno slitamento di civiltà che parve non avere freni. Augusto, la cui saggezza politica era un punto
di riferimento costante per la propaganda fascista, aveva riiutato di seguire il consiglio ricevuto da
Mecenate “di estendere ai provinciali i diriti dei Romani”, dissuadendo Tiberio “dal lanciarsi in avventure del genere”. Claudio, invece (la cui debolezza, scriveva Almirante, “è ben nota e non ci stupisce”) avrebbe probabilmente realizzato un simile proposito se la morte non lo avesse colto45. L’inizio
più lontano di quella tragica evoluzione verso l’imbarbarimento della stirpe doveva quindi essere
individuato in Vespasiano, il quale “esonerò gli italici dal servizio militare”. Tale provvedimento, pur
motivato da buoni propositi – evitare, cioè, “che l’Italia fosse continuamente il campo di sanguinose
lote civili” –, portò a conseguenze gravissime che “estraniarono dalla penisola una delle più grandi
forze dell’Impero; e determinarono, alla lunga, l’iniacchimento della razza, che per le virtù militari
si era sempre luminosamente distinta”46. Furono proprio gli imperatori non romani a distruggere,
gradualmente e inesorabilmente, quell’antichissima civiltà:
“Comincia poi la serie degli imperatori provinciali; e la crisi si aggrava. Adriano, di famiglia spagnola,
decreta l’istituzione della circoscrizione territoriale nelle province, dando così a ciascuna di esse una
forza armata autoctona, assai più disposta a servire gli interessi della propria regione e della propria
razza, che quelli sovrani di Roma.
Marco Aurelio, di famiglia italica ma imbevuto di grecismo, concesse individualmente la citadinanza romana a moltissimi provinciali […]. L’esercito era ormai composto in grandissima parte da barbari. […] Setimio Severo, imperatore nato in Africa, a Leptis, a malapena capace di parlare in latino,
portato al trono da un’armata di rozzi provinciali, gli abitanti della regione traco-illirica, diede il
colpo di grazia all’uicialità italica, concedendo ai provinciali il privilegio di rivestire i gradi dell’esercito. Fu quella – come dice il De Santis – la svolta decisiva della storia di Roma”47.
283
21/09/12 09.58
�Giunse inine Caracalla, “iglio dell’africano Setimio Severo e nato in Gallia, a Lione”, la cui politica
“rappresenta la logica conclusione della politica severiana”. Almirante riconobbe, nelle scelte di questo disprezzato imperatore, motivazioni anche contingenti, di tipo iscale e propagandistico, tute
però estranee agli interessi dell’Impero. Non poteva, del resto, essere altrimenti: Caracalla non era
romano ed era anzi “la personiicazione fedele” del sincretismo religioso e politico. Figlio del meticciato razziale e culturale, era una sorta di nemico interno che inevitabilmente condusse alla distruzione della civiltà alla quale non aveva mai appartenuto: non a caso, Almirante fece un implicito ma
chiarissimo accenno alla scabrosa questione delle relazioni con le “faccete nere”. L’imperatore Caracalla era un semi-africano ed era anche nato in Gallia: era quindi doppiamente meticcio, e – nell’Italia del tempo, ormai contrapposta all’ex sorella latina francese – era il perfeto simbolo della degenerazione insita in qualunque mescolamento razziale e politico con razze e sistemi politici non ariani:
“Africano di razza, celtico di costumi, non è per nessun verso un imperatore romano e non si può
comportare come tale. Agisce come oggi agiscono, nei cosiddeti paesi democratici, i negatori del
razzismo; fa di Roma il crogiuolo in cui tute le genti possono impunemente mescolarsi; e in tal
modo afreta il crollo della civiltà antica, che è civiltà della razza italica. Disconosce, da barbaro
qual’è [sic!], i suoi stessi interessi […]. Favorisce, privo com’è del senso della razza, il meticciato;
facendo citadini di Roma i meticci nati dal connubio dei soldati romani con le ‘peregrine’ […].
Provoca il declino economico dell’Italia intera, la cui prosperità non poteva andar disgiunta da una
posizione di assoluto predominio politico. Dà, in una parola, la vitoria alla barbarie interna, che,
minando il senso della razza, minava le basi stesse dell’Impero; e apre il passo alla vitoria della barbarie esterna, che tarderà due secoli e mezzo a diventar deinitiva soltanto in grazia della straordinaria forza di resistenza delle istituzioni civili e politiche create dalla razza di Roma.
Questa fu l’opera rovinosa dell’imperatore Caracalla: nato a Lione, come si è deto, e così denominato per la sua ridicola manìa di vestire alla foggia dei Galli. Il mal francese, come si vede, è di antichissima data”48.
Qualche tempo dopo la pubblicazione di questo articolo, già nelle prime fasi della guerra, iniziò a
essere evidente che Mussolini, ritenuto l’incarnazione più autentica dell’antico romano, non avrebbe condoto ad alcuna gloria. Il fascismo aveva cercato di replicare i fasti dell’impero romano atraverso l’ideazione di liturgie pubbliche ispirate alle cerimonie romane, l’uso di simboli antichi, il ricorso a nomi che evocavano la romanità, la sovrapposizione di eventi contemporanei ad altri più
antichi. Roma era stata per quasi venti anni “il punto di partenza e di riferimento” di un intero sistema politico, ma il tentativo di atualizzare una civiltà e una cultura idealizzate e mitizzate fu sotoposto, verso la ine degli anni trenta, a un’eccessiva trazione: “l’idea di Roma, per l’uso che il fascismo
ne aveva fato, era stata un’idea plastica, in grado di adatarsi a svariate situazioni: ma non poteva
essere sibrata oltre un certo limite”49. La trasformazione dei romani in “razzisti ino all’inverosimile”
andò ben oltre quel limite, e non a caso, tra i tanti motivi che componevano il mito fascista della romanità, questo fu sul momento il meno convincente e sedutivo. Ma le sue ripercussioni sull’opinione difusa, evidenti nel cinema del secondo dopoguerra, avrebbero segnato ancora ino ai giorni
nostri l’immagine della Roma antica.
284
RomaCaput_IMP_02.indd 284-285
Abbreviazioni
ACS: Archivio Centrale dello Stato
(Roma).
PCM: Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
SPD, CO: Segreteria Particolare del
Duce, Carteggio Ordinario.
DR: “La Difesa della razza”,
1938-1943.
Opera: Opera Omnia di Benito
Mussolini, a cura di E. e D. Susmel, 36
voll., Firenze 1951-1963.
Bibliograia
R. Barthes, I Romani al cinema, in Id.,
Miti d’oggi, Milano 1966, pp. 21-23
(tit. or.: Mythologies, Paris 1957).
I. Calvino, I ritrati del duce, in Id., Saggi 1945-1985, a cura di M. Barenghi, t.
II, Milano 1995, pp. 2878-2891 [=Cominciò con un cilindro, in “la Repubblica”, 10-11 luglio 1983].
M. Canali, ad vocem Interlandi, Telesio,
in Dizionario Biograico degli Italiani,
vol. LXII, Roma 2004, pp. 519-521.
A. Carandini (con D. Bruno), La casa
di Augusto. Dai “Lupercalia” al Natale,
Roma-Bari 2008.
F. Cassata, “La Difesa della razza”. Politica, ideologia e immagine del razzismo
fascista, Torino 2008.
P. Cavallo, P. Iaccio, Vincere! Vincere! Vincere! Fascismo e società italiana nelle canzoni e nelle riviste di varietà (1935-1943),
prefazione di A. Lepre, Inserto fotograico a cura di M. Franco, Napoli 2003.
S. Cavazza, ad vocem “Voi”, campagna
per l’uso del, in Dizionario del fascismo,
a cura di V. de Grazia e S. Luzzato, vol.
II, Torino 2003, pp. 798-800.
F. Coarelli, ad vocem Lupercal, in Lexicon Topographicum Urbis Romae, vol.
III, a cura di E.M. Steinby, Roma 1996,
pp. 198-199.
R. De Felice, Mussolini il duce, II, Lo Stato totalitario. 1936-1940, Torino 1981.
U. Eco, La misteriosa iamma della regina
Loana. Romanzo illustrato, Milano 2004.
E. Gentile, Il culto del litorio. La sacralizzazione della politica nell’Italia fascista, Roma-Bari 1993.
E. Gentile, Fascismo di pietra, RomaBari 2007.
A. Giardina, Ritorno al futuro: la romanità fascista, in A. Giardina, A. Vauchez, Il mito di Roma. Da Carlo Magno
a Mussolini, Roma-Bari 2000, pp. 212296.
A. Giardina, ad vocem Archeologia, in
Dizionario del fascismo, a cura di V. de
Grazia e S. Luzzato, vol. I, Torino
2002, pp. 86-90.
A. Giardina, L’impero di Augusto, in I
volti del potere, Roma-Bari 2010.
N. Giustozzi, Antinoo, l’incanto di
un’imago, in M. Sapelli Ragni (a cura
di), Antinoo. Il fascino della bellezza,
Milano 2012, pp. 108-138.
M. Luzzato, A. Matard-Bonucci, La
vetrina della razza. Saggio iconograico,
in Dizionario del fascismo, a cura di V.
de Grazia e S. Luzzato, vol. II, Torino
2003, s. p.
R. Maiocchi, Scienza italiana e razzismo fascista, Scandicci 1999.
R. Maiocchi, ad vocem “Manifesto degli
scienziati razzisti”, in Dizionario del fascismo, a cura di V. de Grazia e S. Luzzato, vol. II, Torino 2003, pp. 87-88.
G. Marcheti-Longhi 1933a, Il Lupercale ed il suo signiicato politico, in “Capitolium”, 4-5, 1933, pp. 157-172.
G. Marcheti-Longhi 1933b, Il Lupercale nel suo signiicato religioso e topograico, in “Capitolium”, 8, 1933, pp. 365379.
V. Pisanty, Educare all’odio: “La Difesa
della razza” (1938-1943), con un contributo di Luca Bonafé, Introduzione
di Umberto Eco, Milano 2003.
M. Sapelli Ragni (a cura di), Antinoo. Il
fascino della bellezza, Milano 2012.
P.S. Salvatori, L’adozione del fascio litorio nella monetazione dell’Italia fascista,
in “Rivista italiana di numismatica e
scienze aini”, CIX, 2008, pp. 333-352.
P.S. Salvatori 2012a, Liturgie immaginate: Giacomo Boni e la romanità fascista, in “Studi Storici”, 2, 2012, in corso
di stampa.
P.S. Salvatori 2012b, Nascita di un’icona politica: il piccone del duce, in “Quaderni di storia”, 2, 2012, in corso di
stampa.
M. Sarfati, ad vocem Interlandi, Telesio,
in Dizionario del fascismo, a cura di V.
de Grazia e S. Luzzato, vol. I, Torino
2002, pp. 673-674.
A. Vitoria, ad vocem Uomo nuovo, in
Dizionario del fascismo, a cura di V. de
Grazia e S. Luzzato, vol. II, Torino
2003, pp. 765-767.
M.M. Winkler, he Roman Salute. Cinema, History, Ideology, Columbus
2009.
Note
1 Opera, XVIII, 1956, pp. 160-161
(Passato e avvenire, in “Il Popolo d’Italia”, 21 aprile 1922).
2 Nel panorama simbolico fascista rientravano, tra gli altri, il culto dei martiri (con il quale venivano celebrati,
insieme, i caduti del Risorgimento,
della Grande Guerra e della rivoluzione fascista), la devozione per il gagliardeto (simbolo privilegiato dell’identità squadrista), per il fuoco e per il
manganello (immagini di puriicazione e di rinascita, anch’essi legati direttamente all’esperienza dello squadrismo): cfr. Gentile 1993, pp. 39-60.
3 Per un’analisi dei signiicati politici
che l’antico simbolo del fascio litorio
assunse nel periodo fascista (e, dunque, dello stravolgimento di quelli originari), cfr. Giardina 2000, pp. 224227. Più in generale, il saggio di
Giardina rappresenta il punto di riferimento fondamentale per chiunque
decida di studiare i rapporti tra antichità e fascismo.
4 Ivi, p. 214. Sul cosiddeto “saluto romano”, cfr. ora Winkler 2009.
5 Giardina 2002, p. 87.
6 Letera datata 24 dicembre 1922 e
indirizzata dal Ministro delle Finanze
Alberto De Stefani a Mussolini: ACS,
PCM (1922), 9.8, n. 3143.
7 Per una detagliata ricostruzione della vicenda del fascio litorio impresso
sulle monete fasciste, cfr. Salvatori 2008.
8 Sulla liturgia dell’alloro e su altre
ideate da Boni e poi riprese dal regime
fascista, cfr. ora Salvatori 2012a.
9 Letera datata 7 aprile 1923: ACS,
SPD, CO, n. 509.787, f. 1, Roma. Palatino e Foro Romano. Personale del Senatore G. BONI. Lo scoprimento del Lupercale – il luogo, sacro agli antichi, nel
quale i gemelli Romolo e Remo furono nutriti dalla lupa – fu uno dei crucci
scientiici di Boni: durante tuta la sua
vita, l’archeologo cercò inanziamenti
per quell’impresa da lui ritenuta essenziale e fortemente simbolica. Sulla vicenda dell’iconograia di Mussolini
picconatore e delle sue derivazioni dal
progeto di Boni, cfr. Salvatori 2012b.
L’individuazione del Lupercale è un
problema arduo e controverso: per la
questione, cfr. Carandini 2008. In generale, per le indagini del sito, cfr. Coarelli 1996. Negli anni trenta, quando le
aspirazioni imperialiste del regime individuarono nell’antichità precedenti
illustri, il possibile scoprimento di
quel luogo fu oggeto di dibatiti e rilessioni che, talvolta, accanto a motivazioni scientiiche presentavano carateri evidentemente propagandistici:
cfr., per esempio, Marcheti-Longhi
1933a e 1933b.
10 Giardina 2000, pp. 216 sgg.
11 Cfr., tra i tanti, De Felice 1981, pp.
285
21/09/12 09.58
�88 sgg.; Gentile 1993, passim; Giardina 2000, pp. 238-241; Vitoria 2003.
12 Giardina 2000, p. 240.
13 De Felice 1981, p. 89.
14 Opera, XXIX, 1959, pp. 185-196.
15 Ivi, p. 187.
16 Su questa vicenda, cfr. per esempio Cavazza 2003.
17 Opera, XXIX, 1959, pp. 52-53 (discorso tenuto a Roma il 1° febbraio
1938, in occasione del quindicesimo
annuale della MVSN).
18 Sul passo romano fascista, cfr.
Giardina 2000, pp. 259-261.
19 Opera, XXIX, 1959, p. 189.
20 Ivi, p. 190.
21 Giardina 2000, pp. 262 sgg. (p.
264).
22 Ivi, p. 265.
23 Barthes 1966, p. 21.
24 Giardina 2000, p. 215.
25 Su Mussolini antico romano, cfr.
ivi, pp. 241-248, e spec. pp. 242-243: “il
corpo del duce era quasi una dissolvenza incrociata tra una statua romana e un
essere vivente e, in virtù di un contato
di tipo medianico con la romanità, di
volta in volta la statua esprimeva una
vitalità prorompente o il corpo si marmorizzava”. Cfr. anche Gentile 2007,
pp. 131-132.
26 Calvino 1995, p. 2881.
27 Eco 2004, pp. 186-188.
28 Cfr. Luzzato, Matard-Bonucci
2003; Pisanty 2003; Cassata 2008.
29 Per un ritrato biograico di Telesio Interlandi, cfr. Sarfati 2002; Canali
2004.
30 La pubblicazione del Manifesto della razza strideva con le teorie razziste
italiane degli anni precedenti, rappresentando l’evidente tentativo di adeguare la politica e la cultura dell’Italia al
razzismo di stampo biologico e nordico
della Germania. Sulla vicenda del Manifesto, cfr. Maiocchi 1999, pp. 211 sgg.;
Maiocchi 2003.
31 Maiocchi 1999, p. 212.
32 Cfr. ivi, pp. 328-329.
33 DR, I, 1, 5 agosto 1938, p. 3.
34 Per una descrizione di questa come
di altre copertine della “Difesa della razza”, cfr. Luzzato, Matard-Bonucci 2003.
35 Cfr. ora Sapelli Ragni 2012, sopratuto il contributo di Giustozzi
2012, pp. 108-138.
36 Luzzato, Matard-Bonucci 2003.
37 Sulla fortuna dell’Augusto di Prima Porta in età contemporanea e, in
particolare, negli anni trenta, cfr. Giardina 2010, pp. 42 sgg. Per la citazione:
ivi, p. 49.
38 DR, II, 17, 5 luglio 1939, p. 7.
39 Ivi, p. 8.
40 DR, I, 2, 20 agosto 1938, p. 20 (L.
Cipriani, Razzismo coloniale).
41 Ibid.
42 Cfr. per esempio Cavallo, Iaccio
2003, pp. 13-14.
43 DR, I, 1, 5 agosto 1938, pp. 27-29.
44 Ivi, p. 27-28.
45 Sulla politica dell’imperatore Claudio, cfr. Giardina in questo volume.
46 DR, I, 1, 5 agosto 1938, p. 28.
47 Ivi, pp. 28-29.
48 Ivi, p. 29.
49 Giardina 2000, p. 286.
286
RomaCaput_IMP_02.indd 286-287
21/09/12 09.58
�
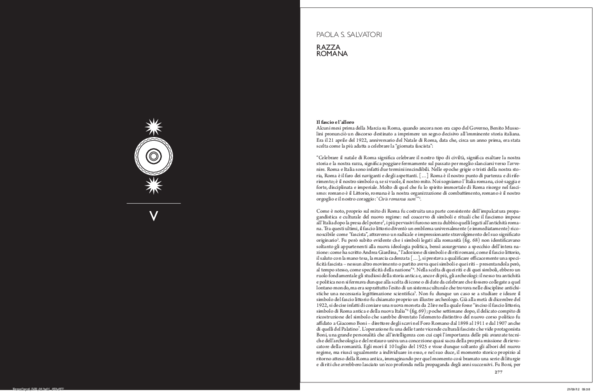
 Paola S. Salvatori
Paola S. Salvatori