Academia.edu no longer supports Internet Explorer.
To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser.
La profezia di fronte al delirio dei potenti (1Re 21)
La profezia di fronte al delirio dei potenti (1Re 21)
2019, Parole di Vita
La vicenda tragica di Nabot è un'efficace riflessione sulla forza devastante del desiderio che spinge l'uomo alla violenza a cui si oppone soltanto la parola profetica di Elia. di Cristiano D'Angelo La forza travolgente del desiderio di possedere è un'esperienza che, prima o poi, ogni uomo o donna sperimenta, o nella forma del desiderio inappagato che induce a fuggire e rinchiudersi in se stessi, come il re Acab che indispettito dal rifiuto di Nabot «volge la faccia da un lato» (1Re 21,4), o nella forma della prepotenza che si accaparra dei beni altrui, incurante di ogni diritto e della verità, come la regina Gezabele che fa uccidere Nabot per impossessarsi della sua vigna. È questo il tema del racconto del cap. 21 del primo libro dei Re che narra la storia di Acab, potente re di Israele, contro Nabot, piccolo proprietario terriero che difende la sua vigna dalle mire del re che la pretende per sé, solo per soddisfare il suo desiderio di ingrandire i territori della corona e di abbellire il suo palazzo. Il racconto, da un punto di vista storico, conserva il ricordo della grande espansione del regno di Israele sotto i re Omri (885-874 a.C.) e Acab (874-853 a.C.), durante i quali un fiorente sviluppo economico e una serie di campagne militari produssero ricchezza ma anche disuguaglianze sociali e ingiustizie. La vicenda di Nabot diventa così un caso emblematico dell'avidità del potere che, pur di realizzare i suoi obbiettivi, non conosce valori, non rispetta la giustizia, perverte la religione. Contro questa tracotanza del potere si erge la parola profetica di Elia che, in nome di Dio, rivela la falsità e l'arroganza del re. Il racconto tuttavia non è solo una denuncia della malvagità del re e dei potenti; è anche una parabola della condizione umana, soggetta alla prepotenza del desiderio di possedere. All'ombra dei potenti L'inizio del racconto-«Nabot di Izreèl possedeva una vigna che era a Izreèl, vicino al palazzo di Acab, re di Samaria» (21,1)-mette al centro della frase la vigna e il palazzo, agli estremi i personaggi, ottenendo l'effetto di contrapporre nella mente del lettore l'immagine verdeggiante della vigna, simbolo della benedizione di Dio e della fecondità della terra, con l'austerità imponente delle mura del palazzo, immagine del potere regale. Le parole con cui Acab si rivolge a Nabot delineano il ritratto di un re che si crede onnipotente e che agisce come agirebbe un Dio: «Cedimi la tua vigna; ne farò un orto perché è confinante con la mia casa». Il palazzo ha diritto a uno spazio vitale; vicino al palazzo non possono esserci territori di altri; la volontà del re di rendere magnificente la sua dimora e di assicurarne il sostentamento valgono più di ogni altra ragione; il rispetto per la memoria dei padri, con cui Nabot rifiuta la richiesta di Acab, non è preso in considerazione dal re. La brama di avere e la prepotenza del potere illudono il re di essere come Dio, rendendo l'uomo insensibile ai diritti degli altri e alle esigenze della giustizia. Il desiderio del re, le sue ambizioni, la disponibilità di denaro lo fanno sentire in diritto di chiedere e ottenere ciò che vuole, a dispetto di ogni tradizione e affetto. Quella del re a Nabot non è una richiesta, ma un ordine mascherato di buone maniere: «Dammi la tua vigna». Il re non chiede di vendere, ma di dare, e il prezzo o la permuta che propone a Nabot appaiono più una concessione di favore che una compravendita. Il re parla e agisce come se fosse un Dio, perché secondo la Bibbia è Dio che dà la terra (Dt 4,21.38) e la divide tra le tribù di Israele (Gs 11,23); ed è Dio che fa di Eden un orto (Gen 1,30) per nutrire gli esseri viventi. La proposta di Acab a Nabot è apparentemente sensata: egli offre in cambio della vigna di Nabot «una vigna migliore» (1Re 21,2) o, se Nabot preferisce, gli darà un corrispettivo in denaro. Il desiderio di possedere produce la presunzione di essere noi a decidere ciò che è buono o cattivo per gli altri, così Acab è lui che sa ciò che è buono o meno buono per Nabot; fino alla farsa di apparire addirittura generoso, dando in cambio una viglia migliore di quella stessa di Nabot! E se Nabot preferisce del
Related Papers
« Prophecy and the sense of History in the Furioso ». From the first edition in 1516, Ludovico Ariosto resorts to profetich figures to tell historic facts that occurred after Charlemagne’s period. These characters, vested with supranatural powers, have the knowledge of the future as established by Providence and already set in the course of the stars. Although these prophetic digressions are strictly anchored in the narrative fiction, they are often closely related to the historical and political context of the 16th century. For instance, in the passage of Merlin’s cave, the wizard and Melissa announce to Bradamante the glorious future that awaits her lineage. Similarly, in the passage of the paintings in the room of Tristan’s fortress, the same Christian warrior sees, thanks to Merlin’s magic art, some representations of major events that will mark the history of the peninsula, including episodes regarding the Italian Wars. Through this narration strategy, contemporary readers of Ariosto could find in the historic reality of their time, the proof of the veracy of some parts, or all, of the prophetic digression. Juan Carlos D’Amico’s article highlights how the use of prophecy in the poem helps the author to prove the ineluctability of narrated historic facts, in a poetic universe dominated by fate and Fortune.
Quaderni d'Altri Tempi
Alle prese con un'elettrica profezia2012 •
Recensione della mostra e del catalogo "Proto Anime Cut", a cura di Stefan Riekeles, dedicati alle architetture e agli scenari dei lungometraggi d'animazione giapponesi di fantascienza.
2018 •
The essay retraces the salient stages of the construction of the prophetic activity of Hildegard of Bingen and the characteristics of her visionary knowledge, and through some surveys in the vast correspondence of the abbess highlights the variety of recipients and the different ways of her writings. It is precisely in the epistles that the complexity of the relationship between strength and weakness emerges several times, which Hildegard elaborates from her valorization of femininity in creation.
G. Frilli, M. Lodone (a cura di), La profezia nel pensiero del Rinascimento e della prima età moderna, Pisa, ETS, 2022, pp. 33-54
Machiavelli e l’arte della profeziaPrendendo le distanze da una lunga tradizione di riflessione teologica, Niccolò Machiavelli si interessa alla profezia non in quanto dono divino o eccezionale condizione di conoscenza, ma in quanto arte politica. Partendo da questo assunto, il saggio intende mostrare che per Machiavelli la profezia è un’arte politica performativa, in cui l’azione del profeta coincide con la sua parola. Nel Principe, nei Discorsi, nelle lettere e in altre opere di Machiavelli emerge in maniera non sistematica un modello nuovo, pragmatico, di comprensione del carisma profetico e del suo operare. L’originalità di tale modello, tuttavia, si comprende solo alla luce del peculiare rapporto tra profezia e comunicazione pubblica presente nella Firenze del tempo, e dell’aspro dibattito che contrappose i fiorentini sulla figura di frate Girolamo Savonarola. Machiavelli partecipò al dibattito dal punto di vista privilegiato di chi era interessato non a stabilire se le profezie di Savonarola fossero autentiche, ma piuttosto a riflettere – facendo largo uso della comparazione tra forme politiche e religiose diverse, antiche e moderne – sulla «verità effettuale» del loro impatto sui contemporanei.
in "Italian Quarterly", LVIII, 229-230 (2021)
Andrea Andretto
Femminilità e profezia2018 •
1) Profezia e mediazione. «La profezia può essere considerata, senza scandalo alcuno, il ministero più alto nella Bibbia, più importante dello stesso sacerdozio. Il profeta, infatti è il mediatore per eccellenza tra cielo e terra, tra bocca di Dio e orecchio dell'uomo». 1 Nella definizione di profezia che ho colto dalla riflessione di Annalisa Guida, emerge il legame profondo che esiste tra la figura del profeta e quella del mediatore. Sappiamo tutti molto bene che il «mediatore» è colui che ha la funzione di rendere possibile e di facilitare l'incontro tra due parti che sono tra di loro, per i più svariati motivi, lontane. Ne viene dunque che il profeta non apre la bocca per dire delle cose o peggio ancora per fare delle chiacchiere; il vero profeta è colui che che ha preso chiara coscienza che la sua bocca è uno strumento posto a servizio di Dio, affinché con le parole da lui proferite ogni ascoltatore possa trovare la strada per incontrarsi e riconciliarsi con Dio stesso. Non a caso un cristiano crede che Gesù, parola definitiva di Dio, è re, sacerdote, profeta. 2 Profeta e profetessa sono dunque uomini e donne che vivono un rapporto appassionato di ricerca e allo stesso tempo di repulsione nei confronti Parola di Dio. Si pensi in modo particolare alla vicenda del profeta Giona che, in prima battuta, si rifiuta di obbedire alla parola che lo vuole profeta in Ninive. La storia di Giona, peraltro, rivela con chiarezza che 3 il profeta può anche respingere la chiamata da Dio, tuttavia è Dio stesso che non guardando a genealogia o a tradizione umane particolari, sceglie il "suo" uomo, la "sua" donna, affinché tutta la sua esistenza diventi profetica. Per il testo sacro diventerà "profetica" anche la sua ribellione di fronte alla Parola di Dio che lo invia a Ninive: questo per dire che le Scritture Sante ci presentano la figura del profeta come la storia di un uomo che vive un travagliato percorso di fede e che alla fine si abbandona e si lascia sedurre dalla missione di collaborare al progetto di Dio di salvare il suo popolo. Ne guadagniamo dunque che nessuno si rende profeta da se stesso: nemmeno se si proclama un anno di riflessione sul ruolo profetico che la vita consacrata può avere ancora oggi! Piuttosto si deve cercare di comprendere come Dio chiede oggi, alla singola coscienza cristiana, di essere un "Suo profeta", collaboratore del suo progetto di salvezza per tutti gli uomini di oggi, inseriti nei problemi vitali di un tempo che è differente da quello della profezia biblica. Da sempre infatti il profeta si sente per certi versi un uomo "fuori tempo", chiamato tuttavia a condividere tutta la compassione con la quale Dio guarda a questo lasso di storia, con le sue caratteristiche peculiari e ai suoi problemi. approfondimento dal punto 2 di vista sistematico: MOIOLI G., Cristologia. Proposta sistematica, Centro Ambrosiano, Milano 2015, pp. 138-143. Per un approfondimento dal punto di vista biblico si veda il pur sempre valido: SEGALLA G., La Cristologia del nuovo testamento, Paideia, Brescia 1985, pp. 48-63.154-155. VIGNOLO R., Un profeta tra umido e secco.
Nei due paper da me presentati durante lo scorso anno accademico, mi sono impegnato nell'offrire al lettore una mappatura complessiva del mio percorso di ricerca. Ho così indicato come, muovendo dal Commento all'Apocalisse (1329) di Nicola di Lyra (1270-1349), diventi possibile individuare nel concetto di profezia un momento di strutturale importanza per apprezzare in una prospettiva organica l'edificio di pensiero proposto da questo autore. Muovendo da una tale impostazione, mi sono rivolto a tre ulteriori sezioni dell'opera del Lyrano: il Prologus Primus che inaugura la sua Postilla Litteralis super Totam Bibliam, il Prologo del Commento ai Salmi e il Commento alla Prima Lettera ai Corinzi. In quest'occasione, intendo analizzare i principali contenuti del Prologo del Commento ai Salmi. Sarà difatti in questo luogo letterario che incontreremo la più consistente elaborazione teorica del concetto di profezia nella cornice di pensiero elaborata da Nicola di Lyra.
RELATED PAPERS
Advances in Chemical and Biological Sciences Volume II (ISBN: 978-93-95847-04-9)
ADVANCES IN CHEMICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES VOLUME II2024 •
2014 •
International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics
IMRT Dose Reconstruction on Cone-Beam Computed Tomography (CBCT): A Platform for Head-and-Neck Adaptive Therapy2007 •
2010 •
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society
Binary star influence on post-main-sequence multi-planet stability2016 •
Scientific reports
Understanding and controlling morphology evolution via DIO plasticization in PffBT4T-2OD/PC71BM devices2017 •
Optics & Laser Technology
Stretching the sensitivity and stability of an acrylamide based photopolymer material with mixture of dyes2018 •
2019 •
Renewable Energy
Multi-step-ahead wind speed forecasting based on optimal feature selection and a modified bat algorithm with the cognition strategy2018 •
2006 •

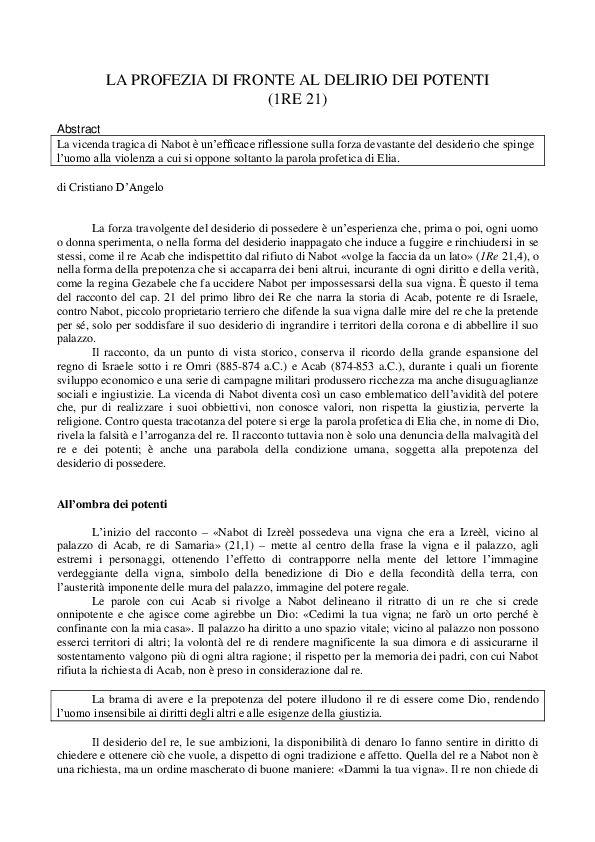
 Cristiano D'angelo
Cristiano D'angelo