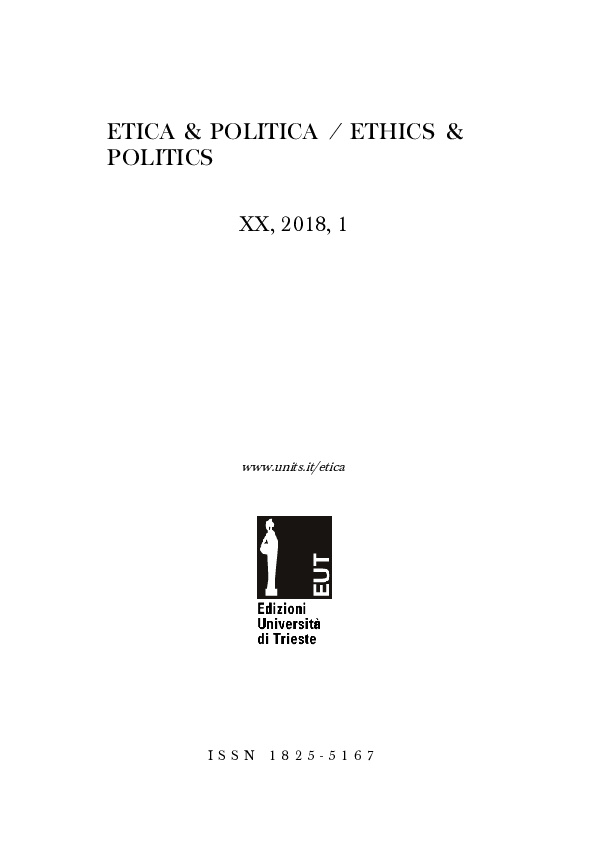ETICA & POLITICA / ETHICS &
POLITICS
XX, 2018, 1
www.units.it/etica
ISSN
1825-5167
�2
�3
Etica & Politica / Ethics & Politics, XX, 2018, 1
Monographica
I
NEGRI E LA FILOSOFIA
7
Vittorio Morfino &
Negri and Philosophy
Elia Zaru
11
Guido Boffi &
Sul concetto di metafisica per Toni Negri
Giacomo Clemente
43
Saverio Ansaldi
La ginestra leopardiana. Lineamenti per un’ontologia eticopoetica del tempo
53
Irene Viparelli
Tra operaismo e biopolitica. Genesi e sviluppo del concetto
negriano di produzione
77
Vittorio Morfino
Sull’orlo del tempo. La teoria negriana della temporalità
107
Mattia Di Pierro
La biopolitica nel pensiero di Antonio Negri. Dalla
“tendenza” all’eccedenza affermativa della vita
127
Elia Zaru
Talpa o serpente? Popolo, classe, moltitudine
145
Frédéric Montferrand
Composition, autonomie, separation. Les formes-parti
d’Antonio Negri
161
Paolo Scanga
Dallo Stato piano al nuovo ordine della globalizzazione.
La sovranità in Antonio Negri
187
Vittorio Morfino & Elia
Zaru
Storia, politica, filosofia. Intervista ad Antonio Negri
Simposio
F erdinando M enga,
L o s candalo del f uturo.
Per una giustizia
i n tergenerazionale
�4
207
Michele Illiceto
Il diritto di chi non c’è: tra ontologia della possibilità e
principio di generatività
223
Mario Vergani
Tempo delle generazioni e temporalità etica
233
Gabriella Baptist
‘Altrimenti che tempo’?: quale futuro per la giustizia
intergenerazionale
239
Tommaso Gazzolo
Yet not enough to say a bomb will fall
249
Tommaso Greco
Da dove vengono i diritti delle generazioni future?
265
Angelo Abignente
Garanzia e cura: l’interpello delle generazioni future
273
Ferdinando G.
Menga
Problemi aperti di giustizia intergenerazionale: risposte ai
miei critici
Varia
307
Stefano Bracaletti
Gianluca Mori sull’ateismo nella filosofia moderna
317
Agostino Cera
Il fenomeno “vivente”
325
Angelo Cicatello
Diritto cosmopolitico e ragione in Kant
341
Carola Isaia
La virtù della sel f -reliance nelle filosofie di Emerson e
Nietzsche
363
Menno R. Kamminga
The Internal-Rawlsian Unsustainability of Rawls’s
Duty of Assistance
383
Franco Manti
The Moral Decision: from Phronesis to Ethical
Competence
395
Pierpaolo Marrone
Margalit sul tradimento
405
Roberta Adelaide
Modugno
Rivoluzione industriale e condizioni dei lavoratori
nell’Inghilterra del diciannovesimo secolo: un’analisi
controcorrente
415
Riccardo Fanciullacci
Althusser di fronte a Hobbes. La critica dell’umanismo
individualista
453
Information on the Journal/Informazioni sulla rivista
�5
Monographica
NEGRI E LA FILOSOFIA
�6
�7
Etica & Politica / Ethics & Politics, XX, 2018, 1, pp. 7-9
ISSN 1825-5167
NEGRI AND PHILOSOPHY
V I T TO RI O MO RFI NO
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”
vittorio.morfino@unimib.it
E LI A Z A RU
Scuola Normale Superiore
Classe di Scienze Umane
elia.zaru@sns.it
This monographic issue aims at offering a reconstruction of Negri’s philosophy.
For this purpose, we have asked the authors to explore Negri’s work starting from
some key-terms capable, within a particular perspective, of restoring the range and
specificity of his philosophical standpoint. In other words, what we aim is to assemble
a fundamental lexicon of Negri’s philosophy.
In this regard, we must affirm two methodological premises, both linked to the
issue of «historicity», which have led the writing of the articles. First, «historicity»
means a philosophy in which temporality does not coincide with a timeless moment
closed within a defined system. On the contrary, it is characterized by a series of
conjunctural stances, in which it is possible to identify some theoretical lines of force.
Keeping in mind the aim of establishing a systematic lexicon, every author has
underlined the relevant variations or hints of specific concepts in different phases of
Negri’s thought.
Second, «historicity» indicates the tight connection between philosophy and
politics which characterizes Negri’s philosophy. The only way to comprehend Negri’s
theory, its origin and development, is to situate it at the crossroads of a double
encounter: one – theoretical – with Marx, the other – political – with the workers’
struggles during the Sixties. This junction defines two essential features on which
Negri has established his philosophy. First of all, the idea of a radical and original
rethinking of Marxism, conceived during the theoretical and political experiences of
«Quaderni Rossi», «Classe Operaia», Potere operaio and Autonomia operaia. Then,
after the defeat of the Italian workers’ movement at the end of the Seventies, and his
arrest and French exile, Negri elaborates the necessity of an «ontological turn» in
�8
V ITTORIO M ORFINO – E LIA Z A RU
which his Marxist core is blended with the materialist tradition (from Lucretius, to
Machiavelli, Spinoza and Leopardi) and the French philosophical milieu (in which
Foucault and Deleuze stand out).
This issue analyses eight fundamental categories of Negri’s thought: ontology,
materialism, production, temporality, biopolitics, multitude, party, and sovereignty.
Each essay examines one of these concepts both diachronically and synchronically.
That is, every article underlines at the same time the development of a specific
concept in Negri’s thought, and the way in which its definition includes different
philosophical materials. «Marx beyond Marx» means, for Negri, to establish a
connection between the founder of the critique of political economy and Foucault
and Deleuze, as in the case of «production» (Tra operaismo e biopolitica. Genesi e
sviluppo del concetto negriano di produzione) and «biopolitics» (La biopolitica nel
pensiero di Antonio Negri), Lucretius, Spinoza and Leopardi with regards to
«temporality» (Sull’orlo del tempo. La teoria negriana della temporalità), «multitude»
(Talpa o serpente? Popolo, classe, moltitudine) and «materialism» (La ginestra
leopardiana. Lineamenti per un’ontologia etico-poetica del tempo), the theological
parable of Job on the «ontology» (Sul concetto di metafisica. Per Toni Negri), Lenin
on the «party» (Composition, autonomie, séparation. Les formes-parti d’Antonio
Negri), Hobbes and Rousseau on the «sovereignty» (Dallo Stato piano al nuovo
ordine della globalizzazione. La sovranità in Antonio Negri). Yet, «beyond Marx»
never means «without Marx». The point of no return for Negri, as a Marxist and
materialist philosopher, is set by the eleventh thesis on Feuerbach. Only by keeping
this in mind it is possible to really understand his theoretical practice.
This issue is dedicated to the memory of Alessandro Pandolfi, scholar, comrade,
friend.
�9
Negri and Philosophy
�10
�11
Etica & Politica / Ethics & Politics, XX, 2018, 1, pp. 11-41
ISSN 1825-5167
SUL CONCETTO DI METAFISICA
PER TONI NEGRI 1
GU I DO BO FFI
Dipartimento di filosofia
Università Cattolica di Milano
guido.boffi@unicatt.it
GI A CO MO CLE ME NT E
Dipartimento di scienze umane per la formazione
Università degli studi di Milano-Bicocca
g.clemente6@campus.unimib.it
ABSTRACT
This essay tries to identify the fundamentals of the metaphysics Toni Negri elaborates in relation
to the changes within the capitalist system. In the domain of real subsumption, we individuate in
the absolute contingency the field of the ontological constitution. This field makes the
Transcendental idealism the theoretical opponent of Negri’s metaphysical position, since the
Transcendental idealism is generally based on demands concerning measurements and
hierarchization.
KEYWORDS
Labour, contingency, history, constitution
I
Il furto del tempo di lavoro altrui, su cui poggia la ricchezza odierna, si presenta come
una base miserabile rispetto a questa nuova base che si è creata nel frattempo e che è
stata creata dalla grande industria stessa. Non appena il lavoro in forma immediata ha
cessato di essere la grande fonte della ricchezza, il tempo di lavoro cessa e deve cessare
di essere la sua misura, e quindi il valore di scambio deve cessare di essere la misura del
valore d’uso .
K. Marx
2
Il testo, pur essendo nella sua interezza stato pensato, progettato e rivisto da entrambi gli autori, è
stato scritto nei punti 1-3 da Guido Boffi e 4-7 da Giacomo Clemente.
Marx, K. (1968), Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica 1857-1858, trad. it.
di E. Grillo, Firenze: La Nuova Italia, vol. II, p. 401.
1
2
�12
G U IDO B OFFI – G IA C OMO C LE ME NTE
La tesi marxiana è nota, e subito ci conduce in medias res, a ritrovare una
premessa discorsiva, cioè empirica, fondamentale nella riflessione di Negri: viviamo
nella sussunzione reale. Diciamo che la premessa è empirica perché, al di là delle
(precarie) tendenze globali opposte, include una constatazione fattuale, ed è
discorsiva, foucaultianamente, in quanto fa segno agli strumenti di un potere (il
capitale, nei suoi costituivi rapporti) che stabilisce regole di funzionamento comune
per i propri enunciati, afferenti ai più diversi campi del sapere e della realtà. E,
tuttavia, è fondamentale ricadendo nella filosofia prima, nel discorso intorno alla
totalità del reale e al suo fondamento che qui, come vedremo subito, inerisce alla
possibilità di produzione d’essere. Essa è cioè una premessa ontologica. Ha a che fare
non soltanto con il cambiamento dell’essere del lavoro nella sua «forma immediata»,
quanto, proprio a partire da quel primo mutamento ontologico, con la possibilità
dell’essere nella sua interezza. È un’ipotesi, questa, che si chiarisce in un triplice
rilascio concettuale, in tre nuclei teorici concatenati.
1. Primo: l’ontologia è storica, sempre storicamente situata nei suoi presupposti e
nei suoi esiti. È uno studio, una ricerca che muove dalla-nella determinatezza
concreta e nelle determinazioni pratiche. Quel che c’è, il «questo qui» è il suo
subjectum: il tema su cui verte. Lo chiama generalmente essere, quando presume di
potere tentare in sorvolo l’inchiesta dei suoi significati fondamentali, predicabili di
qualsiasi ente. In realtà quel che vede è già ciò che esperisce, in cui si trova implicato
colui stesso che a partire dalla propria sensorialità fa, costruisce esperienza. È un
campo di singolarità e molteplicità materiali. Di corpi, forze, artefatti, cose e stati di
cose, modi di essere e di fare, punti di vista determinati nei tempi e nei luoghi: nulla
in tutto ciò è un puro «dato», nulla un puro «essere». Tali determinazioni sono,
appunto, prassiche, dense, forzose, effettuali. L’ontologia vi prende forma e ad un
tempo vi esercita la propria presa concettuale. Ha presa sull’esistenza che è sempre,
spinozianamente, la spontanea espressione dell’essere secondo infiniti modi, lo
sviluppo spontaneo di forze nei corpi e tra di essi. E tuttavia nel rendere l’idea degli
stati di cose esistenti, dei rapporti tra corpi, della composizione delle forze,
l’ontologia non lascia le cose come sono. Le influenza, le altera, le prospetta, così
come, d’altro lato, viene a sua volta condizionata dal mutamento delle cose stesse,
dal movimento reale e segmentato dell’essere sociale, dagli sviluppi e dalle
ricomposizioni delle forze che vi agiscono. È un’ontologia materialistica in senso
marxiano, esposta sull’accrescimento di un (nuovo) essere comune dell’uomo con
l’uomo (con ogni vivente, con le cose stesse) attraverso l’emancipazione-liberazione
del lavoro vivo – inversamente, il materialismo è, e dovrebbe autenticamente essere,
sempre ontologico, costruito cioè non al tavolino delle idee o ideologie, bensì
�13
Sul concetto di metafisica per Toni Negri
nell’insieme di pratiche ontologiche: per ciò marxista 3. In definitiva, dire che si tratta
di un’ontologia storica significa quindi sostenere che è costruita (ripetiamo: l’essere
stesso è sempre costrutto, mai «dato») e percorsa dalle differenze e dalla lotta di
classe.
2. Secondo rilascio: l’ontologia è politica (in senso sia predicativo sia sostantivo).
Non è puramente e semplicemente «disciplina». Anzi, Negri le evita i confini
epistemologici di una disciplinarietà astratta, la collocazione accademica di scienza
dell’ente in quanto ente (v’è chi preferisce: dell’essere in quanto essere). Per il
riguardo tradizionale, risulta piuttosto «indisciplinata». Il suo quaesitum, ciò che
ricerca e interroga non sono le cause prime quali aspetti comuni a tutte le realtà
sensibili: ciò che ricerca è piuttosto la potenza d’essere nella presenza e nell’aperura
che è lì. Né si compie in se stessa attraverso modi sistematici circolari, arborescenti o
piramidali. Così già per il semplice fatto che non dà forma ad alcun tutto, mentre è
elemento di un complesso dispositivo politico in assenza del quale risulterebbe
affatto priva di senso (direzione e significato). L’operazione ontologica – più che mai
per Negri i concetti devono essere operativi – «prende parte» tra corpi. È affermativa,
è interna alla dinamica produttiva del mondo. Diventa una pratica teorica
combattente. Il suo influente avversario teorico (filosofico giuridico politico
ideologico) è il «trascendentalismo». Sotto tale termine Negri fa rientrare, da un
punto di vista teoretico, qualsiasi posizione che, muovendo da un’istanza previa
d’unità e dunque di misura, controllo e gerarchizzazione, duplichi il reale in una
mistificante ma gestibile illusorietà 4 ; da un punto di vista storiografico-filosofico,
certo non manualistico-accademico – va da sé che il pensiero negriano nulla abbia da
spartire con la sedicente «scientificità» di studi specialistici e valutazioni ministeriali
–, designa sia in senso tecnico la filosofia trascendentale kantiana e le sue
diramazioni, sia l’idealismo, le sue lunghe filiazioni sino alle varianti
fenomenologiche, alla trascendenza dell’intenzionalità.
3. Terzo rilascio: l’essere, al pari della verità, s’impianta nel lavoro. Vi prende
«corpo-mente» (di qui in poi scriveremo «corpomente» senza trattino per intendere
un unico implesso ontologico). Usando Spinoza, possiamo forse spingerci ad
affermare che l’essere implica il lavoro e che il lavoro esplica (rende percepibile)
Parecchi volumi di Negri esprimono un’ontologia materialistica potente – e, in quanto tali, sono
potentemente politici. Ma per le considerazioni che svolgiamo rileva in particolare quell’«aureo
libretto» in cui il complesso teorico dei dispositivi ontologici trova una chiave di volta: Negri, A. (2000),
Kairòs, Alma Venus, Multitudo. Nove lezioni impartite a me stesso, Roma: Manifestolibri (d’ora
innanzi nel testo: K).
V’è in ciò un’esplicita ripresa dell’attacco teorico portato da Deleuze alla «logica trascendentale»,
della sua ulteriore esplicazione in Foucault, e della sua implicazione in Nietzsche.
3
4
�14
G U IDO B OFFI – G IA C OMO C LE ME NTE
l’essere. Ogni «questo qui» esprime, a modo suo, lavoro, nel quale l’essere viene a
conoscenza e percepibilità come nel proprio attributo sostanziale. Attenzione:
«lavoro» qui non va inteso quale attività-oggetto (attività finalizzata alla realizzazione
di un qualche prodotto utile o al conseguimento di un bene – oggetto di
un’obbligazione giuridica non meno che di saperi disciplinari, per es. economici o
sociologici). Lavoro è pratica di soggettivazione, e soggettivazione politica, nel campo
dell’attività sociale: pratico-produttiva come pure creativa e affettivo-relazionale.
Pratica che cambia l’attacco ontologico: i processi tecnologici che hanno condotto
alla dematerializzazione (tendenzialmente egemone) delle attività lavorative, il loro
divenire «cognitivo», urgono a un mutamento nella composizione politica delle
soggettività accomunate dalla produzione «lavorativa» del loro essere singolare e
reticolare, analogamente a come sono cambiate violentemente le condizioni di
subordinazione della forza-lavoro e della società intera al capitale. L’attuale livello
della sussunzione reale è il più alto: riconduce a sé, assorbendola, non più soltanto
l’attività lavorativa materiale ma anche, e soprattutto, il lavoro cognitivo, cioè
l’attività intellettuale, linguistica, comunicativa, relazionale, affettiva, insomma la vita
intera di ogni singolo vivente, l’intero, «corposo» orizzonte dell’essere – biopolitica5.
Dirimere i lineamenti di un’ontologia negriana significa dunque collocarsi
preliminarmente e marxianamente nel dominio indeterminato della sussunzione
reale (e via via emergerà in rapporto a quale metafisica – giacché, accanto a
«ontologia», «metafisica» è termine circoscrivibile in varie pagine di Negri, anche a
distanza d’anni e mai decettivo). Ma collocarvisi nella condivisione contestuale del
punto di vista: si badi, osservazione affatto metodologica e per nulla ideologica, anzi:
in tutto «antiideologica». Al punto di vista marxista guardiamo dal punto di vista
marxista: ciò implica e significa non nella filiazione lineare bensì nella relazione
accrescitiva e rizomatica, non nella continuità ma nella discontinuità. Discontinua,
segmentata, aperta a biforcazioni e cedimenti improvvisi è la realtà: altrettanto lo è il
discorso che le inerisce, la prospettiva teorica e la prassi trasformativa. Affermare,
come s’è fatto, che l’ontologia si costruisce nelle differenze di classe e che rimane
percorsa dalle lotte di classe che ne insorgono, ciò significa che la sola continuità è
quella del punto di vista, posto nell’essere della soggettività sociale insorgente.
Soggettività capace di trasformare i singoli soggetti in relazione a se stessi e nelle
relazioni di potere in cui sono presi; di renderli coraggiosi abbastanza per prendere
parola con verità e sottoporre la verità stessa alla prova della realtà; di innovare con
dirompenza, cioè di aprire rotture e sempre diversi fronti di attacco; di rinnovare le
Non è questo il luogo per procedervi secondo un profilo storico-economico, ma ovviamente il
sopravvento dell’orizzonte biopolitico, lungi dall’apparire come un repentino mutamento, trova a sua
volta precise radici nella riorganizzazione «fordista» del lavoro materiale e poi nell’instaurazione
generalizzata dei processi di lavoro e delle politiche sociali del Welfare State nelle regioni più
sviluppate.
5
�15
Sul concetto di metafisica per Toni Negri
esigenze e le procedure, le tattiche interne al processo produttivo della strategia
politica a fronte dei problemi sollevati dalla durezza dello sfruttamento.
4. Il lavoro di Giobbe titola uno dei primi paragrafi: «ontologia negativa del
lavoro» 6 . Espressione che, ci sembra, può essere utilizzata per ridenominare in
termini di filosofia prima la premessa fondamentale. S’intenda: tra le tendenze della
logica di sviluppo del capitalismo industriale vi era la centralità del lavoro materiale,
subordinato alla regimentazione normativa d’estrazione del plusvalore 7. Ma, oggi, «di
tutto questo resta ben poco, forse nulla. Innanzitutto la teoria del valore è, quanto al
suo uso, un ferro vecchio» (LG 29). Ecco la necessità storica, fattuale, di porsi «con
Marx oltre Marx». Il tempo di lavoro (il suo furto) ha smesso di essere la base della
ricchezza odierna (e, con ciò, quel meccanismo che presiedeva alla produzione del
valore e alla riproduzione della sua spartizione sociale ha smesso di funzionare quale
base strategica delle lotte). Misura assente, assenza di determinazione del valore –
smisuratezza, indeterminazione: sinonimie che disegnano il campo di un’ontologia
negativa, appunto. Questa negatività determina l’immediatezza dell’esperienza, non
in generale bensì la nostra: come crisi della legge di valore nella globalità della
produzione e della sussunzione reale. Con essa tramontano le vecchie misure dello
sfruttamento, dunque anche le corrispondenti figure dell’antagonismo, le figure
appartenenti alla trama di quei determinati rapporti sociali, economici, politici che
«facevano» la precedente fase capitalistica e la teoria della rivoluzione imposta
dall’ortodossia marxista. Ora, se non si vuole rimanere allineati a un tale orizzonte
negativo sul quale il sole nero del capitale si è espanso sino ad assoggettare ogni
modalità di vita dei viventi, appiattiti a merce nella totalità della circolazione delle
merci, la linea d’orizzonte va aggredita sulla sua stessa base, ontologica prima ancora
che economica. E all’ontologico va riconcatenato il politico8. V’è infatti, all’epoca
della sussunzione della vita e del campo sociale intero al capitale, cioè per noi
investiti dai nuovi modelli di accumulazione e sfruttamento, una «primarietà
ontologica assoluta»: «l’ontologia precede, nel biopolitico, sia la sfera della
produzione che quella del politico» (K 137). E in tale campo già dispiegato, vero e
proprio orizzonte metafisico su cui si staglia questa nostra epoca, totalità
dell’esperienza delle cose che vi appartengono, va interrogata la possibilità
ontologica di un oltre. Di un’esperienza altra: quella di un’ontologia materialistica
Cfr. Negri, T. (1990), Il lavoro di Giobbe. Il famoso testo biblico come parabola del lavoro umano ,
Milano: Sugarco, nuova ed. senza sottotitolo (2002): Il lavoro di Giobbe, Roma: Manifestolibri (d’ora innanzi
nel testo: LG), pp. 28-32.
Cfr. Id., Il rapporto capitale/lavoro nel capitalismo cognitivo , in Id., Negri, T. (2012), Inventare il
comune, Prefazione di J. Revel, Roma: Derive Approdi, pp. 188-199.
6
7
Di là dall’evidente richiamo affermativo agli agencements deleuzeani-guattariani,
«concatenamento» qui serve anche a prendere le distanze da qualsiasi forma di dialettica, compresa
quella negativa.
8
�16
G U IDO B OFFI – G IA C OMO C LE ME NTE
della potenza, impiantata nel lavoro vivo, nell’«antagonismo contro lo sfruttamento»,
nella «costituzione di nuove costellazioni cooperative» (K 9).
II
L’indifferenza è la tendenza. Quanto più questo mondo si sviluppa, quanto più si
matura e si perfeziona, tanto più esso diviene indifferente. Noi immaginiamo per questo
mondo un’intercomunicabilità totale; ma laddove non esiste criterio di misura,
riferimento oggettivo, la comunicazione è caotica – meglio, è appunto indifferente. Ogni
determinazione viene meno, ogni capacità di riferimento reale è annullata .
A. Negri
9
Cancellazione totalitaria delle differenze, caos, indeterminatezza. Abbiamo
iniziato con l’indicazione di una premessa fondamentale ed eccoci, di nuovo, nel
dominio della sussunzione – questa volta con espressioni di Negri stesso, che ha
insegnato a lavorare precisamente sul Marx dei Grundrisse. Ci troviamo nel mezzo
delle esperienze che permettono di qualificare i contorni del dominio (solo i suoi
«contorni», un complesso di tratti che, da dentro, sembrano individuarlo, nella
consapevolezza che esso non possieda più confini né linee perimetrali). I quali sono
poi i contorni del mondo della vita quotidiano attorno a noi e oltre di noi. Mondoambiente, contesto di attività, soggettività ed eventi del quale certamente la nostra
prassi umana risulta costituente, in quanto lo produce e sospinge di continuo oltre i
limiti attuali (cfr. K 72), e che pure è lo stesso mondo della sussunzione reale di cui
non percepiamo alcun «fuori», inteso sia come esterno sia come fuoriuscita.
Percepiamo immersivamente, quando il nostro corpomente è sveglio abbastanza da
essere in grado di percepire, che la superficie del mondo sia fatta dall’insensatezza
tautologica della comunicazione (che è logica, perché non è epistemologica –
torneremo poi su questa distinzione) e dalla sussunzione produttiva al capitale (per il
fatto che questo mondo linguistico istruito da movimenti circolari privi di verità celi
la totalità del processo produttivo). La circolazione dei flussi linguistici si produce e
riproduce in una realtà la quale, essendo interconnessione e intercomunicabilità,
ridefinisce reticolarmente la totalità togliendo la specificità del produrre. Tutto, in
questo intero ridefinito, è produttivo: cioè subordinato-assoggettato a produzione di
merci (cfr. FS 48). L’intuizione marxiana del completarsi del capitalismo nella fase
della sussunzione reale s’è sviluppata a tutti gli effetti. Ripetiamo, quasi con Spinoza:
quel che percepiamo di un tale essere univoco, il suo attributo, è che al-dal dentro
non vi sia fuori. Ogni singolare e sociale «questo qui» è già sussunto e interconnesso
Negri, A. (2013), Fabbriche del soggetto. Archivio 1981-1986, con una conversazione con Mimmo
Sersante, Verona: ombre corte, (d’ora innanzi nel testo: FS), p. 49.
9
�17
Sul concetto di metafisica per Toni Negri
alla circolazione del capitale (oggi finanziario). L’indifferenziazione è la tendenza,
rovescio speculare dell’equivalenza generale istituita dal denaro (oggi
tendenzialmente elettronico); tutto in tutto è l’esito metafisico; tutta la vita possibile
nella materialità costitutiva di ogni processo vitale è il campo d’immanenza e
d’antagonismo. Sopra s’è detto di come il cambiamento d’essere del lavoro (il
mutamento della sua consistenza ontologica materialmente-immaterialmente
determinata) implichi per Negri un cambiamento dell’essere come tale. Proviamo, in
maniera anche bruta, a scandirne il discorso in tre brevi tesi estrapolabili senza
fatica.
1. Ecco la prima. Parlano i Prolegomeni di una ontologia della sovversione10: «la
distruzione dell’essere è divenuta possibile nella misura stessa in cui l’universo
produttivo è stato sussunto nel capitale e l’universo linguistico è stato ridotto a
comunicazione indifferente» (FS 52). Si badi, in questa possibilità di distruzione
d’essere non si fa riferimento all’essere del particolare, ovvero di quel che accade (e
che dunque può non essere, potendo non accadere). Non ci troviamo cioè sul
versante della contingenza in quanto caratteristica variabilità e inessenzialità di un
qualcosa che può capitare come anche no. La radicalità della tesi negriana, piuttosto,
consiste nell’attribuire questa possibilità di nullificazione, di annientamento e nonsussistenza all’essere come tale (rendere il niente un suo percepibile attributo). In
altri termini, sta nel rendere ontologicamente effettiva, cioè operativa, la possibile
negazione del principio d’identità secondo cui l’essere è ed è impossibile che non sia
(in questa prima tesi si potrebbe vedere un elemento di antieleatismo dell’ontologia
negriana – a lato dell’identità): «L’essere è, il non-essere non è: recita l’antico adagio.
Ma oggi l’essere può non essere» (FS 44). Il non essere, il non esistere è posto nella
«cellula» dell’essere – come sua possibilità ontologicamente equivalente. E se è posta
la possibilità che il non-essere sia, ovvero che il niente, in quanto opposto a ciò che è
(non in quanto inerisce ma in quanto sussiste), divenga essenzialmente potente e
operativo, allora è tolto ogni riferimento alla necessità che l’essere permanga identico
a se stesso, uno e immutabile. L’uno è già dualizzato: uno ed essere che può non
essere. Ma tutto ciò, attenzione, nella misura stessa in cui l’universo produttivo è
stato sussunto nel capitale. Come s’è anticipato: l’essere è impiantato nel lavoro, è
concreto – non ve n’è un altro. (Arrovellarsi nell’immagine, nell’essere in sé astratto,
non porta in alcun luogo che non sia già l’essere del pensiero da cui il pensiero stesso
muove, cioè una postulazione. Per uscirne occorre interrogarsi sulle condizioni di
Testo che costituisce la prima parte di: Fabbriche del soggetto , cit., pp. 35-150; tale volume è nuova
edizione della precedente stampa (quasi clandestina e con sottotitolo assai significativo per il profilo che
c’interessa): Negri, A. (1987), Fabbriche del soggetto. Profili, protesi, transiti, macchine, paradossi, passaggi,
sovversioni, sistemi, potenze: appunti per un dispositivo ontologico , Carrara: Cooperativa Tipolitografica.
10
�18
G U IDO B OFFI – G IA C OMO C LE ME NTE
verità del pensiero stesso: torneremo a trattarne in fine, ma già da ora possiamo
sostenere che l’ontologia negriana ne è ben consapevole, nel momento in cui
impianta nel lavoro, come s’è inteso, non soltanto l’essere ma la verità stessa).
2. Seconda tesi: «L’essere rivela dunque una natura etica: esso, per esistere, è
sottoposto alla volontà, alla soggettività, all’etica» (FS 58). La sussunzione reale è
negazione pratica di ciò che è, della postura dell’esistente e della materia conativa,
desiderante dell’essere il quale consiste, di nuovo spinozianamente, in forza
produttiva, autoesistentificantesi attraverso i modi concreti della sua sostanzialità
(come si capisce, i modi del lavoro vivo). Da qui assume nuova qualificazione la
possibile non sussistenza dell’essere già individuata. In quest’orizzonte pratico spetta
all’etica, concretamente alle soggettività che prendono corpo, alla decisionalità delle
menti, affermare l’essere sull’orlo non assicurabile della sua caduta, la sua
spontaneità esposta a rischio, l’esistenza che, proprio arrischiandosi, può rinnovarsi.
Ancora: spetta di produrlo e riprodurlo e svilupparlo, precisamente però in quanto
già subordinato al potere nullificante della sussunzione. Potere annichilente il quale –
dovrebbe risultare ovvio ma si può esplicitare – non coincide con la negatività della
finitudine né con l’insostanzializzabile nulla metafisico. Parafrasando lo Hegel della
Fenomenologia e Žižek in una volta sola: è con questa «immane potenza del
negativo», quella della sussunzione reale nel capitale, che occorre «fare (e rifare) i
conti». Dunque, la possibilità che l’essere non sia sdipana una tensione pratica la
quale, proprio perché urgente tra ontologia – se già non si debba dire «metafisica» –
materialistica ed etica, non può non porre di continuo il problema del controllo delle
forme in cui essa stessa si estrinseca. Alla base v’è una polarità precaria che vede, da
una parte, nella sussunzione reale, per così dire l’agente della distruzione al limite
dell’annientamento totale, dall’altra, il soggetto produttivo come agente dello
sviluppo e della crescita. Si potrebbe dire che in questa tensione costitutiva la
contingenza assoluta abbia preso essenzialmente medesima figura della necessità
scindendosi da essa, sia appunto smisuratamente «sciolta» da essa (o, meglio ancora,
che natura etica dell’essere sia il suo fare-corpo a fronte alla necessità-assolutezza
della contingenza). Aprire l’essere sino all’estremo lembo possibile del suo opposto
assoluto e qualificarne con l’eticità la naturale tendenza alla dismisura («l’etico, nel
materialismo, si confronta sempre alla dismisura» K 72) significa costituirlo
essenzialmente nella contingenza assoluta. Ovvero: fare della possibilità il suo
attributo necessario. «La radicale contingenza dell’essere non è semplicemente
possibilità di un punto catastrofico – è una tendenza, è un’essenza, è un fluire che ha
la stessa estensione della costruttività umana dell’essere» (FS 52). Ma appunto perché
essenziale, la sua tendenzialità non viene mai totalmente annullata. Rimane
immanenza. «Immane» crescendo su se stessa e rimanendo ogni volta compiuta e al
tempo stesso arrischiata nella precarietà, nell’esposizione: è ogni volta eccedenza e
accrescimento d’essere, pur tra molteplici discontinuità, cedimenti o strappi. È bensì
contingenza dell’essere, tuttavia l’essere della contingenza non soltanto non può
�19
Sul concetto di metafisica per Toni Negri
essere interamente annullato, ma è come tale già compiuto e rilanciato,
assolutamente a rischio su un’altra linea di cresta.
3. In ultimo (terza tesi): «attraverso la scoperta della contingenza noi poniamo in
termini radicali il problema del fondamento» (FS 59). Se la possibilità determinata
eticamente a fronte della sussunzione reale dell’essere – cioè del vivente, giacché ogni
singolare «questo qui», ogni cosa che è prende vita o la perde nell’affermazione
dell’esperienza –, dicevamo, se la possibilità determinata eticamente è un’essenza, e
se la tensione contingente sdipana la polarità dell’essere e del non-essere quali
alternative opposte; se, in ultima istanza, è negata ogni possibilità di togliere la
possibilità (di qui la necessità della contingenza radicale come prius) – allora è negata
ogni posizione ultimativa che stabilisca il fondamento come elemento esplicativo,
causale, originario o principiale di una totalità già determinata o che esso stesso
determina subordinatamente (vedremo in seguito come dire che l’etico è il
fondamento significhi ripetere per altro vertice teorico questa negazione
fondamentale). «Qui il fondamento non è il punto a partire dal quale il mondo si
spiega – al contrario, questo fondamento è il punto a partire dal quale si dà il
massimo allargarsi della dimensione della possibilità» (ibid.). E ancora: «Il
fondamento non è quindi il più semplice degli elementi nei quali possiamo
scomporre il linguaggio etico e logico, quasi il seme da cui sorgono gli alberi della
vita: no, il fondamento è qui una cellula che può scindersi nella vita e nella morte,
l’elemento semplicissimo dell’affermazione, della negazione, dell’essere e del non
essere» (ibid.). Ma non si fraintenda astrattamente: tale simplicissimum è elemento di
un’indicibile potenza e complicazione. Vediamo perché.
4. Nella filosofia prima classica il fondamento semplicissimo, e perciò vero e
veritativo (con Foucault: aleturgico), consisteva aristotelicamente in ciò per cui
qualcosa è o diviene o è conosciuto – chiamato arché, reso di volta in volta anche con
«origine» o «principio» in modo sinonimico, fu ciò che i latini tradussero con ratio:
ratio essendi, fiendi, cognoscendi. Nel trascendentalismo kantiano, sulla base della
caratterizzazione e ridenominazione leibniziana di tale problematica come esigenza
del «principio di ragion sufficiente» (la ratio [Grund] per la quale il «questo qui» è ciò
che è, quindi non è contraddittorio assumerne realtà e conoscibilità), la ratio è il
fondamento che permette di spiegare la costituzione analitico-sintetica (soggettiva)
dell’esperienza (oggettiva). Il fondamento viene epistemizzato, desostanzializzato,
reso nella «semplice» funzione veritativa dell’«io-penso» sganciato dalla questione
della garanzia metafisica – con tutte le criticità che possono essere sollevate al
criticismo stesso, e in generale al trascendentalismo, quanto a «logica della
rappresentazione». Ovvero quanto a presunzione di manifestare verità radicate in
pure identità soggettuali e oggettuali – al proposito i grandi libri di Deleuze,
Differenza e ripetizione (1968) e Logica del senso (1969), hanno trasmesso una
�20
G U IDO B OFFI – G IA C OMO C LE ME NTE
lezione magistrale, ben presente nelle pagine negriane. Il fondamento-origine, l’arché
dall’antico a tutto il moderno, è sempre valsa come unità-identità sovrana, ordinativa
e predeterminante, sia nel senso di principio ontologico-metafisico, sia nel senso
epistemico-trascendentale quale inizio della verità (del conoscere). Nell’uno e
nell’altro caso il suo punto di vista ha subordinato qualsiasi scena di
rappresentazione (e di rappresentanza sul piano politico retto dal potere
autolegittimantesi) ostile al differente in sé, a ciò che è recuperabile per qualsiasi
tramite e trafila al punto sovrano, eccezionale, sovraunitario, dell’identità.
5. In Negri la logica della rappresentazione è soppiantata dall’espressione della
soggettività (appunto: Spinoza-Deleuze!) e dalla dinamica produttiva
dell’immaginazione, su cui torneremo a breve ma che già da ora va intesa,
spinozianamente, non per la sua inadeguatezza conoscitivo-rappresentativa bensì
come apertura ontologica e costituente su cui far leva per produrre soggettività
sociale, per costruire il mondo. Sulla base dell’Ethica: «l’immaginazione è fisicità che
raggiunge intelligenza, il corpo che si costituisce in mente. […] L’immaginazione è al
cuore dell’ontologia costitutiva perché è al centro ed è il suggello della continuità,
dell’univocità assoluta dell’ordine dell’essere. Perché è, di questo, il motore
dinamico» 11. Il che permette, Negri à la Spinoza, di concludere: «la ratio cognoscendi
diviene, attraverso l’immaginazione prospettica e costitutiva, ratio fiendi» (K 32).
Ora, e questo snodo è decisivo per entrare nella costitutività del fondamento, ciò
mette nelle condizioni di capire che il fondamento a partire dal quale si dà il
massimo allargarsi della dimensione della possibilità è, infine, il corpo – un corpo,
ogni singolo corpo interagente nell’essere comune dei corpi. Il fondamento è
singolarissimo. La potente organizzazione dell’avvenire va colta pertanto in senso
ontologico – ciò che Negri scrive con una sola «v»: avenire –, giammai futurologico.
La modellizzazione futurologica proietta in un indefinito domani. Rientra infatti nel
trascendentalismo o nell’utopismo, e in ogni caso agita chimere. Nell’ontologia del
materialismo, qui più che mai risonante con il «materialismo del desiderio» che
Negri legge ancora in Spinoza, il radicamento-fondamento carnale è garanzia
assoluta, «immanentemente metafisica», del cosiddetto passage à l’acte, alla
costruzione pratico-politica della tendenza d’essere. Sulla scia di Marx, vale in
quanto spinta «a ricercare, sul ritmo dell’immaginazione (che fin qui abbiamo visto
collegare ratio cognoscendi e ratio fiendi), l’ulteriore passaggio alla ratio agendi,
perché l’immaginazione è sempre etica» (K 32-33). Cioè «carne» dei corpi che
agiscono e interagiscono.
Negri, A. (1981), L’anomalia selvaggia. Saggio su potere e potenza in Baruch Spinoza , Milano:
Feltrinelli (d’ora innanzi nel testo: AS), pp. 260-261.
11
�21
Sul concetto di metafisica per Toni Negri
III
Tolto alla razionalità della misura il lavoro diviene male .
A. Negri
12
Ci troviamo nei pressi della vita di Giobbe (per taluni aspetti, della vita politica di
Negri e di un passaggio d’epoca che concerne forme culturali alte e basse, modalità
d’aggregazione sociale, ideologie, dispositivi istituzionali). Non bastasse, il
personaggio biblico vale ad exemplum pure di quell’ontologia leopardiana sulla
quale si addensano le contemporanee, fitte pagine critico-filologiche di Lenta
ginestra 13, dov’è la poesia a farsi «rottura dell’esistente, del solido esistente che ci
abbraccia», essendo intera «nell’ultimo Leopardi la consapevolezza di tutti questi
elementi […]: la rottura poetica, l’innovazione ontologica, l’alternativa etica» (G 437).
Vi torneremo presto. Ma per il momento stiamo a Il lavoro di Giobbe, la cui
redazione s’incastona per qualche tempo nella più lunga gestazione del saggio
dedicato all’ontologia di Leopardi – e si badi alla determinazione nello spostamento
discorsivo che il titolo impone, per dir così, sin dalla copertina: dal «libro» di Giobbe,
che parla a Dio e bestemmia con fondamento, al «lavoro» di Giobbe, che parla e
bestemmia del «fondamento» oppresso del lavoro vivo. Nella visione negriana, ci
pare di poter intendere, Giobbe si fa «ontologo elettivo» precisamente in quanto
«lavora» al nome stesso di lavoro, ai lineamenti della sua attualità, all’urgenza della
liberazione-ricreazione del suo essere vivo. Vediamo subito come: «Giobbe lavora – il
suo chiedere ragione del male, la sua bestemmia e la sua protesta contro lo
sfruttamento, la sua sfida al comando sono la macchina ontologica del rinascere
della passione. Scendiamo dunque con Giobbe nel punto più profondo della
creazione, risaliamo con lui fino al punto più alto dell’esperienza etica – laddove egli
ha di petto Dio stesso» (LG 18-19).
1. Nel suo corpo a corpo con Dio, cioè nella rottura del rapporto fondativo tra
l’uomo e il divino che costituisce il reale, nello «strazio della carne», nell’invettiva,
Giobbe dà voce all’assolutezza del contingente. La sua rottura è il rifiuto,
l’irriducibilità del contingente stesso a un piano d’essere generale. Neppure Dio può
sanare il dissidio in cui è posto in questione. Non v’è dialettica che lo possa risolvere
o aggirare. In tal senso sono due assoluti a scontrarsi, dove nessun logos può
mediare: quello di Giobbe, quello di Dio – eccetto che Dio è parte in causa e insieme
giudice del processo che ne viene istruito. È parte e insieme tutto. È (potere) inclusivo
ed esclusivo: inclusione escludente? A ben vedere se l’assolutezza di Giobbe (del
contingente) è ontologica, la sua presa di parola è già innovatrice: non lascia
Id., Il lavoro di Giobbe, cit., p. 30.
Negri, A. (1987), Lenta ginestra. Saggio sull’ontologia di Giacomo Leopardi, Milano, SugarCo;
nuova edizione (2001), Milano: Mimesis (d’ora innanzi nel testo: G).
12
13
�22
G U IDO B OFFI – G IA C OMO C LE ME NTE
l’orizzonte dell’essere così com’è. Smuove tutto – smuove Dio stesso (l’eterno, l’essere
indefettibile necessario sovrano). Appunto perciò non può darsi superamento del
contendere. Perché l’assoluto potere inclusivo (di Dio), il suo mettere Giobbe a parte
e da parte, risulta disintegrato dalla singolarità liminare ma irriducibile
dell’eccedenza produttiva di Giobbe stesso, che mai potrà essere parte, proprio
perché l’assolutezza della sua contingenza lo «scioglie» da qualsiasi vincolo
includente, totalizzante. Non «parte» né «controparte», né «potere» né
«contropotere»: l’assolutezza di Giobbe è nel suo essersi già sottratto al gioco
processuale (dialettico) della totalizzazione, alle strategie della sussunzione, alle
definizioni del potere. Giobbe è un altro assoluto: non però come parte né come altro
intero nel suo ergersi «contro». È assoluto come frammento che produce la propria
soggettività, pezzo-evento di macchina ontologica la quale viene costituendosi,
crescendo su se stessa proprio mentre produce l’accrescimento-intensificazione
d’essere fuori da qualsiasi modello, ordine, schema del Tutto. Altrimenti detto:
Giobbe è da assumere quale exemplum dell’umana creazione di valore e produzione
d’essere, del processo di autovalorizzazione (del lavoro vivo): eppure, si badi, ciò
solamente in rapporto a un potere trascendente (e sovrano: il potere è sempre, qua
talis, trascendente e sovrano) assoluto, spropositato, violento, arbitrario che egli,
figura del contingente, interpella, bestemmia, combatte per mettere in crisi. Giobbe è
Giobbe dentro quel rapporto tragico nel quale Dio è soltanto cagione di dolore (e
quindi del rifiuto di Giobbe). In fondo, si potrebbe vedere metaforizzata nel dolore di
Giobbe, nell’esperienza annichilente dell’incommensurabilità, l’esperienza stessa
della classe operaia dopo la trasformazione dell’intero assetto sociale investito dal
capitale. L’indeterminatezza della legge di valore, la smisuratezza della sussunzione,
la subordinazione caotica: ciò è male. E ci riguarda da presso. «Giobbe come sfondo
(e forse come parabola), come condizione (e forse come analogia) del nostro
procedere» (LG 36).
2. Si Deus est, unde malum? Si malum est, cui Deus?: nel quadro ontologicometafisico in cui ci siamo messi sulla scia di Negri, l’interrogativo risuona quale
variante teologica del problema della sussunzione o, più propriamente, quale
necessità di assumere lo sfondo teologico in quanto è ciò che consente di poter
rispondere alla «questione della fondazione, la questione della genealogia. E cioè
dell’origine del valore e della dinamica del suo sistema, quindi del valore del lavoro e
delle sue trafile creative» (LG 36). Nella seconda tesi del paragrafo precedente (cfr.
supra, II.2) s’è visto come la radicale contingenza sia la base qualificativa dell’essere.
Giobbe, che proietta la sua esperienza nel campo dell’ontologia – ovvero, il cui
dramma è ontologico –, si trova nella stessa condizione: «L’esistenza si rivela a
Giobbe come contenente il suo opposto – la non esistenza. Nel contingente sta la
possibilità della sua distruzione, del suo annullamento» (LG 47). È in questa
possibilità che s’innesta il male. S’impianta cioè in un terreno che è antidialettico
�23
Sul concetto di metafisica per Toni Negri
perché antidialettica è la rottura costitutiva del rapporto di Giobbe con Dio (un
rapporto definito da una guerra assoluta in cui il servo e il padrone non sono uno per
l’altro, nella quale cioè «il riconoscimento comporta semplicemente l’altro» LG 49).
Questa è la situazione metafisica. La rottura che, nel rifiuto, si sottrae all’essere
necessario producendo l’evento, proprio essa pone nella figura di Giobbe la
questione del calvario creativo del valore (valore-lavoro). Si apre così in maniera
costruttiva-creativa il questionamento delle pratiche ontologiche della dismisura
rispetto alle misure del mondo stabilite dalla sovraunità divina di tutto metro. Il
problema, allora, si pone nella «fondazione di un altro ordine di valori, non sulla
misura del mondo ma contro, alternativamente, in luogo di, questo mondo
d’ingiustizia e di dolore» (LG 78). Come s’è capito, si profilano le tematiche
(squisitamente marxiane, dunque ontologiche) della trasformazione e
dell’innovazione. Con queste si aprono i fronti problematici dell’autovalorizzazione e
della transvalutazione, stagliati su un orizzonte di insignificanza (quello posto dalla
sussunzione reale al capitale), una volta che il comando della trascendenza
assiologica è stato interpellato e disconosciuto come folle, bestemmiato nel suo
assoluto potere mortificante, combattuto sino allo strazio. «Transvalutazione» è
termine messo a tema nelle lezioni su: Kairòs, Alma Venus, Multitudo, ma il
problema cui cerca di trovare una linea di fuga costruttiva è certamente quello che
abbiamo appena considerato in Giobbe. Non si tratta, si badi, di un’opzione etica
(appunto come non sono primariamente etici ma ontologici l’interpellazione e il
dramma di Giobbe): di fatto, la transvalutazione è già stata messa in moto
ontologicamente nell’orizzonte dell’investimento della vita di ogni singolo vivente da
parte del potere (del capitale), dalla dematerializzazione dei processi lavorativi e dalle
trasformazioni della conflittualità sociale. Come s’è detto è la vicenda dei biopoteri
nell’epoca e sull’orizzonte ontologico del biopolitico. Non soltanto i valori sono
transvalutati: con essi i linguaggi, le pratiche comunicative e relazionali, le forme
organizzative e cooperative delle energie sociali, le procedure decisionali e le forme
di sfruttamento – e si potrebbe continuare, sfaccettando la singolarissima,
differenziata attività dei corpi viventi, ma anche l’uso e l’assoggettamento.
3. Giobbe è ed è assolutamente possibile che non sia: Dio è assolutamente e può
assolutamente tutto. E se Dio può tutto, se cioè Dio è il potere (sovrano) assoluto
posto a lato della distruzione e della pena, allora la teodicea sembra svolgere una
funzione strategica fondamentale. Essa – che è la spiegazione predisposta a rendere
giusta l’azione divina interpellata dal reclamo – può essere detta la disciplina
teologica atta a ristabilire una misura al valore in luogo della sua smisuratezza, a
dialettizzare il male, a sciogliere la tensione precaria che la contingenza comporta a
lato della sua comprensione analitica. Ovvero: a porre analiticamente l’illusione della
misura – a dare senso allo sfruttamento. «La divina giustizia vive una teodicea
dialettica» (LG 61). Così per gli avvocati di Dio, perfette figure del trascendentalismo:
�24
G U IDO B OFFI – G IA C OMO C LE ME NTE
Elifaz, per il quale la giustizia retributiva è immanente sul piano dei rapporti umani
(versione trascendentale della teodicea); Bildad (nella sua versione trascendente: la
giustizia immanente è garantita dall’onnipotenza divina); in ultimo, Zofar (e la sua
variante mistica: bisogna cedere a questo ordinamento). Ciò che rileva è, di nuovo, il
fatto che queste figurazioni, nel loro variare, siano accomunate dal progetto
dialettico-trascendentale di instaurare una misura dettata dalla necessità di una
regola retributiva, ovvero da un’istanza unitaria di misura e d’ordine che, dall’alto,
premi e condanni. Tale sforzo dialettico è teso a garantire, nella trama del senso che
è il mondo nella sussunzione, una triangolazione lineare e geometrica tra valore
lavoro e giustizia. Ma questa triangolazione lineare salta con la dissoluzione
dell’ontologia (politica) costruita attorno alla centralità della trascendenza, alla sua
sovrastante unità assoluta (il potere sovrano), e il costituirsi in suo luogo dei nuovi
ordinamenti biopolitici (ovvero dei biopoteri) con la conseguente trasformazione del
campo di cose che siamo soliti categorizzare come «realtà». Cambia il quadro
ontologico perché muta il campo del lavoro, infine pienamente «socializzato»: «Ecco
dunque il primo punto. Valore, lavoro, giustizia non si ripartiscono secondo una
comune misura. Quanto più il mondo è costituito da una trama unica di valore, e
ognuna delle espressioni naturali e storiche ne è manifestazione, tanto più questa
comunanza si rivela insensata» (LG 65). È la dialettica, dunque, che Giobbe non può
non rifiutare urtandosi alle argomentazioni degli avvocati di Dio. Vi si urta di fatto,
per i suoi gesti, per la sua passione, anche qualora l’urto non ricorresse fra le sue
intenzioni.
IV
Con l’essere libero, autocosciente, sorge al contempo un intero mondo dal nulla –
l’unica creazione dal nulla vera e pensabile .
Hegel (?), Schelling (?), Hölderlin (?)
14
Se mai fosse possibile ristabilire, oggi, una giusta misura tra valore e lavoro nel
dominio della sussunzione reale, sarebbe come se al male inflitto da Dio si
aggiungesse l’oltraggio della sua comprensione. Insostenibile. Al contrario, qui si
tratta di restituire ontologicamente l’immediatezza dell’esperienza contro la
mediazione dello schematismo della ragione. Ecco il punto che rileva sottolineare:
«La teoria del valore, nelle sue diverse dimensioni e applicazioni, è la forma più alta
nella quale si presenti l’analitica trascendentale» (FS 56). Tutto, nello scenario
Hegel, G.W.F. (?), Schelling, F.W.J. (?), Hölderlin, F. (?) (2007), Il più antico programma di sistema
dell’idealismo tedesco, Introduzione, traduzione e commento di L. Amoroso, Pisa: ETS, p. 21. Forse
redatto comunitariamente ai tempi dello Stift dai giovani Hölderlin Hegel e Schelling, il testo è giunto
a noi per un autografo di mano hegeliana risalente all’inizio estate 1796.
14
�25
Sul concetto di metafisica per Toni Negri
ontologico delineato fin qui, si colloca anche in una sorta di decostruzione delle
categorie kantiane. Negri le strappa a vivo dal loro contesto filosofico per impiantarle
nel campo d’immanenza materialistico, bruciando l’illusorio orizzonte del
trascendentalismo che ne racchiuse il chimerico fulgore durante la modernità, dalla
quale separa una cesura ontologica definitiva – come pure ne risulta
automaticamente azzerata l’assunzione nell’analitica e nell’eidetica razionali del
neokantismo. Tale pratica quasi decostruttiva negriana si esercita sul Programma di
sistema che sta al fondo della filosofia classica tedesca 15. Il punto di arrivo è, ancora
una volta dopo quella prodotta nel corpo a corpo con il pensiero di Spinoza,
un’anomalia: forse non del tutto «selvaggia» ma certamente giunta, attraverso Kant e
contro Kant, a un trascendentale corposo e corporeo, empirico ed espanso, denso.
Dunque, un trascendentale irreperibile sulla mappa della disgiunzione criticokantiana fra essere fisico e razionale (noumenicità oceanica), da un lato, e, d’altro
lato, apparire della verità (fenomenicità terrestre, insulare), così com’è disegnata nella
prima Critica; fra gittata teleologicamente-riflessivamente metafisica e gittata
determinatamente-scientificamente ontologica dei giudizi, al modo in cui vi si
affatica la terza Critica. Ora, come s’inserisce questo «lavoro» negriano sul
trascendentale nel quadro delineato sin qui? Quali forme e quali dimensioni di
significato assume?
1. Una prima risposta è, a ben vedere, già nelle premesse. Si tratta, com’è evidente
proprio a partire dalle disgiunzioni kantiane, del riposizionamento di un nesso,
quello tra epistemologia e ontologia. Ciò non toglie che permanga un resto da
interrogare, sul quale apriamo la nostra questione: qual è la funzione di uno
schematismo trascendentale oggi, ben più di due secoli dopo l’epoca di Kant? Quali
significati assume entro un esercizio di attività critica, qual è interamente la filosofia
di Negri, che vuole cogliere questo tempo e orientarvisi? Come vi «lavora» per
costruire il destino di questa realtà, per interpretare il tessuto delle sue
trasformazioni (quasi in un paradossale rovesciamento della celeberrima undicesima
glossa marxiana a Feuerbach), per elaborare una testimonianza del mondo?
Possiamo anticipare il nocciolo di una risposta. È possibile prefigurare uno
schematismo che trovi nell’immaginazione la sua macchina di produzione ontologica
In Fabbriche del soggetto Negri scrive: «Questo testo mi ha sempre sconvolto. Potrei dire che tutta
la prima fase del mio lavoro filosofico maturo (negli anni Sessanta: dallo studio sul formalismo dei
giuristi kantiani fino alla traduzione e al commento degli scritti di Hegel del 1802-1803, dagli studi
sulla macchina dello Stato alle parallele ricerche sul cartesianismo nell’ideologia politica e statuale) –
che questa prima fase matura di lavoro filosofico non sia stata dunque altro che una riflessione
sull’attualità di questi temi: riprendendone la fortissima valenza critica, e cioè guardando come l’opera
umana della libertà venga resa meccanica e ridotta al nulla dai grandi poteri che le si oppongono: la
natura produttiva e lo Stato», (FS 38-39).
15
�26
G U IDO B OFFI – G IA C OMO C LE ME NTE
e nell’estetico (cioè nel sensorio-sensibile, nell’affettività, nella comunicabilità, nei
corpi, nel tutto predato dalla sussunzione reale) il campo di una battaglia, di una
costruzione di libertà. Ora, non ci si deve nascondere che in questo lavoro negriano a
un’estetica trascendentale materialistica vi sia, indubbiamente, anche uno sviluppo
della rilettura dell’estetica trascendentale kantiana fatta da Deleuze – e, con ciò, la
traccia di un pensiero comune che oggi, ex post, risuona come un omaggio di Negri
al grande filosofo e all’amico. Ma torniamo ad argomentare per gradi.
2. Analitica e dialettica (è possibile allacciare in un’equivalenza effettiva queste
categorie critiche nella misura in cui l’esercizio dialettico risulti inscritto nella
legittimazione del trascendental-idealismo) rappresentano il tentativo di costituire
l’esperienza ora depurando ora mediando la negazione o, che è lo stesso, muovendo
dalla cattura delle istanze immediate della contingenza. A partire cioè dalla
mistificatoria comprensione di una radicale negatività che, con ciò, viene
neutralizzata nelle sue istanze immediate e ricondotta alla circolarità indifferente
della trama del senso: «La dialettica diviene dunque una ‘realistica’ accettazione del
negativo – con tutte le capriole che si vuole e che la funzione dell’Aufhebung
largamente permette» (G 380). Ogni teoria del valore in quanto teoria della misura
resa operativa nell’ambito della sussunzione conduce dunque a perversioni pratiche
effettive: tutto fuorché innocua, l’analitica rivela nel contesto della sussunzione la
«capacità capitalistica di comando attraverso gli strumenti del nuovo dominio e della
stessa produzione di soggettività» (FS 28). E tuttavia, cosa impedisce ogni possibilità
di mediazione se non precisamente la natura etica dell’essere, ovvero la presenza di
un’istanza smisurata qual è quella dell’evento di contingenza? È nella precarietà
dell’opposizione radicale (dell’essere e del non essere) che s’innesta l’impossibilità
della sua comprensione. Alla totalità della riflessione è sostituita la separatezza della
costituzione: l’essere costituito non è il non essere da cui parte la costituzione –
vedremo poi come questa fondazione attraversata da una radicale alterità costituisca
una seconda tesi antieleatica (a lato dell’eternità). V’è stata generazione d’essere
autopoietica; v’è stata creatio ex nihilo. Alla necessità della comprensione è sostituita
la radicale precarietà della tensione: l’essere è, appunto, frutto della sua produzione.
Da questo punto di vista l’ontologia diviene etica, nel senso di un rapporto di
equivalenza assoluta che situa la pratica nell’ambito della possibilità dell’essere come
suo attributo necessario (cioè, nell’ambito della non identità, della differenza).
3. «La ragione ha costruito la sua analitica, dentro la quale lo studio
dell’esperienza ed il riferimento al reale sono stati di volta in volta depurati o
distrutti» (FS 49). A partire da questa impossibile presa sulla realtà, la comprensione
si preclude di poter essere assunta nel dominio della riflessione (e con ciò, lo
vedremo più avanti, è resa impossibile una teoria della verità nei parametri
dell’epistemologia classica fondata sull’adeguazione dell’intelletto alla cosa
�27
Sul concetto di metafisica per Toni Negri
sussistente). Ogni pensiero analitico che volesse pensare il campo dell’esperienza in
quanto campo della contingenza incorrerebbe nelle contraddizioni logiche inerenti
all’inverificabilità delle determinazioni nel campo dell’indeterminatezza.
Incorrerebbe cioè in «contraddizioni irresolubili che partecipano dell’intero
meccanismo concettuale che regge ogni tentativo di costruzione di un’analitica della
ragione – logica o etica» (FS 53). Altro non può essere il compito: ristabilire
l’immediatezza dell’esperienza, della potenza ontologica di autodeterminazione,
assumere il fondamento (contingente e singolarissimo) come assenza-separatezza del
fondamento (universale) e collocarsi nel ventaglio massimale della possibilità.
Un’etica – è così che inizia, rivoluzionariamente, il Programma di sistema
dell’idealismo tedesco. Un’etica deprivata della trascendenza assiologica, impiantata
però nei processi spontanei, sensibili, corporei dell’essere autocostituitosi sul
presupposto assoluto della sua nullificabilità – e per ciò, un’estetica. Un’estetica
trascendentale che principia da un’etica, avendo di fronte la condizione metafisica
della distruzione, per dir così l’incondizionato della distruzione, al pari di Giobbe di
fronte a Dio. L’essere è ed è possibile che non sia – collocarsi nel terreno dell’estetica,
del non identico implica fare del paradosso metafisico fondamentale il proprio
contenuto di liberazione, presupporre tale paradosso e porvisi di fronte nell’ambito
della produzione d’essere. Insomma: lungi da qualsiasi – impossibile, come s’è
ripetutamente detto – dialettica negativa, proprio nullificabilità e distruzione aprono
alla riconquista dell’esperienza, della prassi. Aprono al dislocamento del fare e
dell’essere su bordi ancora da produrre. Altrimenti detto: sui bordi di
un’autodeterminazione veemente, strategica, ricostruttiva, in fieri. «Un essere
fondamentale perché lo si può distruggere o ricostruire, un fondamento che è
contingenza assoluta. E la singolarità viene determinata dalla tensione che la
contingenza comprende in definizione. L’estetica trascendentale viene così
positivamente determinandosi» (FS 67). Nei corpi, che sono sempre anche menti:
«corpomenti al lavoro».
4. Abbiamo scritto: «attraverso Kant e contro Kant». Ci sembra arduo uno snodo
teoretico a quest’altezza senza pensare, se non discutere, le pagine di Negri con
Deleuze – come s’è anticipato. Appunto perché snodo teoretico, risulta meno
rilevante che sul punto i testi negriani non rechino tracce, pur a fronte di numerosi
riconoscimenti all’ontologia deleuzeana (e deleuzeana-guattariana) dell’immanenza,
impiantata con una metodologia materialistica ed esplicata con una pragmatica
altrettanto materialistica16 . Certamente Deleuze e Negri hanno in comune talune
amicizie e inimicizie: fra queste ultime, tanto per farla breve, proprio quelle nei
S’intravede come uno scavo ancora tutto da compiere, ma che andrà svolto presto, quello tra
Deleuze Guattari Negri.
16
�28
G U IDO B OFFI – G IA C OMO C LE ME NTE
confronti di Kant ed Hegel. Muoviamo però da un nucleo teorico comune, in medias
res, e di per sé nient’affatto scontato nella letteratura critica su Kant: il sapere del
sensibile (l’estetica quale forma di sapere – scienza – che verte su di esso) deve
cercare l’unità di condizione e condizionato nell’essere del sensibile stesso. Via
negationis: l’estetica non può risolversi formalmente-trascendentalmente in una
teoria dell’esperienza possibile secondo la macchinazione analitico-sintetica
dell’intelletto (senza la quale per Kant invece il sensibile sarebbe pura rapsodia)17. Il
piano della generalità-universalità-possibilità e quello della realtà devono convergere:
ma nella realtà fisico-sensibile stessa – così convergeranno estetica (in senso
trascendentale) e filosofia delle arti, altrimenti destinate a permanere i «due campi
irriducibili» dell’estetica 18 , vincolati da essenziale dissidio. Nessuna fondazione
eteronoma, nessun dualismo tra realtà e possibilità devono essere ammessi, e
concessi, con il trascendentale, solo che l’estetica (più in generale la filosofia) non
vogliano scindere analisi e piano di realtà, mathemata ed essere sensibile. Il
trascendentale stesso va perciò esperito-sperimentato, calato nell’esperienza genetica
del «questo qui», che è sempre un «differente». Anzi, il trascendentale diviene
suggello della singola cosa reale presente nella sua hæcceitas. Lungi dal poter
continuare a sussistere scorporato, nella pura formalità su cui s’impianta l’apriori, il
trascendentale deve potersi incorporare all’«essere del sensibile». «Vero è che
l’empirismo diviene trascendentale, e l’estetica una disciplina apodittica quando
afferriamo direttamente nel sensibile ciò che può essere solo sentito, l’essere stesso
del sensibile: la differenza, la differenza di potenziale, la differenza d’intensità come
ragione del diverso qualitativo» 19.
5. L’empirismo e l’estetica, con Deleuze e Negri, ricreano il trascendentale
affermandolo nella differenza del corpo singolarissimo, che lo fonda. La mossa è
epistemologico-teoretica e ontologica. Rispetto alla tradizione del trascendentalismo
e dell’idealismo moderni, la macchinazione dualistica tra identità/differenza,
uno/molti risulta completamente arrestata e messa fuori uso. Non sussiste
trascendenza, se non nel senso materialistico di soprassalto eccedente e
irrappresentabile dell’essere sensibile stesso, singolarissima differenza che piega
senza poter essere spiegata. Trascendenza tutta immanente (come sono quella
dell’inconscio o dell’«avenire»). Infatti, deleuzeneamente, il non rappresentato è,
«È strano che si sia potuto fondare l’estetica (come scienza del sensibile) su ciò che può essere
rappresentato nel sensibile, anche se in verità non è migliore il procedimento inverso che sottrae alla
rappresentazione il puro sensibile, e tenta di determinarlo come quel che resta una volta che la
rappresentazione sia abolita (per esempio un flusso contraddittorio, una rapsodia di sensazioni)»,
Deleuze, G. (1971), Differenza e ripetizione, trad. it. di G. Guglielmi, Bologna: il Mulino, p. 99.
Ivi, p. 116.
Ivi, p. 99.
17
18
19
�29
Sul concetto di metafisica per Toni Negri
come abbiamo appena letto, l’essere stesso del sensibile: la differenza, forse meglio: il
singolarissimo differente in sé. Ora, se tale differente in sé valesse puramente e
semplicemente in quanto non-identico, risulterebbe altresì esposto al rischio della
propria assolutizzazione astratta, al limite dunque della costituzione (sovrana) di
un’altra identità assoluta. Di fronte a ciò sta un’alternativa: o la comprensionericomprensione del non-identico (cioè della negatività dell’eccedente differente)
nell’identico, in un ripristino infinitizzato della rappresentazione (perché il rinvio
speculare a rigore – di diritto – potrebbe non trovare fine) e dunque l’inassumibilità
del differente (dell’essere sensibile) in quanto differente; oppure l’affermazione della
negatività in quanto positiva (posizione della) differenza d’intensità del differente –
immanenza. È questa irriducibile differenza di potenziale, d’intensità, a fare
l’assoluta singolarità dell’essere sensibile (nei termini usati precedentemente: della
«contingenza»). L’essere sensibile-contingente è «corposamente-mentalmente»
multiplo – ma non è multiplo dell’uno irrelato, estensione quantitativa che ne
ripristina la sovranità. È multiplo (multitudo) di singolarità differenti (corpi) in
quanto differenze intensive, potenzialità d’essere correlabili e confliggenti.
V
[…] Or non aggiunse
Il ciel nullo conforto ai nostri affanni;
E teco la mortal vita saria
Simile a quella che nel cielo india.
[…] E potess’io,
Nel secol tetro e in questo aer nefando,
L’alta specie serbar; che dell’imago,
Poi che del ver m’è tolto, assai m’appago.
Se dell’eterne idee
L’una sei tu, cui di sensibil forma
Sdegni l’eterno senno esser vestita,
E fra caduche spoglie
Provar gli affanni di funerea vita;
O s’altra terra ne’ superni giri
�30
G U IDO B OFFI – G IA C OMO C LE ME NTE
Fra’ mondi innumerabili t’accoglie,
E più vaga del Sol prossima stella
T’irraggia, e più benigno etere spiri;
Di qua dove son gli anni infausti e brevi,
Questo d’ignoto amante inno ricevi 20.
G. Leopardi
Quello dell’estetica è un campo di battaglia – l’immediatezza sensibile non è data
e conclusa. Disordina ogni mistificatorio tentativo di mediazione e di presa
trascendentalistico-idealistica della polarità che fa la contingenza. Ora, le
considerazioni svolte nell’ultimo paragrafo vorrebbero provare a rendere in filigrana
teoretica l’impianto ontologico comune ai due testi già menzionati: Il lavoro di
Giobbe e Lenta ginestra. La redazione del primo si colloca durante quella del
cospicuo volume dedicato a Leopardi. Di là dalla materia diversa dei due saggi, dalle
loro diverse intenzioni, uno e solidissimo è il pensiero che li regge, pure aprendoli a
sviluppi su diverse linee di fuga. Dunque, Leopardi. Il quale «ripete l’eccezione
spinoziana rispetto alla propria contemporaneità», sulla base di uno strumentario
teorico che opera nel presente come sua apertura critica: «il materialismo, la
concezione produttiva dell’essere, la teoria dell’immaginazione, l’impianto etico
dell’ontologia […]. E il concetto di potenza» 21. Ora, nel prendere in considerazione
alcuni tra i lineamenti ontologici che l’analisi negriana ricava dai Canti e dallo
Zibaldone leopardiano, riteniamo di potervi ritrovare il rilancio di una problematica
già abbozzata e che dovrà impegnare di nuovo a pensare. In modo schematico e un
po’ brutale si è profilata una sorta di gigantomachia: tra due assoluti. Ebbene,
conviene soffermarsi momentaneamente a riflettere se in entrambi i casi si stia
trattando lo stesso concetto di «assoluto».
1. Due assoluti: da un lato, essere necessario in sé, dall’altro, essere sensibilecontingente (che diventa necessario per autodeterminazione, non per determinazione
divina – come vorrebbe la tradizione filosofica europea erede del necessitarismo di
Leopardi, G. (2009), Alla sua donna , in Id., Canti, ed. critica diretta da F. Gavazzeni, a cura di C.
Animosi, F. Gavazzeni P. Italia et alii, nuova ed., Firenze: Accademia della Crusca, vol. I: I canti,
XVIII, pp. 329-345, qui 344-345.
Negri, A. (1989), Between Infinity and Community. Notes on Materialism in Spinoza and Leopardi ,
«Studia Spinozana», vo l. V, pp. 151-176; trad. it. Fra infinito e comunità. Appunti sul materialismo in
Spinoza e Leopardi , in Id. (1992), Spinoza sovversivo. Variazioni (in)attuali , Introduzione di E. Giancotti,
Roma: Pellicani, ora in Id. (2006 ), Spinoza, Prefazioni di G. Deleuze, P. Macherey, A. Mathero n, Verona:
20
21
2
DeriveApprodi, p. 346.
�31
Sul concetto di metafisica per Toni Negri
Avicenna). Torniamo per un istante a porre mente alla riflessione di Negri sul grande
libro veterotestamentario. Ciò che si mostra è la «secessione» tramite la quale Giobbe
insorge ad (auto)determinare l’assolutezza del proprio essere sensibile-contingente a
fronte di quella di Dio, l’essere perenne, necessario in sé. Paradossalmente, si trovano
fronte a fronte, corpo a corpo, resi «perfetti» dalla rottura. Il nesso avrebbe dovuto
continuare a vincolarli ma è spezzato, avrebbe dovuto liberarli per sempre da legami
vicendevoli, renderli assolutamente indifferenti, due unità in sé e per sé sovrane, e
invece, così come sono, li congiunge ancora più strettamente. Il nesso è tolto eppure,
più propriamente, trasformato e per ciò affermato, persino «eternizzato», senza
alcuna Aufhebung dialettica. Essenzialmente, ontologicamente opposti:
essenzialmente, ontologicamente uniti – simpliciter, non secundum quid. Altrimenti
detto: quella che si profilava come un’opposizione dicotomica – la rigidità di due
assoluti i cui discorsi autoaffermativi non potevano produrre se non, logicamente,
contraddizioni – si trasforma in una contrarietà dipolare, tensionale e tensiva,
vettoriale. Ora, questa problematica teoretica va pensata fuori dalla figurazione
metaforica. Occorre dislocarla nel concreto da cui effettivamente muove, dove fa
problema vero. Come sappiamo, è quel campo di tensioni e di rapporti di forza in cui
l’essere sociale si produce in modi differenziati e che, ad un tempo, coincide con il
dominio della sussunzione reale al capitale, tendente all’indifferenziatezza,
all’omogeneizzazione-circolazione totale di merci. Campo fisico d’indeterminabilità
nella misura in cui continua a generarsi la tensione precarizzante tra vettori sinteticoricompositivi e analitico-scompositivi; tra, da un lato, l’astrazione concreta,
onnipervasiva, globalizzante del capitale e, dall’altro, la generazione e riproduzione
d’essere nuovo. Infine, in quanto campo della contingenza-possibilità, può essere
qualificato mediante l’introduzione di due tesi ulteriori, che cogliamo tra le pagine
critiche dedicate a Leopardi.
2. La prima: «L’astratto, in quanto si è posto come assoluto, pone un altro assoluto
contro di lui» (G 236). Un assoluto contro un altro assoluto: all’astrazione del capitale
è messa di fronte la produzione – la relazione tra i termini della possibilità è cioè una
contrapposizione. Il punto, già introdotto nella nostra seconda tesi, dev’essere
chiarito: se v’è possibilità (se cioè è tolta l’identità), essa non toglie la determinatezza
dei termini della contrapposizione. I termini che fanno la contingenza sono cioè
determinati perché determinate sono le istanze che la disegnano in un rapporto di
irriducibilità. La contingenza si estrinseca in un’alternativa ontologica, ovvero
un’alternativa politica (fuori da qualsiasi improponibile hegelismo o idealismo di
ritorno, si ricordi lo Hegel della Prefazione alla Fenomenologia: «la forza dello spirito
�32
G U IDO B OFFI – G IA C OMO C LE ME NTE
è grande quanto la sua estrinsecazione») 22. Dire determinatezza equivale a dire, cioè,
che gli agenti che definiscono la contingenza sono collocati in una relazione
immediata che fa dell’antagonismo il principio della loro individuazione
determinata, e dell’assolutezza la sua qualificazione perché assoluta è la differenza
che, in quella contingenza indialettizzabile, è posta tra l’essere e il non-essere: «C’è
una nascente metafisica che si mostra in maniera opposta, antagonista, per il lavoro e
il capitale» (FS 135 – corsivo nostro). La determinatezza dei termini della
contingenza è la stessa determinatezza della contrapposizione che delinea il quadro
del differente (dell’essere sensibile eccedente, non solo della non identità) come
campo immediato della possibilità – della determinatezza di due assoluti separati
perché antagonisticamente determinati (sì che, si potrebbe dire rovesciando il
discorso, è da questo antagonismo determinato che è possibile risalire all’alternativa
tra essere e non essere – si badi: sempre infondata e precaria). Determinati sono i
termini perché nella fase storica della sussunzione, determinati sono gli agenti che
delineano la possibilità (secondo il principio di non identità): «Quanto più si
determinano sviluppo e modernità, quanto più questo antagonismo perviene
all’alternativa dell’essere e del non essere, perché a questo punto al lavoro del
soggetto è dato il rapporto con l’essere in maniera esclusiva, mentre al capitale è
dato, in maniera sempre più stringente, il non essere» (FS 135). Ontologia è dunque
dire-aprire-innovare l’essere in quanto spazio dell’antagonismo; porre l’essere nello
spazio eversivo dell’alternativa radicale; fare già dell’assolutezza della
contrapposizione ontologica, l’assolutezza della lotta politica. Di «un assoluto altro
[…] un assoluto temporale e vitale» (G 236).
3. Seconda tesi (introdotta nel punto precedente sotto le specie di una seconda tesi
antieleatica): «laddove tutto può essere distrutto, tutto può essere costruito» (G 277).
Una proposizione, questa, che ricorre nei testi di Negri con la stessa potenza
intensiva di un frammento presocratico ritrovato. Dal nulla della sussunzione
all’essere della produzione (s’intenda: «da… a…» senza voler introdurre una scansione
cronologica: si tratta piuttosto di un passaggio kairologico, ontologico-metafisico
materialistico, un evento «a dismisura» che spezza il tempo cronometrico) 23 . V’è
trasformazione e innovazione – essere che sborda a lato della non-eternità dei corpi,
della mutevolezza creativa ed immaginativa del mondo. Vi sono pratiche ontologiche
di produzione e prassi di trasformazione del mondo nel e contro il nulla della
distruzione, nell’irrazionalità annichilente della dismisura e contro di essa. Stare sul
bordo d’essere, ovunque potendo porsi-insorgere il bordo; stare nella contingenza,
. Hegel, G.W.F (1973), Fenomenologia dello spirito, trad. it. di E. De Negri, Firenze: La Nuova
Italia, vol. I, p. 8 (corsivo nostro).
Non si può che rimandare alla prima lezione di Kairòs…, cit., pp. 17-64.
22
23
�33
Sul concetto di metafisica per Toni Negri
essendo contingenza la possibilità d’essere dell’immanenza: ciò significa stare dentro
e stare fuori, creare nel contempo l’alternativa a partire dalla nullità – contro di essa.
L’essere è produzione, costruzione, immaginazione: non è dato, né la somma dei
dati. È ciò che si produce e riproduce nella fase della sua nullificazione. Differenza,
separazione, alterità: categorie equivalenti che definiscono i modi dell’eversione
immanente
cioè,
della
produzione
immaginativa
dell’essere
(e
dell’autovalorizzazione opposta all’indeterminatezza della legge di valore). Categorie
equivalenti che definiscono l’assolutezza dell’opposizione, l’intransitività della
costituzione: «La rottura è separazione» (G 239). Separazione dal nulla dell’essere in
quanto prodotto rilanciato della costruttività della potenza. Sempre pensando
Leopardi, Negri scrive: «Ed è questo che a noi interessa: questo scuotersi di un
universo che è stato concepito nella sua assoluta, totale nullità. Questa possibilità di
desiderio e di speranza. Questo porsi della domanda metafisica sul nulla del mondo,
quindi sul nulla di determinazioni logiche, quindi solo sulla possibilità della
domanda di porsi, sulla sua irresistibile ed ‘altra’ potenza. Si potrà dire che questo
mondo è ‘altro’?» (G 284).
4. L’alterità di quest’altro mondo potrà essere detta prendendo possesso della
potenza del proprio atto linguistico nel gesto dell’immaginazione. La quale, quando è
usata per quel che può, è sempre produttiva e mai riproduttiva. Insorge con una
funzione ontologica di ricomposizione degli strati d’essere. Si sporge dalla materia
fin sull’orlo della sua eventualità, anticipando la conoscenza e provocando l’agire. V’è
in Negri un esplicito rilancio della spinoziana potentia imaginandi e una sua
esemplare applicazione a Leopardi, come vedremo subito. Perché Spinoza è noto e vi
abbiamo fatto cenno (cfr. supra II. 4). In lui l’immaginazione trova ritmo ontologico
assieme al percepire e all’essere affetto del corpomente. Immaginando, la mente, per
assecondare o aumentare la propria potenza di pensare, cerca e ripresenta quelle
affezioni favorevoli o piacevoli che il corpo ha avvertito nell’interrelazione con altri
corpi, in ciò assecondando o aumentando nel medesimo istante la potenza d’agire
del corpo, giacché corpo e mente fanno quell’unico singolarissimo, complicatissimo
implesso ontologico che stiamo chiamando «corpomente». Si originano sempre di
nuovo nell’immanenza dell’essere sensibile, in modi simultanei, dentro al processo
espressivo e autoproduttivo dell’essere. L’immaginazione è facoltà: non però
dell’individuo bensì della soggettività, che è sempre sociale, o meglio, che si produce
nell’essere comune del vivente. Accresce l’essere in un potente gesto cooperativo,
proteso sulla sua costruzione a venire, per organizzarne interminati spazi. Se la
successiva filosofia moderna in prevalenza ha fatto i conti con l’immaginazione
ricondotta da Kant allo schematismo analitico-sintetico trascendentale, restandovi
del tutto implicata o estenuandosi al suo tavolo per incessanti trattative, Negri coglie
il rilancio della potentia imaginandi spinoziana nell’ontologia e nella poetologia di
Leopardi, che di quella filiera tradizionale produce lo scarto materialistico, la
�34
G U IDO B OFFI – G IA C OMO C LE ME NTE
divergenza epistemologica, l’innovazione creatice24. L’immaginazione produce essere,
produce valore non come misura ma in quanto eccedenza creativa, produce senso
sulla scena dell’attività umana, che trasforma nella determinazione della possibilità.
Nel Canto Alla sua donna, che abbiamo letto, l’immaginazione dà vita a una «grande
sensazione metafisica» dentro a un’esperienza eccezionale di dolore e desiderio.
Produce la consapevolezza che getta luce retrospettiva anche sulla vicenda di Giobbe:
«‘Mondi innumerabili’ sono dunque dinanzi al ‘solido nulla’ nel quale viviamo. Solo
il massimo di esperienza di rottura, solo la cognizione del dolore ci permettono la
libertà dell’immaginazione. L’imago non è un riflesso ma una costituzione» (G 182).
VI
La moltitudine postmoderna è un insieme di singolarità il cui utensile di vita è il
cervello e la cui forza produttiva consiste nella cooperazione. E cioè: se le singolarità che
costituiscono la moltitudine sono plurime, il modo nel quale esse si connettono è
cooperativo .
A. Negri
25
Forza produttiva che si poggia su niente, sul bordo dell’essere e in un essere che fa
bordo perché si produce e si sviluppa nel rischio, la moltitudine è insieme di
singolarità affettive, desideranti, cooperative. È rete di carne ontologica: corpomenti
irrappresentabili, espansi ed espansivi, reciprocamente mutantisi, capaci di
trasformare e suscettibili di trasformazioni (letteralmente: deformati perché pure
potenzialità insostanziali, tolte cioè alla determinatezza della forma). Il lavoro e il
capitale si situano in un rapporto precario che toglie sussistenza e sensibilità a ciò che
è, che espone l’essere sul presupposto antieleatico della nullità. La moltitudine,
dunque, è ciò che si costituisce nell’autodeterminazione di nuove forme di vita e
nell’attraversamento delle forme determinate dell’esistenza. È nella sussunzione che
si compone e tuttavia è fuori, cioè contro di questa, che essa genera (in tale
antagonismo essa risulta determinata quanto a termine d'opposizione, e pure
indeterminata perché, in questa determinatezza, le singolarità emergenti e differenti
si muovono sempre – eternamente, essenzialmente). Per tali ragioni Negri preferisce
alla categoria di «soggetto» quella di «soggettività». Con la prima si fa segno, per lo
Nelle pagine in cui si distende il commento critico precisamente al canto leopardiano Alla sua
donna che abbiamo posto ad esergo di questo paragrafo, possiamo leggere: «Fatico a riprodurre la forza
24
teorica del concetto leopardiano di immaginazione. Se confronto questo concetto alla terminologia
classica, da Kant fino a Heidegger, il suo significato mi sfugge. Perché qui, in Leopardi, immaginazione
non è una funzione conoscitiva, meglio, non è solo questo: è piuttosto una funzione costitutiva. Di
infiniti mondi, di indefiniti spazi e tempi – da vivere, da percorrere», (G 180).
A. Negri, Kairòs…, cit., p. 115.
25
�35
Sul concetto di metafisica per Toni Negri
più si è fatto segno, ai lineamenti (siano essi cogitanti o appercettivi – comunque
analitici) di uno spirito-coscienza, di un’egoità-interiorità definita, cioè al locus
epistemico di un principio di sapere stabile, autofondativo; con la seconda, si esprime
nient’altro che un segno di imputazione nominale, instabile perché ciò che le
singolarità estroflesse producono rimane liminare: «la soggettività non sarà altro che
quell’imputazione di esperienze comuni, ovvero di comune forza produttiva» (K 77).
Moltitudine è soggettività. E se l’essere sensibile è interamente contingenza, ovvero
se quel che c’è, ogni singolare «questo qui» è bordo di una radicale possibilità di
distruzione-costruzione, allora sul piano di questa mappatura ontologica la
soggettività non può collocarsi-prodursi se non nella differenza. Stando così le cose,
in riferimento a tali singolarità moltitudinarie Negri individua tre vertici descrittivi.
1. Primo vertice descrittivo: «la moltitudine è il nome di una immanenza» 26. Ci
siamo già soffermati (cfr. supra IV) sui rompicapi analitici (effettuali per il potere che
media), sull’impossibilità della presa, sulla contraddittorietà riflessiva inerente alla
contingenza – insomma, sull’impossibilità trascendentale di verificare la misura in
seno all’indeterminatezza. Nello specifico, benché tutto ciò valga per ogni tentativo di
sovradeterminazione (come nelle teorie dell’Uno in quanto teorie della sovranità, in
qualsiasi modo le si comprendano), questo vale anche per ogni tentativo di
sottodeterminazione (come nelle teorie dell’Altro in quanto teorie che riducono il
molteplice al medio dell’equipollenza). «Il pensiero della modernità opera in duplice
maniera su questa base: da un lato astrae la molteplicità delle singolarità e la unifica
in maniera trascendentale nel concetto di popolo; dell’altro dissolve l’insieme delle
singolarità (che costituiscono la moltitudine) in una massa di individui» (OM 157).
Ma, si badi, tolta alla mediazione trascendentale del popolo, la moltitudine non
equivale neppure alla plebe o alla massa intese come multipli indefiniti di individui,
unità irrazionali (le quali, in ultima istanza, rappresentano il rovescio convalidante
delle teorie analitiche della sovranità). Un modo, questo, per dire che il materialismo
moltitudinario, la sua immanenza, benché sia antirazionalistico (perché
antidialettico) non è però irrazionale (perché è organizzato: qui, il gesto teorico di
Negri si situa al livello della leopardiana irriducibità della soggettività materiale alle
istanze metafisiche irrazionalistiche e antidialettiche dell’epoca). In definitiva, dire
«singolarità non rappresentabili» significa già collocare il corpo moltitudinario fuori
dalle istanze individualistiche della trascendenza (ovvero, fuori dalle maglie
trascendentali dell’unità di misura e dalla sua logica di rappresentazione).
Id. (2002), Pour une définition ontologique de la multitude, «Multitudes», poi in Id. (2010),
Inventer le commun des hommes, Préface de J. Revel, Paris: Bayard; trad. it. Per una definizione
ontologica della moltitudine, in Id. (2012), inventare il comune, Prefazione di J. Revel, Roma:
26
DeriveApprodi (d’ora innanzi nel testo: OM), p. 157.
�36
G U IDO B OFFI – G IA C OMO C LE ME NTE
2. Secondo vertice descrittivo. La moltitudine è politica: il suo «è un concetto di
classe» (ibidem). Siamo, ancora una volta, nei pressi del passaggio fondamentale che
determina la crisi del capitalismo industriale. «Se si definisce il passaggio storico
come epocale (ontologicamente tale), vuol dire che i criteri o i dispositivi di misura,
che valevano in un’epoca, sono radicalmente messi in discussione» (OM 158). Si
tratta, qui, di metamorfosare concettualmente la lotta di classe, di sottolinearne la
variazione ontologica (e quindi politica) prima che economica. La moltitudine non è
la classe operaia. Quest’ultima, nei vecchi modelli produttivi, riferendosi ai lavoratori
dell’industria indicava soltanto una porzione determinata dell’insieme dei lavoratori
nel contesto della produzione sociale. Oggi, nella fase terminale della sussunzione
questo quadro salta (questo quadro è un ferro vecchio, si potrebbe dire, perché ferro
vecchio è la legge di valore). Se, cioè, la classe operaia era funzionale alla definizione
determinata di una posizione antagonista al capitale industriale, con la caduta della
legge di valore (ovvero, della giusta misura) cambia anche (ontologicamente) la sua
composizione. La moltitudine, a differenza della classe operaia, è smisurata quanto
lo è la ricchezza sociale, cioè il suo sfruttamento – essa si colloca al di fuori della
categoria di individualità. Fare oggi della classe operaia l’attore della lotta di classe
significherebbe ricadere, seppur anche in buona fede, in un concetto analitico
(funzionale alla determinatezza della mistificazione) oltre che scarseggiare di senso
storico alla fine già sopravvenuta della modernità. Ossia scarseggiare di strategia
ontologico-politica e di tattiche disposizionali.
3. Terzo vertice descrittivo: la moltitudine è potenza. «Già analizzando la
cooperazione noi possiamo infatti scoprire che l’insieme delle singolarità produce
oltre misura» (OM 159). Smisuratezza, qui, è sinonimo di un’asimmetria, cioè –
spinozianamente – di un’«irriducibilità dello sviluppo del desiderio costituente
(sociale, collettivo) alla produzione (pur necessaria) delle norme del comando» 27. A
lato dell’essere v’è smisuratezza. Nel mezzo delle trafile creative ed immaginative del
conatus e della cupiditas, fino ad amor, asimmetria e dismisura caratterizzano la
potenza: un contrasto che produce crescita d’essere, surplus ontologico. Che porta,
cioè, alla posizione antinomica di limiti e insieme al loro alternativo, perenne
scavalcamento. Ovvero: conduce sia a un «diritto» non analitico, non chiuso già
nell’apriori, bensì aperto, nato dalla vitalità collettiva e formatosi sull’opposizione
(democratico in quanto immanenza vale costituzione di forme di vita differenziali),
sia alla «rivoluzione», solo che si riconduca questa al suo significato ontologico
costituente (e la si ripulisca delle connotazioni immediatamente politicistiche o
Id. (2010), Spinoza et nous, trad. fr. (dall’italiano) di J. Revel, Paris: Galilée; (2012) Spinoza e noi,
Milano-Udine: Mimesis, (d’ora innanzi nel testo: SN), p. 14.
27
�37
Sul concetto di metafisica per Toni Negri
utopiche). Potenza «è un contrasto continuamente prodotto, un conflitto
continuamente posto e continuamente risolto, e di nuovo continuamente riproposto
ad altri livelli, una tensione etica che emerge attraverso le difficoltà e gli ostacoli del
percorso che dal conatus, attraverso la cupiditas, perviene all’espressione di amor. Se
il rapporto tra potentia e potestas è poi riconosciuto come ‘asimmetrico’, ciò avviene
perché la potentia, in quanto cupiditas, non può mai diventare cattiva e ha sempre
eccesso» (SN 26).
4. Spinoza versus Hobbes: rovesciamento del suo meccanicismo politico radicato
sulla simmetria, anzi sulla coniugazione di potentia e potestas sino alla loro
coincidenza nell’imperium (il potere legittimo dello Stato). Quella di Hobbes è bensì
una metafisica materialistica ma anche deterministica (sulla base della fisica
galileiana). Dove sta il punto? A illuminarlo un istante basta il confronto con
Aristotele. Nella fisica e nella filosofia prima aristoteliche lo spettro della possibilità
rimane più ampio di quello della realtà in virtù sia, per il primo riguardo,
dell’esplicazione genetica del rapporto potenza/atto in quanto divenire (e
mutamento), dunque della posizione (antieleatica) del movimento, sia, a riguardo
metafisico, dell’articolazione ancora della coppia potenza/atto, qui una delle forme in
cui l’ente si semantizza. La potenza (dynamis) è simultaneamente essere e non essere,
in quanto potenza affermativa e potenza privativa (la quale è sempre un «potere
non», mai un «non potere»). Non possiede alcuna determinazione in quanto le
possiede tutte: il suo essere potrà possederne una o alcune soltanto
nell’attualizzazione, ovvero in un passaggio attraverso il possibile – potentia è
aristotelicamente potentia possibilitas – sino all’atto (energeia) di posizione del
«questo qui», dell’ente singolo che è nella sua compiutezza (entelecheia) di materia e
forma. Tuttavia il passaggio all’atto mantiene essere ed inesauribilità della potenza,
in quanto «potenza di non» che permane nell’atto (al modo in cui, secondo il noto
esempio portato dal De interpretatione aristotelico, la potenza di non camminare
rimane nell’atto del camminare). Se Hobbes riduce potentia a potestas, ed
esplicitamente contra Aristotele (bastano già soltanto alcune pagine del De corpore
per renderne conto), avendo schiacciato meccanicisticamente il rapporto
potenza/atto su quello di causa/effetto e perciò cogliendolo in una prospettiva
necessitaristica e deterministica, con una lettura «attuosa» della potentia possibilitas
spinta a irresistibile realizzazione, per parte sua Negri legge Spinoza sollevandolo
contra Hobbes, pur in un’apparente convergenza antiaristotelica28. Le proposizioni
XXXIV (Dei potentia est ipsa ipsius essentia) e XXXV (Quicquid concipimus in Dei
Del resto suona già antiaristotelica la concezione univocistica dell’essere nella metafisica
spinoziana rispetto alla multivocità dell’essere che può essere detto in molti modi e significati, riferiti a
tutto ciò che è esperibile, appunto secondo la filosofia prima di Aristotele.
28
�38
G U IDO B OFFI – G IA C OMO C LE ME NTE
potestate esse, id necessario est) della Prima parte dell’Ethica chiariscono, nella loro
complementarietà, che la potentia sta alla potestas come la forza che produce
attualmente le cose sta alla loro pensabilità e alla capacità produttiva. Di nuovo ecco
un (tendenziale) riassorbimento della determinatezza attuale (modale) nella
coincidenza, in Dio, di potenza ed essenza. Ovvero nell’unica potenza infinita e
illimitabile della sostanza, che coincide con il processo della sua continua
autocausazione ed autoeffettuazione in quanto causazione di tutte le cose naturalimateriali (nei termini della dimostrazione alla proposizione XXXIV: causa sui e
causa omnium rerum). Nulla v’è che Dio non abbia il potere di fare e fa, perché ciò
deriva necessariamente dall’espressione-dislocazione nell’esistente della sua
essenziale potenza. L’attuosa essenza «naturante» di Dio fa corpo con la sua
medesima esistenza «naturata», e la realtà con la perfezione. Potentia-potenza e
potestas-potere di Dio compongono il medesimo piano d’immanenza e univocità. Ma
qui v’è un’etica! Un agere investe Dio e le cose. La sua stessa potenza ontologica, che
ne è essenza metafisica, attiva ogni singola res mettendola a parte dell’agire divino:
per la potenza di Dio «egli stesso e tutte le cose sono e agiscono» (ancora nella
dimostrazione alla proposizione XXXIV: Ergo potentia Dei, qua ipse et omnia sunt
et agunt, est ipsa ipsius essentia). Di qui Negri può ritenere la dinamica di una
sporgenza ontologica radicata nell’etica – nella potentia, nella forza costituente, nella
produzione, nell’agire determinato dentro la realtà. «‘Potestas’, potere, da questo
punto di vista non può che significare: ‘potentia’ verso costituzione: un rafforzamento
che il termine potere non rappresenta ma solo allude, poiché la potenza dell’essere lo
fissa o lo distrugge, lo pone o lo oltrepassa, dentro un processo di costituzione reale.
Il rafforzamento che il concetto di potere propone al concetto di potenza è solo
relativo alla dimostrazione della necessità – per la potenza – di porsi sempre contro il
potere» (AS 226).
VII
L’etico è il rovesciamento a fronte del nulla, è l’agire come seguito della separazione
dalla dialettica del nulla, come insistenza su una regione altra dell’essere. La precarietà
teorica di questo fondamento fa parte della sua natura – dell’esposizione che esso
subisce, all’intera tragica dinamica dell’essere – ma non perciò questo fondamento è
meno reale .
A. Negri
29
Questi passaggi, colti dal libro su Leopardi, conseguono implicazioni cruciali ai
limiti estremi dell’elaborazione di Negri. Qui, infatti, si dice che il fondamento
manca di presupposti, dal momento che la potenza, sul fondo del «solido nulla»,
29
Id., Lenta ginestra , cit., p. 392.
�39
Sul concetto di metafisica per Toni Negri
pone e ripropone bordi di una contingenza assoluta e insieme, per dir così,
assolvente, «svincolante», «liberatoria». Tolto il dato e presupposto il nulla, «solido»
perché reale e carico di effetti, l’unico essere consiste in quello che pone insieme
all’effettività della sua distruzione, o meglio, «esposto» nella propria autoproduzione
e autodeterminazione sul niente che è e a cui non è affatto mediabile-dialettizzabile.
L’essere si configura nell’atto (etico-ontologico) dell’esporsi sul vuoto reale e
nell’antagonismo materiale della contrapposizione (alle forze annientanti,
indifferenzianti). Esposizione irrappresentabile perché non introduce spettatori né
oggetti sulla sua stessa scena vuota: qualsiasi punto di vista non la precede ma si crea
in essa e per suo tramite, in una produzione di soggettività tutte sempre da farsi non
«a fronte di» ma dentro e contro forze deoggettivanti. Concretamente: l’essere si
configura nel campo delle tensioni vettoriali che si producono, oggi, in quella totalità
biopolitica che non conosce né sopra né sotto, né dentro né fuori, ma soltanto
relazioni ricorsive su un’unica superficie globale svuotata di principi, di origini, di
misure, dove risultano tendenzialmente egemonica l’indifferenziatezza, la
dematerializzazione, la circolazione calcolata e sorvegliata di flussi (di dati,
informazioni, merci, viventi) deprivati in sé di alcun valore. Qui non v’è fondamento:
è stato azzerato, per poter ricalcolare dopo la vorticosa sparizione delle differenze. Se
vi sarà, non potrà che esporsi «avenire». Si collocherà nell’etica: certo, ma in quanto
questa si sarà istruita nelle genealogie e nell’ontologia del presente, nelle
discontinuità e nelle segmentazioni dell’essere sociale, si sarà liberata delle morali
normative trascendenti, si sarà prodotta nelle scelte arrischiate, agite nella dismisura
di impreviste linee di cresta e nell’apertura di nuovi fronti di soggettivazione, nella
trasformazione innovatrice, nella produzione di libertà, nell’insorgenza contro lo
sfruttamento al livello più alto della sussunzione reale al capitale.
1. Il fondamento s’incarna nella potenza disidentificata, plurale, instabile. È
un’eventualità – da farsi. Se avverrà, avrà preso carne e cervello sociali nella singola
presenza dei corpi che fanno essere comune, con gesto trasvalutante, affettuoso,
intenso, creativo. Un tale fondamento si trova bensì nell’etica, tuttavia in quanto
infondato e soprattutto come sempre soltanto fondabile «su una regione altra
dell’essere». Esso resta cioè – con Negri – sempre soltanto avenire, essendo nella
possibilità che prende corpo e si situa ontologicamente. Nell’etica, sul bordo d’essere,
porre il fondamento significa averne negato la presupposizione metafisicotrascendentale astratta (la datità oscura di ente sommo, uno, previo e sempre
presente). Il che è già avvenuto epocalmente. Nel (fondabile) fondamento, oggi, v’è e
consiste (vi può essere e consistere) soltanto contingenza. Questa è la sua impronta
precaria nell’essere e la postura ontologico-metafisica che ogni ente riproduce
differenziandosi. Dunque, i vettori costituenti e tensivi del suo campo sono:
opposizione, non identità, differenza, sensibilità, eccesso. Così, nelle perpetue
pratiche di determinabilità-fondabilità effettiva, viene impedita la sua eventuale
�40
G U IDO B OFFI – G IA C OMO C LE ME NTE
rideterminazione in un’assolutezza astratta: «Dire l’etico come fondamento è dunque
esatto solo se questo fondamento lo si considera come un processo assolutamente
privo di presupposti – che si costruisce, dentro la tragedia intera dell’essere, come un
autonomo e forte momento di comprensione di un’alternativa possibile, di una
possibilità da realizzare» (G 394). Ecco, allora, cosa ne è della verità – ed è qui una
delle implicazioni cruciali di cui sopra, perché cruciale, diremmo essenziale, è il
rapporto che da sempre l’ontologia, e la metafisica per mezzo di essa, hanno stabilito
con la verità. Oltre a venir meno il riferimento al principio eziologico in quanto
principio veritativo ed esplicativo della cosa (aristotelicamente, la conoscenza della
verità è conoscenza delle cause), in questa metafisica, in special modo, si mostra del
tutto insensata la distinzione tra filosofia pratica e filosofia prima (se, di nuovo
ascoltando Aristotele, con la prima s’intende tradizionalmente la scienza il cui
oggetto è l’azione e con la seconda la scienza il cui oggetto è la verità). Il fondamento
(fondabile) apre alla prassi dispositiva del vero, singolarissima perché incarnata in
corpomenti, cioè in intensità ricorsive complesse e differenziantisi.
2. Verum ipsum factum: ecco che il vero si è emancipato dalla sua qualificazione
passiva, perché la verità è un fatto quale effetto da fondare a venire, eternamente
preso e rilanciato nella storicità (e geograficità) dei rapporti di forza – in tensione,
eticamente tolto e riprodotto tra molteplici contrasti, fallimenti, falsificazioni,
sdoppiamenti. Spetta alle pratiche disposizionali, cooperative e creative porre verità.
A partire da esse risulterà forse possibile rifondare un’epistemologia che non risolva
formalmente in mathemata (digitali-informazionali) l’essere del sensibile, che non
riproduca i meccanismi di veicolazione delle verità entro la circolazione dei discorsi
scientifici, giuridici, economici, politici, filosofici. Un discorso che cioè faccia a meno
alle maglie analitiche della giusta misura (manifeste in ogni forma aggiornata di
schematismo adeguativo dell’intelletto alla cosa) come pure delle sue
rappresentazioni simboliche. La verità non è un dato perché non è un dato l’essere.
Piuttosto, è procedurale, stratificata. S’incorpora alla realtà come sua «posta in gioco»
politica (Foucault), s’insinua nelle ontologie regionali del mondo attuale. È flessa sul
reale ed estroflessa nelle sue condizioni differenziali, sì che, alla ricerca teoretica
delle cause è possibile sostituire, qui, la genealogia delle pratiche di soggettivazione,
che sono politiche non più che estetiche proprio in quanto connesse in modo
intrinseco al fare: «Il fare è l’unico elemento di verifica del soggetto che noi
possediamo. Il vero può essere solo costituito nel fare. Il vero esiste solo in quanto
subordinazione al fare» (G 381). Dicendo «estetiche», in uno si dice che il fare e il
verificare, modi e forme del fare e del verificare, sono gesti corporei, con tutto ciò che
oggi implica l’intervento delle nuove tecnologie, in concretissime modalità
protesiche, ibride. L’ipsum factum del verum è dispositivo dei/dai corpi che sono
menti, che si attrezzano comunemente nel cervello sociale e producono
cooperazione. Sul frutto di pratiche cooperative nella pienezza operosa del lavoro
�41
Sul concetto di metafisica per Toni Negri
vivo, di soggettivazioni etiche organizzate strategicamente, in relazioni che
approfondiscano quell’eterogeneità che il capitalismo globale invece tende ad
annientare: qui s’impiantano nuove verità, materialistiche.
3. La verità, nella ridefinizione pratica appena profilata, è – spinozianamente,
leopardianamente – un atto d’amore: nell’amore si definiscono la dinamica sociale e
collettiva, le manifestazioni autovalorizzantesi delle singolarità, l’intelligenza delle
conoscenze e delle relazioni, il rifiuto dei rapporti di potere subordinanti e la
manifestazione estensiva della potenza in una alterità («la verità è l’altro», potrebbe
essere la sua definizione, perché l’essere è nella separazione). «L’evento critico
consiste appunto in ciò, nel fatto di rifondare interamente il punto di vista dal quale
la verità è considerata, nel trasformare la resistenza etica alla morte ed al vero in
possibilità formale di nuova vita e nuovo vero, di svolgere il rifiuto in amore» (G 377).
Tutto ciò fa sì che il rapporto al vero nel dominio della riflessione sostituisca alle
contraddizioni dell’analitica formale una nuova categoria epistemologica in quanto
categoria politica, costruita sul campo dell’immediatezza come campo della
contingenza e della soggettivazione, del lavoro materiale-immateriale in cui
s’impiantano concretamente, storicamente, conflittualmente essere e verità.
«Analitico a posteriori» è il nome negriano di questa categoria inedita: essa, basata
sull’immediatezza dell’esperienza, conosce, nell’opposizione alla mediazione
trascendentale, ciò che nasce dalla contingenza sempre da rifondare. Vera
conoscenza, che è conoscenza del vero, si dà solo nell’atto di costituzione: ma, oggi,
esposti perennemente sull’annientamento dell’essere – perché questo è l’orizzonte
metafisico invalicabile determinato dalla sussunzione della vita al capitale e insieme
il campo d’immanenza resistenziale, creativa –, non v’è costituibilità ontologica se
non alla luce fredda degli stessi diagrammi dei poteri (foucaultianamente, i suoi
«dispositivi»). Si tratta di farne esperienza (di nuovo un rilancio politico
dell’empirismo trascendentale deleuzeano!): come? Appartenendo al loro
riorientamento etico quali meccanismi performanti di condivisione affettiva e
cooperazione cognitiva; impiantando linee di fuga nella produzione di nuovo essere
empirico-sensibile, carnale, desiderante, sovversivo sull’orizzonte del nulla che cresce.
«Nella nostra terminologia, e al fondo del nostro progetto, ‘analitico a posteriori’
rovescia radicalmente l’impostazione kantiana. Significa infatti che l’elemento
necessario della conoscenza, il momento formativo del processo e della tendenza
conoscitivi, risiedono nell’esperienza empirica» (FS 68). E ancora: «L’analitico sorge
dunque qui, da questo non poter essere diverso dal reale che è descritto dalle
relazioni, da questa immanenza assoluta dell’approccio filosofico. L’analitico dunque
può e deve trovare il suo rapporto con la contingenza» (FS 70).
�42
�43
Etica & Politica / Ethics & Politics, XX, 2018, 1, pp. 43-52
ISSN 1825-5167
LA GINESTRA LEOPARDIANA.
LINEAMENTI PER UN’ONTOLOGIA
ETICO-POETICA DEL TEMPO
S AV E RI O A NS A LDI
Università di Reims
Champagne-Ardenne
saverio.ansaldi@univ-reims.fr
ABSTRACT
In this article I explore the main themes of Antonio Negri’s interpretation of Giacomo Leopardi’s
work, published in his essay Lenta Ginestra. Saggio sull’ontologia di Giacomo Leopardi (1987).
Negri’s reading focusses on the notions of imagination, illusion, second nature, power, so as to
sketch the portrait of Leopardi as a philosopher and a politician. In this sense, poetry becomes an
ethics to build the future, a materialistic praxis through which the construction of common forms
of life, within history and nature, becomes possible.
KEYWORDS
Nature, history, imagination, poetry, philosophy, time, future, power, infinity, finite, ethics, illusion
Lenta ginestra. Saggio sull’ontologia di Giacomo Leopardi, pubblicato nel 1987, è
il libro che fa seguito al saggio sulla filosofia spinoziana e alla sua «anomalia
selvaggia», uscito nel 1981 1. Se quest’ultimo è un testo di combattimento,
profondamente inserito nel contesto delle lotte politiche italiane della fine degli anni
settanta, scritto in condizioni di detenzione, il saggio su Leopardi è un’opera di
ampio respiro europeo, che si propone quindi superare la nozione stessa di «esilio»
per aprirsi ad una dimensione, teorica e pratica, in grado di oltrepassare ogni confine
nazionale. Ed è anche un’opera che si propone di riprendere, con lucida
determinazione, la trama complessa della trasformazione politica intrapresa dai
movimenti nei decenni precedenti, ribaltando così ogni ipotesi di «sconfitta» politica.
1 Negri, A. (1987), Lenta Ginestra. Saggio sull’ontologia di Giacomo Leopardi, Milano: Sugarco
Edizion; Negri, A. (1981), L’Anomalia selvaggia. Saggio su potenza e potere in Baruch Spinoza, Milano:
Feltrinelli.
�44
S A V E RIO A NSA LDI
Leopardi diventa in tal senso il paradigma di un pensare e di un agire che non cede
in nulla alle passioni tristi, ma che si propone al contrario di costruire, nell’Europa,
forme di resistenza sempre nuove, contro il tempo della catastrofe imposto da quelli
che, nella storia di adesso, cercano di dominare le nostre vite.
Scritto a Parigi, Lenta Ginestra si propone prima di tutto di «sprovincializzare»
Leopardi. Il punto di partenza è chiarissimo e saldamente mantenuto: «nella figura
di Leopardi […] il risorgimento italiano si pone al livello della metafisica europea» 2. A
partire del XVI secolo l’Italia diventa infatti un’espressione geografica sullo
scacchiere politico europeo. Un paese senza storia e senza tempo.
Il pensiero e la poesia di Leopardi, scrive Negri, ci fanno immediatamente vivere una
dimensione diversa, ci restituiscono il tempo – il tempo metafisico della poesia e il
tempo dell’alternativa politica; ci fanno respirare un fondo fluente di immaginazione, di
trasgressione, di risorgimento. La memoria della catastrofe è qui assunta come tema
centrale sia sul lungo periodo del ricordo della crisi rinascimentale, sia sulla più breve
esperienza della sconfitta dei Lumi, del giacobinismo, della rivoluzione. Affrontare
questi nodi storici e portarli al livello della sensibilità europea del secolo, concludere in
questa sensibilità il processo di ricomposizione della memoria storica e la sua
liberazione verso un orizzonte universale, è quanto Leopardi fa 3.
Come fa il suo contemporaneo Hölderlin e come farà in seguito Rimbaud,
Leopardi è quindi pienamente immerso nella «libera sensibilità temporale del
moderno». È solo da qui che può veramente iniziare quella che Negri definisce la
«critica del futuro», perché «il tempo va assunto nella filosofia come tempo
criticato» 4. Qui si innesta la forza critica del Leopardi europeo di Negri, che si apre
ad una dimensione costitutiva e costituente che non si appiattisce sulla ripetizione
del tempo della restaurazione, ma cerca, con materialistica determinazione, la forma
e il contenuto di un nuovo futuro di libertà. Questo Leopardi non può che essere che
la sintesi dinamica di tre filoni che definiscono la specificità del suo materialismo. In
primo luogo, la filosofia dei Lumi, francesi in particolare. Montesquieu, Condorcet,
Diderot, Condillac, La Mettrie e Rousseau sono gli interlocutori quotidiani di
Leopardi, le voci con le quali si confronta per tutta la sua vita, e non solo nelle dense
pagine dello Zibaldone. Il rapporto che Leopardi stabilisce con la filosofia dei Lumi è
«multipolare» e frastagliato: da un lato, c’è la ripresa di una concezione materialistica
della natura e delle sue forze; dall’altra, egli sviluppa una critica dell’astratta ragione,
figura contraria alla vita e alle sue passioni.
In secondo luogo, ritroviamo in Leopardi «quella tradizione filosofica e poetica
rinascimentale che vede l’uomo costruire la storia e la storia, nel bene e nel male,
2 Negri, A. (1987), Lenta Ginestra, cit., p. 8.
3 Ibidem.
4 Ivi, p. 10.
�45
La ginestra leopardiana. Lineamenti per un’ontologia etico-poetica del tempo
resa significante dall’azione umana» 5. Soffermiamoci su questo punto, decisivo. La
tradizione dell’umanesimo rinascimentale infatti si incontra e si scontra in Leopardi
con il materialismo dei Lumi, aprendo una scansione antagonistica fra le due
dimensioni, che Negri chiama quella della vita e quella della conoscenza. Qui si apre
di fatto il confronto con Hegel, sul quale Negri costruisce buona parte della sua
lettura leopardiana. L’opposizione che si attua in Leopardi fra vita e conoscenza non
dà luogo ad alcuna cesura dialettica, soprattutto temporale, come in Hegel. Non c’è
mai una contraddizione superata e risolta in un processo di integrazione dei contrari,
in un assoluto che assorbe, nella sua infinità, il tempo della storia, con le sue passioni,
i suoi desideri e le sue sconfitte. L’infinito di Leopardi è invece tempo sempre aperto
alle determinazioni dell’esperienza e alla potenza dell’immaginazione che la
costituisce dal di dentro. Il senso profondo del materialismo leopardiano è proprio
questo: il suo scontrarsi con una dialettica, come quella hegeliana, che vuole
«chiudere» con le faglie e con gli strappi del reale, per imporre alla fine la sua
«conclusione» ad ogni processo di critica e di costruzione del tempo. Questo
materialismo è invece quello della poesia leopardiana.
La poesia – scrive Negri – si pone allo stesso livello del pensiero riflesso. Fa
corpo con esso perché solo la poesia può spostare in avanti la conoscenza
dell’essere e organizzare, con vigore estremo, questo seguito di materialistiche
rotture. La poesia è la forma nella quale il materialismo esalta la dimensione
critica che lo costituisce 6.
Si innesta qui la terza ed ultima qualificazione del materialismo leopardiano,
quella che Negri chiama la sua «attualità». In che cosa consiste esattamente? «È il
cammino che lo porta, attraverso l’universo sensistico, dalla critica della natura
all’elaborazione del concetto di ‘seconda natura’» 7. Quest’ultimo aspetto è essenziale,
poiché ci permette di mettere in luce uno dei punti chiave del saggio di Negri. La
«seconda natura» definisce in Leopardi la capacità propria alla natura umana di
diventare altro da sé e di produrre «vita» nel mondo. Questa vita è quella della
parola, delle istituzioni e dei costumi, è «forma» che crea nuove metamorfosi del fare
e del dire, in un processo che ad ogni passo distrugge ogni possibile fissità, è vero
«progresso» dell’umana potenza.
Ora – sottolinea Negri – Leopardi vive e descrive questo passaggio – dalla
natura alla «seconda natura» – come passaggio dal significato al senso, dalle cose
5 Ivi, p. 11.
6 Ivi, p. 13.
7 Ivi, p. 14.
�46
S A V E RIO A NSA LDI
alle parole, e comprende come questo passaggio sia un passaggio che investe
interamente l’essere, lo riqualifica e lo determina […] Qui la poesia costruisce un
mondo 8.
E questo «mondo» si configura a sua volta come quello di una doppia «attualità»
politica. Perché da un lato Leopardi descrive nella sua poesia e nella sua prosa il farsi
artificio capitalistico di questa forma di vita nelle diverse strutture del suo dominio,
la «sussunzione della società al capitale», il suo volto tragico, la presa d’atto delle
difficoltà che si frappongono alle lotte necessarie per trascenderlo; ma dall’altro,
Leopardi sviluppa già la critica immanente di questa «seconda natura» e delle sue
tante alienazioni. Egli determina una nuova proposta (poetica, filosofica e politica)
proprio nel più fitto delle concrete forme di vita del mondo artificiale: adesso c’è
l’etica, che costituisce una nuova ontologia, contro ogni metafisica artificiale e contro
ogni violenza della dominazione capitalista;
la poetica infatti, rompendo la superficialità dell’essere, progetta una vera e
propria costituzione umana del mondo […] Leopardi disloca il reale fino ad un
orizzonte sul quale il mondo è costruito. È il rapporto fra il lento movimento
ontologico dell’essere e la potenza dell’ispirazione poetica, dell’atto della rottura
e di costituzione, che diventa quindi centrale. Questo rapporto è il fondamento.
Un fondamento completamente aperto e tragico, precario e costitutivo, eppure
definito dalla speranza 9.
La parola di Leopardi è dunque «evento critico» che si fa «attualità antagonistica»,
nel tempo pieno e denso della «seconda natura», che si configura come profondo
desiderio di «vita nuova» – progetto mai conchiuso di solidarietà dinamica e
collettiva.
Sono questi i tre cardini che scandiscono l’intera interpretazione leopardiana di
Negri. Ne segnaliamo qui gli snodi più significativi. Il primo passaggio non può
essere che quello del rapporto fra la memoria e il tempo, che fin dalla prima grande
canzone leopardiana, All’Italia, del settembre 1818, scandisce il ritmo formale e il
progetto etico della poetica leopardiana. Vediamo perché. Al di là in effetti di una
presa d’atto concreta della «catastrofe della memoria» realizzatasi nelle vicende della
Restaurazione e del blocco reazionario di ogni trasformazione rivoluzionaria sulla
spinta dell’89 francese, Leopardi non rinuncia, nel fondo, a tracciare e a riannodare i
fili di un nuovo strappo del tempo storico. L’appiattimento della memoria restaurata
non spegne l’urgenza delle passioni, la sconfitta degli oppressi è temporanea e
8 Ibidem.
9 Ivi, p. 17.
�47
La ginestra leopardiana. Lineamenti per un’ontologia etico-poetica del tempo
risolvibile in un nuovo inizio, vero, che la poesia può non solo cantare ma di cui essa
può anche farsi carico, nella pratica. In tal senso la poesia determina e «fa tempo»,
«tempo ontologico, e cioè dimensione dinamica e trasformativa dell’essere –
dell’essere intero. Il tempo storico della memoria è immediatamente tempo
ontologico» 10.
È nel determinarsi di questo tempo ontologico che la poesia di Leopardi si fa
pratica, aprendosi ad un «tempo problematizzato», che fa di lui un poeta (e un
filosofo) totalmente europeo, poiché il problema del tempo ontologico leopardiano è
lo stesso con cui si stanno confrontando, negli stessi anni in Germania, Hölderlin,
Hegel, Schelling, Fichte e Novalis. Come per loro, anche per Leopardi, «l’ontologia
del tempo è immediatamente etica», perché «il tempo nel quale siamo immersi, è il
tempo del fare», perché «la potenzialità del tempo è l’orizzonte innovativo del fare» 11.
Dimensione tutta «civile» quindi, del farsi poetico leopardiano, che non si risolve
tuttavia, come in Hegel o in Schelling, in totalità del processo dialettico, ma che
diventa, come in Hölderlin, «bisogno di azione» e «ipotesi di trasformazione»,
inglobando nella sua dinamica anche il tempo fisico, con la sua stringente
materialità. Il «problema» leopardiano del tempo diventa allora pienamente
strutturale, perché è onnicomprensivo ed aperto, è forza che lotta contro le scorie
velenose della storia presente e dei suoi abbietti cascami. Per questo «l’esperienza del
tempo storico non regge quella del tempo ontologico» 12.
La scrittura di Negri incontra qui il grande idillio de l819, L’Infinito.
L’argomentazione si fa allora serrata e stringente, perché quello che è in gioco
nell’idillio è la determinazione del rapporto fra il tempo, finito, che costruisce pratica
e quello, infinito, metafisico, che la sussume. Determinazione drammatica, che
esacerba la tensione fino al limite della rottura, alla possibile sconfitta della poesia e
della sua etica del fare. Ma Leopardi, ci ricorda Negri, alla fine la risolve, «poiché
etica non è appunto discriminazione, e gerarchia dell’essere, è bensì costituzione,
esserci dentro, all’essere, come attori della sua creazione continua. L’infinito non è
una prospettiva di possesso, di dominio, ma un cammino conoscitivo. Il finito è
fondante, l’infinito è un’apertura – etica» 13. Come potrebbe mai d’altro canto un
astratto orizzonte metafisico impadronirsi della passione del fare e del conoscere?
Come farebbe un assoluto solo pensato a chiudere lo spazio delle concrete relazioni
della vita, con i suoi movimenti e i suoi scarti, le sue invenzioni e i suoi bisogni? Non
c’è quindi arresto del tempo strutturale ed ontologico nell’Infinito del 1819, ci sono
invece le linee etiche che attraversano le passioni del mondo e ne costruiscono ad
ogni passo il denso significato politico e civile.
10
11
12
13
Ivi, p. 26.
Ivi, p. 28.
Ivi, p. 32.
Ivi, p. 47.
�48
S A V E RIO A NSA LDI
Qui la domanda sorge spontanea: abbiamo allora a che fare con un Leopardi
«progressista»? Con quel Leopardi che Luporini e Binni sono riusciti a strappare a
Schopenhauer, al quale Croce l’aveva volutamente incatenato? Su questo punto la
risposta di Negri è senza ambiguità:
Leopardi non è progressista perché il suo pensiero, antidialettico, fa reagire la
storia solo su stessa. È un atteggiamento catastrofico, quello leopardiano,
impiantato su un materialismo solido, costruttivo, ma non lineare né
progressivo. È la catastrofe della memoria e del tempo storico, il momento
fondamentale nel quale si colloca il pensiero di Leopardi e partire dal quale
alcuni motivi essenziali si formano […] La catastrofe è contro la reazione. Non
può tuttavia essere progressista, perché non v’è un tempo pensato che regga il
reale – v’è solo l’insorgenza umana, del finito, che rompe ed innova la realtà 14.
È su questa linea che si apre il confronto con la lettura di Luporini, in particolar
modo sull’interpretazione dello Zibaldone. Al Leopardi «moralista» di Luporini,
Negri oppone il Leopardi etico-politico che costruisce senza sosta nuove trame di
senso a partire dal presupposto, sempre mantenuto saldo, «che la vita è una forza
attiva» 15. Se per Luporini il «progressismo» e il «moralismo» di Leopardi sono il
frutto della sua disillusione rispetto alle attese fallite della Rivoluzione francese 16, per
Negri invece la filosofia (etica e politica) di Leopardi vive sempre dentro il reale,
continuando a progettarlo per stravolgerlo e reinventarlo, proprio grazie alla forza
delle illusioni – dell’immaginazione produttiva che ad ogni passo costruisce il «senso
vero» del mondo 17.
Ripercorriamo allora i capisaldi delle analisi che si dipanano sul filo delle pagine
dello Zibaldone. «La ragione stessa», ribadisce Negri, «è senso che si sviluppa e si
articola nella realtà. Questa corrispondenza del senso e della ragione è illusione vera.
Il senso è costitutivo della realtà – della sola, foss’anche illusoria, tragica realtà che
viviamo» 18. Più Montesquieu quindi che Rousseau, perché il materialismo sensistico
del primo permette a Leopardi di innervare l’orizzonte materiale del senso con la
linea sempre aperta dell’immaginazione, contro la cattiva illusione dialettica del
secondo, che spesso cede alla trascendenza di una volontà generale che tende ad
annullare l’attività dirompente del finito. Illusioni vere contro illusioni false, dunque.
Al di là di Rousseau, in ogni caso, Leopardi ricerca sempre una «scienza del reale»
14 Ivi, p. 62-63.
15 Ivi, p. 66. Cfr. Luporini, C. [1980 (1987)], Leopardi Progressivo, Roma: Editori Riuniti, p. 4: «La
‘filosofia’ di Leopardi si risolve tutta, o pressoché tutta, su questo terreno: egli fu un grande
‘moralista’».
16 Ivi, p. 53.
17 Negri, A. (1987), Lenta Ginestra, cit., p. 71.
18 Ivi, p. 73.
�49
La ginestra leopardiana. Lineamenti per un’ontologia etico-poetica del tempo
che sia posteriore all’«esistenza», che sia capace di produrre la «trama della vita».
Punto cruciale, questo, di grande tensione teorica. Perché è su di esso che Leopardi
ritorna à più riprese, nello Zibaldone ma anche nelle Operette morali. Se si tratta di
costruire vita al di là della pura esistenza naturale, se questo processo è quello che
comunque determina l’umana civiltà – la «seconda natura» – esso induce però anche
infelicità, assuefazione, blocco delle possibilità e delle aperture di senso. C’è quindi il
conflitto fra il dolore e il desiderio, ma questo conflitto è anche la loro intima
connessione, che Leopardi esplora in pagine straordinarie redatte nell’autunno del
1823. Allora, «come mettere in contatto l’uno con l’altro? Come articolare questo
universo? Come rideterminare gioia creativa nell’esistenza? » 19.
La risposta è ancora quella di un’etica che fonda l’ontologia e la costruisce nel suo
farsi. «L’etica del dolore e del desiderio è lo scandalo e insieme il motore di questa
costruzione» 20. Su questo terreno si gioca ancora per Negri il confronto con Hegel.
Perché in Leopardi il «dolore del negativo» non è mai sussunto in una «redenzione»
(giuridica e statuale) che lo toglie astraendolo dalle sue determinazioni, ma è
sconfitto dall’attività stessa dei soggetti, dall’incedere e dal procedere della loro
potente immaginazione produttiva, che crea nuove condizioni per la loro «salvezza»,
tutta mondana e concreta. Amore e libertà diventano allora i termini di questo «fare
insieme» nel mondo, perché
il soggetto, irrompendo nella crisi della dialettica, e sulla costruzione
dell’immaginazione trascendentale del materialismo, definisce una dimensione nuova,
bellissima, degna d’amore […] La redenzione ideale è impossibile, quella materialistica
percorribile – in questo abisso un cui siamo condannati, sotto questo cielo cui
aspiriamo. Esplode la dimensione metafisica del materialismo, vale a dire l’ontologia
aperta della libera necessità 21.
Il nuovo senso delle illusioni prende qui corpo. Non è l’illusione di un’idea
platonica o hegeliana, non è un astratto progetto etico-politico, è invece «rottura
aperta sul tempo futuro», determinata dalla funzione costitutiva dell’immaginazione.
Quest’apertura è per sé stessa un valore. L’essere non è potenza formale, ma una
direzione di vita. Stare nell’essere è conquistare il mondo, secondo infinite direzioni. La
trama del senso può essere ripercorsa in maniere microscopica. Mille prospettive, mille
piani, dell’esistenza così come del mondo e dello spazio interstellare 22.
19
20
21
22
Ivi, p. 81 e p. 107.
Ivi, p. 115.
Ivi, p. 117.
Ivi, p. 119.
�50
S A V E RIO A NSA LDI
Il materialismo leopardiano può allora diventare vita, perché la materia vive
ormai dentro l’immaginazione poetica, filosofica e politica. L’essere, nelle sue infinite
ramificazioni e possibilità, innerva le forme del mondo, e queste acquistano il loro
senso in virtù della vita attiva dei soggetti che lo popolano, con i loro desideri e le
loro nuove, e vere, illusioni di libertà e d’amore. La natura si fa «orizzonte pratico»,
«poiché il tempo dell’esistenza è esaltato sulla vicenda della vita» 23 – sulla «seconda
natura», che sempre più assume nuovi caratteri e nuove configurazioni, soprattutto
nello Zibaldone del 1823-24.
È in queste pagine infatti che Leopardi ci descrive la natura umana nei termini di
una potenza che la rende sempre più capace di conformazioni e di metamorfosi
inattese, di disposizioni e di qualità che le consentono di svilupparne e di
aumentarne le virtualità. Si delinea fra le righe dello Zibaldone di quegli anni
un’antropologia veramente rivoluzionaria ed inedita, quale solo forse Nietzsche sarà
in grado di proporre qualche decennio più tardi. «Una nuova determinazione
dell’uomo come potenza storica» 24 e come ricomposizione collettiva del reale, che si
muove sempre sul filo teso dell’immaginazione materiale e della sua aperta creatività.
Une tale antropologia resiste anche ai «dubbi» metafisici espressi da Leopardi nelle
Operette morali, scritte fra il 1824 e il 1827, nelle quali il cammino della ragione
umana sembra farsi «critico» e pare quasi cedere alle tentazioni di un astratto
ripiegamento su di sé. Ma il percorso della ricerca leopardiana non è interrotto da
questi dubbi, anzi. La prosa poetica di Leopardi continua a dispiegarsi «dentro al
vero, dentro all’essere», sfuggendo per esempio alla melancolia della Storia del
genere umano e del Dialogo d’Ercole e di Atlante con la lucida intensità delle
sensazioni e delle passioni che attraversano il Dialogo di un fisico e di un metafisico,
il Dialogo di Timandro e di Aleandro, o ancora il Dialogo della Natura e di un
Islandese. Dialoghi forti, nei quali Leopardi ricostruisce il percorso di una speranza
materialistica, che rifugge l’astratto e immette l’immaginazione, di nuovo, nel tempo
del mondo umano che lotta contro le leggi implacabili della natura e del suo cieco
fato. «Conoscendo il fato, l’immaginazione non si gli oppone se non dichiarandosi
altro – ride dell’urgenza e rifiuta la necessità concettuale del fato: gli si oppone in ciò,
in questa copernicana vocazione. Essere altro. Costruire altro? La sola speranza è
l’immaginazione» 25.
Da questo punto di vista, le Operette del ’24 rappresentano, allo stesso tempo, un
punto di arrivo e un punto di partenza nella traiettoria del pensiero leopardiano. «Di
qui in avanti», sottolinea Negri, «non si tratterà più di scrivere prolegomeni di una
possibile-impossibile conoscenza, ma di produrre questa conoscenza dentro la
condizione ontologica data» 26. Nello Zibaldone del 1825-1827 e nelle Operette del ’27
23
24
25
26
Ivi, p. 135.
Ivi, p. 138.
Ivi, p. 159.
Ivi, p. 167.
�51
La ginestra leopardiana. Lineamenti per un’ontologia etico-poetica del tempo
Leopardi approfondisce la sua critica alla metafisica e alla teleologia per approdare
ancora una volta, ma con più sicurezza adesso, al nodo che lega «natura» e «seconda
natura», violenza «matrigna» e illusione costruttiva. Perché è proprio qui che
Leopardi perfeziona la sua «macchina materialistica». «Che la materia pensi, è un
fatto. Un fatto perché noi pensiamo; e noi non sappiamo, non conosciamo di essere,
non possiamo conoscere, concepire, altro che materia» è la tesi espressa da Leopardi
in una pagina straordinaria dello Zibaldone del 18 settembre 1827. Il materialismo
diventa qui «fabbrica» filosofica e poetica che passo dopo passo nega ogni teleologia
ed ogni idealismo consolatori. È il materialismo che regge, nelle Operette del ’27, il
Copernico. Dialogo e il sublime Dialogo di Plotino e di Porfirio. Filosofia e poesia
diventano potenza rivoluzionaria che esalta la «seconda natura», perché solo in essa e
con essa gli uomini possono inventare felicità materialistica, poiché «la rivoluzione
copernicana si è fatta seconda natura e il sapere è divenuto potenza costitutiva» 27.
Tale potenza costitutiva del sapere alimenta nel profondo i grandi Canti di quegli
anni: Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, La quiete dopo la tempesta, Il
pensiero dominante. «Con questi Canti, scrive Negri, la poetica leopardiana si fa
pratica dell’essere, afferra i sensi particolari e quello generale dell’essere, per
trasformarli» 28. Abbiamo in effetti a che fare con un «poetico materialistico, costruito
nel fare, definito nella tensione estrema di una realtà che si nega come origine e si
presenta come superficie creativa» 29. La poesia si dipana adesso come «pratica
trasformativa dell’essere», ossia come «etica della libertà», spinozianamente intesa,
che risolve sempre l’infinito e l’assoluto nella costruzione di «vite finite», coscienti del
loro fare e del loro essere. In Leopardi, a differenza di Spinoza, le vite finite
sperimentano la gioia del senso con gli occhi sempre rivolti sull’orlo del nulla, ma ciò
non toglie che esse ritrovino sempre e comunque il desiderio e l’amore di un «essere
etico», che, proprio nella sua radicale differenza dalla natura, è sempre affermazione.
«Non utopia, dunque, ma esperienza dell’essere alternativo» 30.
Come si configura allora la costruzione di questo «essere alternativo»? Come
definire l’essere sulla base di un «fondamento etico»? In effetti, afferma Negri, per
Leopardi «il problema è ormai quello di identificare una nuova base di fondazione
etica del politico» 31. Questo problema non è altro che il «programma» della Ginestra.
Programma che prova, con forza, a rispondere alle seguenti domande: «che cos’è una
politica dell’amore? che cos’è quella radicale alternativa costituzione dell’essere che
viene costruendo il vero e mostrandolo come essenza pratica? Che cos’è il fare della
poesia?» 32. In questo canto del 1836, Leopardi porta alla massima tensione il
27
28
29
30
31
32
Ivi, p. 173.
Ivi, p. 182.
Ivi, p. 189.
Ivi, p. 247.
Ivi, p. 244.
Ivi, p. 259.
�52
S A V E RIO A NSA LDI
rapporto fra agire umano e natura, fra costruzione etica dell’essere e destino. Il suo
materialismo è messo alla prova, perché il confronto fra le due dimensione
ontologiche è durissimo, senza concessioni. La verità della seconda natura, così
sapientemente definita nelle dense pagine dello Zibaldone, si confronta con la
spietata lava del fato, che sembra procedere inarrestabile per ferire ed annientare il
fare etico, poetico e politico dei mortali. Leopardi accentua la violenza dello scontro,
esalta la forza del nemico, ma solo per opporgli l’umana virtù, – l’ostinazione del suo
progetto e la sua costituente resistenza. Machiavelli lirico, scrive Negri. Perché contro
la necessità della fredda natura c’è solo la «guerra comune» delle donne e degli
uomini che riescono a coniugare, nel loro sforzo collettivo, libertà, cupiditas e amor.
Machiavelli, certo, ma anche Spinoza, filtrato da Leopardi attraverso il materialismo
francese settecentesco, ma che acquista nei versi della Ginestra una sua propria
autonomia, che ne mostra una «prassi», ostinata e capace, che sembra renderlo
invincibile. «Leopardi produce qui, come ultima parola della sua poesia, un eroismo
etico di grande intensità ontologica […] Potenza contro natura, potenza contro storia:
l’etico eroicamente lo propone», conclude Negri 33.
L’etica, la politica e la poesia si fondono qui in un unico movimento. Fra i fiori
della Ginestra, la poesia leopardiana ci dice che essa non sarà mai ritorno alla terra
ed elogio di una originaria comunità. Che non sarà mai meraviglia, ingenuità,
stupore di fronte all’essere, ma che sarà invece, sempre e comunque, esperienza
produttiva dell’essere comune. «Costituzione dell’essere, in senso ontologico, come
progetto della comunità umana – questo è il fine della poesia» 34. Contro la necessità
della natura e la violenza della storia, la poesia diventa verità del fare concreto, vera e
propria «vita nuova» – vita che innova, che desidera gioia e libertà proprio là dove
non sembra esserci nulla, solo l’assurdo e l’irrazionale. Poesia è allora il «no» alla
tragedia del mondo che diventa il «sì» della creazione umana, è trama comune di
senso, di innovazione e di alterità – poeisis e praxis, pensiero e lavoro, mente e corpo
nel tempo e allo stesso tempo. Ecco perché, «non ci resta che questo cammino da
iniziare: con una rottura fondamentale, che ci dica altro, che istauri altrove la nostra
umanità. Non siamo né reazionari né progressisti, né avanti né indietro – ma fuori:
l’atto poetico è rivoluzionario, perché costruisce nuova materia collettiva» 35. Questa
potente materia collettiva è quella che il Leopardi europeo canta nella Ginestra,
poiché quella materia è il presente della nostra natura e il futuro immanente della
nostra libertà.
33 Ivi, p. 285.
34 Ivi, p. 287.
35 Ivi, p. 301.
�53
Etica & Politica / Ethics & Politics, XX, 2018, 1, pp. 53-75
ISSN 1825-5167
TRA OPERAISMO E BIOPOLITICA.
GENESI E SVILUPPO DEL CONCETTO
NEGRIANO DI PRODUZIONE
I RE NE V I PA RE LLI
Centro de investigação em Ciência Política
Universidade de Évora
viparelli1@gmail.com
ABSTRACT
The crucial moments in the development of Negri’s concept of production are examined herein.
The description of its genesis is first presented by reconstructing the «passage of production» from
Fordism to post-Fordism. The importance of the French structuralism is then discussed to
definitively move the concept of «production» from the dialectical field to the constituent ontology.
Finally, the fundamental features of the biopolitical mode of production are introduced to
highlight the essential differences with the industrial production.
KEYWORDS
Social worker, biopolitical production, workerism, constituent ontology, post-structuralism
1. INTRODUZIONE
Il concetto di produzione elaborato da Negri risulta esser non solo eterogeneo, ma
addirittura opposto rispetto a quello di Marx. Se quest’ultimo, infatti, aveva
riconosciuto nella composizione organica del capitale, nel vincolo dialettico tra
capitale costante e capitale variabile, il presupposto dello sviluppo contraddittorio del
capitale; per Negri è invece la dissoluzione della composizione organica; la
separazione dei suoi elementi costitutivi, che afferma le condizioni della produzione:
Il ciclo del capitale costante si caratterizza ormai come un rapporto
contraddittorio e insolubile fra il capitale e la forza lavoro: la sintesi non può
farsi che in modo superficiale, in una dimensione ontica, poiché dal punto di
�54
I RE NE V IPARE LLI
vista ontologico, al contrario, la forza lavoro (il Kv) ha trovato lo spazio di
autonomia 1.
Tale trasformazione/opposizione nella definizione del concetto di produzione
risponde all’esigenza negriana di garantire una continuità del punto di vista
marxiano nella contemporaneità. Le innovazioni, le rivoluzioni concettuali che
occorrono sul terreno epistemologico rappresentano infatti, secondo Negri, la
conditio sine qua non per garantire la persistenza di quel «dialogo con Marx […]
essenziale per coloro che sviluppano lotta di classe […] e si propongono oggi una
prospettiva comunista» 2.
Il metodo è sempre storicamente determinato:
Ogni volta […] che cambia il contesto storico cambia anche il metodo. Non c’è
un metodo «per sempre», universale. Meglio: ci sono metodi universali
concretamente determinati, metodi che valgono «generalmente» in certe
situazioni e in certi tempi. La determinazione è tanto importante quanto
l’universalità del metodo 3.
Così le categorie dialettiche marxiane sono stati validi strumenti epistemologici
per la comprensione del modo di produzione capitalistico fino alla crisi dello Statopiano. Come Negri ha infatti ampiamente sottolineato in Marx oltre Marx, la critica
marxiana dell’economia politica, così com’è sviluppata nei Grundrisse, possiede
un’incredibile potenza anticipatrice, che le ha permesso, inseguendo la tendenza
immanente allo sviluppo contradditorio del capitale, di «trascendere» il punto di
vista del capitalismo arretrato della seconda metà del XIX secolo e di strutturare
l’analisi dal punto di vista del pieno sviluppo del capitale. In tal modo, il Marx «oltre
Marx» dei Grundrisse ha di fatto anticipato la prospettiva soggettivista
dell’operaismo, riconoscendo nell’antagonismo tra la forza-lavoro massificata e il
capitale socializzato la chiave di lettura dello sviluppo e della crisi del capitale.
Il passaggio di produzione dal fordismo al post-fordismo, che si impone tra il 1968
e il 1973, inaugura però, proprio a partire dalla crisi dello Stato piano, una nuova fase
di esistenza del capitale, caratterizzata dalla fine del vincolo dialettico che legava le
forze produttive ai rapporti capitalistici di produzione. Da un lato i processi di
automazione, informatizzazione e terziarizzazione della produzione separano la
forza-lavoro socializzata dal vincolo col capitale; dall’altro, parallelamente,
Negri, A. (2006), Fabbrica di Porcellana , trad. it. M. Tarì, Milano: Feltrinelli, p. 60.
Negri, A., «Perché Marx?» in Id. (2012), Il comune in rivolta , Verona: Ombrecorte, p. 15.
3 Negri, A. (2003), Cinque lezioni di metodo su Moltitudine e Impero, Soveria Mannelli:
Rubbettino, p. 31.
1
2
�55
Tra operaismo e biopolitica. Genesi e sviluppo del concetto negriano di produzione
quest’ultimo si è trasforma in potere politico; in una forza che, esterna ai processi
produttivi, fa dell’esproprio violento del valore socialmente prodotto la base della sua
riproduzione storica. Tale nuova realtà, che supera ormai definitivamente la
dialettica e definisce nuove e inedite condizioni della produzione del valore, pone
l’esigenza teorica di una vera e propria rivoluzione «epistemologica»; di una
rielaborazione delle categorie atta a superare non solo le interpretazioni oggettiviste e
economiciste di Marx, ma anche lo stesso operaismo.
Cosa resta di Marx, quando il presupposto dell’analisi non può più essere
l’antagonismo, ma la definitiva autonomizzazione delle forze produttive sociali? Qual
è l’elemento che resiste alle trasformazioni metodologiche? Su che cosa si struttura il
persistente, necessario dialogo con Marx?
Quello che ci interessa è il lavoro non come oggetto ma come attività; non come
valore esso stesso ma come sorgente viva del valore. Di fronte al capitale, nel
quale la ricchezza generale esiste oggettivamente, come realtà, il lavoro è la
ricchezza generale come sua possibilità, che si conferma nell’attività come tale 4.
Il riconoscimento della potenza del lavoro vivo come nucleo ontologico dell’essere
rappresenta quindi quell’invariante teorico-politica che si pone come la condizione
teorica fondamentale per l’elaborazione di una prospettiva genuinamente
materialista e rivoluzionaria.
Possiamo concludere che la prospettiva di Negri, nella sua opposizione rispetto
all’ortodossia marxiana, rinnova la tradizione marxista attraverso l’ipotesi teorica
dell’affermazione di un nuovo modo di produzione, espressione della specifica
caratterizzazione contemporanea della potenza ontologica del lavoro vivo 5. Ne risulta
un concetto di produzione per un verso più inclusivo, per un altro più esclusivo
rispetto a quello marxiano.
Più inclusivo, nella misura in cui il processo di separazione della forza-lavoro dal
capitale corrisponde all’universalizzazione del lavoro produttivo. In Marx oltre Marx
Negri aveva criticato la categoria marxiana di «lavoro produttivo», considerandola
una «definizione pesantemente riduttiva […] inficiata da una considerazione
oggettivistica e atomizzata-feticistica della teoria del valore» 6. Quando invece elabora
la voce «lavoro produttivo-lavoro improduttivo» in Lessico Marxiano, Negri riabilita
la prospettiva marxiana:
Negri, A., «È possibile essere comunisti senza Marx?» in Id. (2012), Il comune in rivolta , cit., pp.
49-50.
5 «Questo rovesciarsi della produzione in principio di un’ontologia costitutiva è il simbolo della
liberazione delle forze produttive dai rapporti di produzione, comunque dati e consistenti. E il
principio della rivoluzione alla base della filosofia moderna». Negri, A., L’anomalia selvaggia, in Id.
(2006), Spinoza , Roma: DeriveApprodi, p. 279.
6 Negri, A (1979), Marx oltre Marx, Milano: Feltrinelli, p. 74.
4
�56
I RE NE V IPARE LLI
In realtà, lavoro produttivo è il lavoro non assoggettato. Quest’ultima
definizione di lavoro produttivo mette inoltre insieme elementi tratti dai
Grundrisse con proposte teoriche che nascono dalla considerazione dei processi
di transizione nel Libro terzo de Il Capitale: si tratta della concezione
dell’«uomo come capitale fisso», e quindi dell’«autovalorizzazione del lavoro
sociale operaio», nonché di alcuni spunti che possono sorgere dalla
riconsiderazione degli schemi di riproduzione del marxiano Tableau
économique. […] Il lavoro produttivo potrà allora – di contro al poter
capitalistico – essere concepito come quella forza collettiva sociale che produce il
comune 7.
Insomma, contro Marx o seguendo le anticipazioni marxiane, lavoro produttivo
non può comunque, in nessun caso, esser inteso come quel «lavoro immediato» che
produce plusvalore, esprimendo piuttosto la potenza sociale del lavoro vivo; quella
creatività della cooperazione umana che si oppone al capitale e si afferma come forza
produttiva autonoma. In tal modo, il concetto di produzione si espande rispetto alla
rappresentazione marxiana, diventando una categoria eminentemente ontologica;
espressione della potenza «oltre misura» dell’attività creatrice umana.
D’altra parte, però, tale spostamento dell’analisi sul terreno ontologico implica
una declinazione più esclusiva del concetto di produzione. Mentre infatti il
dispositivo dialettico marxiano attribuiva al capitale una specifica e fondamentale
funzione nel processo produttivo, ponendolo come soggetto dell’organizzazione della
cooperazione; in Negri, invece, il capitale ha ormai terminato la sua funzione
progressiva; si è definitivamente separato dai processi di creazione del valore per
rifondarsi sul piano politico del comando. Lungi dal definire quindi le condizioni
della produzione, il capitale rappresenta ormai «l’altro», il negativo, l’indeterminato,
il parassitario. Un vuoto ontologico che riesce a ristabilire forzosamente il vincolo di
classe soltanto in virtù del blocco dei processi produttivi. La teoria dello
sfruttamento, conseguentemente, si autonomizza rispetto alla teoria della produzione
e si disloca interamente sul terreno politico dei rapporti di potere:
Lo sfruttamento è così gettato fuori da ogni misura economica, la sua realtà
economica è fissata in termini unicamente politici; lo sfruttamento è funzione di
un processo di riproduzione sociale che si pone come finalità il mantenimento e
la riproduzione del comando capitalista. Il concetto di misura deperisce, si
spegne; la riproduzione del sistema capitalista si dà un ordine secondo dei
Negri, A., «Lavoro produttivo e improduttivo», in AA.VV. (2008), Lessico marxiano, Roma:
Manifestolibri, pp. 128-129.
7
�57
Tra operaismo e biopolitica. Genesi e sviluppo del concetto negriano di produzione
processi di disciplinarizzazione e/o di controllo della società e delle sue diverse
parti 8.
Nel corso dell’articolo, cercheremo di ripercorrere i momenti principali della
formazione di tale inedito concetto di «produzione», fondato sulla definitiva
liberazione della forza-lavoro dal suo vincolo storico con il capitale. Il détour
attraverso il poststrutturalismo francese risulterà essere un passaggio teorico
assolutamente fondamentale; lo strumento per liberare definitivamente il metodo
dalla dialettica e per dislocare l’analisi sul terreno ontologico delle forze produttive
biopolitiche contemporanee.
2. ROTTURA ONTOLOGICA
La congiuntura storica che si delinea tra il 1968 e il 1973, caratterizzata
dall’emersione di nuove soggettività antagoniste e dalla crisi capitalista
internazionale, se da un lato mette in luce i limiti della prospettiva teorica
dell’operaismo degli anni ’60, strutturata sull’assoluta centralità dell’operaio massa,
dall’altro, parallelamente, ne conferma pienamente la validità epistemologica. «Il
meccanismo attacco operaio, ristrutturazione capitalistica, riconfigurazione della
composizione di classe» 9, infatti, rappresenta lo strumento analitico privilegiato per
la comprensione di tale passaggio storico fondamentale. Seguendo Marx, la «crisi
dello Stato piano» dev’essere interpretata come l’espressione del pieno
dispiegamento della contraddizione capitalistica tra l’aumento della produttività del
lavoro e la valorizzazione del capitale. La legge della caduta del saggio di profitto,
trasformandosi da tendenza in effettività storica, concretizza l’«utopia marxiana» del
General Intellect, affermando una società in cui la «produzione di ricchezza» non
dipende più dal «lavoro immediato» ma dalla «produttività generale» della società;
dallo «stato generale della scienza e dal progresso della tecnologia»; dallo sviluppo
dell’ «individuo sociale» 10.
Oltre Marx, però:
La descrizione marxiana del meccanismo va […] marxianamente corretta su
questo punto decisivo: il rapporto fra saggio del profitto e massificazione della
Negri, A.,«Crisi della legge del valore-lavoro», in AA.VV. (2008), Lessico marxiano, cit., p. 92.
Negri, A. (2007), Dall’operaio massa all’operaio sociale, Verona: Ombrecorte, p. 21.
10 Marx, K. (1997), Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica 1857-1858, Vol. II,
trad. it. E. Grillo, Firenze: La Nuova Italia Editrice, pp. 400-401.
8
9
�58
I RE NE V IPARE LLI
produzione si dà dentro rapporti di forza nuovi, a partire da una base sociale che
lo sviluppo capitalistico stesso ha determinato e che le lotte hanno definito e
costituito in soggetto 11.
Lo sviluppo capitalistico non solo oggettivamente, ma soprattutto soggettivamente
ha spinto all’estremo lo sviluppo contraddittorio del capitale. Sono state le lotte sul
salario dell’operaio massa che, aumentando progressivamente il tempo di lavoro
necessario, hanno trasformato il salario da «variabile indipendente» in «ostacolo
radicale» 12 allo sviluppo capitalistico. È stato, quindi, l’antagonismo proletario che,
obbligando il capitale a portare avanti il processo di svalorizzazione del lavoro; ha
stabilito le condizioni del realizzarsi della tendenza alla caduta del saggio di profitto
e all’affermazione della crisi.
«Come gestisce il capitale questo passaggio? Come salva se stesso espellendo il
lavoro?» 13: «Il salto qualitativo», la sola risposta capitalistica possibile,
non è solo dentro un’ulteriore riduzione del tempo di lavoro necessario
(aumento della produttività del lavoro) bensì soprattutto dentro una radicale
svalutazione del tempo di lavoro come componente essenziale del processo
produttivo (controllo politico e schiacciamento della classe operaia) 14.
I processi di automazione della produzione rappresentano l’arma con cui il
capitale si propone di isolare la «nuova base sociale […] dal processo produttivo» 15,
per dissolvere le basi tecniche e, con esse, la potenza politica dell’operaio massa. In
tal modo però, spingendo all’estremo il processo di svalorizzazione del lavoro, il
capitale dissolve definitivamente le basi del funzionamento della legge del valore e,
con esse, le sue proprie condizioni d’esistenza.
Il capitale sa che lo sfruttamento è legittimato, che esso ha «ragione» di esistere
solo in quanto il saggio di profitto cresca, e su esso lo sviluppo capitalistico, e con
esso la forza progressiva del capitale. La gestione capitalistica di questa crisi deve
allora passare attraverso la ricerca di una nuova legittimazione, attraverso
l’ancoramento del potere del capitale a sorgenti di lavoro vivo, se non ne trarrà
Negri, A., «Partito operaio contro il lavoro», in Id. (1997), I libri del rogo, Roma: Castelvecchi
Editoria, p. 88.
12 Ibid .
13 Ivi, p. 92.
14 Negri, A., «Proletari e Stato», in Id. (1997), I libri del rogo, cit., p. 177.
15 Negri, A., «Partito operaio contro il lavoro», in Id. (1997), I libri del rogo, cit., p. 88.
11
�59
Tra operaismo e biopolitica. Genesi e sviluppo del concetto negriano di produzione
ricchezza, ne trarrà l’illusione legittimamente di essere ancora capace di
sfruttamento 16.
Il capitale, nell’impossibilità di ristabilire un virtuoso ciclo di sviluppo, pone la
crisi definitiva della legge del valore come nuovo orizzonte della sua esistenza storica
e, rinunciando definitivamente ad ogni «funzione progressiva», procede alla
definitiva separazione di pianificazione e sviluppo. Così il dominio, la capacità di
comando sulla società, diventa la nuova base della persistenza storica del capitale, la
sua esclusiva ragion d’essere:
Dentro l’appiattimento quantitativo del saggio del profitto e l’espulsione del
valore dal processo, la permanenza dell’orizzonte del profitto rivela il suo
segreto: essa è solo permanenza del potere del capitale, è solo esaltazione della
sua faccia irrazionale di comando 17.
Nel saggio Per la critica della costituzione materiale, del 1977, Negri si preoccupa
di descrivere minuziosamente tale processo di metamorfosi, attraverso il quale il
capitale perde la sua fisionomia tradizionale per trasformarsi in amministrazione, in
strumento di inclusione della totalità delle relazioni sociali nella logica del profitto
dell’impresa capitalistica. Il primo effetto di tale «colonizzazione» capitalistica del
sociale è l’integrazione di produzione e circolazione: la sempre più completa
subordinazione della circolazione ai processi di valorizzazione del capitale realizza la
tendenza capitalistica all’azzeramento dei faux frais della produzione:
Quanto più il capitale scopre strumenti per determinare «circolazione senza
tempo di circolazione» (denaro, credito ecc.) tanto più esso è costretto a «dare al
tempo di circolazione in quanto tale il valore di tempo di produzione nei diversi
organi in cui si media il processo di circolazione e il processo del tempo di
circolazione, a dargli cioè un valore» 18.
In secondo luogo, e conseguentemente, si inaugurano quei processi di
terziarizzazione e unificazione del lavoro che, espandendo l’orizzonte di
valorizzazione all’intera società, dissolvono le tradizionali opposizioni marxiane tra
produzione e riproduzione, tra lavoro produttivo e lavoro improduttivo:
16
17
18
Ivi, p. 94.
Ivi, p. 92.
Negri, A., «Per la critica della costituzione materiale», in Id. (1997), I libri del rogo, cit., p. 221.
�60
I RE NE V IPARE LLI
Ne viene che, come tendenza storicamente verificabile, l’azione del capitale
potenziale produttivo, latente nella struttura della circolazione, spinge alla
riduzione ed al controllo del tempo di produzione attraverso la centralizzazione
del capitale e la terziarizzazione crescente dei processi produttivi. Così la
categoria di capitale sociale passa dalla latenza all’effettualità, in quanto
presupposto effettivo di un modo di produzione sociale 19.
Socializzazione della produzione e unificazione del lavoro fanno però
immediatamente intravedere i limiti e il tragico destino della ristrutturazione
capitalistica. Proprio come nella precedente ristrutturazione, anche stavolta, infatti, il
capitale è destinato a veder fallire i propri obiettivi politici. La rivoluzione
tecnologica messa in atto all’inizio del secolo XX dal taylorismo, per sottrarre il
«partito bolscevico alla classe» 20 e dissolvere il rapporto potenzialmente
rivoluzionario tra le avanguardie operaie e il proletariato, lungi dall’esser riuscita a
distruggere le condizioni dell’antagonismo, aveva invece definito i presupposti della
sua massificazione e generalizzazione. La nuova ristrutturazione capitalistica degli
anni ’70, parallelamente, nel tentativo di dissolvere la potenza della classe operaia,
aveva anch’essa determinato le condizioni per un ulteriore dislocamento della lotta di
classe; per un decisivo passo in avanti nel processo di generalizzazione e
radicalizzazione dell’antagonismo proletario:
È un’ipotesi sconvolgente quella che comincia a configurarsi, la categoria classe
operaia va in crisi ma continua a produrre tutti gli effetti che gli sono propri sul
terreno sociale intero, come proletariato. […] Dopo che il proletario si era fatto
operaio, ora il processo è inverso: l’operaio si fa operaio terziario, operaio sociale,
operaio proletario, proletario. Ma questa figura è aufgehoben. Perché qui, su
questo proletariato nuovo, non è l’esclusione dell’erogazione del lavoro
capitalistico che è specifica ma, al contrario, è l’inclusione nella totalità del
processo produttivo sociale – e nell’andamento alterno delle sue condizioni – che
è fondamentale 21.
Le caratteristiche politiche proprie dell’operaio massa – rifiuto del lavoro e
l’autovalorizzazione della classe – lungi dallo scomparire per effetto della
ristrutturazione, si ripresentano invece, generalizzandosi, sul terreno della
produzione sociale. Nel momento in cui non c’è più alcuna indipendenza del valore
d’uso, poiché la sottomissione della circolazione alla produzione ha subordinato
19
Ivi, p. 220.
Negri, A., «J. M. Keynes e la teoria capitalistica dello stato nel ’29», in AA.VV. (1973), Operai e Stato.
Lotte operaie e riforma dello stato capitalistico tra rivoluzione d’Ottobre e New Deal, Milano: Feltrinelli, p.
71 .
20
21
Negri, A., «Proletari e Stato», cit., p. 149.
�61
Tra operaismo e biopolitica. Genesi e sviluppo del concetto negriano di produzione
completamente il sistema dei bisogni alla logica del profitto capitalistico, è il valore
d’uso operaio, la creatività del lavoro vivo, che si presenta come nuovo nucleo
antagonistico della società:
L’opposto del valore di scambio non è dunque il valore d’uso, che anzi ci è dato
come riflesso del primo – quale che sia la composizione di classe. […] L’opposto
del valore di scambio è invece il valore d’uso del lavoro, il lavoro come attività,
come mera forza di produzione creativa, di invenzione 22.
Il passaggio dall’operaio massa all’operaio sociale, quindi, non indica appena una
riproduzione allargata delle caratteristiche antagoniste dell’operaio massa, ma
piuttosto un «salto qualitativo», una radicale metamorfosi delle condizioni
dell’antagonismo e della liberazione. Quando infatti la totalità del lavoro vivo si
oppone al capitale, allora «alla possibilità formale della ricchezza di lotte […] si
aggiungono condizioni reali fondate sulla qualità della composizione di classe e sulla
intensità della crisi di capitale» 23. Da un lato il capitale, avendo espulso il lavoro e
avendo posto il comando come nuovo orizzonte della sua valorizzazione, si presenta
ormai come un elemento completamente esterno rispetto al processo produttivo di
valore. Quindi, «non tendenzialmente ma attualmente non si potrà più attribuire una
qualsiasi menzione di forza produttiva allo sviluppo capitalistico» 24. Dall’altro,
parallelamente, «solo la composizione proletaria rivela, rappresenta, può essere
sviluppo storico delle forze produttive, della forza produttiva» 25. Così, in questo
fondamentale passaggio di produzione, caratterizzato dalla tendenza di entrambi i
termini del rapporto di capitale all’autonomizzazione, si compie un vero e proprio
«salto ontologico», un’inversione completa del rapporto di classe: «la classe operaia,
anziché essere mossa dal capitale, muove essa stessa e subordina ai suoi propri
comportamenti il capitale» 26.
«La positività radicale, ontologica del rifiuto del lavoro» 27, l’effettiva e concreta
capacità delle forze produttive sociali di produrre e di riprodursi nella completa
indipendenza, stabilisce così le condizioni storiche per un nuovo rapporto di classe
che, proprio per esser fondato sulla separazione della forza-lavoro dal capitale, per la
prima volta nella storia afferma le condizioni della definitiva liberazione del/dal
lavoro.
In conclusione Negri, attraverso l’analisi del passaggio di produzione dall’operaio
massa all’operaio sociale, utilizza il metodo operaista per spingere lo stesso
22
23
Ivi, p. 174.
Negri, A., «Proletari e Stato», cit., p. 177.
24
Negri, A., «Il dominio e il sabotaggio», in Id. (1997), I libri del rogo, cit., p. 289.
25
Ibid.
Negri, A., «Proletari e Stato», cit., p. 186.
27 Negri, A., «Per la critica della costituzione materiale», cit., p. 224.
26
�62
I RE NE V IPARE LLI
operaismo oltre i suoi presupposti originari, verso un «secondo operaismo» 28 che,
superando definitivamente il fabbrichismo e la dialettica di capitale, disloca e
generalizza l’antagonismo sul terreno della totalità delle relazioni sociali. In tal
modo, si definiscono le basi su cui poter elaborare il concetto di un nuovo modo di
produzione che, caratterizzato dalla scissione, dal dualismo degli elementi costitutivi
del rapporto di capitale, riesca a esprimere l’impossibile mediazione tra un capitale
ormai completamente irrazionale e parassitario e il lavoro vivo, ontologicamente
potente 29.
3. POSTSTRUTTURALISMO
È il concetto di «autovalorizzazione», ci avverte Negri nella Prefazione del 1997 a I
libri del rogo, che porta a compimento il processo di dissoluzione della composizione
organica del capitale, il divorzio tra forze produttive sociali e capitale e il definitivo
dislocamento del concetto di produzione sul terreno ontologico:
Il concetto di autovalorizzazione non è solo importante perché raccoglie ed
unifica i nuovi elementi che configurano la forza produttiva nel postfordismo:
[…] Il concetto di autovalorizzazione, così come viene espresso in questi saggi, è
ancora importante per due ragioni. La prima è che qui si dichiara interrotta,
definitivamente interrotta, la cattiva dialettica che legava lo sviluppo del capitale
Negri, A. (2015), Storia di un comunista , Ponte alle Grazie (edizione digitale), p. 463. «Cogliere da
un lato il denaro come ‘equivalente generale nella misura in cui è immediatamente organizzazione del
comando di capitale’ e dall’altro il fatto che l’operaio sociale si rappresenta ormai anch’esso sul terreno
sociale dello sfruttamento è un passaggio che resterà centrale nello sviluppo del ‘secondo’ operaismo. È
possibile collocare qui la nascita di un secondo operaismo? È probabile, se si tiene conto che su questa
base verranno poi sviluppati il concetto di ‘autovalorizzazione’ e il passaggio dall’egemonia – nella
produzione – della produzione materiale a quella del lavoro immateriale. Qui è fissato quella specie di
‘dualismo di potere’ che verifica in positivo il principio operaista di soggettivazione della forza lavoro e
lo pone come motore non solo della lotta di classe ma anche della trasformazione della struttura
capitalista» (ibidem ).
28
«L’operaio sociale è dunque il produttore della cooperazione sociale lavorativa. Egli non vuole avere
padroni perché non può avere padroni – se questi si dessero verrebbe meno la sua definizione stessa, e non
sarebbero tali la sua natura e la sua identità. Identità collettiva, perché la coscienza operaia è sempre
collettiva, e tanto più lo è la coscienza di sé nel momento in cui ci si riconosce come esclusivi organizzatori
del lavoro collettivo. […] Su questa svolta – l’operaio sociale come ordinatore, organizzatore diretto della
cooperazione lavorativa, il rifiuto della funzione capitalistica di comando sul lavoro diviene estremo, tanto
da trasformarsi nell’esclusione materiale, dotata della violenza del dispositivo fisico, del capitalista. Ogni
giustificazione storica, progressiva, della funzione del capitale, viene così meno. L’operaio sociale è una sorta
di attualità del comunismo, la sua condizione sviluppata. Il padrone, di contro, non è più neppure
condizione del capitalismo» (Negri, A. (2005), Fine Secolo, Roma: Manifestolibri, pp. 53-54).
29
�63
Tra operaismo e biopolitica. Genesi e sviluppo del concetto negriano di produzione
allo sviluppo delle lotte. […] E, cosa molto più importante, l’autovalorizzazione si
poteva vedere qui, nella sua separazione, nella larghezza dello spettro di
incidenza della sua azione, come latenza e potenza di un radicalissimo potere
costituente 30.
Il passaggio oltre Marx, verso una neue Darstellung che sappia descrivere la
potenza costituente dell’operaio sociale sembra esser dunque definitivamente
compiuto 31. Ed in effetti talvolta, leggendo gli scritti di Negri successivi al 1980, si ha
la sensazione che si tratti di un ininterrotto processo di formalizzazione,
approfondimento e riscrittura di quel fondamentale «passaggio di produzione»,
vissuto e studiato attraverso e nella militanza politica.
Ma è davvero possibile leggere il rapporto tra gli scritti «militanti» e gli scritti
posteriori attraverso il binomio creazione-formalizzazione teorica?
Sempre nella Prefazione del 1997 a I libri del rogo Negri afferma:
Questi opuscoli sono essenzialmente politici. Essi non potevano, sul terreno
della pratica politica, produrre un’analisi teorica tanto completa quanto quella
condotta nel poststrutturalismo francese. Per dirla con Michael Hardt, negli anni
Settanta in Italia si fece quella politica che nello stesso tempo la metafisica
francese teorizzava: così come nell’Ottocento la politica si faceva in Francia – lo
ricorda Marx – e la metafisica di quella politica in Germania. Dunque a questi
opuscoli mancano molte cose, poiché essi non sono stati concepiti come trattati,
ma appunto, al contrario, come strumenti di intervento immediato nella lotta
politica. Ma questa mancanza non ci fa pena, neppure oggi dopo tanti anni: anzi,
incita non solo a far propria, come complemento necessario, la teoria
poststrutturalista francese, ma ad attraversarla gioiosamente, e sulla base di
quell’enorme esperienza che il lavoro politico, (nelle sue vittorie e nelle sue
sconfitte) e il lavoro di inchiesta hanno accumulato 32.
Tali considerazioni sembrano in effetti confermare la possibilità di una lettura
della produzione teorica di Negri successiva al periodo militante come un lungo
processo di formalizzazione della verità dell’operaio sociale. Da un lato,
individuando nel carattere eminentemente politico degli opuscoli, nella loro
subordinazione alle esigenze della pratica militante, la causa dei loro limiti
fondamentali, Negri sembra in effetti suggerire l’ipotesi di una «latenza», di un «non
detto», di un nucleo teorico che, implicito in tali testi, deve pervenire alla sua
formulazione concettuale. Dall’altro, interpretando il poststrutturalismo come
30
Negri, A. (1997), «Prefazione» a I libri del rogo, cit., p. 11.
31
Cfr. Negri, A (1979), Marx oltre Marx, cit., p. 189.
32
Negri, A. (1997), «Prefazione» a I libri del rogo, cit., p. 17.
�64
I RE NE V IPARE LLI
movimento filosofico che ha affrontato le medesime questioni operaiste dal punto di
vista «della teoria», Negri sembra porre l’esigenza di un «complemento
poststrutturalista» dell’operaismo, teso a colmarne le latenze attraverso la
esplicitazione dei presupposti teorici.
Possiamo davvero ridurre la funzione del poststrutturalismo a strumento di
formalizzazione della prospettiva operaista? Possiamo davvero leggere il percorso
operaista e il percorso poststrutturalista attraverso un presunto parallelismo di teoria
e politica? In che cosa consiste e come si configura, propriamente, tale parallelismo?
Per Negri, la comune percezione, in forme differenti, di quel «passaggio di
produzione» dal fordismo al postfordismo, pone all’operaismo e al poststrutturalismo
francese una medesima esigenza epistemologica; la necessità di una vera e propria
svolta metodologica. Così, mentre Negri in Italia forza il dispositivo operaista in
direzione di un’ontologia costituente, descrivendo il passaggio dall’operaio massa
all’operaio sociale; Foucault, parallelamente, in Francia, spinge le premesse
strutturaliste dell’analisi in direzione di una radicale ridefinizione della teoria della
soggettività.
Secondo Negri, infatti, in Francia «negli anni ’60, attorno a Althusser, a Claude
Lévi-Strauss, a Lacan, a Foucault, più tardi a Derrida, il problema della riproduzione
è posto in maniera radicale» 33 e produce, come effetto filosofico fondamentale, la
definitiva dissoluzione di ogni trascendentale, di ogni dualismo di struttura e
sovrastruttura, di economico e politico-ideologico. Lo strutturalismo francese afferma
così in modo radicale l’assolutezza del piano di immanenza, distruggendo le basi su
cui si era costruito il soggetto cartesiano e ponendo le premesse per una
riformulazione, su altre basi, della teoria della soggettività. Il «secondo» Foucault
risponde a tale sfida teorica e, opponendosi radicalmente alla chiusura
monodimensionale dell’essere della scuola francofortese, pone il passaggio dal
politico al biopolitico come nuovo presupposto della teoria del soggetto: da un lato
non più solo i corpi ma le popolazioni – la totalità della vita sociale – diventano
oggetto del potere; dall’altro, proprio questa completa inclusione della vita
nell’orizzonte del potere, questo completo assoggettamento si capovolge e inaugura
continuamente processi di soggettivazione, inedite pratiche di resistenza:
Qui l’incontro con le posizioni dell’operaismo italiano che considerava sempre
il capitale come un rapporto di comando, e cioè il capitale come un’unità rotta in
due – capitale variabile contro capitale costante, come resistenza e comando, come
puissance e pouvoir – bene, quest’incontro è dato 34.
Negri, A. (10/01/2011), Alle origini del biopolitico. Un seminario, «Uninomade 2.0» , URL:
http://www.uninomade.org/alle-origini-del-biopolitico/
33
34
Ivi.
�65
Tra operaismo e biopolitica. Genesi e sviluppo del concetto negriano di produzione
Questo parallelismo tra operaismo e poststrutturalismo, però, non è soltanto
espressione di un comune orizzonte teorico, ma permette anche, e soprattutto, di
mettere in luce un medesimo limite teorico.
Nel passaggio dagli anni Settanta agli anni Ottanta, Negri infatti, a più riprese,
manifesta la sensazione di un «ritardo teorico». Così, in Dall’operaio massa
all’operaio sociale, afferma: «Non so, ma probabilmente – ed è una cosa che devo
dire anche rispetto ai miei scritti – si è terribilmente indietro rispetto a questo salto
qualitativo, a questa situazione teorica» 35. La rivoluzione dell’operaio sociale,
l’autonomizzazione definitiva delle forze produttive, stravolgendo completamente la
logica di funzionamento della società, aveva posto l’esigenza di una radicale
rivoluzione metodologica che era però ben lungi dall’esser ancora compiuta.
Nella «Introduzione» del 1997 a La costituzione del tempo. Prolegomeni, Negri
elabora ulteriormente tale «disagio teorico», riconoscendo nel metodo operaista la
base di un vero e proprio impasse: «la rigidità dello sviluppo antagonistico delle due
tendenze della temporalità (capitalistica e operaia) trasformava l’antagonismo in
‘blocco’ della ricerca» 36. Sebbene infatti i Prolegomeni si proponessero di descrivere
la «temporalità autonoma» dell’operaio sociale, in realtà non riuscivano a sviluppare
una rappresentazione «per sé» della soggettività, qualificandola soltanto in funzione
del capitale; come suo «altro», opposto simmetrico. L’analisi restava così bloccata in
una dimensione relazionale che non permetteva di compiere il definitivo
dislocamento sul terreno ontologico:
Avevo un bel ripetere che la temporalità capitalistica era distruttiva, quella
proletaria costitutiva – ma non lo mostravo se non astrattamente, come si indica
un’idea della ragione piuttosto che come, materialisticamente, si costruisce un
«nome comune», una comunanza cioè di esperienze costitutive. Il topos era sì
identificato in una ontologia fondamentale, ma gli mancava un telos. C’era la
cornice e non c’era la figura che anima ogni rappresentazione. C’era una
geologia delle temporalità, non c’era una genealogia della soggettività di massa.
Ne veniva che le stesse nuove figure del lavoro che erano identificate, dall’
«operaio sociale» all’«intellettualità di massa», […] erano incapaci di
rappresentarsi come nuovo paradigma della soggettività 37.
Insomma, il dispositivo antagonista dell’operaismo, di fronte alla autonomia delle
forze produttive sociali, si era trasformato in un ostacolo allo sviluppo teorico; in un
vero e proprio «blocco della ricerca», che impediva la liberazione del tempo
ontologico e la qualificazione delle forze produttive autonome. Conseguentemente la
35
36
37
Negri, A. (2007), Dall’operaio massa all’operaio sociale, cit., p. 127.
Negri A. (1997), «Introduzione» a La costituzione del tempo. Prolegomeni, Roma: Manifestolibri, p. 15.
Ivi, p. 16.
�66
I RE NE V IPARE LLI
specificità produttiva dell’operaio sociale era posta, ma restava priva di
determinazioni concrete, «poveramente etica» 38.
La medesima indeterminatezza ontologica, la stessa incapacità di superare
l’orizzonte teorico di riferimento, lo stesso «blocco della ricerca» si ritrova nel
passaggio foucaultiano dalla politica alla biopolitica:
Non ci sembra […] che Foucault – anche quando scopriva efficacemente
l’orizzonte biopolitico della società e lo caratterizzava come piano di immanenza
– sia mai riuscito a portare il suo pensiero al di fuori dell’epistemologia
strutturalista che ha orientato la sua ricerca sin dall’inizio. […] Se a questo punto
potessimo chiedere a Foucault chi o che cosa guida il sistema o, piuttosto, che
cosa è il «bios», la sua risposta sarebbe ineffabile o sarebbe il silenzio. Ciò che in
definitiva Foucault non è riuscito a cogliere sono le dinamiche reali della
produzione nella società biopolitica 39.
Ci sembra di poter concludere che i «vuoti teorici» degli scritti operaisti non
esprimono semplici «latenze», ma sono piuttosto i segni di un vero e proprio «blocco
della ricerca». Il parallelismo Foucault/operaismo, parallelamente, lungi dal mettere
in luce una presunta «funzione formalizzatrice» della «teoria francese» rispetto
all’elaborazione militante, lascia invece emergere il riproporsi, sul piano dell’analisi
teorica, della medesima incapacità a spingere l’analisi definitivamente sul terreno
dell’ontologia costitutiva. Come superare tali «blocchi della ricerca»?
La figura di Deleuze assume in tale contesto un’importanza assolutamente
fondamentale: singolarizzando e soggettivando il piano di immanenza, Deleuze
individua il nucleo fondamentale dell’ontologia costitutiva, superando
l’indeterminatezza e inaugurando il movimento veramente creativo della teoria.
Nel 1983 ritorno in Francia dopo una lunga carcerazione in Italia. […] Respiro
quindi da vicino l’aria di quel capolavoro […] di letteratura e di condivisione
spirituale che fu il suo libro Foucault . Esso rappresentò il definitivo superamento di
quella impasse fra «soggettività senza oggetto» e «struttura senza soggetto» della
quale abbiamo già descritto la topografia in Foucault. […] Quanto a noi, per
ottenere l’insieme del quadro di questo formidabile oltrepassamento della
tradizione filosofica francese […] dovevamo ancora attendere la pubblicazione
dei corsi foucaultiani al Collège de France. Avevamo comunque compreso che, se il
secolo ventesimo era divenuto deleuziano, il ventunesimo sarà foucaultiano 40.
38
Ibid.
Negri A.; Hardt, M. (2002), Impero, trad. it. A. Pandolfi, Milano: Rizzoli, p. 43.
40
Negri, A. (30/12/2014), Un’esperienza marxista di Foucault, «EuroNomade»,
http://www.euronomade.info/?p=3903
39
URL:
�67
Tra operaismo e biopolitica. Genesi e sviluppo del concetto negriano di produzione
L’incontro di Negri con il poststrutturalismo si arricchisce così di altri due
momenti fondamentali: la «mediazione» deleuziana nell’interpretazione di Foucault
e la pubblicazione dei corsi foucaultiani al Collège de France. Ciascuno di questi
«incontri» rappresenta un passaggio fondamentale nel superamento del «blocco
teorico» e nella definizione della base ontologica adeguata all’analisi del nuovo modo
di produzione.
Deleuze, in primo luogo. La riflessione sul concetto di singolarità permette la
definitiva rottura con il quadro teorico strutturalista. Singolarità è, infatti, una
rappresentazione del soggetto che, abbandonato ogni individualismo e ogni
collettivismo, esprime una molteplicità irriducibile ad ogni identità e unità, formata
dalla relazione di «singolarità differenti, mai identificate nell’insieme e neppure mai
sostanzializzate come individui separati. La singolarità è fatta dall’insieme e fa
l’insieme» 41. Tale rete di relazioni singolari, esprimendo la potenza desiderante
dell’esser soggettivo e definendo quei processi molecolari che fanno del piano di
immanenza l’orizzonte di un’indefinita generazione e creazione d’essere, riesce a
dare infine consistenza ontologica al biopolitico foucaultiano e all’operaio sociale
negriano 42.
Il concetto deleuziano di singolarità rappresenta quindi indubbiamente un
passaggio teorico necessario. Non sufficiente, però! In Deleuze, infatti, il concetto di
singolarità si definisce su «un orizzonte caotico e indeterminato segnato
dall’ineffabilità dell’evento» 43; un terreno aleatorio in cui il movimento creativo
dell’essere non riesce mai a determinarsi, a storicizzarsi. Conseguentemente, la
prospettiva teorica deleuziana ripropone in nuova forma, secondo Negri, i limiti della
metafisica spinoziana.
Nell’ Anomalia selvaggia Negri aveva sottolineato l’incapacità spinoziana di
dislocare l’analisi della potenza ontologica dal terreno astratto-spaziale a quello
concreto-temporale della storia. In Alle origini del biopolitico la medesima critica è
estesa a Deleuze:
Se infatti si assume che, in Deleuze, continua sia la mutazione di tutti i termini
di riferimento ed aleatoria la base di ogni loro consistenza e/o di ogni pulsione
desiderante, ne viene comunque che, dentro questa definizione di «campo di
immanenza», sarà comunque ben difficile definire un’idea di politica e/o di
potere. […] Il negativo che si oppone all’ «essere per», il potere che nega la
Negri, A. (2003), Guide, Milano: Raffaello Cortina Editore, p. 125.
«Qui è fondamentale il richiamo a Spinoza – ad una nuova lettura di Spinoza che toglie al panteismo
ogni effetto statico per scoprirvi, di contro, riccamente, una pulsione creativa. La biopolitica sarà allora qui
percorsa dalla ‘cupiditas’, dal desiderio, quindi dalla puissance d’agire. Ed è qui che il pensiero di Nietzsche,
oltre a quello di Spinoza, sono messi al servizio di una filosofia materialista della liberazione». (Negri, A.
(10/01/2011), Alle origini del biopolitico. Un seminario, cit.)
43 Negri A.; Hardt, M. (2002), Impero, cit., p. 43.
41
42
�68
I RE NE V IPARE LLI
«generazione» non ci sono – c’è solo la loro negatività, il loro «non-essere». […] In
Deleuze manca la piena riduzione dell’immanenza alla storicità: una
convincente definizione del campo di immanenza e del biopolitico esige invece
la coincidenza di immanenza e storia 44.
Insomma, l’indiscusso progresso teorico deleuziano nella determinazione
soggettiva del piano di immanenza è, allo stesso tempo, un regresso dal punto di vista
della determinazione storica rispetto alle posizioni foucaultiane che invece, attraverso
la definizione del passaggio dalla società disciplinare alla società del controllo, dal
politico al biopolitico, avevano determinato storicamente il piano di immanenza.
C’è dunque bisogno di un ulteriore passaggio teorico; di un ritorno a Foucault,
dopo e «oltre» Deleuze. I corsi al Collège de France rappresentano così il momento
culminante e fondamentale dell’incontro di Negri con il poststrutturalismo.
Qui, infatti, la riflessione foucaultiana sul «rapporto a se» esprime il definitivo
superamento della prospettiva strutturalista e la piena assunzione della dimensione
deleuziana della potenza soggettiva:
Negli anni che ci interessano, Foucault avanza nell’articolazione di politica e di
etica, definendo un «rapporto a sé» che è – contro ogni operazione
individualizzante ed ogni ripresa del soggetto cartesiano – costituzione collettiva
del soggetto e sua immersione nel processo storico. Ne viene una «destituzione»
del soggetto, che si presenta come scavo del Noi – del rapporto Io/Noi – non solo
come divenire ma come pratica della molteplicità. Il Noi è una moltitudine e l’Io
vi è definito nella relazione all’altro. […] Per dirlo in modo brutale e schematico,
il sé greco non è l’io cartesiano e a fortiori non è l’individuo costruito dal
liberalismo economico e politico di cui Foucault descrive la nascita nel ’78 – è
piuttosto quella singolarità che Deleuze aveva definito 45.
Tale singolarità però, in Foucault, non appare più astrattamente determinata sul
terreno aleatorio degli eventi, ma si presenta invece come effettività storica, come
singolarità concreta che trova nel passaggio dal politico al biopolitico le condizioni
concrete, «politiche della sua produzione e riproduzione. […] Il campo di immanenza è
biopolitico» 46.
In conclusione, quell’operazione di ibridazione dell’operaismo col
poststrutturalismo, quello «sciacquare i panni nella Senna» 47 si presenta come un
processo ben complesso, strutturato su due momenti teorici fondamentali: in primo
Negri, A. (10/01/2011), Alle origini del biopolitico. Un seminario, cit.
Negri, A. (30/12/2014), Un’esperienza marxista di Foucault, cit.
46 Negri, A. (10/01/2011), Alle origini del biopolitico. Un seminario, cit.
47 Negri, A. (2002), Il Lavoro di Giobbe, Roma: Manifestolibri, p. 14.
44
45
�69
Tra operaismo e biopolitica. Genesi e sviluppo del concetto negriano di produzione
luogo, il concetto deleuziano di singolarità permette di superare quella
«indeterminatezza ontologica» comune a Foucault e all’operaismo. In secondo luogo,
i corsi di Foucault al Collège de France definiscono le condizioni politiche per la
concretizzazione storica di tale singolarità deleuziana. In tal modo, attraverso questo
duplice movimento, il poststrutturalismo definisce quel contesto biopolitico di
continua produzione e riproduzione della vita, che rappresenta la base teorica
adeguata per poter sviluppare l’analisi di un modo di produzione che ormai esprime
soltanto la temporalità del lavoro vivo; la potenza ontologica dell’autonoma
cooperazione sociale:
Il concetto marxiano di forza lavoro che, a livello del General Intellect è
divenuto «indeterminazione capace di tutte le determinazioni», è così sviluppato
da Deleuze e Foucault in un processo di produzione di soggettività autonomo. La
soggettività come elemento di indeterminazione assoluto diventa un elemento di
potenzialità assoluta. […] Il processo di produzione di soggettività, cioè il
processo di produzione tout court, si costituisce «fuori» dal rapporto di capitale,
«in seno» ai processi costitutivi dell’intellettualità di massa, cioè nella
soggettivazione del lavoro.
In conclusione, il détour di Negri attraverso il poststrutturalismo francese ha
permesso di cogliere le dinamiche fondamentali dei processi di soggettivazione che si
sviluppano sul terreno biopolitico. Bisogna, su tale base, compiere un passaggio
ulteriore, mostrando la possibilità di applicare il concetto di biopolitico «alla nostra
attualità» 48. Così, a partire dalla prima metà degli anni ’90, grazie anche al lavoro
svolto attorno alla rivista Futur Antérieur, Negri, pone la teoria poststrutturalista del
soggetto al servizio di una vera e propria fenomenologia del modo di produzione
contemporaneo.
4. PRODUZIONE BIOPOLITICA
Il concetto poststrutturalista di singolarità risulta essere perfettamente adeguato a
descrivere la specificità del nuovo soggetto produttivo. La moltitudine infatti da un
lato, ponendosi in opposizione alla categoria di popolo, descrive la soggettività come
molteplicità irriducibile all’unità. Dall’altro, opponendosi egualmente ai concetti di
massa e di plebe, si afferma come espressione di un’immanenza produttiva; di una
48
Negri, A. (30/12/2014), Un’esperienza marxista di Foucault, cit.
�70
I RE NE V IPARE LLI
molteplicità che è in grado di produrre organizzazione, cooperazione e creazione di
valore.
Nel corso della storia moderna il concetto di moltitudine, dato il limitato sviluppo
delle forze produttive, non poteva che presentarsi come una categoria astratta,
formale: cupiditas spinoziana o «carne» merlau-pontiana, la moltitudine esprimeva
quella «comune sostanza vivente nella quale il corpo e l’intelletto coincidono e sono
indistinguibili» 49; quella potenza che perennemente tende alla pienezza della vita, alla
costituzione di nuove forme di vita. Una forza ontologica che però riusciva a
diventare effettivamente produttiva soltanto attraverso la sottomissione a un
principio organizzatore esteriore, soltanto se inserita in una struttura sociale
trascendentalmente posta.
Nella postmodernità, invece, il concetto di moltitudine ha per la prima volta la
possibilità di superare tale tradizionale astrattezza e porsi come effettività storica.
Oggi, infatti, «nell’economia politica dell’impero il potere dell’invenzione», quelle
capacità creative della cooperazione sociale che realizzano il passaggio dalla potenza
ontologica soggettiva alla «attualità» della creazione di forme di vita, «è diventato la
condizione generale e comune della produzione» 50. Non più solo astrattamente
quindi, ma concretamente, la produzione è creazione di libertà, di socialità, di
cooperazione, di democrazia. Così, il passaggio dal fordismo al postfordismo realizza
una metamorfosi assoluta della realtà, trasformando la «carne» delle moltitudine, le
astratte potenzialità del lavoro vivo, nel «corpo del General Intellect» 51, in un
processo di continua produzione e riproduzione di modi di vita, affetti, relazioni,
conoscenze, saperi, socialità.
In tale contesto biopolitico, dominato dalla potenza ontologica della moltitudine,
non è più il lavoratore salariato, ma è piuttosto il povero a diventare la «la figura
paradigmatica della produzione» 52, capace di esprimere il carattere assoluto della
forza ontologica del bios:
Il povero non è quindi un oggetto costituito dalla pena ma, absolute, il soggetto biopolitico. Non è un
esistenziale tremore (o un sofferto differenziale dialettico): il povero è la nuda eternità della potenza di essere.
[…] La povertà è infatti quel luogo smisurato nel quale la questione biopolitica è posta assolutamente. È lì che il
corpo, nella sua nudità, è costretto all’esperienza dell’innovazione sull’orlo dell’essere, che il linguaggio è aperto
all’ibridazione nell’urgenza di riconoscere il comune; è qui insomma che il biopolitico si definisce,
smisurandosi fra eterno ed avvenire 53.
Il radicamento del modo di produzione biopolitico nella potenza ontologica del
lavoro vivo implica una metamorfosi totale del concetto di produzione.
49
Negri, A. (2012), Inventare il comune, Roma: DeriveApprodi, p. 160.
50
Negri, A. (2003), Guide, cit., p. 107.
Negri, A. (2012), Inventare il comune, cit., p. 159.
Negri A.; Hardt, M. (2004), Moltitudine, cit., p. 180.
53 Negri, A. (2000), Kairós, Alma Venus, Multitudo, Roma: Manifestolibri, pp. 83-84.
51
52
�71
Tra operaismo e biopolitica. Genesi e sviluppo del concetto negriano di produzione
In primo luogo, la tradizionale rappresentazione del processo produttivo come
creazione di un oggetto da parte di un soggetto risulta esser ormai inapplicabile alla
nuova realtà. Qui, infatti, nel contesto biopolitico, la soggettività domina l’intero
processo di creazione del valore, presentandosi tanto come condizione fondamentale
quanto come il principale prodotto della produzione: «Gli esseri umani producono e
gli esseri umani sono prodotti» 54, in un orizzonte sociale interamente produttivo che
«non crea tanto i mezzi delle interazioni sociali, quanto piuttosto la vita sociale
stessa» 55.
Si delineano così le due forme fondamentali della produzione biopolitica
contemporanea: la produzione di conoscenze, o produzione cognitiva, e la
produzione affettiva:
La prima riguarda gli aspetti prettamente linguistici e intellettuali del lavoro,
come la risoluzione di problemi, i compiti di natura simbolica e analitica e le
questioni linguistiche. Questo genere di lavoro immateriale è produttivo di idee,
simboli, codici, testi, figure linguistiche, immagini e prodotti analoghi. L’altra
forma del lavoro immateriale potrebbe essere definita «lavoro affettivo». […] Il
lavoro affettivo è dunque un lavoro che produce e modifica degli affetti come
l’essere a proprio agio, il benessere, la soddisfazione, l’eccitazione e, più in
generale, la passione. […] Molti tipi di lavoro riconducibili al lavoro immateriale
abbinano queste due forme 56.
In secondo luogo, nel modo di produzione contemporaneo, «la rottura ontologica
tra il lavoro vivo e il capitale costante» diventa «il presupposto di ogni analisi» 57. Il
carattere biopolitico della produzione, infatti, impone una vera e propria rivoluzione
nel rapporto del lavoro sia con i prodotti, sia con gli strumenti di produzione. In
relazione al prodotto del lavoro, il suo carattere eminentemente immateriale ne
impedisce qualsiasi separazione dal produttore, qualsiasi privatizzazione: «esso resta
incorporato nel cervello del lavoratore […] è dunque indissociabile dalla sua persona»
e non è espropriabile da parte del capitale. Quando, infatti, la creatività diventa
produttiva e lo sviluppo capitalistico perviene così alla sua piena maturazione, allora
«l’attore fondamentale del processo sociale di produzione è […] ‘Il sapere sociale
generale’ (sia sotto la forma del lavoro scientifico generale che sotto la forma della
messa in relazione delle attività sociali: ‘cooperazione’)» 58. Un attore che, producendo
un indefinito incremento di conoscenze, di capacità, di competenze, di abilità,
stabilisce le condizioni per una vera e propria «nuova accumulazione originaria»: la
54
55
Negri A.; Hardt, M. (2010), Comune, trad. it. A. Pandolfi, Milano: Rizzoli, p. 142.
Negri A.; Hardt, M. (2004), Moltitudine, trad. it. A. Pandolfi, Milano: Rizzoli, p. 174.
Ivi, pp. 132-133.
Negri, A. (2006), Fabbrica di Porcellana , cit., p. 39.
58 Negri, A. (2012), Inventare il comune, cit., p. 56.
56
57
�72
I RE NE V IPARE LLI
«metamorfosi continua di modi di vita e un’invenzione sempre più accelerata di
forme di vita in comune» 59 accrescono indefinitamente la potenza ontologica espressa
da quella produzione sociale che «si pone in termini di indipendenza dal tempo di
lavoro imposto dal capitale» 60.
In relazione ai mezzi di produzione, parallelamente, nel momento in cui tutte le
facoltà umane sono poste immediatamente al lavoro, allora gli strumenti di
produzione non sono più oggettivati nel capitale fisso, ma sono rappresentati
piuttosto dalle qualità sociali umane: dai cervelli, dagli affetti, dalle relazioni sociali,
dalla cooperazione. Insomma, nel modo di produzione biopolitico «i ‘modi di vita’
divengono ‘mezzi di produzione’» 61; strumenti di lavoro su cui «il capitale non ha più
possibilità di articolare il comando […]: la dialettica strumentale perciò si esaurisce» 62.
Con Deleuze, Negri fa di tale trasformazione delle condizioni tecniche della
produzione; di tale interiorizzazione del «mezzo di produzione […] alle singolarità
impegnate nell’organizzazione del lavoro» 63 la base di una vera e propria mutazione
antropologica. La macchina, infatti, non si presenta più come separata dal soggetto
nella forma di capitale fisso, ma diventa piuttosto parte integrante di tale nuova
soggettività produttiva; la condizione del continuo incremento delle capacità
produttive autonome di un soggetto che, persa ormai l’antica fisionomia umana, si è
trasformato in cyborg:
L’operare comune, l’egemonia produttiva del comune derivano non solo dalla
trasformazione del lavoro in macchina cognitiva ma soprattutto dalla
trasformazione antropologica che gli sottostà, dalle condotte da cui è nutrita,
dalla nuova potenza tecnologica. Se affondano nell’antichità classica, le
foucaultiane tecnologie di sé esondano in una nuova antropologia che non ha
nessuna caratteristica naturalistica, identitaria – che tuttavia configura l’uomo
dopo la «morte dell’uomo» 64.
La terza grande rivoluzione del modo di produzione biopolitico riguarda la
temporalità. «Fuori misura» dal punto di vista capitalistico, ovvero espressione di una
produzione di valore che non può essere rinchiusa dentro il rapporto di capitale,
ontologicamente l’attività produttiva si presenta piuttosto come un creare «oltre»
misura, come un continuo fluire di processi inventivi, affettivi, conoscitivi che, in
virtù della loro essenza immateriale, si presentano come essenzialmente irriducibili a
qualsiasi unità di misura. Il tempo della produzione biopolitica appare così
59
Negri A.; Hardt, M. (2010), Comune, cit., p. 316.
60
Ibid.
Negri, A. (30/12/2014), Un’esperienza marxista di Foucault, cit.
Negri, A. (2003), Guide, cit., p. 72.
63 Negri, A. (2006), Fabbrica di Porcellana, cit., p. 60.
64 Negri, A. (30/12/2014), Un’esperienza marxista di Foucault, cit.
61
62
�73
Tra operaismo e biopolitica. Genesi e sviluppo del concetto negriano di produzione
essenzialmente come eccedenza; come tempo che, liberato dalla misura capitalistica,
rifiuta ormai ogni distinzione tra tempo di lavoro, tempo della riproduzione e tempo
libero e si pone come un «tempo di vita globale dove è quasi impossibile distinguere
tra il tempo produttivo e il tempo del godimento» 65.
Il comune è la categoria che sintetizza la totalità delle specificità del modo di
produzione biopolitico.
Il comune è essenzialmente definito come il campo aperto nel quale il lavoro
vivo (forza lavoro, Kv) si muove in maniera indipendente; il terreno sul quale i
risultati della produzione di soggettività indipendenti e quelli della cooperazione
delle singolarità si accumulano e si consolidano. Il comune è la somma di tutto
quello che è prodotto dalla forza lavoro (Kv) indipendentemente dal Kc (capitale
costante, capitale totale) e contro quest’ultimo 66.
In primo luogo, il comune è dunque il presupposto della produzione biopolitica, il
solo terreno in cui può continuamente riprodursi quel processo di infinita creazione
di saperi, di soggettività e di socialità; quell’inarrestabile movimento di
accumulazione di conoscenze e di cooperazione:
L’accumulazione del comune è indicativa del fatto che i nostri sensi e, più in
generale, la nostra potenza si accresce: si accresce la nostra potenza di pensare,
di sentire, di vedere, di relazionarci, di amare. In termini più affini a quelli
dell’economia, questa crescita implica un aumento quantitativo delle dimensioni
del comune accessibile socialmente e un’accresciuta capacità produttiva fondata
sul comune 67.
In secondo luogo, il comune esprime la forma fondamentale dell’organizzazione
biopolitica della produzione; quella struttura reticolare che rappresenta il terreno
ontologico del darsi continuo di nuovi incontri singolari e della continua creazione di
comunicazione, relazioni sociali, cooperazione sociale, modi di vita. Infine, il
comune esprime la natura propria dei prodotti biopolitici, degli affetti e delle
conoscenze, che diventano produttivi soltanto attraverso la loro condivisione,
soltanto attraverso la loro socializzazione.
Così, nel momento in cui il lavoro si separa dal vincolo di capitale e si pone come
attività creativa, tutte le categorie fondamentali dell’economia politica devono essere
ripensate a partire dalla dissoluzione della proprietà privata e riformulate a partire
dal comune. C’è bisogno, insomma, di nuova teoria del valore,
Negri, A. (2012), Inventare il comune, cit., p. 56.
Negri, A. (2006), Fabbrica di Porcellana , cit., pp. 60-61.
67 Negri A.; Hardt, M. (2010), Comune, cit., p. 284.
65
66
�74
I RE NE V IPARE LLI
fondata sulla potenza dell’innovazione economica, politica e sociale espressiva
del desiderio della moltitudine. Il valore è creato da una resistenza divenuta
debordante, creativa e fluente. Il valore è creato quando la pratica delle
singolarità eccede gli equilibri del potere determinandone la rottura. Il valore è
creato, conseguentemente, quando le relazioni tra gli elementi costituenti del
processo biopolitico e le strutture del biopotere non possono in nessun modo
essere riportate in equilibrio 68.
5. BREVE CONCLUSIONE
Un’analisi che, come la nostra, si è interamente concentrata sul concetto di
«produzione» in Negri rappresenta necessariamente una riflessione parziale e
insufficiente: la descrizione delle condizioni ontologiche della produzione partecipa
infatti necessariamente di quell’astrattezza deleuziana e spinoziana, riproducendo
quell’incapacità di storicizzare il biopolitico:
Il biopolitico – espressione del desiderio vitale dei soggetti – si scontra con il
biopotere. […] Quest’ultimo cerca di dominare ognuna e tutte le espressioni vitali,
cerca di proporsi come dissoluzione del tessuto biopolitico. L’esercizio del potere
vuole risolvere in sé le differenze del biopolitico, sussumerne la singolarità degli
atti, unificarne il soggetto. Di contro: le esperienze vitali che costituiscono il
campo di immanenza biopolitico danno consistenza a dispositivi differenti da
quelli che il biopotere vorrebbe fissare 69.
L’ontica coesistenza di biopotere e biopolitico impone un ulteriore, fondamentale,
passaggio teorico.
In Marx, come abbiamo già avuto modo di sottolineare nell’introduzione, il
dispositivo dialettico permetteva di sviluppare una teoria della produzione che, allo
stesso tempo, era una teoria dello sfruttamento e che costituiva la base per una teoria
della sovranità.
La separazione negriana degli elementi costitutivi del rapporto di capitale, però,
liberando la produzione dallo sfruttamento e dalla sovranità, necessariamente
dissolve l’antica «capacità onnicomprensiva» della critica marxiana dell’economia
politica. Conseguentemente, l’analisi ontologica del modo di produzione biopolitico
si presenta come un’analisi «regionale», parziale, che trova il suo senso soltanto
68
69
Ivi, p. 317-318.
Negri, A. (10/01/2011), Alle origini del biopolitico. Un seminario, cit.
�75
Tra operaismo e biopolitica. Genesi e sviluppo del concetto negriano di produzione
attraverso la messa in relazione con una nuova teoria dello sfruttamento e della
sovranità imperiale.
Solo così l’oggetto specifico della riflessione di Negri emerge; solo così quel
rapporto forzoso che vincola, in modo arbitrario, violento, parassitario, le forze
produttive al comando capitalistico diventa il centro dell’analisi; solo così è infine
possibile determinare le condizioni di quel «dialogo essenziale» con Marx che, «oltre
Marx», «oltre» Foucault e «oltre» Deleuze, definisce le coordinate fondamentali della
lotta di classe e della costituzione del comunismo nella contemporaneità.
�76
�77
Etica & Politica / Ethics & Politics, XX, 2018, 1, pp. 77-105
ISSN 1825-5167
SULL’ORLO DEL TEMPO. LA TEORIA
NEGRIANA DELLA TEMPORALITÀ
Ad Alessandro,
che mi ha mostrato la strada
V I T TO RI O MO RFI NO
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”
vittorio.morfino@unimib.it
ABSTRACT
This essay aims to clarify the theory of «time» in Negri's thought by considering his two
fundamental test on this issue, «The Constitution of Time» and Kairòs, Alma Venus, Multitude.
The former text, written in prison in 1982, can be considered the high point of the first period of
Negri’s thought, which poses the basis for his «ontological turn». The second text, written during
Negri’s period in prison after his Parisian exile, develops a theory of temporality as the realization
of his political theory in between Insurgencies and Empire.
KEYWORDS
Negri, time, kairòs, eternity, innovation, revolution
La questione della temporalità attraversa tutta l’opera di Negri e certamente
potrebbe essere una prospettiva privilegiata fatta oggetto di una ricostruzione
storiografica attenta a cogliere le continuità e le discontinuità e le differenti
sfumature della sua produzione. Un tale lavoro necessiterebbe tuttavia di
un’estensione assai più ampia rispetto a quanto previsto dallo spirito di questo
progetto. Mi sono dunque risolto a far ruotare la ricostruzione della teoria della
temporalità negriana attorno a due testi che considero chiave in questo senso, il
capitolo finale «La costituzione del tempo. Prolegomeni» della Macchina tempo e
Kairòs, Alma Venus, Multitudo. Ciò che in prima istanza accomuna questi due testi
sono le analoghe circostanze in cui sono stati scritti, entrambi in carcere: il primo
pubblicato da Feltrinelli nell’82 porta i segni di quella che Negri chiama «la furia
�78
V ITTORIO M ORFINO
devastatrice della repressione dello Stato» 1, cioè la distruzione delle celle fatta dalle
guardie carcerarie in seguito alla rivolta nel carcere di Trani, in cui sono andati
perduti i quaderni preparatori, costringendo Negri a scrivere il testo facendo
affidamento solo sulla propria memoria 2; il secondo, pubblicato da manifestolibri nel
2000, appartiene al periodo del carcere dopo il ritorno dall’esilio parigino. Certo, i
due periodi appartengono a congiunture storico-politiche molto differenti: il primo
periodo carcerario copre gli anni della sconfitta del movimento operaio e di una
violenta repressione del movimento del ’77; la seconda appartiene agli anni della
speranza di quello che è stato chiamato movimento di Seattle prima che la feroce
repressione di Genova ne producesse l’arretramento, se non l’arresto.
Tra questi due testi, tra questi due periodi in carcere dedicati alla questione della
temporalità, si fissa a mio avviso la teoria negriana del tempo: il primo, che insieme
all’Anomalia selvaggia, costituisce il culmine della prima fase del suo pensiero
aprendo alla successiva, ed il secondo che riprende, sviluppandole sul versante
temporale, le acquisizione del Potere costituente e di Impero. Ad una prima lettura
balza all’occhio la differenza nei riferimenti teorici agli autori contemporanei: nei
«Prolegomeni» vengono usati, citati e discussi Luhman, Prigogine, Thom,
Feyerabend, Kuhn, per non fare che i nomi più importanti, mentre in Kairòs, Alma
Venus, Multitudo soprattutto Foucault e Deleuze, ma anche Agamben. Tuttavia una
forte continuità nello schema di fondo è riscontrabile, al punto che si potrebbe forse
identificare nei «Prolegomeni» il luogo sorgivo dell’intera filosofia negriana 3.
1. I «PROLEGOMENI»
I «Prolegomeni» ci offrono una grande quantità di annotazioni, spesso
frammentarie, spesso non del tutto perspicaci, sulla storia Occidentale del concetto
Negri, A. (1982), La macchina tempo, Milano: Feltrinelli, p. 254.
Così Negri racconta l’episodio nell’«Introduzione» alla seconda edizione: «Vi avevo lavorato con
molta fatica e dedicandovi molto tempo nei diversi ‘carceri speciali’ nei quali mi trovai ad abitare in
quegli anni, fra il 1980 e 1981. Roma, Fossombrone, Palmi, Trani. Fu in quest’ultima prigione che,
durante una rivolta ferocemente repressa, tutti i miei quaderni di appunti furono, senza alcuna ragione
se non quella dettata dalla vendetta di una plebe di guardie carcerarie vigliacche e ignoranti (tuttavia
coperta da Procuratori della Repubblica che tuttora sono considerati eroici e generosi), furono distrutti
nel piscio e nel fuoco dei repressori. A quel punto, nudo di tutto, fui di nuovo trasferito nel braccio
speciale di Rebibbia. Qui, senza appunti, se non quelli che avevo fissato nella mia testa, scrissi i
‘Prolegomeni’. Anch’essi rischiarono di essere pisciati e bruciati in quel periodo di risse carcerarie; non
avvenne, chissà perché» (Negri, A. (1997), La costituzione del tempo. Prolegomeni, Roma:
Manifestolibri, pp. 14-15).
3 Su questi due testi cfr. l’introduzione di Matteo Mandarini all’edizione inglese congiunta in Negri,
A., (2003), Time for Revolution, London: Bloomsbury, pp. 1-18.
1
2
�79
Sull’orlo del tempo. La teoria negriana della temporalità
di tempo. Per ridurre all’essenziale la ricostruzione di Negri, si potrebbe sintetizzarla
nell’affermazione secondo cui l’Occidente, a differenza dell’Oriente 4, ha spazializzato
il tempo:
L’hard core della tradizione occidentale dell’idea del tempo è il suo eterno
parmenidismo: consiste nella spazializzazione del tempo. Il tempo negato e
illusoriamente ricostruito sulla trama dello spazio 5.
Negri legge tutta la storia della tradizione filosofica Occidentale alla luce di questa
mossa fondamentale: la spazializzazione. Mossa che caratterizza tanto lo
spiritualismo che il materialismo. A dire il vero nota di passaggio l’esistenza di linee
sommerse, «come quella democritea ed epicurea» 6, ma ribadisce che essendo
appunto sommerse, non intaccano la continuità della superficie. Vera rottura in
questa tradizione si dà con le concezioni relativistiche del rapporto spazio-temporale
che tuttavia hanno dovuto
lottare per sganciarsi da una postulazione di omologia-isotopica, con esclusione
di ogni asimmetria –, per liberarsi da un continuo tentativo di irrigidimento
geometrico dell’idea di tempo 7.
Ma, anche prima della rottura einsteiniana, il materialismo moderno ha raggiunto
alcuni risultati riguardo all’elaborazione del concetto di tempo, «anche se il ciarpame
dell’immaginazione teologica e spiritualista, surrettiziamente ma non meno
efficacemente infiltrato, gli è presente» 8:
due – scrive Negri – sono [...] gli apici della concezione materialista (ipocrita) e
moderna del tempo: quello newtoniano e quello kantiano. [...] In entrambi i casi,
per dirla con von Wright, il tempo è finalmente considerato come involucro
«dell’ordine degli eventi temporali» e quindi come «natura del medium
temporale», – e l’aver conquistato questa indipendenza del concetto è
indubbiamente un enorme salto in avanti. Solo che nel caso di Newton, la natura
del medium temporale è oggettivata in senso teologico: tempo quale «sensorium
Dei»; nel caso di Kant la natura del medio temporale recupera la sua oggettività
«Quanto differentemente vanno le cose nella tradizione orientale, ed in particolare nel pensiero
cinese!» (Negri, A. (1982), La macchina tempo, cit., p. 260).
5 Ivi, p. 260.
6 Ivi, p. 259.
7 Ivi, p. 260.
8 Ivi, p. 261.
4
�80
V ITTORIO M ORFINO
attraverso la trascendentalità del soggetto. [...] In entrambi i casi reminiscenze
teologiche e spiritualistiche rendono timido e sminuiscono l’approccio
innovativo 9.
Con Hegel poi il «problema dell’ordine degli eventi temporali è dialettizzato» 10;
egli attribuisce al tempo quel «ruolo di mediazione complessiva che il principio
spaziale della divinità si avviava a perdere» 11:
L’effetto di questa operazione è indubbiamente quella della definitiva
cancellazione della rigidità della definizione spaziale del tempo che la storia del
pensiero aveva tramandato 12.
Tuttavia in Hegel, secondo Negri, il tempo non è ancora concepito
nell’indipendenza e autonomia del suo concetto, «la mediazione temporale delle
contraddizioni è ancora preda di rigurgiti teologici e le contraddizioni sono spesso, di
conseguenza, riportate all’orizzonte spaziale» 13. In altre parole, conclude Negri, in
Hegel
Il problema è posto, il tessuto della ricerca è definito: ma la soluzione è
tutt’altro che attinta 14.
È con Marx allora che i limiti della storia del materialismo insieme alla difficoltà
di liberare l’idea di tempo da una fondazione geometrica e da una metafisica dello
spazio sono, secondo Negri, «insieme percorsi e superati» 15. Superati nel Marx
capace di andare oltre se stesso, e qui lo sfondo è la lettura dei Grundrisse proposta
in Marx oltre Marx, cogliendo il «passaggio dal tempo ridotto a convenzione dello
spazio, a medietà, a misura dello sfruttamento, fino alla sua pura e semplice generale
astrazione, e quindi al suo inveramento mistificato, totale nel mondo della vita
quand’è la fase della sussunzione».
«Sussunzione reale» è il termine chiave perché indica allo stesso tempo la fase
predetta da Marx andando oltre se stesso e la fase contemporanea a Negri:
9
Ibidem .
Ibidem .
10
11
Ivi, p. 262.
Ibidem .
13 Ibidem .
14 Ibidem .
12
15
Ivi, p. 263.
�81
Sull’orlo del tempo. La teoria negriana della temporalità
La tautologia marxiana del tempo e della vita e della produzione a livello della
sussunzione reale, è quindi, insieme, compimento della tradizione materialistica
(e superamento delle sue sostanziali insufficienze) ed esplosione di un nuovo
orizzonte di riflessione sul tempo. In Marx, nella teoria dello sviluppo
capitalistico fino alla sussunzione reale, il rapporto tradizionale tra tempo e
spazio viene definitivamente rovesciato. Lo spazio è temporalizzato, è
dinamizzato, è una condizione della realizzazione costitutiva del tempo. Con
Marx il tempo diviene il materiale esclusivo della costruzione della vita 16.
Dal punto di osservazione della «sussunzione reale» non solo è possibile cogliere il
tempo come «tempo della costituzione», «tempo della composizione» in senso
ontologico 17, ma è possibile percorrere il cammino a ritroso cogliendo la
corrispondenza tra «i diversi paradigmi scientifici del tempo [e] le diverse figure della
composizione di classe» 18.
Negri ci offre la seguente periodizzazione:
a) Operaio indifferenziato. 1848-1870. Tempo come involucro naturale, il tempo
del servo-proletario;
b) Operaio professionale. 1870-1917. Tempo orologio. Tempo come mediazione
dialettica. Il tempo del prodotto.
c) Operaio massa. 1917-1968. Tempo flusso. Il tempo della produzione.
d) Operaio sociale-multinazionale. 1968 e sgg. Tempo struttura, tempo sociale.
Il tempo della riappropriazione e dell’autovalorizzazione 19.
L’ipotesi newtoniana corrisponde alla fase dell’operaio indifferenziato, il
paradigma kantiano rappresenta la transizione da questa fase a quella dell’operaio
qualificato, senza però accedervi, come accadrà con Hegel e la sua concezione
dialettica del tempo; il paradigma marxiano del tempo rappresenta in prima istanza
la transizione dall’operaio qualificato all’operaio massa, e in seconda istanza «il
paradigma temporale della composizione sociale dell’operaio massa» 20. Un
paradigma all’altezza della composizione dell’operaio sociale non è stato ancora
raggiunto:
16
Ibidem .
Riprendendo espressamente un termine di Thomas Kuhn, Negri afferma che «il paradigma è
ontologico» (ivi, p. 264).
18 Ibidem .
19 Ivi, p. 296.
20 Ivi, p. 298.
17
�82
V ITTORIO M ORFINO
Forse – scrive Negri – è solo una rinnovata analisi della concezione einsteiniana
del tempo [...] che potrà condurci ad una definizione adeguata del paradigma
temporale nella composizione dell’operaio sociale 21.
Ma è soprattutto il Marx che va oltre Marx, quello che fornisce a Negri gli
strumenti concettuali per pensare la contemporaneità. In altre termini, per lasciare la
parola a Negri,
lo spiazzamento generale dei termini dell’antagonismo, inserito nella matrice
temporale, ci restituisce il collettivo come molteplicità di soggetti. I processi di
sussunzione, quanto più si realizzano, tanto più creano il collettivo. Il tempo qui
si dà – già nel punto di vista capitalistico – come collettivo. Capitale collettivo,
operaio collettivo, ecc. Ma la cosa non è semplice. Nel distruggere il tempo come
misura, il capitale costituisce il tempo come sostanza collettiva. Questa sostanza
collettiva è una molteplicità di soggetti antagonistici. La necessità capitalistica è
quella di integrare questo collettivo dentro un equilibrio che riduca a zero le
possibilità dialettiche: questa è la nuova qualità dell’antagonismo nella
sussunzione reale 22.
Qui si possono già cogliere le linee di tendenza su cui Negri innesterà i concetti di
potere costituente e di biopolitica, nella misura in cui il tempo collettivo si presenta
su due orizzonti:
quello del tempo chiuso della legittimazione e dell’equilibrio, nella tendenza
zero della circolarità assoluta del sociale; quello del tempo aperto, molteplice,
antagonista produttivo, costitutivo. [...] Da un lato la tendenza formale e
analitica, l’idea di equilibrio. Dall’altro la tendenza materialistica e l’insistenza
sulla molteplicità 23.
Qual è il rapporto tra questi due tempi, il tempo chiuso ed il tempo aperto?
Secondo Negri, la sussunzione reale, che nella sua lettura significa anche fine della
«vigenza e della funzione della legge del valore» 24, dà luogo ad un mondo «sussunto,
21
Ibidem .
Ivi, p. 268.
Ivi, pp. 269-270.
24 Ivi, p. 270.
22
23
�83
Sull’orlo del tempo. La teoria negriana della temporalità
massificato, socializzato, compatto» 25. Ora, questo mondo può essere visto da due
punti di vista tra i quali non c’è dialettica:
[...] la tendenza della sussunzione si presenta, dal punto di vista formale, in
termini di logica lineare: la realtà del dominio capitalistico si realizza come
sistemica e totalitaria. L’intera società diviene produttiva. Il tempo di produzione
è il tempo della vita. A questo punto, tuttavia, la tendenza formale e lineare deve
ricordare la propria realtà: è tendenza dello sviluppo capitalistico. Ma il capitale
è un rapporto, – un rapporto di sfruttamento. Lo spiazzamento dello sviluppo
sul livello della sussunzione reale è dunque un dislocamento antagonistico. Il
fatto che tutto sia divenuto produttivo non nega l’asimmetria del rapporto
produttivo: non nega cioè lo sfruttamento che costituisce il rapporto di
produzione. La realizzazione sociale del rapporto di produzione capitalistico
sovradetermina, non nega ma accentua lo sfruttamento. Ma [...] a questo livello
[va] in crisi l’idea unitaria del tempo misura del valore e sorg[ono], opponendosi,
almeno due tendenze sul tessuto della molteplicità dei tempi reali. Bene, questi
tempi si pongono, così dislocati, in un’opposizione materiale che è adeguata alla
asimmetria del rapporto originario. Nella Umwelt della sussunzione reale (del
tempo avvolgente) si sviluppa non solo l’isteresi dell’analitica del tempo e dei
tempi reali molteplici, ma anche e soprattutto l’asimmetria del tempo del
comando e dei tempi della liberazione dallo sfruttamento. L’asimmetria è la
forma iniziale e potente, radicale ed insolubile dell’antagonismo 26.
In questo quadro Negri ricorda la «tradizione minore» nella storia dell’idea di
tempo, quella rappresentata da Democrito, Epicuro e Lucrezio: essi, sulla base della
«tendenziale unità di mutamento e tempo» formulano una teoria del tempo che
Negri
definisce
«ontologica»,
cioè una teoria del tempo come
innovazione/corruzione, insomma, riassumendo: «tempo come direzione, vettore
ontologico sensato, asimmetria, dislocamento» 27. Tuttavia questa tradizione non può
che avere valore di simbolo del superamento della «concezione antica, spaziale del
tempo e come anticipazione delle teorie relativistiche contemporanee» 28:
[essa] simboleggia [...] la radicale alterità di una concezione libertaria,
materialistica e collettiva del tempo: a queste origini piace – ed il piacere è forte
– ricollegarci. Contro il tempo come «numero del movimento rispetto al prima e
al dopo», contro la concezione di un tempo come risonanza universale
dell’«armonia dei cieli», contro Aristotele e Platone – quindi contro ogni
Ivi, pp. 270-271.
Ivi, p. 271.
27 Ibidem .
28 Ivi, pp. 271-272.
25
26
�84
V ITTORIO M ORFINO
concezione del tempo misura (sia pur essa – e tanto più – misura assoluta del
moto degli astri) – qui il tempo ci si presenta come pienezza e come differenza 29.
Non è possibile ricostruire nel dettaglio la complessa argomentazione negriana a
proposito di questi due tempi, quello chiuso e quello aperto, che costituiscono come
le facce della sussunzione reale, il suo interno antagonismo. Riproduciamo lo schema
che Negri stesso ci offre:
[...] noi partiremo dall’analisi del tempo collettivo, così come determinato dal
dislocamento della sussunzione reale, identificando da un lato l’analitica
capitalistica della sussunzione del lavoro al capitale, dall’altro il suo specifico
antagonismo e cioè il lavoro sociale, l’operaio sociale come crisi dell’analitica
sociale del capitale [...]. In secondo luogo noi definiremo il tempo produttivo ed
anche questo nella specificità dell’antagonismo: da un lato il tempo produttivo
ed anche questo nella specificità dell’antagonismo: da un lato il tempo
produttivo di plusvalore, il tempo come denaro e circolazione, ma dall’altro il
tempo
della
cooperazione
produttiva,
dal
lavoro
complesso
all’autovalorizzazione [...]. In terzo luogo il tempo verrà visto nella sua figura
costitutiva. La costituzione del potere capitalistico nello Stato,
nell’organizzazione globale e articolata del comando, quando l’analitica del
tempo capitalistico si fa potere. E dall’altro lato il tempo operaio di una giornata
lavorativa globale che esplode dall’autovalorizzazione all’autoorganizzazione,
alla nuova istituzionalità proletaria [...]. Infine ci troveremo di fronte
all’irriducibilità definitiva delle diverse serie del tempo: la serie capitalistica si
azzera nella formalità del tempo della distruzione, della disgregazione, dello
spreco; la serie dei tempi molteplici del punto di vista antagonistico si risolve nel
tempo rivoluzionario e lungo e spesso della costituzione comunista [...] 30.
In questo nuovo quadro salta il problema classico della transizione inteso come
passaggio intermedio e lineare dal capitalismo al comunismo (socialismo). I due
tempi si affrontano dentro la sussunzione reale intesa come crisi 31, il tempo misura,
vuoto, puro comando, del capitale ed il tempo collettivo, in realtà non uno, ma
pluralità, multiverso, «vera e propria materia di cui è costituito il comunismo» 32. In
altre parole, nella sussunzione reale in quanto circolazione produttiva globale
l’antagonismo nasce non fuori, ma dentro il sistema, l’«antagonismo è soggettività
Ivi, p. 272.
Ivi, p. 272.
31 «Crisi è [...] sinonimo di sussunzione reale» (ivi, p. 279).
32 Ivi, p. 273.
29
30
�85
Sull’orlo del tempo. La teoria negriana della temporalità
collettiva plurima a fronte della riduzione capitalistica della complessità» 33. Per
pensare questa soggettività collettiva plurima Negri fa appello alla linea maledetta
della modernità, già evocata nell’Anomalia selvaggia e che sarà poi al centro del
Potere costituente: Machiavelli – Spinoza – Marx. Ma anche Kant, che da una
posizione individualistica, illuministica e borghese, demistifica anticipatamente la
dialettica; in Kant il tempo è salvato dalla dialettica
[p]erché, primo, esso ci dà una concezione del tempo come forma della
soggettività – una concezione rivoluzionaria del tempo come progetto della
soggettività; secondo, proprio perché la concezione della soggettività è
rivoluzionaria, per questo la concezione del tempo rifiuta di farsi dialettica –
chiusura cioè del progetto in una generalità gabellata per universale 34.
Due tempi nella sussunzione dunque, uno del lavoro vivo, l’altro del lavoro morto,
entrambi «piantati nella dimensione del collettivo», ma «materialmente,
storicamente, diversi ed antagonisti» 35. Da una parte il tempo sociale predisposto al
comando, in cui la misura si fa comando, possibilità di essere tempo dell’eccezione,
dello stato di guerra, il cui culmine è il terrore del nucleare:
Il nucleare è valore, è misura in quanto funzione del comando. Non circola ma
sovradetermina. L’unico valore che il comando, nella sussunzione reale, ammette
è la sovradeterminazione. Un plus di comando, un plus di valore. Il terrore 36.
Dall’altro la dimensione collettiva del tempo fondata sull’essenza cooperativa del
lavoro produttivo, «tempo come appropriazione che – nel momento stesso in cui ha
superato la soglia di mera sottrazione al capitale – presenta storicamente
materialmente la sua vocazione radicalmente alternativa» 37.
Nella sussunzione reale, secondo la lettura di Negri, si dà dunque una separazione
del tempo della composizione dal tempo della totalità dello sfruttamento: da una
parte una collettività antagonistica, dall’altra lo Stato come organizzazione e
comando della vita, il cui fondamento è autoritario e fascista: a livello della
sussunzione reale infatti «normale è lo stato di eccezione, strutturale
l’autoritarismo» 38. La costruzione del tempo costitutivo dello Stato si risolve in
Ivi, p. 282.
Ivi, p. 284.
35 Ivi, p. 285.
36 Ivi, p. 292.
37 Ivi, p. 295.
38 Ivi, p. 302.
33
34
�86
V ITTORIO M ORFINO
un’attività di negazione di un antagonismo che è tuttavia insopprimibile. Di fronte al
tempo duro dello Stato troviamo il tempo molle del lavoro negativo, della mobilità,
dove per mobilità Negri intende «la costante formazione e riformazione di strati
materiali e dei soggetti collettivi del lavoro sociale» 39. La lotta sulla giornata lavorativa
non si dà allora «relativamente a parti [...] e ad alle quantità di tempo che queste parti
rappresentano, ma attorno a codici temporali opposti»: di nuovo, da una parte il
tempo del comando, dall’altro il tempo della liberazione, dell’autovalorizzazione, che
si fa tempo costitutivo, tempo pieno. Il tempo della costituzione proletaria è una
trama ontologica già attivata, in altre parole «il tempo è la sostanza del processo in
cui si mostra la multiversa forza dell’essere proletario» 40, dall’autovalorizzazione
all’autodeterminazione, all’istituzionalità proletaria intesa come «presenzialità del
tempo organizzato dalla razionalità operaia e proletaria [...] fondazione collettiva del
tempo come sostanza goduta» 41. Tuttavia il tempo della lotta di classe proletaria
presenta un altro carattere, non è solo lavoro negativo che trascorre dalla mobilità
all’autovalorizzazione e all’autodeterminazione, ma è anche potenza prefigurativa,
contemporaneità di futuro e presente:
Il tempo della lotta di classe contiene in sé il futuro e tenta continuamente di
plasmarlo. La contemporaneità del futuro e del presente [...] non determina
sfasature utopiche: è il collettivo che costruisce, il futuro è condotto alla
dimensione del collettivo. [...] Il lavoro qualificato, complessificato, tecnicoscientifico trova nel futuro la dimensione adeguata della sua potenza 42.
Per riassumere, da una parte la temporalità ontologica e multiversa della potenza,
dall’altro il tempo duro dello Stato. Certo, Negri si chiede se il mondo della
liberazione non costituisca l’omologo rovesciato del mondo del comando, se non vi
sia mistificazione in questo dualismo, per concludere che nella sussunzione reale «il
dualismo è la matrice logica assolutamente fondamentale» 43:
lo spazio al capitale, il tempo alla classe operaia – si potrebbe così scherzare 44.
Negri si impegna tuttavia a mostrare come alla matrice dualistica, quella
antagonistica, si affianchi quella plurale, «anzi onniversatile» definendo «la materia e
Ivi, p. 309.
Ivi, p. 311
41 Ibidem .
42 Ivi, p. 313.
43 Ivi, p. 314.
44 Ibidem .
39
40
�87
Sull’orlo del tempo. La teoria negriana della temporalità
le procedure della matrice multiversa per quanto riguarda il polo proletario, e cioè la
dimensione sociale dell’antagonismo» 45. Questa matrice può essere colta attraverso
quella che Negri chiama una «fenomenologia della prassi collettiva», non dialettica,
nel senso di non soggetta a leggi, che muove dall’individuale verso il collettivo, come
«tensione di una completa costitutività temporale»:
Questo è – scrive Negri – il regno della libertà più piena. Dove la libertà sa
essere amore. I meccanismi di ricomposizione sono dotati della più alta
spontaneità, tanto quanto sono spontanei i processi e le tensioni di
differenziazione. Qui la differenza è ricca e l’unità è spontanea. Questo è il
territorio temporale, il corpo della comunità comunista 46.
Tuttavia, non va dimenticato che il tempo della costituzione, «per quanto vissuto
al massimo delle tensioni multiverse, ha comunque di fronte la realtà del nemico» 47.
Vi è una disgiunzione nella sussunzione reale tra essere e non essere, dove il non
essere è legato ad un’idea del tempo del comando, che è negazione del tempo reale
sotto forma di ciclo, circolazione, moneta, in cui progresso e innovazione sono
pensati «come eterno ritorno illuminato da uno Jetzt-Zeit» 48, disegnando un
orizzonte unidimensionale comandato dallo Stato nucleare, cioè dalla catastrofe e
dalla morte; l’essere è invece il tempo pieno della liberazione, dell’esperienza diretta
del comunismo, di una molteplicità che possiede la totalità del tempo reale, dalla
rivoluzione che tuttavia non è l’emergenza dell’uno, la ripetizione della «maledetta
vicenda giacobina», ma
innovazione reale [come] sempre nuova costituzione sociale del tempo delle
moltitudini sfruttate, attraverso la continua distruzione delle articolazioni
dell’uno, del comando, dell’unità astratta 49.
Ivi, p. 315.
Ivi, p. 318.
47 Ibidem .
48 Ivi, p. 321. Negri – a questa altezza – critica in modo netto il concetto benjaminiano di Jetzt-Zeit,
che rivaluterà nella «Introduzione» del 1997: «Lo Jetzt-Zeit, l’utopia si presentano come innovazione,
come tocco e tatto del reale, dentro la routine dell’essere temporale del comando [...] Lungi dall’essere
la distruzione dello storicismo e dei suoi perversi esiti politici, la concezione dello Jetzt-Zeit messianico
è il massimo ammodernamento del pensiero reazionario: è conversione dei materiali storici, plurali,
puntuali, multiversatili, nell’illusione taumaturgica della vuota innovazione. La concezione dello JetztZeit messianico riduce la tautologia della sussunzione a misticismo – ed il misticismo puzza sempre di
padrone» (ivi, p. 321 e 323).
49 Ivi, p. 329.
45
46
�88
V ITTORIO M ORFINO
Questo è il senso profondo dell’espressione «macchina tempo» che dà il titolo
all’intero libro. L’espressione «macchina» sembra riferirsi al capitale fisso, ma Negri
precisa che in realtà essa si riferisce alla forza capace di disgregare e distruggere i
nessi della società capitalistica, si riferisce ad una «massa di relazioni versatili,
onnilaterali, universali» 50, alla qualità e razionalità produttiva, alla collettività intesa
come amore. La macchina tempo è una macchina di costituzione:
La nostra macchina del tempo liberato si muove potentemente e gentilmente
definendo un nuovo mondo che non conosce la morte 51.
Laddove la tradizione del potere, la linea Hobbes-Rousseau-Hegel, pensa la pace
come soluzione della guerra, nella tradizione materialista l’opposto della guerra non
è la pace, ma la vita: alla pace mantenuta attraverso lo Stato nucleare, Negri oppone
l’estinzione dello Stato frutto della costituzione proletaria, al vuoto ontologico il
pieno della vita, dell’istituzionalità proletaria fondata sul lavoro tecnico-scientifico in
cui si incontrano immaginazione liberatoria e cooperazione:
Non dunque – queste le ultime righe di Negri – la pace, il tempo misura, il
vuoto ontologico, bensì la vita, il tempo ontologico, la produzione sono la
potenza costituzionale – dio vivente e non vitello d’oro 52.
2. LA PREFAZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE DEI «PROLEGOMENI»
Nel 1997 esce per Manifestolibri la seconda edizione dei «Prolegomeni» con una
«Introduzione» che vuole allo stesso tempo misurare la distanza da quel testo e la
continuità della riflessione negriana. Ecco le prime righe:
Quando, dopo tanti anni, corrispondendo alla richiesta di vecchi amici/nuovi
editori, ho riletto questi «Prolegomeni sul tempo», i sentimenti provati sono stati
vari. Era insieme, mi dicevo, un testo ricco e povero, colto e incompleto, una
«macchina da guerra» del tutto apprestata e sconfitta. Valeva davvero la pena
ripubblicarlo? Ne vale la pena, rispondevo, se riesco a dimostrare, a me stesso
prima di tutto [...], che i blocchi teorici di questo testo sono anche aperture, o
Ivi, p. 330.
Ivi, p. 331.
52 Ivi, p. 334.
50
51
�89
Sull’orlo del tempo. La teoria negriana della temporalità
meglio, che proprio il blocco teorico di allora può permettere di aprire nuove
prospettive oggi 53.
L’«Introduzione» ha per Negri lo scopo di «tradurre questo incunabolo in lingua
parlata [...] in dialetto rivoluzionario della postmodernità» 54.
Retrospettivamente Negri legge i «Prolegomeni» come un tentativo di
comprendere perché «la linearità della prospettiva socialista fosse in crisi e come,
dentro la crisi postmoderna, la cupiditas comunista [...] potesse ricollocarsi» 55.
Fondamentale per comprendere il testo è la sua collocazione dentro quello che Negri
definisce il «laboratorio Italia», cioè la collocazione di quel pensiero dentro le lotte,
dentro «il conoscere delle lotte»:
un’incredibile capacità di anticipazione nella conoscenza dello sviluppo
capitalistico si era allora accumulato nel sapere antagonistico. Nel «laboratorio
Italia» vennero [...] messe a punto conoscenze relative al passaggio postfordista
dell’industria, venne anticipata l’attesa della rivoluzione informatica e del suo
impatto sociale, fu anticipatamente compreso il passaggio alla società dei servizi,
al decentramento produttivo, ed elaborata la figura del «lavoro immateriale»
come funzione produttiva egemonica del capitalismo che veniva. Ma insieme, e
precisamente, si analizzavano i nuovi comportamenti sociali della forza
produttiva, si definivano «operaio sociale» e «intellettualità di massa» –
acquisizioni definitive, che nel laboratorio italiano erano colte, per essere
successivamente verificate e teorizzate sul livello internazionale 56.
Negri afferma qui il primato del punto di vista del «laboratorio Italia» rispetto alla
scena internazionale. Solo in esso infatti «la nuova realtà soggettiva del lavoratore
sociale, immateriale, intellettuale massa, saltava fuori dall’analisi come nuovo
referente dell’analisi materialista, del progetto antagonista» 57. I «Prolegomeni» in
questo senso secondo Negri hanno il merito di essere il riassunto della conoscenza di
quelle lotte alla fine degli anni Settanta, conoscenza cioè di un mutamento:
Le categorie cambiavano, l’esperienza della vita cambiava, la natura del lavoro
cambiava, la qualità dello sfruttamento cambiava, il progetto rivoluzionario
cambiava, il mondo e le sue alternative cambiavano [...] se l’analitica del capitale
53
Negri, A. (1997), La costituzione del tempo. Prolegomeni, Roma: Manifestolibri, p. 9.
54
Ibidem.
Ivi, pp. 9-10.
Ivi, pp. 10-11.
57 Ivi, p. 11.
55
56
�90
V ITTORIO M ORFINO
si opponeva al processo costitutivo del proletariato, ora l’analitica del capitale
era confrontata a un «tempo altro» fondato sull’esperienza costitutiva dei nuovi
movimenti 58.
Egli vede nei «Prolegomeni» emergere una serie di categorie (l’immaterialità, la
cooperazione, l’intellettualità del lavoro) che poi diverranno concetti-cardine del suo
pensiero. Questa la sua ricchezza. E l’incompletezza? Essa non è dovuta solo alla
storia del testo, alla distruzione dei quaderni preparatori, ma ad una sua
«incompletezza teorica» 59. Corretta è secondo Negri «la definizione del topos
generico, quello della ‘sussunzione reale’, oggi si direbbe del ‘postmoderno’» 60,
mentre la «rigidità dello sviluppo antagonistico delle due tendenze della temporalità
(capitalistica e operaia) trasformava l’antagonismo in ‘blocco’ della ricerca» 61:
La mia preoccupazione – scrive Negri – era stata evidentemente quella di
togliere ogni possibilità di recupero dialettico dell’antagonismo, di fissare
l’opposizione delle temporalità, allo scopo di rompere con ogni eventualità di
recupero riformista, «sintetico» e «sublimante» dell’analisi della temporalità 62.
In altre parole, definita la temporalità soggettiva in modo simmetrico alla
temporalità analitica del capitale, come farne emergere la differenza radicale? Negri
stesso definisce la posizione dei «Prolegomeni» come un involontario
scimmiottamento della dialettica negativa, come un «heideggerismo rovesciato dove
la temporalità costitutiva si faceva poiesis, se non estetica, certo poveramente etica» 63.
Quello che Negri chiama «blocco della ricerca» consisteva nel fatto che il testo
presentava una «geologia delle temporalità» ma non una «genealogia della
soggettività di massa» 64. In questo contesto la figura dell’«operaio sociale», pur
individuata, rischiava secondo Negri «l’appiattimento sociologico, la definizione
quantitativa» 65. Tuttavia questo blocco ha aperto nuove piste di ricerca nei testi di fine
anni Ottanta e Novanta e nell’esperienza teorica di «Futur Antérieur»:
Ivi, pp. 12-13.
Ivi, p. 15.
60 Ibidem .
61 Ibidem .
62 Ibidem .
63 Ivi, pp. 15-16.
64 Ivi, p. 16.
65 Ibidem .
58
59
�91
Sull’orlo del tempo. La teoria negriana della temporalità
Ognuna di queste ricerche scava sempre più profondamente la radicalità
ontologica del tempo costitutivo, lo fa vivere produttivamente dentro la
biopolitica, ricompone cervello e affetto nella produttività dell’intellettualità di
massa e, in genere, nell’attività desiderante del proletariato nel postmoderno.
Vale a dire che approfondisce sempre di più la costituzione del telos nella
riqualificazione del topos. Vale a dire che apre il topos a una nuova «pubblicità»,
che è azione della moltitudine, intreccio e sovrapposizione di lotte sociali e
politiche, di lotte economiche e lotte per i diritti, di sovversione etica 66.
Ma ciò che è più importante e significativo di quel «blocco della ricerca»
testimoniato dai «Prolegomeni» è che esso non rappresenta tanto l’impasse teorico di
un pensatore, quanto piuttosto della logica stessa dell’operaismo:
Il ragionamento che stiamo facendo, in maniera critica, sulla necessità di
coniugare una tematica del topos e quella del telos, oltre il blocco registrato dalla
tematica operaista, ha dunque un valore generale e attuale propositivo. Quei
vecchi problemi infatti sono i medesimi che propongono oggi: 1) quel che rimane
del vecchio marxismo, e 2) quello infinitamente più importante, che nasce di
nuovo sul terreno della lotta di classe. Voglio dire che dopo quel blocco c’è
un’epoca. Ed è dentro questa che dobbiamo muoverci e costruire coscientemente
la nuova temporalità. La tensione del blocco si spezza e rivela la forza che il
blocco tratteneva. Oggi, dunque, è possibile ricostruire il telos dentro quel
«topos» che si era presentato come blocco 67.
Questo percorso di ricostruzione del telos nel topos è temporale, ma non lineare.
Si tratta, dice Negri, di uno spazio e di un tempo «pieni di fosse, di anfratti, di
dislivelli, inesplorabili dal potere», che «nascondono una potenza di vita
inafferrabile» 68:
Dopo il blocco simmetrico di temporalità dialettiche scisse, c’è l’asimmetria di
una vita che si costruisce. [...] La nuova temporalità non è qui dunque «altro» ma
semplicemente se stessa. Le due serie temporali che i «Prolegomeni» descrivono
costituiscono un paradosso esplosivo: quando si vive ne resta una sola delle due.
Autonomizzandosi 69.
Ivi, p. 17.
Ivi, p. 18.
68 Ivi, p. 19.
69 Ibidem .
66
67
�92
V ITTORIO M ORFINO
E in questa nuova prospettiva, accanto alla «grande tradizione materialista che va
da Machiavelli a Spinoza a Marx» che ci racconta che «il desiderio di liberazione ha
una sua logica irriducibile» 70, a Foucault e Deleuze-Guattari, troviamo una
rivalutazione di Benjamin in quanto pensiero capace di «far esplodere il blocco» 71.
Il blocco costituito dai «Prolegomeni» non è altro che l’impasse necessario «per
liberarsi – spingendola al limite – da una dialettica della lotta di classe che, pur
vivificata da nuove esperienze, resisteva al nuovo» 72:
Il passaggio – conclude Negri – s’è fatto. Il topos si è esso stesso aperto al telos.
Per produrre e per esprimere desideri e affetti di libertà, il proletariato
immateriale non ha bisogno né di simmetrici trascendentali né di macchinari
che siano opposti: esso ha recuperato l’utensile e ha fatto del linguaggio la sua
macchina. Il senso della temporalità costitutiva, sganciandosi dall’opposizione al
nemico, si autonomizza e appare qui piuttosto come medium fra topos e telos,
fra nuovo paradigma e nuova prassi 73.
3. KAIRÒS, ALMA VENUS, MULTITUDO
Nell’«Introduzione» a Kairòs, Alma Venus, Multitudo, pubblicato da
Manifestolibri nel 2000, Negri ci offre un’ulteriore chiave di lettura del tentativo dei
«Prolegomeni».
Vi era, in quegli scritti, la piena presa di coscienza dell’impossibilità di
mantenere, e comunque di difendere, la teoria dello sfruttamento e della
rivoluzione che, nel modello «valore-misura-tempo», l’ortodossia marxista
imponeva. Questa critica della teoria del valore non era infame e non era
espressione di una coscienza sconfitta: era coscienza della temporalità sconvolta
dalle lotte, dal progresso della coscienza proletaria e dalla vittoria militare del
potere capitalista. A quest’anima razionale marxiana, come poteva
accompagnarsi la passione rivoluzionaria? Come poteva, a partire dal
rinnovamento della critica, e dalla sua temporale tragedia, ricominciare la voglia
di rivoluzione? 74
70
71
Ibidem .
Ibidem .
Ivi, p. 20.
Ibidem .
74 Negri, A. (2000), Kairòs, Alma Venus, Multitudo. Nove lezioni impartite a me stesso, Roma:
Manifestolibri, p. 12
72
73
�93
Sull’orlo del tempo. La teoria negriana della temporalità
Kairòs, Alma Venus, Multitudo è un testo scritto quasi vent’anni dopo Macchina
tempo nel bel mezzo dell’esperienza del ritorno in Italia, di una nuova prigionia, in
una congiuntura differente, che Negri nomina «postmoderno», tracciandone così la
differenza rispetto al moderno:
Fra moderno e postmoderno molto, moltissimo è mutato. In primo luogo sono
mutati i rapporti di produzione, perché la forza lavoro si è metamorfosata. In
secondo luogo, trionfando dei suoi avversari e concorrenti socialisti, il regime
capitalistico si è fatto più totalitario e, certo, più feroce. Per una sola ragione:
esso non fa più fare produzione alle sue sole fabbriche ma fa lavorare per il
proprio arricchimento tutta la società; non sfrutta più solamente gli operai ma
tutti i cittadini, non paga ma si fa pagare per comandare ed ordinare tutta la
società. Il capitalismo ha investito la vita; la sua produzione è biopolitica: il
potere nella produzione è «sovrastruttura» di quello che si è disteso e si
riproduce nella società, al sistema disciplinare dell’organizzazione sociale s’è ora
sostituito un «sistema di controllo» [...]: non poteva essere diversamente se i
produttori [...] si sono riappropriati l’utensile della produzione, che sempre più si
chiama cervello 75.
Come nei «Prolegomeni» Negri si propone di costruire una teoria materialista del
tempo il cui centro è costituito dal concetto di kairòs:
Qui, conoscere (un’episteme ed una logica che stanno dentro il campo
materialista) è kairòs: l’evento del conoscere, del nominare, ovvero il conoscere
come singolarità, intreccio di innovazione logica e creazione ontologica, – kairòs
è l’immagine classica di scoccare la freccia –, qui, nella postmodernità, è
l’occasione ontologica, assolutamente singolare, di nominare l’essere a fronte del
vuoto, anticipando e costruendolo sull’orlo del tempo 76.
Nel materialismo, scrive Negri, «predicare l’essere è innovarlo» 77. Tuttavia del
materialismo non si dà storia né continuità categoriale: in quanto irriducibile «altro»
del potere, in quanto forza sovversiva, il materialismo è stato sempre represso
rendendo impensabile kairòs. Negri esibisce i tre modelli dominanti di temporalità –
quello antico, quello moderno e quello postmoderno – e le strategie differenti
attraverso cui essi hanno neutralizzano e neutralizzano kairòs, cioè il presente
singolare e aperto «proprio qui», l’istante come qualità del tempo, l’arciere che scocca
la freccia:
Ivi, p. 14.
Ivi, p. 11.
77 Ivi, p. 16.
75
76
�94
V ITTORIO M ORFINO
L’atto dello sporgersi dell’essere sul vuoto del tempo avenire, ovvero l’avventura
oltre l’orlo del tempo 78.
Kairòs si dà secondo Negri quando il nome chiama all’esistenza la cosa nominata
e la cosa risponde nella sua concretezza e singolarità. In altre parole, «l’evento della
conoscenza vera sorge [...] proprio su quel punto dove l’inquietudine del tempo si
rivela come potenza» 79. Kairòs è dunque generare, è l’istante che sta tra compimento
del tempo e apertura avenire, esso ondeggia fra nominare e cosa nominata, esprime
nuovo essere e decide del vuoto. Ora, questa «decisione di nuovo essere» 80 che è
costruzione del nome comune si fa, scrive Negri, «in quel prolungamento dell’essere,
in quell’evento del kairòs, che chiamiamo immaginazione» 81. L’immaginazione è
potenza di kairòs che ha trovato intera espressione, l’immaginazione è dunque
creatrice di nuovo essere. E qui il riferimento è naturalmente Spinoza:
In Spinoza l’immaginazione ha una funzione ontologica di ricomposizione
degli strati dell’essere: perciò essa anticipa, fin dall’interno della materia, quello
sviluppo della vita etica che conduce all’atto assoluto di conoscenza, l’amore. La
filosofia moderna, da Kant a Heidegger, con miserabile regressione, ha tentato
di tradurre l’immaginazione ontologica in immaginazione trascendentale, in
schematismo che indica tracce temporali della costruzione dell’essere. Ma,
attraverso il trascendentale, l’immaginazione s’è affogata nella dialettica [...].
Occorre dunque ritornare a Spinoza, e riconoscere nell’immaginazione non la
via per giungere alla sintesi del sapere, ma il rischio e l’amore del conoscere,
della costruzione di luoghi comuni del nome, della prospezione creativa
dell’avenire. Perché l’essere è kairòs 82.
Detto in termini classici, l’immaginazione lega ratio conoscendi, ratio fiendi e
ratio agendi definendo in modo nuovo il rapporto tra kairòs e telos: kairòs contiene
infatti in sé il proprio telos, kairòs è autotelico, è trasformazione del mondo nell’atto
stesso di interpretarlo:
è infatti – scrive Negri – nella lotta per la libera appropriazione del presente
che la vita si apre all’avenire; e il desiderio percepisce – contro il tempo vuoto e
78
Ivi, p. 26.
79
Ibidem .
Ivi, p. 28.
Ivi, p. 31.
82 Ivi, pp. 31-32.
80
81
�95
Sull’orlo del tempo. La teoria negriana della temporalità
omogeneo che tutto eguaglia (ivi compreso soprattutto il futuro) – la potenza
creatrice della prassi 83.
Tuttavia questa concezione della temporalità permette non solo un differente
sguardo sul futuro, ma anche sul passato: il tempo trascorso non appare più come
morta estensione distesa nella durata, sotto forma di corruzione e morte o di mero
deposito; dalla prospettiva di kairòs al passato viene restituita la vitalità che l’ha
creato. È l’innovazione che promana da kairòs a produrre il mondo, a produrre tanto
l’essere che viene prima quanto quello che viene dopo. «Divenire» è invece il concetto
che tradisce kairòs, che perde il pulsare della temporalità.
A questo punto dell’argomentazione Negri introduce un nuovo concetto usando
un termine che ha una lunga tradizione nell’ontoteologia Occidentale: eternità.
«Eternità – ci dice Negri – è il tempo che è prima. Esso è infatti potenza di vita
accumulata, è temporalità irreversibile ed indistruttibile, è nome comune dell’essere
che è» 84. A questo punto si tratta di definire la relazione tra eternità e kairòs: «ogni
kairòs è installato nell’eternità» 85. In altre parole, eternità e kairòs devono essere
pensati insieme, pensare l’eterno significa instaurare kairòs in una «indistruttibile
massa di vita» che solo attraverso di esso può essere continuamente riattualizzata.
L’analogia entis e la dialettica, «concentrandosi sull’assoluto», non sono in grado di
concepire la semplice verità del legame eternità-kairòs: «che sia il finito ad
incrementare l’assoluto ed il kairòs a dar respirazione alla potenza dell’eterno» 86. In
altre parole, essere nell’eterno secondo Negri significa essere nella produzione e
kairòs è lo stesso eterno che crea. Nella teoria della temporalità negriana eterno ed
avenire si fronteggiano come un prima e un poi: il tempo è allora la dismisura tra
questi «prima» e «poi», la sua impossibile linearità e continuità. Questa dismisura è
ciò che Negri chiama «innovazione», che nel campo del materialismo si dà come
predicazione dell’essere. In altre parole la verità dell’essere è creata: è kairòs che crea
tra eterno ed avenire. Ma chi «porta» kairòs, chi ne è il Träger? Il corpo, risponde
Negri. E aggiunge:
è [...] sullo stacco della temporalità ontologica che sta [...] la chiave della
produzione dell’essere. Il corpo reagisce allo stacco producendo essere nuovo.
Essendo il corpo inserito nel campo materiale dell’eterno, esso conduce l’eterno
Ivi, p. 41.
Ivi, p. 43.
85 Ibidem .
86 Ivi, p. 45.
83
84
�96
V ITTORIO M ORFINO
stesso allo stacco [...] e lo rivivifica, sperimentandosi, – se stesso corpo – come
prassi del tempo 87.
Riprendendo le fila del discorso negriano è il nominare che genera nuovo essere
attraverso kairòs, ma questo nominare è il frutto dell’immaginazione e
l’immaginazione è nel corpo. Dunque il corpo è l’incarnazione di kairòs.
Allo scopo di chiarificare la sua concezione della temporalità Negri propone un
détour attraverso il primo libro del Capitale laddove sono introdotti i concetti di
capitale costante e capitale variabile: il primo come «l’insieme degli elementi
materiali e tecnici accumulati dalla produzione e conservati nello sviluppo»; il
secondo come «lavoro vivo che rianima ciò che è stato accumulato (e vive come
latenza nell’accumulazione) e di questo fa la base di una nuova valorizzazione» 88.
Negri conferisce a questa distinzione marxiana una valenza immediatamente
ontologica. Essa riguarda «l’intero campo materialista, [...] il mondo»:
La produzione costruisce infatti il mondo, seguendo una traccia di cui la
temporalità è sostanza. Sul «prima» di questo processo continua ad accumularsi
il lavoro morto, il tempo concluso della creazione; il «poi» è rappresentato dal
lavoro vivo, ossia dal kairòs dei corpi che creano verità attraverso la prassi.
Sull’orlo del tempo, il lavoro vivo è così potenza del mondo, di quello che è già
stato (e che vi permane costante) e che ora è rivivificato; di quello che apparirà
dal nuovo lavoro vivo creatore. Ecco dove la metafisica del materialismo trova la
sua base e, insieme, il suo centro: riconoscendo che il processo capitalistico ha
sussunto il mondo, facendone una creatura morta; e che al contrario il lavoro
vivo è kairòs, inquieto creatore di avenire. Il lavoro vivo prende il mondo in
mano, lo trasforma e lo innova, radicalmente, nel comune 89.
L’inchiesta ontologica è dunque situata all’interno della dinamica produttiva (la
conduce chi esprime lavoro vivo): «non v’è nome che non sia adeguato all’evento, né
evento che non sia creativo della freccia tempo» 90. Negri definisce allora i termini di
un «materialismo creativo» capace di aprirsi al tempo che viene, all’«essere nuovo,
costruito in ogni istante, che accresce l’eterno» 91.
Machiavelli, Spinoza e Marx hanno costruito le premesse di questo materialismo,
perché del materialismo non si dà storia precisamente perché, nella storia del
pensiero, il materialismo è sempre stato definito dall’avversario che l’aveva vinto:
Ivi, p. 55.
Ivi, p. 58.
89 Ivi, pp. 58-59.
90 Ivi, p. 59.
91 Ibidem .
87
88
�97
Sull’orlo del tempo. La teoria negriana della temporalità
«non v’è spazio [...] né tradizione né durata per chi perde. Al materialismo la filosofia
dei potenti lascia davanti agli occhi una catena di catastrofi» 92. E tuttavia il
materialismo risorge sempre e «penetra la storia del pensiero nelle maniere più
subdole (dal punto di vista della Inquisizione accademica) e più sovversive (dal punto
di vista della scienza di Polizia)»:
In questo suo insorgere – scrive Negri – il materialismo è sempre rottura del
pensiero del dominio, è Machiavelli, Spinoza, Marx, è il pensiero comune delle
lotte. La storia del materialismo, quale kairòs può definirla nella genealogia di
un presente che si apre all’avenire, è una storia di resistenze ed insorgenze. Esso
pone la durezza della materia contro ogni trascendenza e contro ogni dialettica,
del pensiero e del potere 93.
Circolo virtuoso tra materialismo e kairòs: il pensiero materialista rende possibile
pensare il tempo come kairòs che a sua volta rende concepibile una storia del
materialismo come insorgenza («chi insorge pone il problema: ed il kairòs ama chi
insorge» 94). Fare storia del materialismo significa allora, con le parole di Negri, «far
parlare la dismisura dentro la quale sta ogni monade di kairòs nel momento in cui
decide di produrre» 95. L’Angelus Novus benjaminiano si presenta qui trasfigurato:
non con lo sguardo rivolto all’indietro, ma in avanti, «procedendo nella bufera» 96. La
produzione di tempo è allora predicazione dell’essere del mondo nel reseau di attimi
o di monadi di Kairòs:
Il campo materialista è il campo delle verità comuni, creato dalla dismisura
della produzione fra eterno e avenire. E noi ne siamo gli attori 97.
Kairòs dunque non è un punto di una sequenza, ma un intreccio in cui le monadi
di kairòs si collegano in eventi comuni:
siamo immersi nel comune – scrive Negri – perché kairòs è un pulviscolo di
monadi che espongono, intrecciandosi e concatenandosi, sul vuoto che la freccia
del tempo indica, così costruendo avenire 98.
Ivi, p. 60.
Ivi, p. 61.
94 Ivi, p. 60.
95 Ivi, p. 61.
96 Ibidem .
97 Ivi, p. 64.
92
93
�98
V ITTORIO M ORFINO
L’etica materialista ci rende responsabili, secondo Negri, del presente in quanto
innovazione di essere ed in questo senso si può parlare di «teleologia» in relazione ad
esso. Con una precisazione però: nel materialismo il telos non è precostituito, ma è il
prodotto dell’esistere comune, «è la forma nella quale, senza qualificazioni
assiologiche, si costituisce progressivamente l’eternità della materia, quindi
l’orizzonte del mondo» 99.
Alla ridefinizione in senso materialista del termine «teleologia» Negri fa seguire
un’operazione analoga sul termine «destino»:
Il comune che il movimento dell’umano e suo Umwelt produce, non è un
valore, è bensì un destino. Ma la parola destino va tolta alla cecità del caso così
come a qualsiasi predeterminazione; va piuttosto ridefinita nella prospettiva
costitutiva del comune. Destino è l’insieme delle azioni dell’uomo, come
moltitudine generica, cui nulla è presupposto, se non le condizioni ambientali
che l’uomo continuamente modifica e che agiscono quindi, in quanto modificate,
sull’esistenza comune. Eticamente destino è il nome comune di uomo in quanto
esso materialmente si costruisce 100.
Il mondo è un tessuto di kairòs che si incrementa, è creato nuovamente ad ogni
istante. Ora, il tema del novum, nel linguaggio negriano, dell’«innovazione», è
«centrale e irrisolto» nel materialismo classico:
Fra Democrito ed Epicuro la costruzione atomistica del mondo è immersa
nell’eternità. Quanto alla libertà, essa è conduzione della vita, giocata in termini
di metafora del cosmo. In quest’appiattimento la libertà si estingue e
l’innovazione è incomprensibile. Solo in Lucrezio la libertà si sforza di rompere
l’insignificante metafora e di agire autonomamente nell’insieme fisico
dell’atomismo, di imporre uno strappo all’eternità 101.
Tuttavia Lucrezio pone il clinamen «in punta di piedi». Solo con Spinoza il
problema viene trasformato:
Ivi, pp. 68-69.
Ivi, p. 69.
100 Ivi, p. 71.
101 Ivi, p. 73.
98
99
�99
Sull’orlo del tempo. La teoria negriana della temporalità
L’ontologia del materialismo non è infatti qui sfiorata dal clinamen ma investita
e rifondata dal desiderio. Il ritmo di costituzione del mondo è sorretto – in
confusione di forme – da una forza viva che si svolge nel mondo per costruirsi
come divina. La libertà si costruisce in questo sviluppo e ne interpreta la
continuità nell’assoluta immanenza produttiva di una vis viva che si svolge da
conatus fisico a cupiditas umana ad amor divino 102.
Tuttavia la trasformazione del problema che il materialismo spinoziano impone
rispetto al materialismo antico è ancora «cauta, quando non insignificante» 103, poiché
non è dato «senso creativo alla progressione del comune, all’unità di eternità e
innovazione» 104. Solo nel postmoderno, quando «si estingue la follia metafisica della
trascendenza e del comando», il comune è «nelle condizioni di apparire nella
pienezza della sua definizione» 105, nella misura in cui le qualificazioni dell’essere
sono divenute interamente comuni (linguaggio, produzione di soggettività,
biopolitica):
basti avere presente – scrive Negri – che, se produzione è comunicazione, il
mondo della natura e degli artefatti va interamente ricondotto alla produzione di
soggettività, e che la soggettività, e che la soggettività instaura la produzione del
biopolitico 106.
Epoca post-moderna da lui caratterizzata attraverso la metafora dell’uomomacchina, laddove per l’epoca antica usa l’immagine del centauro e per quella
moderna dell’uomo-uomo. Ora, secondo Negri, solo nell’epoca postmoderna, come
detto, il pensiero materialista arriva a congiungere «eternità ed innovazione» 107:
Il rinnovamento del materialismo va operato attraverso il riconoscimento che,
attraverso l’innovazione, l’eterno si affaccia sulla dismisura 108.
Su questo passaggio Negri fa entrare in scena un nuovo concetto: quello di
povertà. Il «povero» è il motore della teleologia materialista: è la moltitudine di
Ivi, p. 73.
Ivi, p. 75.
104 Ibidem .
105 Ivi, p. 76
106 Ivi, p. 79.
107 Ivi, p. 80.
108 Ivi, p. 81.
102
103
�100
V ITTORIO M ORFINO
poveri che costruisce comunemente il mondo sporgendosi oltre il limite del presente.
Questo è precisamente ciò che viene cancellato dall’«ideologia del trascendentale»:
essa stabilisce una filosofia della storia, nelle due forme dell’apologia o
dell’escatologia, che si pretende una teleologia «negativa» del comune.
Nell’apologia della razionalità della storia, la teleologia trascendentale nega la
stessa presenza della moltitudine dei poveri come produttrice del mondo; nella
versione escatologica rinvia il riconoscimento di questo destino protagonista alla
fine dei tempi 109.
Vi è però un’«altra storia» secondo Negri:
Il suo cammino è ontologicamente lineare, e tuttavia interrotto dai salti
innovativi che la moltitudine dei poveri impone alla storia: essa rompe l’«ordine»
del mondo per gettare la vita oltre i limiti del tempo, per smisurarla
radicalmente, alla ricerca e nella costruzione del comune. Questa «altra storia»
ontologicamente presuppone, alla freccia del tempo, l’eterno e riarticola,
storicamente, l’eterno e la freccia del tempo. Ma quest’«altra storia» è vista solo
da kairòs 110.
Questa esperienza della povertà che si dà «sull’orlo del tempo, innovando l’eterno»
si presenta come esperienza del «fuori misura», cioè, secondo Negri, come resistenza,
e dell’«oltre misura», come potenza costituente.
La resistenza è produttiva di nuovi spazi di creazione e di circolazione che «nuove
istituzioni della misura cercheranno di controllar[e] e di ridurr[e] sotto il loro segno,
mentre nuove imprese cercheranno di sfruttar[e]»: «Così si costruisce il mercato
mondiale del trascendentalismo parassitario. È qui che all’avenire si oppone il futuro,
al kairòs la statistica, alla differenza la ripetizione» 111. Il general intellect è la
condizione produttiva del post-moderno, l’epoca dell’uomo-macchina: la potenza dei
poveri sull’orlo del tempo si progetta oltre-misura e si apre alla dismisura. Tuttavia
«nessuna linearità è presupposta a questa produzione, e nessuna linearità ne segna il
corso». «Questo ci attesta povertà», conclude Negri. La povertà è infatti una potenza
irrecuperabile a qualsivoglia sintesi: «Ponendosi sul limite del tempo, fra pieno e
vuoto, fra eterno e innovazione, la povertà domanda amore» 112. E l’amore, aggiunge
Negri, è la prassi costituente del comune, nella misura in cui la povertà non è oggetto
Ivi, p. 88.
Ivi, p. 88.
111 Ivi, p. 92.
112 Ivi, p. 102.
109
110
�101
Sull’orlo del tempo. La teoria negriana della temporalità
di amore, come nel cristianesimo, ma soggetto: «L’esperienza di povertà introduce
alla costituzione del comune, l’esperienza di amore è attività di costruzione del
comune» 113.
Ora, proprio l’eterno ritorno della potenza di amore sul luogo di povertà è ritorno
creativo, è un clinamen soggettivato. In altre parole, la temporalità incrementa
l’eterno solo quando è sostenuta da amore:
è da una moltitudine di esistenze singolari che l’essere comune è generato, e
l’eternità del comune è un cielo stellato di singolarità. L’amore accende
continuamente questo cielo comune 114.
Alma Venus è allora una creazione continua dell’eterno perché solo amore può
abbracciare la freccia del tempo rendendola creativa: «Tempo è figlio di amore
perché solo la generazione prolunga la temporalità nell’avvenire. Il tempo dell’eterno,
si smisura, attraverso la generazione, nell’avvenire» 115. E ciò che nel tempo è
generazione, nello spazio è cooperazione, cioè «amore che agisce facendosi comune
fra la molteplicità, [...] potenza della vita moltiplicata»:
Il nome comune d’amore si mostra a questo punto come potenza costitutiva
ontologica in senso proprio – costitutiva del tempo e dello spazio,
rappresentazione adeguata dell’essere comune e, soprattutto, instaurazione
fondatrice del biopolitico 116.
Ritornando sulla periodizzazione che sta al cuore del libro, Negri afferma che se la
teologia è la forma adeguata all’epoca del centauro, la politica la forma dell’epoca
dell’uomo-uomo, mentre nell’epoca dell’uomo-macchina questa non può essere che
un «orrido anacronismo». L’amore distrugge e sostituisce il contesto del politico con
il biopolitico. Ora, proprio questo passaggio obbliga Negri a ridefinire la questione
della decisione in seno alla moltitudine:
Il «potere costituente» non è più, nel postmoderno, quell’istantanea
concentrazione creativa della moltitudine (o della povertà in rivolta) che,
attraverso l’insurrezione [...] costruisce un nuovo ordine: così era il moderno. Ora
il potere costituente è la dimensione politica aderente allo sviluppo della
teleologia del comune, ovvero è la spinta costitutiva che procede da una base
Ivi, p. 104.
Ivi, p. 106.
115 Ivi, p. 107.
116 Ivi, p. 108.
113
114
�102
V ITTORIO M ORFINO
biopolitica, sull’intero orizzonte dell’essere, quindi in ogni istante di
temporalità 117.
Il potere costituente nega che qualcosa possa presentarsi come costituito, in altre
parole «l’ontologia ha assorbito il politico» 118.
In questo senso Negri fissa una fondamentale distinzione rispetto al materialismo
classico e a quello moderno: questi non concepiscono la «trasvalutazione», dove per
trasvalutazione Negri intende il punto di incontro tra eterno e innovazione, la
creazione di nuovo essere, l’evento produttivo sull’orlo del tempo. La trasvalutazione
procede dalla moltitudine, dalla potenza del povero e dalla creatività di amore. Il
corpo è il luogo di questa trasvalutazione: «La macchina di trasvalutazione [...] fila i
dispositivi delle singolari possibilità dei corpi, costruendo nella moltitudine il ricco
tessuto comune che va a riempire il vuoto dell’essere, dunque a innovare l’eterno» 119.
La decisione allora non è che una variante della trasvalutazione dei corpi: sono
infatti i corpi che decidono. «Decisione – scrive Negri – è un altro modo di dire
trasvalutazione, di dire cioè innovazione ontologica sull’orlo del tempo» 120. Decisione
è sempre e solo decisione della moltitudine. L’enfasi sul «decidere dell’eccezione» è in
questo senso completamente sbagliata, in realtà in ogni istante «le singolarità
decidono dell’eccezione» 121. In realtà trasvalutazione e decisione non sono che figure
del «lavoro vivo»:
Oggi – scrive Negri – il lavoro vivo ha ricondotto a sé ogni produzione. In
ragione del fatto che la produzione è linguaggio, allo stesso modo la produzione
è lavoro vivo, perché lavoro immediatamente intellettuale e affettivo. Esso
produce il mondo e, nel momento in cui lo produce, lo innova. [...] nell’economia
politica dell’età dell’uomo-uomo [moderna], la produzione e la riproduzione del
mondo sono sempre state separate. L’uomo produceva e la donna riproduceva. Il
settore dell’economia che riguardava la produzione era del maschio, quello
riproduttivo della femmina. Solo nel postmoderno, quando il lavoro è linguistico
ed affettivo, produzione e riproduzione non possono più separarsi, anzi
costituiscono un tutto circolare. Ed il lavoro vivo è di tutti. È per segnalare
questa metamorfosi che si palesa nel divenire comune del lavoro vivo, che si dice
laconicamente: il lavoro vivo e femmina! 122
Ivi, pp. 135-136.
Ivi, p. 136.
119 Ivi, p. 140.
120 Ivi, p. 143.
121 Ibidem .
122 Ivi, p. 147.
117
118
�103
Sull’orlo del tempo. La teoria negriana della temporalità
Dunque il lavoro vivo produce il mondo e lo innova e lo fa in quanto general
intellect, secondo un duplice movimento: «dal corpo linguistico all’intelletto
generale» e dalla «macchina al corpo» 123. In questo senso Negri dichiara essere false le
definizioni spiritualiste della decisione, cioè le definizioni della decisione come pura
e unilaterale: «La decisione è sempre plurilaterale e sporca perché il singolare è
sempre determinazione smisurata di corpi, linguaggi, macchine» 124. Questa la
definizione infine:
Una potenza che allunga il comune nell’avenire, che costruisce comunemente i
corpi oltre l’orlo del tempo, che manifesta l’eterno innovandolo, – questo
chiamiamo decisione? 125
L’evento della decisione riguarda una singolarità non dialettica, poiché la
dialettica rifiuta «alla decisione la potenza di creare ex nihilo», e ancora non può
cogliere nella decisione «il rapporto potente di povertà e amore» 126. Da Machiavelli a
Marx Negri ricerca elementi utili alla costruzione della definizione della decisione:
da Machiavelli va ritenuta la teoria della decisione come «generazione di
temporalità», che Marx distende sul tempo storico. Tuttavia, aggiunge Negri,
La concezione marxiana è trattenuta da tali e tante controtendenze che solo
andando «oltre Marx», il marxismo può confrontarsi alle dimensioni produttive
del postmoderno, e decidere della liberazione del lavoro vivo dal lavoro morto 127.
L’evento singolare della decisione è il trionfo di amore che insorge dalla
moltitudine: «[l’evento-decisione] è la trasvalutazione soggettiva dei corpi della
moltitudine. L’evento si determina attraverso le costellazioni delle singolarità,
realizzando in forma attiva il telos della moltitudine, ovvero dal basso, laddove
agiscono le tecnologie d’amore. L’evento diviene soggetto» 128. L’epoca dell’uomomacchina è definito «dalla metamorfosi dell’umano in macchina comune
amorosa» 129, di cui la Comune di Parigi è stata prefigurazione, metamorfosi che
indica un «kairòs comune, nel quale si dice: tutti insieme decidiamo» 130.
Ivi, p. 151.
Ivi, p. 156.
125 Ivi, p. 158.
126 Ivi, p. 159.
127 Ivi, p. 161.
128 Ivi, p. 165.
129 Ivi, p. 166.
130 Ibidem .
123
124
�104
V ITTORIO M ORFINO
4. CONCLUSIONE
Al termine di questo percorso attraverso i due testi-cardine di Negri sulla
temporalità che si è tentato di ricostruire, seppur in modo inevitabilmente
schematico, vorrei proporre due notazioni sul modo in cui Negri lavora sulla
tradizione filosofica. La prima notazione riguarda un’operazione negriana che
caratterizza entrambi i testi, ed è riconducibile all’idea di pratica filosofica come
«lotta di classe nella teoria» (senza per questo voler immaginare un’influenza diretta
di Althusser, l’idea in fondo è leninista): Negri traccia linee di demarcazione tra due
storie del «tempo», quella idealistica e quella materialista. Tuttavia le due storie non
hanno lo stesso statuto: la prima è periodizzabile con precisione e di essa è offerta
una decriptazione attraverso una riconduzione al suo orizzonte sociale e politico, la
seconda invece non ha continuità, se vi è accumulazione, ciò accade per salti e
insorgenze, è un fiume sotterraneo che improvvisamente emerge in superficie, contro
il potere, perché questa è la natura del materialismo. Ma proprio questo carattere
attribuito al materialismo scompagina le carte delle sue storie tradizionali: negli stessi
anni in cui Althusser scriveva frammenti di storia sotterranea di materialismo
aleatorio, Negri disegna, costruisce per noi, una tradizione materialista che va dagli
atomisti greci a Lucrezio, da Machiavelli a Spinoza a Marx, dove Marx è il punto di
arrivo ma anche di partenza, la ragione per cui il percorso stesso è stato tracciato:
ampliarne, potenziarne il pensiero, facendo ricorso ad autori misconosciuti, fraintesi
e combattuti nella tradizione filosofica Occidentale e con queste armi affrontare la
tradizione «del potere», Hobbes, Rousseau, Hegel e, più di ogni altro, Heidegger,
grande nemico onnipresente nel pensiero di Negri contro cui è costruito tutto il
«suo» Spinoza.
Ma una seconda notazione, di carattere metodologico, va abbozzata al termine di
questo percorso, a proposito della «strategia» filosofica di Negri, che consiste non
solo nel tracciare linee di demarcazione rispetto alla tradizione idealistica, alla
tradizione del potere, ma anche nello strapparne brandelli per risemantizzarli dentro
una machina materialista capace di produrre effetti di liberazione. Troviamo nella
costruzione teorica negriana termini provenienti da campi e tradizioni differenti:
l’«innovazione» di Schumpeter, la «decisione» di Schmitt, la «povertà» e l’«amore»
della tradizione cristiana, l’«eternità» e la «creazione continua» della tradizione
teologica, la «monade» leibnizina, la «metamorfosi» goethiana, la nietzscheana
«trasvalutazione», il «kairòs» e il «fato» greci, persino la «teleologia». Per leggere
Negri, come per leggere il suo maestro Spinoza, non ci si può abbandonare alla
memoria semantica dei termini, farsi attrarre dalla loro forza evocativa; è necessario
�105
Sull’orlo del tempo. La teoria negriana della temporalità
invece ripercorrere i nessi che egli istituisce all’interno del suo sistema,
risemantizzando profondamente ciascuno di questi termini, per metterli al servizio
della ridefinizione «ontologica» di un concetto-chiave del pensiero di Marx, quello di
«lavoro vivo». In questo senso, e per concludere, lascerei la parola di nuovo a Negri
con un passo già citato, ma che mi sembra esemplare di questa «strategia»:
La produzione costruisce [...] il mondo, seguendo una traccia di cui la
temporalità è sostanza. Sul «prima» di questo processo continua ad accumularsi
il lavoro morto, il tempo concluso della creazione; il «poi» è rappresentato dal
lavoro vivo, ossia dal kairòs dei corpi che creano verità attraverso la prassi.
Sull’orlo del tempo, il lavoro vivo è così potenza del mondo, di quello che è già
stato (e che vi permane costante) e che ora è rivivificato; di quello che apparirà
dal nuovo lavoro vivo creatore. Ecco dove la metafisica del materialismo trova la
sua base e, insieme, il suo centro: riconoscendo che il processo capitalistico ha
sussunto il mondo, facendone una creatura morta; e che al contrario il lavoro
vivo è kairòs, inquieto creatore di avenire. Il lavoro vivo prende il mondo in
mano, lo trasforma e lo innova, radicalmente, nel comune.
�106
�107
Etica & Politica / Ethics & Politics, XX, 2018, 1, pp. 107-126
ISSN 1825-5167
LA BIOPOLITICA NEL PENSIERO DI
ANTONIO NEGRI.
DALLA «TENDENZA» ALL’ECCEDENZA
AFFERMATIVA DELLA VITA
MAT T I A DI PI E RRO
Scuola Normale Superiore
Université Diderot- Paris VII
mattia.dipierro@sns.it
ABSTRACT
This essay reflects on the reception and the use of biopolitics in Antonio Negri's work. Within
certain essays that Negri wrote in the Seventies, through his attempt of exceeding some Marxist
categories, we can find the premises of a possible encounter with the biopolitical paradigm. Negri
finds Michel Foucault during the Seventies. Reading the pages of the French philosopher, he
discovers the invasiveness of contemporary capitalism and the new form of power. Then, thanks to
the work of Gilles Deleuze, he exceeds Foucault, conceiving the immanence of life, discerning from
biopolitics and biopower, imagining a subject that represents bios affirmation: the multitude.
KEYWORDS
Antonio Negri, workerism, Michel Foucault, Gilles Deleuze, biopolitics, biopower.
L’obiettivo del presente saggio è quello di cogliere il senso della ricezione del
paradigma biopolitico nell’opera di Antonio Negri. La tesi qui sottesa è che il
pensiero negriano sia sempre rimasto fedele a una radicale e personale 1 impostazione
operaista, attraverso la quale devono essere colte sia la sua lettura di Foucault, sia la
sua interpretazione della biopolitica. Per questo, l’analisi proposta non si sofferma
L’uso di questo termine vuole indicare la peculiarità dell’operaismo negriano. Senza poter
scendere nel dettaglio dell’ampia e articolata discussione intorno ai legami e alle differenze tra
operaismo e post-operaismo, crediamo che esistano tanti ed evidenti punti di contatto quanti di
divergenza fra l’impostazione operaista delineata da Tronti negli anni Sessanta e la sua interpretazione
ad opera di Negri. Contro ogni «post-», invece, lo stesso Negri rivendica la postura operaista del suo
lavoro e la continuità con quello che qui chiameremo «operaismo classico». Per la posizione di Negri
sul tema cfr. Negri, T. (2017), Post-operaismo? No. Operaismo, in «Euronomade»,
http://www.euronomade.info/?p=9189 . Consultato il 10/02/2018.
1
�108
M A TTIA D I P IE RRO
soltanto sugli ultimi testi, dove Negri affronta esplicitamente il tema biopolitico, ma
muove piuttosto da alcuni scritti degli anni Settanta in cui prende forma il nucleo
dell’operaismo negriano. Quest’arco lungo dell’analisi proposta, se rischia forse di
essere eccessivamente schematico, risponde alla precisa necessità di chiarire alcune
articolazioni del pensiero di Negri senza le quali risulterebbe impossibile
comprendere la sua interpretazione della biopolitica.
1. DALLA FABBRICA ALLA SOCIETÀ: LA SUSSUNZIONE REALE
Tra il 1971 e il 1975 Antonio Negri scrive una serie di saggi che riarticolano il
pensiero operaista «classico» 2 aprendo la strada a quello che si sarebbe chiamato postoperaismo 3. In questi scritti l’autore delinea la transizione verso una nuova fase del
capitalismo, caratterizzata dalla permanenza della crisi e dal confinamento dello
Stato moderno nell’impossibilità di regolare i flussi di capitale. Fino agli anni
Sessanta, sostiene Negri, il progetto capitalistico si era strutturato attorno alla forma
dello Stato-piano, attraverso cui la massificazione della forza produttiva veniva
utilizzata per alimentare la crescita del saggio di profitto 4. Questo «sogno riformista»,
costruito sulla ripartizione dei profitti tra i vari partecipanti all’ordine sociale, si è
però infranto contro la stagnazione e l’appiattimento del saggio di profitto. Negri
legge questi mutamenti da una prospettiva saldamente operaista e coglie la
ristrutturazione capitalistica come risposta all’azione operaia 5. Le lotte operaie,
Con questo aggettivo ci riferiamo all’operaismo degli anni Sessanta e al pensiero di Mario Tronti.
Cfr. Tronti, M. (1966), Operai e capitale, Torino: Einaudi. Dal 2006 il saggio è disponibile in una nuova
ristampa della casa editrice DeriveApprodi. Per un approfondimento del pensiero trontiano e della sua
evoluzione cfr. Filippini, M. (2011), Mario Tronti e l’operaismo degli anni Sessanta , in «Cahiers du
GRM», n. 2, https://grm.revues.org/220 , consultato il 16 gennaio 2018; Milanesi, F. (2014), Nel
Novecento. Storia, teoria, politica nel pensiero di Mario Tronti, Milano: Mimesis; Tronti, M., Cavalleri,
M., Filippini, M., Mascat, J.M. (2018), Il demone della politica. Antologia di scritti (1958-2015),
Bologna: Il Mulino.
3 Il riferimento è in particolare a: Negri, A. (1973), Crisi dello Stato-piano: comunismo e
organizzazione rivoluzionaria , Milano: Feltrinelli; Id. (1974), Partito operaio contro il lavoro, in
Bologna, S., Carpignano, P., Negri A. (1974), Crisi e organizzazione operaia , Milano: Feltrinelli, pp. 99–
160; Id. (1976), Proletari e Stato: per una discussione su autonomia operaia e compromesso storico,
Milano: Feltrinelli. Tutti questi interventi sono oggi raccolti in Negri, T. (2006), I libri del rogo, Roma:
DeriveApprodi. D’ora in poi faremo riferimento a questa edizione. Come scrive lo stesso nella
Prefazione a questo volume (cfr. Ivi, p. 5), gli articoli a cui ci riferiamo sono stati scritti in un periodo
compreso tra il 1971 (Partito operaio contro il lavoro) e il 1975 (Proletari e Stato).
4 Negri, T., Partito operaio contro il lavoro, cit., p. 84.
5 Era stato Mario Tronti, in un saggio apparso sul primo numero di «Classe operaia» con il titolo
Lenin in Inghilterra , ad affermare: «Abbiamo visto anche noi prima lo sviluppo capitalistico, poi le lotte
operaie. È un errore. Occorre rovesciare il problema, cambiare il segno, ripartire dal principio: e il
principio è la lotta di classe operaia. A livello di capitale socialmente sviluppato, lo sviluppo
capitalistico è subordinato alle lotte operaie, viene dopo di esse e ad esse deve far corrispondere il
2
�109
La biopolitica nel pensiero di Antonio Negri.
Dalla «tendenza» all’eccedenza affermativa della vita
afferma, hanno scardinato il meccanismo dello Stato-piano: il capitale ha perso il
controllo sulla potenza creativa del lavoro vivo, ritrovandosi nell’impossibilità di
estrarne ulteriore plusvalore. La fabbrica, apice dell’organizzazione capitalistica e
sede privilegiata della produzione di plusvalore, si è rivoltata contro il meccanismo
del capitale. L’organizzazione operaia, appropriandosi direttamente della produzione
di plusvalore, ha fatto delle catene di montaggio un luogo ostile per il padronato.
Alla crisi di stagnazione, sostiene Negri, il capitale ha risposto attraverso una
doppia strategia: cercando di aumentare la produttività del lavoro e svalutando al
contempo il tempo di lavoro. Un doppio meccanismo volto a schiacciare la capacità
immediata di esprimere valore propria del lavoro vivo, salvaguardando allo stesso
tempo l’estrazione di plusvalore. Svalorizzazione e limitazione della potenza del
lavoro vivo hanno quindi costretto il capitale a reperire altre vie, fuori dalla fabbrica,
per continuare a generare profitto. Si è aperta in questo modo la strada per la
«sussunzione reale» 6 dell’intera società al meccanismo del capitale 7.
La linea capitalistica di ristrutturazione non può che passare attraverso il tentativo
di isolare la caduta del saggio di profitto in fabbrica (ed i suoi agenti) dal processo di
meccanismo politico della propria produzione», Tronti, M. (1964), Lenin in Inghilterra , in «Classe
operaia», n. 1, p. 1 e pp. 18-20, ora in Id. (2006), Operai e Capitale, cit., pp. 87-93. Si veda inoltre Id.
(1962), La fabbrica e la società , in «Quaderni Rossi», n. 2, pp. 1-31. Lo stesso saggio, pubblicato nel
1966 in Operai e capitale (cit., pp. 39-59), è ora in Id., Il demone della politica, cit., pp. 95-122.
6 La categoria è esposta da Marx ne Il Capitale in relazione all’analisi della giornata lavorativa. La
sussunzione formale e la sussunzione reale sono due modalità attraverso cui il capitale cerca di
recuperare plusvalore assoluto attraverso la riduzione del lavoro necessario. Mentre la prima modalità
si esplica con il prolungamento della giornata lavorativa, la sussunzione reale si distingue per
un’estrazione intensiva di plusvalore (attraverso progresso tecnologico ecc.). Marx, K., Das Kapital,
trad. it. (1970), Il Capitale, 2 voll., Roma: Editori Riuniti, in particolare Libro I, cap. XIV. La categoria
è inoltre discussa da Marx nel cosiddetto «Capitolo sesto inedito». Il manoscritto, scritto probabilmente
tra il 1863 e il 1864, venne pubblicato in Italia nel 1969 (a cura di Maffi, B. (1969), Il capitale: libro 1.
Capitolo 6. inedito: risultati del processo di produzione immediato, Firenze: La Nuova Italia, pp. 51-72).
Per le considerazioni di Negri intorno al manoscritto marxiano cfr. Negri, T. (2012), Spunti di ‘critica
preveggente’ nel Capitolo VI inedito di Marx, in «UniNomade 2.0», http://www.uninomade.org/criticapreveggente-capitolo-sesto/. Consultato il 12/02/2018.
7 «Ora questa idea del valore il capitale non può che andare a recuperarla laddove il lavoro
produttivo, il lavoro cioè produttore di plusvalore, si esprime in forma eminente, nella fabbrica ,
nell’impresa capitalistica più avanzata. Ma nella fabbrica la classe operaia contesta in maniera
eminente – oggettivamente come limite inferiore del lavoro necessario, soggettivamente come lotta – la
produzione di plusvalore. Il valore può essere allora ritrovato solo facendo dell’impresa il momento di
recupero complessivo di tutta la produzione sociale, il momento in cui il limite minimo del lavoro
necessario valorizza tutta la produzione sociale. La produzione di merci attraverso comando è la
subordinazione totale che il capitale impone al rapporto della società con la fabbrica. L’intera società è
raccolta nella subordinazione al comando d’impresa, la forma della produzione d’impresa diviene la
forma egemone del rapporto sociale complessivo», Negri, T., Partito operaio contro il lavoro, cit., pp.
90-91.
�110
M A TTIA D I P IE RRO
socializzazione del lavoro produttivo che si svolge nella società intera. Ogni
prospettiva riformistica è caduta, il piano è tutto rivolto a far valere sul livello sociale,
attraverso l’estensione e l’onnipotenza delle forme del comando d’impresa, le ragioni
dell’isolamento e (su questa base) della rivincita padronale sugli operai di fabbrica, –
come tentativo di riprendere un meccanismo di valorizzazione diretta 8.
Il capitale, costretto alla stagnazione dalle lotte operaie, ha cercato plusvalore
direttamente nel tessuto sociale, trasformando ogni attività in lavoro produttivo.
L’intera società risulta così subordinata alla logica d’impresa che pervade e
struttura il rapporto sociale complessivo . Terziarizzazione, automazione,
flessibilità, perdurare sistemico della crisi sono gli effetti evidenti della
ristrutturazione capitalistica, in Italia come nel resto degli stati capitalistici
occidentali . Una trasformazione della società in fabbrica che è, allo stesso
tempo, il tentativo di distruggere la fabbrica come luogo dell’unità operaia e del
proletariato organizzato .
9
10
11
2. TENDENZA E SOGGETTIVITÀ PROLETARIA
All’interno del quadro proposto da Negri, fedele all’ottica operaista, emerge in
modo chiaro lo stretto legame tra ristrutturazione e conflitto, tra crisi e composizione
di classe. Agli occhi del teorico e militante padovano è Marx a cogliere al meglio
questo nesso. Proprio nella teoria marxiana 12 la caduta tendenziale del saggio di
Ivi, p. 99.
Ivi, p. 91.
10 «In Italia è almeno dal 1963 che un processo di ristrutturazione produttiva è in corso. Fondato
essenzialmente, in una prima fase e in seguito all’ondata di lotte degli ultimi anni Cinquanta,
sull’applicazione di macchinario labour-saving, dopo l’ondata di lotte del ’69 il processo di
ristrutturazione ha assunto un’estrema accelerazione e una intensità globale. Nelle sue linee portanti il
processo di ristrutturazione in atto riprende in Italia le caratteristiche principali della ristrutturazione
capitalistica del e sul mercato mondiale: punta cioè a determinare una maggior forza del comando
capitalistico attraverso un massimo di flessibilità nell’uso della forza lavoro, contro l’organizzazione
operaia’, – vale a dire contro la sua mobilità politica e contro la sua rigidità salariale. Questo obiettivo è
approssimato attraverso modificazioni che riguardano l’articolazione settoriale della produzione (sua
riorganizzazione con accentuazione del peso del settore dei beni strumentali: motori, cibernetizzazione,
telefonia ecc., e con la conseguente strumentazione diffusa del ‘controllo tecnologico’ della
socializzazione del lavoro industriale), l’integrazione tra industria e settori collaterali (soprattutto il
credito e la distribuzione: che è come dire ‘terziarizzazione’ del lavoro industriale), e infine la
riorganizzazione interna dell’industria (processi di decentramento della lavorazioni ecc.)», Negri, T.,
Proletari e stato, cit., p. 161.
11 Ivi, p. 162.
12 Il riferimento è in particolare ai Grundrisse. Cfr. Marx, K. (1939-1941), Grundrisse der Kritik der
politischen Ökonomie, Mosca: Verlag fur fremdsprachige Literatur; trad. it. a cura di Backhaus, G.
(1976), Lineamenti fondamentali di critica dell’economia politica («Grundrisse»), 2 voll., Torino:
Einaudi, in particolare pp. 39-141.
8
9
�111
La biopolitica nel pensiero di Antonio Negri.
Dalla «tendenza» all’eccedenza affermativa della vita
profitto, la fine catastrofica del capitalismo, si sgancia dal puro meccanicismo per
legarsi all’antagonismo di classe, al rapporto di forza tra operai e capitale 13. Benché
l’opera di Marx, avverte Negri, possa risultare un mezzo datato per intuire
l’andamento odierno delle crisi capitalistiche, essa è comunque uno strumento
essenziale per afferrare il senso dello sviluppo contemporaneo del capitale. In
particolar modo, Marx è riuscito a delineare una tendenza del capitalismo che si è
dimostrata reale con la ristrutturazione degli anni Settanta.
L’attenzione di Negri si concentra sulle pagine dei Grundrisse per leggervi la
descrizione di una tendenza che governa lo sviluppo del capitale. La sussunzione
reale, esito ineluttabile dello sviluppo del capitale, comporta una massificazione della
produzione sociale 14 la quale determina a sua volta l’amplificarsi di un’opposizione.
In altri termini: al massimo grado dello sviluppo corrisponde il massimo grado
dell’antagonismo 15. È questo, sinteticamente, il nucleo della «teoria della tendenza»
che, anticipata da alcuni precedenti scritti trontiani, è portata da Negri alle sue
estreme conseguenze 16.
Il realizzarsi della tendenza è in Marx l’emergenza di una necessità di massa –
oggettiva in quanto l’oggettività è costituita dal rapporto di massa delle
soggettività agenti, articolata alle determinazioni specifiche che lo sviluppo
capitalistico è – in questo rapporto – costretto a raccogliere. Realizzarsi della
tendenza significa allora vittoria del movimento dialettico nella misura in cui in
esso la specificità di una situazione storica è maturata nel rapporto, e sarà
distrutta dal rapporto, con un soggetto storico. […] La tendenza è essa stessa
movimento, movimento di un rapporto specifico e solo nella specificità di questo
trova la sua genesi e la sua distruzione: la tendenza alla crisi del capitale come
crisi del modo di produrre dinanzi alle condizioni del lavoro, della totalità del
comando capitalistico dinanzi alla totalità della soggettivazione operaia è un
Cfr. Negri, T., Partito operaio contro il lavoro, cit., p. 70.
Ivi, p. 84.
15 Negri, T. (1977), Dall’«Estremismo» al «Che fare?». Per la critica della costituzione materiale:
autovalorizzazione operaia e ipotesi di partito, in Id., La forma Stato. Per la critica dell’economia
politica della Costituzione, Milano: Feltrinelli. Il saggio è ora in Id., I libri del rogo, cit., p. 215.
16 Per un’analisi del ruolo della teoria della tendenza all’interno dell’operaismo cfr. Tomba, M.,
Bellofiore, R. (2015), Letture del frammento sulle macchine. Prospettive e limiti dell’approccio
operaista e del confronto dell’operaismo con Marx, in «Quaderni materialisti», n. 11-12, pp. 145-161.
Gli studiosi presentano la centralità di tale teoria all’interno del discorso operaista e sostengono che
Negri abbia solo sviluppato delle linee di ricerca già delineate da Panzieri e poi, soprattutto, da Tronti.
La tendenza, abbozzata già in Crisi dello Stato-piano e, soprattutto, in Partito operaio contro il lavoro,
è approfondita ed esplicitata da Negri per tutti gli anni Settanta e, come si vedrà, mai più abbandonata.
Cfr. Negri, A. (1979), Marx oltre Marx. Quaderno di lavoro sui Grundrisse, Milano: Feltrinelli. Per un
approfondimento di questa fase del pensiero negriano cfr: Sersante, M. (2012), Il ritmo delle lotte. La
pratica teorica di Antonio Negri (1958-1979), Verona: ombre corte.
13
14
�112
M A TTIA D I P IE RRO
movimento che ha una preistoria immediata – tutta determinata – e uno sbocco
che solo dentro il rapporto complessivo si determina .
17
Verso la fine degli anni Settanta quella che è ormai l’attualità della tendenza è
colta da Negri con una radicalità ancora maggiore nei termini di uno scontro totale
tra società e capitale. L’astrazione e la socializzazione del lavoro hanno dischiuso la
possibilità di un proletariato generalizzato, esteso a tutta la società, ormai divenuta
fabbrica 18. La dilatazione dello sfruttamento all’intero campo del sociale trasforma la
generalità del lavoro astratto in soggetto, in autonomia di comportamenti irriducibili
alla logica del capitale. Al di là del «dentro e contro» operaista, dev’essere affermato
il «fuori e contro» di un proletariato autonomo, in grado di autovalorizzarsi, di
combattere il capitale nel terreno del sociale 19.
Lo sforzo teorico negriano si orienta perciò verso la ricerca della fisionomia del
soggetto proletario sorto dal nuovo assetto del capitalismo 20. L’ipotesi teorica
dell’operaio sociale è un primo tentativo di rispondere a questa esigenza. Attraverso
tale figura Negri cerca di riassumere la socializzazione del lavoro e lo sfruttamento
che pervade ormai ogni campo della società. L’operaio massa, protagonista delle lotte
della seconda metà degli anni Sessanta e delle teorizzazioni del «primo operaismo», è
stato travolto dalla crisi della composizione di classe. Il lavoratore non qualificato,
proveniente dal Mezzogiorno e occupato nelle catene di montaggio del Nord
industriale, ha lasciato il cuore della teoria per fare spazio a nuove soggettività e
istanze di lotta 21. Così, il soggetto proletario a cui approda Negri in questo periodo si
caratterizza per il rifiuto spontaneo delle regole imposte dal metodo di produzione,
per una fuga verso il terziario, per una generale tendenza al rifiuto del lavoro e per
Negri, T., Crisi dello Stato-piano, cit., p. 32.
«Si tratta cioè di capire che cosa sia oggi la classe operaia davanti e dentro questa ristrutturazione.
E tutti gli elementi dell’analisi compiuta portano a proporre un’ipotesi specifica: cioè che, dinanzi alle
impotenti modificazioni provocate, o in via di essere determinate, dalla ristrutturazione, il corpo di
classe operaia si distende ed articola in corpo di classe sociale, in proletariato. Ma questo distendersi e
articolarsi non è inerme. La negatività della risposta capitalistica alla lotta dell’operaio-massa è
rovesciata nella sintesi della socializzazione del lavoro vivo, come lotta ed insubordinazione crescenti. È
un’ipotesi sconvolgente quella che comincia a configurarsi, la categoria ‘classe operaia’ va in crisi ma
continua a produrre tutti gli effetti che gli sono propri sul terreno sociale intero, come proletariato»,
Negri, T., Proletari e Stato, cit., p. 145.
19 Cfr. Negri, A. (1978), Il dominio e il sabotaggio. Sul metodo marxista della trasformazione sociale,
Milano: Feltrinelli; ora in Id., I libri del rogo, cit., pp. 245-301.
20 Cfr. Lanza, A. (2013), Quando è finita la rivoluzione. Il divenire storico dei movimenti italiani
degli anni settanta , in «Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali», n. 76, pp. 205-227.
21 Per un approfondimento intorno alla teoria dell’operaio massa e del passaggio all’operaio sociale
cfr.: Millefusco W, Sersante M. (2016), Dall’operaio sociale alla moltitudine, Roma: DeriveApprodi;
Negri, A. (2007), Dall’operaio massa all’operaio sociale. Intervista sull’operaismo, Verona: ombre corte;
S. Wright, L’assalto al cielo, cit., in particolare pp. 201-227.
17
18
�113
La biopolitica nel pensiero di Antonio Negri.
Dalla «tendenza» all’eccedenza affermativa della vita
un’altrettanto generale volontà di godimento e di immaginazione 22. L’operaio sociale,
insomma, è l’annuncio di un nuovo proletariato che pervade l’intera società fino a
comprenderla ed è in grado, in prospettiva, di porsi oltre e contro il capitale. In
quanto lavoro vivo, esso ha ormai scoperto la sua capacità produttiva e la sua
autonomia 23. Lontano dal prefigurare una semplice risposta al nuovo assetto del
capitale, il proletariato sociale dimostra piuttosto l’attuarsi della tendenza. Esso è
un’eccedenza, una forza attiva, creatrice, affermativa a cui il capitale è costretto a
rispondere, senza poterla mai assumere completamente. Proprio la teoria della
tendenza, inoltre, dona a questa continua eccedenza, che il capitale è costretto ad
inseguire, un carattere conflittuale e, dunque, una precisa direzione: contro il
capitale. Si delinea in questo modo la struttura binaria della società capitalistica
contemporanea: da una parte lo sfruttamento, il potere del capitale e dall’altra la
liberazione del lavoro vivo, del proletariato sociale. Come si vedrà, tale dicotomia
guiderà il lavoro successivo di Negri, sempre più impegnato sia a descrivere lo
sviluppo dello sfruttamento capitalistico, sia a cogliere le parallele modificazioni del
soggetto proletario.
3. FOUCAULT CON MARX: DALLA SUSSUNZIONE REALE ALLA
BIOPOLITICA
Il termine «biopolitica» ha una storia complessa che affonda le radici nel XIX
secolo 24. Il lavoro di Michel Foucault rappresenta una svolta cruciale in questo
percorso. Egli, infatti, «inventa da capo il termine e lo problematizza» imprimendo
una «rotazione dell’asse prospettico» 25. Dagli scritti intorno alla follia, passando per
Negri, T., Partito operaio contro il lavoro, cit., p. 93.
Cfr. Negri, T., Proletari e Stato, cit., pp. 162-163.
24 Se il termine «biopolitica» appare per la prima volta ai primi del Novecento, le sue radici
affondano almeno nel secolo precedente, nel darwinismo, nel pensiero di Auguste Comte o, più
genericamente, nella filosofia positivista. Per un approfondimento cfr. Cutro, A. (2005), Biopolitica:
storia e attualità di un concetto, Verona: ombre corte; Lemke, T (2011). Biopolitics. An Advanced
Introduction, New York-Londra: New York University Press; Bazzicalupo, L. (2012), Biopolitica. Una
mappa concettuale, Roma: Carocci. Si veda inoltre: a cura di Prozorov, S., Rentea, S. (2017), The
Routledge Handbook of Biolitics, New York: Routledge.
25 Bazzicalupo, L., Biopolitica , cit., p. 33. Il termine biopolitica è indagato da Foucault per la prima
volta in alcuni corsi tenuti tra il 1977-78 e il 1978-79. Tuttavia, già negli studi sulla clinica e sulla
psichiatria è possibile rintracciare il delinearsi di una forma di potere legata alla vita. Dell’autore si
vedano almeno: Foucault, M. (1975), Surveiller et punir. Naissance de la prison, Parigi: Gallimard; trad.
it. (1995), Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Torino: Einaudi; Id. (1976), Histoire de la
sexualité 1. La volonté de savoir, Parigi: Gallimard; trad. it. (1991), La volontà di sapere, Milano:
Feltrinelli. Si farà d’ora in poi riferimento all’ultima edizione del 2016; Id., a cura di Ewald, F.,
Fontana, A., Senellart, M. (2004), Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France 1977-78,
22
23
�114
M A TTIA D I P IE RRO
l’analisi delle istituzioni penitenziarie e della società punitiva, fino allo studio della
sessualità: l’attenzione per la presa del potere moderno sui corpi e sulla vita biologica
risulta un filo conduttore di tutto il lavoro del filosofo francese. È però a partire dagli
anni Settanta che la biopolitica emerge prepotentemente nei suoi studi, prima in
relazione alla medicalizzazione della società e poi sganciandosi dall’analisi medica e
divenendo un paradigma d’interpretazione della modernità occidentale.
L’analisi genealogica foucaultiana individua nel XVI secolo l’inizio di una
trasformazione della relazione di potere. Nella sua antica forma assoluta e in quella
«limitata» 26 dei primordi della modernità, sostiene Foucault, il sovrano si relazionava
alla vita solo attraverso la morte. Il suo diritto era limitato alla possibilità di uccidere
o lasciare vivere. In questo quadro il potere risultava «istanza di prelievo,
meccanismo di sottrazione, diritto di appropriarsi di una parte delle ricchezze,
estorsione di prodotti, di beni, di servizi, di lavoro e di sangue, imposti ai sudditi» 27.
Tutto ciò muta profondamente a partire dal XVI secolo, quando la forma del
prelievo viene affiancata e poi sostituita da funzioni di incitazione, rafforzamento,
controllo, organizzazione, maggiorazione e sorveglianza 28. Al diritto di morte del
Parigi: Gallimard; trad. it. a cura di Napoli, P. (2005), Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al
Collège de France (1977-78), Milano: Feltrinelli; Foucault, M., a cura di Ewald, F., Fontana, A.,
Senellart, M. (2004), Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France 1978-79, Parigi:
Gallimard; trad. it. a cura di Bertani, M, Zini, V. (2005), Nascita della biopolitica. Corso al Collège de
France (1978-79), Milano: Feltrinelli. Si farà d’ora in poi riferimento all’edizione del 2015. Gli studi
intorno ai più diversi aspetti dell’opera di Foucault sono ormai un numero considerevole, tanto che è
difficile elencarne anche solo i maggiori. Ci limitiamo qui a dei riferimenti introduttivi e a qualche
studio che più da vicino analizza la tematica del potere. Per un’introduzione all’opera foucaultiana cfr.:
Dreyfus, H. L., Rainbow, P. (1993), Michel Foucault: beyond structuralism and Hermeneutics, Chicago:
The University of Chicago Press; trad. it. (2010), La ricerca di Michel Foucault: analitica della verità e
storia del presente, Firenze: La Casa Usher; Catucci, S. (2000), Introduzione a Foucault, Roma-Bari:
Laterza; Iofrida, M., Melegari, D. (2017), Foucault, Roma: Carocci. Per un approfondimento della
tematica del potere cfr: Revel, J. (1996), Foucault, le parole e i poteri, Roma: Manifestolibri; Id. (2005),
Expériences de la pensée. Michel Foucault, Parigi: Bordas; Bernini, L. (2008), Le pecore e il pastore.
Critica, politica, etica nel pensiero di Michel Foucault, Napoli: Liguori; Redaelli, E. (2011), L’incanto
del dispositivo. Foucault dalla microfisica alla semiotica del potere, Pisa: ETS. Per uno studio
incentrato sul tema della biopolitica nel pensiero di Foucault si veda almeno Cutro, A. (2004), Michel
Foucault. Tecnica e vita. Bio-politica e filosofia del bios, Napoli: Bibliopolis.
26 Una delle caratteristiche peculiari del potere antico era, secondo Foucault, il diritto di vita e di
morte. Nella modernità dei teorici classici tale diritto viene notevolmente limitato: il sovrano non può
più esercitare tale potere in modo incondizionato e assoluto ma solo nei casi in cui esso si trova
minacciato nella sua esistenza. Su questo passaggio cfr. Foucault, M., La volontà di sapere, cit., pp. 119120.
27 Ivi, p. 120.
28 «L’Occidente ha conosciuto a partire dall’età classica una trasformazione molto profonda di
questi meccanismi di potere. Il «prelievo» tende a non essere più la forma principale, ma solo un
elemento fra altri che hanno funzioni d’incitazione, di rafforzamento, di controllo, di sorveglianza, di
maggiorazione e di organizzazione delle forze da sottomettere: un potere destinato a produrre delle
forze, a farle crescere e ad ordinarle piuttosto che a bloccarle, a piegarle o a distruggerle. Il diritto di
�115
La biopolitica nel pensiero di Antonio Negri.
Dalla «tendenza» all’eccedenza affermativa della vita
sovrano subentra un potere che gestisce la vita, che la rafforza, la organizza, la
difende. Per la prima volta nella storia «la realtà biologica si riflette in quella
politica» 29 e l’uomo moderno diviene «un animale nella cui politica è in questione la
sua vita di essere vivente» 30. Al declino definitivo della sovranità corrisponde
l’emersione di una rete diffusa di poteri strutturati attorno alla gestione di fenomeni
specifici: salute, igiene, natalità, longevità, razza 31.
Questa trasformazione opera per tutto il corso della modernità agendo sui poli del
corpo e della specie 32. È però solo nel XIX secolo, quando emerge la categoria di
«popolazione», quando corpo e specie vengono a contatto attraverso il dispositivo di
sessualità, che il potere biopolitico può mostrarsi nella sua forma più compiuta.
Foucault si concentra su questa fase di sviluppo biopolitico del potere in alcuni corsi
tenuti al Collège de France tra il 1977-78 e 1978-79. A questo punto della riflessione il
tema della biopolitica si intreccia a doppio filo con la questione del capitalismo e, in
particolar modo, con la sua forma neo-liberale 33.
Questo bio-potere è stato, senza dubbio, uno degli elementi indispensabili allo
sviluppo del capitalismo; questo non ha potuto consolidarsi che a prezzo
dell’inserimento controllato dei corpi nell’apparato di produzione, e grazie ad un
adattamento dei fenomeni di popolazione ai processi economici. […] l’adeguarsi
dell’accumulazione degli uomini a quella del capitale, l’articolazione delle forze
produttive e la ripartizione differenziale del profitto, sono stati resi possibili in
morte tenderà da questo momento in poi a spostarsi, o almeno ad appoggiarsi sulle esigenze di un
potere che gestisce la vita ed a finalizzarsi a ciò che queste domandano», Ibidem .
29 Ivi, p. 126.
30 Ivi, p. 127.
31 Foucault, M., Nascita della biopolitica , cit., p. 261.
32 «Concretamente, questo potere sulla vita si è sviluppato in due forme principali a partire dal XVII
secolo; esse non sono antitetiche; costituiscono piuttosto due poli di sviluppo legati da tutto un fascio
intermedio di relazioni. Uno dei poli, il primo sembra ad essersi formato, è stato centrato sul corpo in
quanto macchina: il suo dressage, il potenziamento delle sue attitudini, l’estorsione delle sue forze, la
crescita parallela della sua utilità e della sua docilità […] Il secondo, che si è formato un po’ più tardi,
verso la metà del XVIII secolo, è centrato sul corpo-specie, sul corpo attraversato dalla meccanica del
vivente e che serve da supporto ai processi biologici: la proliferazione, la nascita, la mortalità, il livello
di salute, la durata di vita […] la loro assunzione si opera attraverso una serie di interventi e di controlli
regolatori: una biopolitica della popolazione», Foucault, M., La volontà di sapere, p. 123. Sul rapporto
tra biopolitica, liberalismo e capitalismo si veda anche Id. (2001), Biopolitica e liberalismo, Milano:
Medusa. L’uso del lavoro di Foucault e, in particolar modo, del paradigma biopolitico, ha avuto grande
peso nell’analisi della società neoliberale. Si vedano, a titolo di esempio: Bazzicalupo, L. (2006), Il
governo delle vite. Biopolitica ed economia, Roma-Bari: Laterza; Lemm, V., Vatter, M. (2014), The
government of life: Foucault, biopolitics, and neoliberalism , New York: Fordham University press;
Audier, S. (2015), Penser le «néolibéralisme»: Le moment néolibéral, Foucault et la crise du socialisme,
Lormont: Le bord de l’eau.
33 Cfr., Foucault, M., Nascita della biopolitica , cit., p. 267.
�116
M A TTIA D I P IE RRO
parte dall’esercizio del bio-potere, nelle sue forme e con i suoi procedimenti
svariati.
34
Com’è stato giustamente osservato «le analisi sul liberalismo sono una
introduzione alla biopolitica nella misura in cui presentano il quadro in cui la vita
viene inscritta in un reticolo economico» 35. Proprio la società neo-liberale si è
dimostrata capace di portare alle sue estreme conseguenze la presa del potere sul
bios, integrando la vita biologica e i corpi nel meccanismo economico 36.
Le riflessioni foucaultiane hanno una portata dirompente nel campo di una teoria
post-marxista disorientata dalla crisi dei vecchi paradigmi, dalla perdita di capacità
descrittiva di alcune categorie marxiane 37 e dagli imponenti cambiamenti a opera del
capitale. Gli studi sulle discipline, sulla prigione e gli ultimi corsi al Collège de
France sembrano allora offrire gli strumenti concettuali necessari per tentare una
nuova modalità di analisi e di interpretazione, sia del potere sorto dalla
ristrutturazione capitalistica, sia delle nuove esigenze di emancipazione. La
pervasività delle discipline, lo sfruttamento della vita biologica e dei corpi,
l’immagine di un potere diffuso e non unicamente repressivo appaiono strumenti
utili al rilancio di una teoria rivoluzionaria che stenta a comprendere e tradurre i
processi reali (lo sfaldamento della classe operaia, il nuovo assetto dell’economia
globale). Così, nell’Italia della fine degli anni Settanta, le pagine foucaultiane iniziano
ad essere lette da una serie di pensatori radicali, per lo più provenienti dall’area
dell’operaismo, avidi di nuovi mezzi per interpretare il presente.
Proprio Negri, in un articolo apparso nel 1978 su «Aut-aut» dal titolo Sul metodo
della critica della politica, analizza l’incontro tra il pensiero foucaultiano e la sinistra
rivoluzionaria italiana, sostenendo la fertilità e l’utilità dell’incontro tra Foucault e
Marx 38. In quegli anni, d’altronde, il teorico padovano lavora per adeguare
Foucault, M., La volontà di sapere, cit., pp. 124-125.
Cutro, A., Michel Foucault. Tecnica e vita, cit., p. 137.
36 Cfr. Foucault, M., Nascita della biopolitica , cit., p. 267.
37 Il riferimento è qui, genericamente, alla «crisi del marxismo» che caratterizza gli anni Settanta e
Ottanta. La letteratura a riguardo è fin troppo abbondante. Per una veloce panoramica si veda, ad
esempio Fistetti, F. (2006), La crisi del marxismo in Italia. Cronache di filosofia politica (1980-2005).
Un abbozzo di storia degli intellettuali, Genova: Il Melangolo. Per un panorama del marxismo francese
dai primi anni del dopoguerra fino alla crisi dei maggiori paradigmi con l’esplosione del Maggio cfr.
Faracovi, O. P. (1972), Il marxismo francese contemporaneo. Fra dialettica e struttura , Milano:
Feltrinelli. Si veda anche Iofrida, M. (2015), Marx in Francia , in a cura di Petrucciani, S., Storia del
marxismo II. Comunismi e teorie critiche nel secondo Novecento, pp. 43-75.
38 Negri, A. (1978), Sul metodo della critica della politica , in «Aut aut», n. 167-168, pp. 197-212. Lo
stesso testo è stato poi pubblicato in Id. (1982), Macchina tempo: rompicapi, liberazione, costituzione,
Milano: Feltrinelli, pp. 70-84. Qui Negri afferma: «La ‘neue Darstellung’ – nella tematica marxiana –
non è ovviamente solo una nuova esposizione dei contenuti, deve essere anche una nuova
identificazione di soggetti e quindi una rifondazione teorica . Oggi siamo nel mezzo, se non oltre quella
fase liminare intravvista da Marx, comunque esigita dal suo procedimento critico. Oggi assistiamo
dunque ad un primo fertile sconvolgimento dell’orizzonte scientifico dei rivoluzionari’, – di ciò occorre
34
35
�117
La biopolitica nel pensiero di Antonio Negri.
Dalla «tendenza» all’eccedenza affermativa della vita
l’interpretazione dei testi e delle categorie marxiane al nuovo sviluppo del capitale 39.
Ai suoi occhi, il mutamento della società e del capitalismo occidentali ha messo in
questione la pregnanza delle categorie marxiane – a partire da quella di classe
operaia – nella diagnosi e nella critica del reale. In questo quadro problematico,
l’opera di Foucault, la sua analitica del potere e, in particolar modo, il tema della
biopolitica appaiono decisamente utili 40.
Provate a leggere con la semplicità del metodo dialettico e delle sue paradossali
alternative qualcuno dei grandi problemi della (critica dell’) economia politica e
della politica: un pugno di mosche è quanto, al massimo, vi trovate in mano! La
verità mostra invece oggi la sua complessità attraverso le mille vie che
introducono al processo critico della rivoluzione. Seguirle, articolare a fronte,
contro il potere, l’infinitamente complesso interconnettersi di autonomie e
indipendenze, di autonomia e autonomie, di possibilità e potenze – spiegare
questo processo come fonte e insieme come catastrofe del dominio nemico: di
quel metodo che ci permette questo lavoro abbiamo bisogno, della sua pienezza
ontologica. Approssimazione a questo metodo ed alla sua fingente, molteplice
diversa attività, alla complessità della funzione semantica che determina: il
esser grati anche a Foucault. […] Quel che è certo è che già molto cammino s’è in proposito
sensatamente fatto. L’intensità dell’approccio foucaultiano e la fertilità del suo metodo son parte delle
cose fatte e insieme sono compiti da eseguire», Ivi, p. 211. «Aut aut» è una delle prime riviste italiane a
occuparsi del pensiero di Foucault e Deleuze. Oltre al numero citato, interamente dedicato al nesso
potere-sapere, si vedano i numerosi interventi di Foucault, Deleuze o di commento alle rispettive teorie.
Cfr., ad esempio: Cacciari, M. (1977), «Razionalità» e «Irrazionalità» nella critica del Politico in
Deleuze e Foucault, in «Aut aut», n. 161, pp. 119-133; Foucault, M. (1978), Poteri e strategie, in «Aut
aut», n. 164, pp. 22-30.
39 È lo stesso Negri a notare la coincidenza delle due ricerche: «la lettura di Foucault avviene nel
momento stesso in cui riassumo in un corso universitario una lunga esperienza ‘revisionista’ di letture
marxiane», Negri, A. (2011), Quand et comment j’ai lu Foucault, in «Cahier de l’Herne», pp. 199-208;
trad. it. Quando e come ho letto Foucault, in Id. (2012), Il comune in rivolta. Sul potere costituente
delle lotte, Verona: ombre corte, p. 67.
40 Per un approfondimento della ricezione negriana di Foucault e del contesto storico-teorico cfr.:
Negri, A., Quando e come ho letto Foucault, cit.; Id., Marx and Foucault, cit.; Id., Alle origini del
biopolitico. Un seminario, in Id., Il comune in rivolta , cit., pp. 78-96. Per uno studio della biopolitica in
Negri, del suo legame con Foucault e oltre cfr. Toscano, A. (2007), Always Already Only Now: Negri
and the Biopolitical, in a cura di Murphy, T.S., Mustapha, A-K., The Philosophy of Antonio Negri.
Revolution in Theory. Vol. 2, Londra: Pluto Press, pp. 109-128. Sulle relazioni tra il pensiero marxiano
e quello di Foucault si veda almeno: a cura di Leonelli, R. M. (2010), Foucault-Marx. Paralleli e
paradossi, Roma: Bulzoni; Revel, J., Expériences de la pensée, cit., in particolare pp. 187-194; Macherey
P. (2013), Il soggetto produttivo, Verona: ombre corte; Bidet, J. (2014), Foucault avec Marx, Parigi: La
fabrique; Audier, S. (2015), Penser le «néolibéralisme», cit.; a cura di Laval, C., Paltrinieri, L., Taylan F.
(2015), Marx & Foucault. Lecture, usages, confrontations, Parigi: La Découverte .
�118
M A TTIA D I P IE RRO
metodo della critica dell’economia politica e della politica si prova oggi, anche
grazie a Foucault, su questo compito.
41
Le letture di Sorvegliare e punire e poi del primo capitolo della Storia della
sessualità 42 dischiudono un nuovo approccio all’analisi del potere. Allo stesso tempo
offrono un sostegno per pensare una conflittualità che non si svolga al livello delle
istituzioni ma nell’immanenza del sociale 43. In netto contrasto con la prospettiva del
compromesso storico e con la direzione intrapresa da alcuni vecchi compagni 44, Negri
si preoccupa di riattivare la potenzialità rivoluzionaria cercando là dove si attua lo
sfruttamento e dove, perciò, c’è ancora possibilità di conflitto: nella società. Per
riuscire in questo intento è anzitutto necessario abbandonare ogni piano
trascendente e ogni spiegazione dialettica, comprendere fino in fondo il significato
della sussunzione reale e riuscire, di conseguenza, a cogliere la nuova fisionomia del
proletariato sociale. Un’analisi condotta al livello dei micropoteri, della loro presa sui
corpi e sulle vite, insomma, può chiarire le modalità di sfruttamento neoliberale e,
allo stesso tempo, delineare sembianze e possibilità del lavoro vivo, di quel
proletariato diffuso potenzialmente conflittuale che Negri tratteggia dall’inizio degli
anni Settanta.
Così comparve il biopolitico: come vita messa al lavoro, e quindi come politica
attivata per organizzare le condizioni ed il controllo dello sfruttamento sociale,
sull’intera dimensione della vita. Si diceva in termini marxisti: il capitale ha
«sussunto» l’intera società. La scuola di Francoforte aveva descritto l’effettività e
la violenza della sussunzione; ma non aveva colto la cosa fondamentale: il
mutamento della figura di classe, la continuità metamorfosata della resistenza.
Insomma, il biopolitico diventava centrale nel discorso politico quando cambia
la natura della forza-lavoro; ed al lavoro industriale (come sorgente di
produttività) si sostituisce l’attività sociale. Alla fine degli anni ’70 – ma poi
soprattutto negli anni ’80 e ’90 – questa consapevolezza diviene generale. 45
Negri, A., Sul metodo della critica della politica, cit., p. 212.
Cfr. Foucault, M., La volontà di sapere, cit.
43 Cfr. Negri, A., Quando e come ho letto Foucault, cit., p. 70.
44 I riferimenti polemici di Negri in questo periodo sono sia la via intrapresa dal PCI verso il
cosiddetto compromesso storico, sia la linea teorica seguita da Tronti. Quest’ultimo, attraverso
l’autonomia della dimensione politica, teorizza la necessità di portare il conflitto di classe al livello delle
istituzioni. Cfr., ad esempio, Negri, T., Proletari e Stato, cit. Tronti presenta invece la sua teoria in
Tronti, M. (1977), Sull’autonomia del politico, Milano: Feltrinelli; ora in Tronti, M., Cavalleri, M.,
Filippini, M., Mascat, J.M., Il demone della politica , cit., pp. 285-312.
45 Negri, A., Alle origini del biopolitico, cit., p. 81.
41
42
�119
La biopolitica nel pensiero di Antonio Negri.
Dalla «tendenza» all’eccedenza affermativa della vita
4. LA BIOPOLITICA, L’IMPERO, LA POST-MODERNITÀ
Impero, scritto nel 1997 con Michel Hardt, rappresenta un momento chiave nella
produzione negriana. Con questo testo il paradigma biopolitico diviene uno
strumento centrale d’indagine e un oggetto più chiaro e definito 46. Nel celebre saggio
gli autori tentano di tratteggiare il nuovo assetto del capitalismo internazionale
contemporaneo. Con il termine «Impero» descrivono un nuovo paradigma, una
nuova logica che governa il mondo. Si tratta di una struttura sistemica, dinamica,
flessibile, articolata orizzontalmente, senza un centro né confini definiti 47, sorta dalle
ceneri della sovranità nazionale e in grado di gestire l’accumulazione di capitale al
livello del mercato globalizzato 48.
L’impero emerge al crepuscolo della sovranità europea. Al contrario
dell’imperialismo, l’Impero non stabilisce alcun centro di potere e non poggia su
confini e barriere fisse. Si tratta di un apparato di potere decentrato e
deterritorializzante che progressivamente incorpora l’intero spazio mondiale
all’interno delle sue frontiere aperte e in continua espansione.
49
Le enormi corporations, la finanza, le reti di comunicazione e l’informatizzazione
sono gli attori principali di questo nuovo ordine 50. La rete si impone come principale
modello organizzativo della produzione 51, mentre l’affermazione dell’economia
informatizzata trasforma il lavoro rendendolo immateriale 52. Proprio la categoria di
«lavoro immateriale» rende evidente una delle caratteristiche peculiari dell’Impero:
Hardt, M., Negri, A. (2000), Empire, Cambridge: Harvard University Press; trad. it. (2002)
Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione, Milano: Rizzoli.
47 «Occorre sottolineare che noi non usiamo il termine ‘Impero’ come una metafora che implica la
46
definizione delle somiglianze tra l’attuale ordine mondiale e gli imperi di Roma, della Cina, quelli
precolombiani ecc. – ma piuttosto come un concetto che esige un approccio essenzialmente teorico. Il
concetto di Impero è caratterizzato, soprattutto, dalla mancanza di confini: il potere dell’Impero non ha
limiti. In primo luogo, allora, il concetto di Impero indica un regime che di fatto si estende all’intero
pianeta, o che dirige l’intero mondo ‘civilizzato’. Nessun confine territoriale limita il suo regno», Ivi, p.
16.
48 La teoria esposta in Impero ha provocato un ampio dibattito che sarebbe difficile ridurre in una
nota. Per un panorama della ricezione: cfr. Zaru, E. (2016), «Impero» e «Imperialismo». Michael Hardt
e Antonio Negri nel dibattito internazionale, in «Scienza & Politica», n. 54, pp. 147-161. Si veda anche
Negri, A. (2003), Guide: cinque lezioni su impero e dintorni, Milano: Raffaello Cortina.
49 Hardt, M., Negri, A., Impero, cit., p. 14.
50 «Le trasformazioni giuridiche indicano mutamenti effettivi nella costituzione materiale del potere
e dell’ordine mondiale. La transizione, di cui siamo attualmente testimoni, tra il precedente diritto
internazionale, definito dai contratti e dai trattati, e la definizione e costituzione di una nuova sovranità
mondiale sovranazionale (e conseguentemente, di una nozione imperiale del diritto), benché
incompleta, ci fornisce un quadro di riferimento per leggere la totalizzazione dei processi sociali
dell’impero», Ivi, p. 27.
51 Ivi, p. 276.
52 Ivi, p. 275.
�120
M A TTIA D I P IE RRO
l’applicazione di un’estrazione intensiva di plusvalore direttamente al corpo sociale.
Nel nuovo ordine imperiale, infatti, la società intera è sussunta nel regime della
produzione 53. Non solo i settori informatizzati della produzione industriale, le attività
analitiche e creative ma anche il linguaggio, la creatività, gli affetti divengono ambiti
da cui è possibile ricavare plusvalore.
I grandi poteri finanziari e industriali non producono solo merci ma anche
soggettività. Producono soggettività agenti nel contesto biopolitico: producono
bisogni, relazioni sociali, e cervelli; in altri termini producono i produttori. Nella
sfera biopolitica, la vita è fatta per lavorare per la produzione e la produzione
lavora per la vita. È un grande alveare in cui la regina sorveglia notte e giorno la
riproduzione. Mano a mano che scende in profondità, l’analisi trova – a livelli di
intensità crescenti – gli assemblaggi interconnessi delle relazioni interattive .
54
Come si osserva da questa breve citazione, l’Impero si costituisce a partire dalla
sussunzione reale del bios, collettivo e individuale, al capitale. Nello spazio imperiale
è messo in atto in tutta la sua forza un potere biopolitico che trae plusvalore tanto
dalla comunicazione e dalla produzione industriale, quanto dalla gestione dei corpi e
delle nascite 55.
Quest’ulteriore espansione della sussunzione reale spiega, per Hardt e Negri, il
passaggio dalla foucaultiana società disciplinare alla «società del controllo». Una
categoria, quest’ultima, non esplicitamente elaborata da Foucault ma utile agli autori
per descrivere la diffusione delle discipline contemporanea al crollo delle istituzioni 56.
Uno stretto legame lega lavoro immateriale e biopolitica. Affermano, ad esempio, Hardt e Negri:
«Nel lavoro immateriale, la produzione travolge i limiti dell’economia tradizionalmente intesa e investe
direttamente la cultura, la società e la politica. L’oggetto della produzione non sono più soltanto beni
materiali, bensì relazioni e forme di vita. Chiameremo questo genere di produzione «produzione
biopolitica», per indicare il livello di generalità dei suoi prodotti e il modo in cui coinvolge direttamente
la totalità della vita sociale», Hardt, M., Negri, A. (2004), Multitude. War and Democracy in the Age of
Empire, New York: Penguin Press; trad. it. (2004), Moltitudine. Guerra e democrazia nel nuovo ordine
imperiale, Milano: Rizzoli, p. 119.
54 Hardt, M., Negri, A., Impero, cit, pp. 46-47.
55 La riformulazione della sussunzione reale in termini biopolitici è esplicitata in molti passaggi
dell’opera negriana. Si veda ad esempio questo, particolarmente efficace: «A questo punto ci è possibile
sviluppare l’analisi della biopolitica così come essa ci appare nell’epoca liberale e mercantilista – e della
resistenza contro questa – attraverso l’individuazione delle funzioni che assume, una volta uscita dalla
modernità, nel quadro della ‘sussunzione reale della società sotto il capitale’. Quando parliamo di
sussunzione reale della società sotto il capitale (cioè dell’attualità dello sviluppo capitalistico),
intendiamo certo la mercificazione della vita, la scomparsa del valore d’uso, la colonizzazione delle
forme di vita da parte del capitale», Negri, A. (2006), Fabrique de porcelaine. Pour une nouvelle
grammaire du politique, Parigi: Stock; trad. it. (2008), Fabbrica di porcellana. Per una nuova
grammatica politica, Milano: Feltrinelli, p. 32.
56 È stato Gilles Deleuze a leggere nell’opera foucaultiana il passaggio dalla società disciplinare alla
società del controllo. Afferma lo stesso Deleuze: «Foucault ha situato le società disciplinari tra il XVIII
e il XIX secolo; esse raggiungono l’apogeo all’inizio del XX secolo, procedendo all’organizzazione dei
53
�121
La biopolitica nel pensiero di Antonio Negri.
Dalla «tendenza» all’eccedenza affermativa della vita
Quando le istanze verticali delle istituzioni disciplinari collassano sul piano
orizzontale della rete di dispositivi di controllo 57, le logiche di soggettivazione che
operavano all’interno di ambiti circoscritti – la famiglia, l’ospedale, il carcere, la
caserma – si diffondono confondendosi con l’intera superficie del sociale. Di
conseguenza, le molteplici soggettivazioni ibride che emergono nella dimensione
immanente del sociale sono immediatamente assunte dal capitale, si strutturano cioè
secondo la sua logica 58.
La diffusione e generalizzazione delle discipline e il crollo della verticalità delle
istituzioni inaugurano una società liscia, senza striature, senza un fuori, in cui il
potere biopolitico si esplica in tutta la sua potenzialità. L’Impero segna perciò una
netta cesura con la modernità, la quale si strutturava invece attorno alla verticalità
delle istituzioni, alla trascendenza della sovranità e alla dinamica dentro/fuori. È
l’esordio di un’epoca post-moderna, contraddistinta dalla sussunzione completa della
società al piano immanente del capitale 59. Quest’ultimo, infatti, agisce sul piano
d’immanenza, lungo una rete che connette rapporti di potere, senza dover dipendere
da un centro trascendente 60.
La trascendenza della sovranità moderna è quindi in conflitto con l’immanenza
del capitale. Da un punto di vista storico, il capitale si è sempre avvalso della
grandi ambienti di internamento. L’individuo non fa che passare da un ambiente chiuso all’altro,
ognuno con le sue leggi: prima la famiglia, poi la scuola (‘non sei più in famiglia’), poi la caserma (‘non
sei più a scuola’), poi la fabbrica, di tanto in tanto l’ospedale, eventualmente la prigione, l’ambiente di
internamento per eccellenza. […] Ma le discipline, a loro volta, conosceranno una crisi a vantaggio di
nuove forze che lentamente guadagneranno terreno, fino a precipitare dopo la Seconda Guerra
mondiale: le società disciplinari erano già qualcosa del nostro passato, qualcosa che stavamo smettendo
di essere. Siamo in una crisi generalizzata di tutti gli ambienti di internamento, carcere, ospedale,
fabbrica, scuola, famiglia. […] Sono le società di controllo che stanno sostituendo le società disciplinari»,
Deleuze, G. (1990), Pourparlers, Parigi: Les Éditions de Minuit; trad. it. (2000), Pourparler, Macerata:
Quodlibet, pp. 234-235. Dello stesso autore si veda almeno: Deleuze, G. (1968), Différence et répétition,
Parigi: PUF; trad. it. (1972), Differenza e ripetizione, Bologna: Il Mulino; Deleuze, G., Guattari, F.
(1972), L'anti-Œdipe : Capitalisme et schizophrénie, Parigi: Les Éditions de Minuit, trad. it. (1975),
L’Anti-Edipo: capitalismo e schizofrenia, Torino: Einaudi; Deleuze, G. (1986), Foucault, Parigi: Les
Éditions de Minuit: trad. it. (1987), Foucault, Milano: Feltrinelli; Id. (2014), Il sapere. Corso su Michel
Foucault (1985-1986)/1, Verona: ombre corte.
57 Hardt, M., Negri, A., Impero, cit., p. 307. Per una definizione del controllo nella sovranità
imperiale si veda Ivi, pp. 187-189.
58 Ivi, p. 308.
59 «il mercato capitalistico è una macchina che ha sempre funzionato contro qualsivoglia divisione
tra un dentro e un fuori. È allergico alle barriere e alle esclusioni e si sforza sempre di includere ogni
cosa nella propria sfera di dominio. Il profitto è generato solo dal contatto, dal coinvolgimento,
dall’interscambio e dal commercio. Il mercato mondiale è il capolinea di questa tendenza. Nella sua
forma ideale il mercato mondiale non conosce nessun fuori: il suo dominio è il mondo intero», Ivi, p.
180.
60 Ivi, p. 303.
�122
M A TTIA D I P IE RRO
sovranità – e, in particolare, delle sue strutture giuridiche e della sua forza – ma
queste stesse strutture, in linea di principio, contraddicono continuamente il suo
sviluppo e, in pratica, lo ostruiscono. L’intera storia della modernità che
abbiamo ricostruito sino a questo punto può essere intesa come l’evoluzione del
tentativo di negoziare e di mediare questa contraddizione .
61
L’Impero, insomma, definisce sempre più uno scarto epocale. La dimensione e la
profondità della presa biopolitica del potere marcano una cesura rispetto alla
modernità qualificando un’era post-moderna, caratterizzata dal tramonto della
trascendenza sovrana in favore dell’immanenza del capitale. La traduzione della
sussunzione reale nel lessico biopolitico coincide così con l’apertura di uno sguardo
più ampio dell’indagine negriana 62, in favore della descrizione del lungo tragitto della
modernità. Uno sguardo che richiede la rinuncia a un linguaggio e a una ricerca
immediatamente politici in favore del lessico dell’ontologia 63.
5. «LINEA DI FUGA»: BIOPOTERE E BIOPOLITICA
Ivi, p. 305.
L’importanza di Foucault per la comprensione del passaggio al post-moderno è ben descritta da
Negri: «Cercherete invano, nella discussione foucaultiana dello sviluppo capitalistico, la
determinazione del passaggio dal welfare state alla sua crisi, dall’organizzazione fordista a quella
postfordista del lavoro, dalle figure keynesiane a quelle neoliberali, della macroeconomia; ma nella
scarna definizione del passaggio dai regimi disciplinari a quelli di controllo scoprirete che il
postmoderno non rappresenta un ritirarsi dello stato dal dominio sul lavoro sociale, bensì un ulteriore
perfezionarsi del controllo sulla vita. Nell’opera di Foucault quest’intuizione è sviluppata ovunque,
come se l’analisi del passaggio postindustriale costituisse l’elemento centrale del suo pensiero. La
determinazione metodica, la teoria della genealogia e infine i dispositivi di produzione della
soggettività sono impensabili fuori dalla determinazione materiale di questo presente e fuori da questo
orizzonte di transizione. È il passaggio dalla definizione del politico moderno a quella della biopolitica
postmoderna, cioè ciò che Foucault, qui, implicitamente teorizza», Negri, A. (2006), Movimenti
dell’Impero. Passaggi e paesaggi, Milano: Raffaello Cortina, p. 283. Lo sguardo ampio e periodizzante
dell’indagine negriana è ben visibile in un saggio di qualche anno anteriore a Impero. Cfr. Negri, A.
(1992), Il potere costituente. Saggio sulle alternative del moderno, Carango: SugarCo.
63 Lo spostamento verso il piano dell’ontologia è un rivendicato passaggio politico per Negri. Cfr.
Negri, A. (1982), L’anomalia selvaggia. Saggio su potere e potenza in Baruch Spinoza , Milano:
Feltrinelli, ora in Id. (1998), Spinoza , Roma: DeriveApprodi, pp. 21-285. Su questo tema cfr. Callinicos,
A. (2007), Antonio Negri and the Temptation of Ontology , in a cura di Murphy, T.S., Mustapha, A-K.,
The Philosophy of Antonio Negri, cit., pp.169-197; Viparelli, I. (2016), Antonio Negri. La necessità
della svolta ontologica , in «Cahiers du GRM», n. 10, http://journals.openedition.org/grm/888.
Consultato il 12/02/2018. Spinoza è sicuramente un altro autore chiave nel pensiero negriano, sia per
quanto riguarda la «svolta ontologica», sia per un pensiero dell’affermazione e della vita. In questa
sede, tuttavia, non prenderemo in considerazione quest’ambito del lavoro di Negri.
61
62
�123
La biopolitica nel pensiero di Antonio Negri.
Dalla «tendenza» all’eccedenza affermativa della vita
È necessario ora tornare brevemente alla «teoria della tendenza». Come si è visto,
tale teoria istituisce una connessione tra lo sfruttamento capitalistico e l’emersione di
una soggettività antagonista. Durante gli anni Settanta, Negri ridefinisce i termini
della tendenza attraverso la sussunzione reale e l’operaio sociale. In seguito,
l’incontro con l’opera di Foucault spinge il teorico padovano verso la traduzione della
sua analisi in un lessico biopolitico. In questo passaggio, la teoria della tendenza e lo
schema operaista che postula il primato dell’azione «operaia» sulla reazione del
capitale, continuano a costituire le radici del pensiero negriano e lo schema
interpretativo attraverso il quale anche le pagine foucaultiane vengono lette 64. Così,
per il filosofo padovano, dopo aver identificato la qualità e la vastità biopolitiche
dello sfruttamento capitalistico, è necessario rintracciare, all’interno dell’opera
foucaultiana, la soggettività che sorge parallela, le caratteristiche della resistenza al
biopotere.
Negri porta così l’attenzione su quell’incognita che la teoria foucaultiana
indicherebbe e che fin dagli anni Settanta attira la sua attenzione 65. Trascurando lo
strutturalismo delle prime opere 66, egli lavora su quel «secondo Foucault» 67 che ha
appreso la lezione deleuziana dell’Anti-Edipo ed è perciò divenuto capace di
reinserire l’ontologia della produzione nel tessuto biopolitico, di concepire la
produzione della soggettività come libertà post-moderna 68. Il tentativo di Negri, in
altri termini, è quello di scoprire, nelle pieghe della teoria foucaultiana, la possibilità
64
Uno schema interpretativo che è mantenuto anche nelle ultime opere: cfr. Hardt, M., Negri, A.,
Multitude, cit., pp. 63-69; Id., (2017), Assembly , New York: Oxford University Press, pp. 227-245.
Fin dalla fine degli anni Settanta l’interesse di Negri per le pagine foucaultiane risiede nella
possibilità di leggervi la tematizzazione di «un’incognita , collocata al di là dell’orizzonte conoscitivo».
Nel saggio Il dominio e il sabotaggio l’autore dichiara il suo interesse verso l’analisi foucaultiana in
questi termini: «Dalla constatazione della destrutturazione come effetto non si può risalire al processo
di autovalorizzazione come causa. Questo è particolarmente evidente nell’analitica di Michel Foucault
che pure colpisce la mia attenzione per la tensione che rivela verso la produttività, la creatività di
un’incognita, collocata al di là dell’orizzonte conoscitivo», Negri, T., Il dominio e il sabotaggio, cit., p.
256. Si veda anche Negri, A., Il potere costituente, pp. 43-45.
66 Negri e Hardt dedicano diverse pagine del loro Impero al superamento dell’impianto teorico
foucaultiano. Quest’ultimo, affermano i due studiosi, è colpevolmente rimasto all’interno di
un’epistemologia strutturalista, la quale ha impedito la messa a fuoco di quell’«incognita , collocata al di
là dell’orizzonte conoscitivo». Il quadro epistemologico a cui il filosofo francese non è riuscito a
rinunciare avrebbe distolto lo sguardo di quest’ultimo dalla dimensione sempre eccedente e
irrappresentabile del bios, dalla produzione ontologica e autonormativa del sociale. Di conseguenza, la
teoria foucaultiana si sarebbe incagliata nelle ambivalenze del rapporto tra norma e vita, tra potere e
resistenza. Affermano così gli autori: «Se a questo punto potessimo chiedere a Foucault chi o che cosa
guida il sistema o, piuttosto, che cosa è ‘il bios’, la sua risposta sarebbe ineffabile o sarebbe il silenzio.
Ciò che in definitiva Foucault non è riuscito a cogliere sono le dinamiche reali della produzione nella
società biopolitica», Hardt, M., Negri, A., Impero, cit., p. 43.
67 Su questa fase del pensiero foucaultiano si veda almeno: Eiden, S. (2017), Foucault: The Birth of
Power, Cambridge: Polity Press e Id. (2016), Foucault's Last Decade, Cambridge: Polity Press.
68 Negri, A., Fabbrica di porcellana , cit., pp. 87-88.
65
�124
M A TTIA D I P IE RRO
di pensare l’eccedenza del vivente, l’affermazione della resistenza sul potere, di
rintracciare in Foucault la traduzione della differenza in resistenza 69. Questo
approccio permette al filosofo padovano di vedere come l’immanenza della norma
descritta da Foucault dischiuda la possibilità di pensare l’autonormatività del
vivente 70. Gli consente di scorgere il potere della vita che emerge dal potere sulla
vita 71.
Si tratta di pensare la biopolitica come un insieme di biopoteri? Oppure, nella
misura in cui dire che il potere ha investito la vita significa anche che la vita è un
potere, si può localizzare nella vita stessa – cioè nel lavoro e nel linguaggio, ma
anche nei corpi, negli affetti, nei desideri e nella sessualità – il luogo di una
produzione di soggettività che si dà come momento di disassoggettamento?
72
Dalle ambiguità della biopolitica foucaultiana, letta attraverso il filtro deleuziano,
si apre così la possibilità di una diversa prospettiva teorica: all’interno del circolo
ricorsivo di un potere che forma le soggettività è scovata una potenza creativa non
determinata da alcuna norma. Il meccanismo del potere biopolitico si divide così in
una prospettiva duplice: da una parte la dimensione oppressiva delle discipline,
dall’altra l’autonormatività eccedente e de-soggettivante del bios. È questa la base
della distinzione posta da Negri fra biopotere e biopolitica. Una dicotomia,
Cfr. Ivi, 83-98.
Sul rapporto tra norma e vita e sulle ambivalenze della biopolitica foucaultiana cfr. Bazzicalupo,
L., Biopolitica , cit., pp. 52-56 e 62-64.
71 Questa distinzione, mai esplicitamente articolata da Foucault, è alla base di molte letture postfoucaultiane. Si veda, ad esempio, Esposito, R. (2004), Bios. Biopolitica e filosofia , Torino: Einaudi, in
particolare pp. 79-114. Lo stesso autore ha proposto la particolare ricezione del paradigma biopolitico
in Italia, caratterizzato anche dalla sua ricerca dell’affermatività della vita, come elemento
caratterizzante di uno stile di pensiero che, per sottolineare la sua ricezione avvenuta soprattutto nei
campus americani, ha preso il nome di Italian Thought. Cfr. Esposito, R. (2010), Pensiero vivente.
Origine e attualità della filosofia italiana, Torino: Einaudi, in particolare pp. 218-224; Id. (2016), Da
fuori. Una filosofia per l’Europa , Torino: Einaudi; Gentili, D. (2012), Italian Theory: dall’operaismo
alla biopolitica , Bologna: Il Mulino; a cura di Gentili, D., Stimilli, E. (2015), Differenze italiane. Politica
e filosofia: mappe e sconfinamenti, Roma: DeriveApprodi; a cura di Lisciani-Petrini, E., Strummiello,
G. (2017), Effetto Italian Thought, Macerata: Quodlibet. Una rifelssione paradigmatica è sicuramente
quella di Giorgio Agamben. Per questo autore si veda, almeno: Agamben, G. (1998), Homo sacer. Il
potere sovrano e la nuda vita , Torino: Einaudi; Id. (2014), L’uso dei corpi, Homo sacer, IV, 2, Vicenza:
Neri Pozza. Per un panorama critico della ricezione del paradigma biopolitico da parte di alcuni dei
principali autori italiani contemporanei come Giorgio Agamben, Antonio Negri e Roberto Esposito,
cfr. Bazzicalupo, L., Biopolitica , cit., in particolare pp. 81-121; Lemke, Bio-politics, cit.; Marchesi, F.
(2016), Origine e struttura nel pensiero contemporaneo della «biopolitica», in «Officine filosofiche», n.
3, pp. 163-176; Vatter, M. (2017), Community and Subjectivity in Italian Biopolitics, in a cura di
Prozorov, S., Rentea, S., The Routledge Handbook of Biolitics, cit., pp. 123-139.
72 Negri, A., Fabbrica di porcellana , cit., p. 27.
69
70
�125
La biopolitica nel pensiero di Antonio Negri.
Dalla «tendenza» all’eccedenza affermativa della vita
quest’ultima, mai esplicitata da Foucault, sorta piuttosto da una lettura
profondamente influenzata dall’interpretazione deleuziana 73.
In questo modo Negri utilizza un Foucault letto attraverso Deleuze con e contro
l’opera dello stesso Deleuze, in una contaminazione duplice e ricorsiva tra differenza
e resistenza, biopolitica e affermazione della vita. Un procedimento per cui la
potenza e la creatività del desiderio, le linee di fuga deleuziane si inseriscono nel
paradigma biopolitico foucaultiano acquistando uno spessore politico e aprendo lo
spazio per la concezione di un potere affermativo della vita. La differenza e l’infinita
ripetizione divengono resistenza. Il risultato è un campo d’immanenza come terreno
biopolitico creativo 74 in cui l’intreccio dei biopoteri non esclude linee di fuga verso la
de-soggettivazione e l’affermazione di un’alternativa.
La prospettiva operaista rielaborata al livello dell’ontologia conduce Negri a
sciogliere la relazione potere-resistenza per rintracciare la produttività, l’affermatività
di una soggettivazione resistente in grado di oltrepassare, anticipare e combattere il
biopotere 75.
Può senza dubbio sembrare paradossale, ma il pensiero di Foucault è arrivato
all’idea seguente: è quando il potere si estende, si diffonde in tutti i rapporti
sociali – di qualunque natura esso sia –, quando di conseguenza si cancella la
vecchia struttura dicotomica dei rapporti di classe a favore di un’analitica dei
poteri ben più fine, allo stesso tempo meno visibile e infinitamente più efficace,
che anche l’antagonismo si estende al mondo sociale nella sua interezza e tocca
tutti i nodi della rete che costituisce…il passaggio è essenziale: non consiste nel
vedere della potenza dappertutto, ma nell’identificare l’antagonismo nello spazio
che prende posto tra la potenza e il potere, nelle maglie più fini del tessuto
sociale e nella totalità delle articolazioni del potere politico. Foucault riconduce
dunque la libido e il desiderio di Mille piani all’interno stesso dell’antagonismo
sociale e della lotta politica .
76
La costitutiva eccedenza autonormativa della vita, scovata in un Foucault
deleuziano-operaista, si rivela così il punto di partenza necessario per pensare una
forza affermativa che, negli ultimi lavori di Negri prende il nome di «moltitudine» 77.
Sul rapporto tra il pensiero di Foucault e quello di Deleuze e sulla possibilità di pensare un
«fuori», un’esteriorità ai meccanismi di soggettivazione cfr. Esposito, R. (2016), Da fuori, cit., in
particolare pp. 133-145.
74 Negri, A., Alle origini del biopolitico, cit., p. 87.
75 Cfr. Negri, A., Fabbrica di porcellana , cit., p. 33.
76 Ivi, p. 88.
77 Hardt, M., Negri, A., Moltitudine, cit. Sul concetto di moltitudine nel pensiero di Negri cfr.: Id.
(2003), Cinque lezioni di metodo su moltitudine e impero, Soveria Mannelli: Rubettino; Id., Fabbrica
di porcellana , cit., in particolare pp. 25-40; Millefusco W, Sersante M. (2016), Dall’operaio sociale alla
moltitudine, cit. Tale categoria ha avuto una certa diffusione nella teoria politica contemporanea. Si
veda, ad esempio: Virno, P. (2003), Grammatica della moltitudine: per una analisi delle forme di vita
73
�126
M A TTIA D I P IE RRO
Quello che appare interessante, in conclusione, non è né sottolineare, come già è
stato fatto 78, i tratti vitalistici della concezione negriana della biopolitica o gli aspetti
teleologici della tendenza, né segnalare le più o meno giustificate infedeltà al testo
foucaultiano presenti nell’opera di Negri. Ciò che è possibile trarre dal percorso
teorico qui considerato e dalla ricezione negriana della biopolitica, è piuttosto la
difficoltà, condivisa da parte della teoria politica contemporanea, di pensare il
politico oltre uno schema binario: costituente-costituito, negazione-affermazione,
potere sulla vita-potere della vita 79. Una difficoltà, questa, iscritta nell’interpretazione
negriana della teoria della tendenza, che si traduce in una caratterizzazione soltanto
e totalmente affermativa dell’emancipazione e dei soggetti rivoluzionari. Eppure, la
sfida più ardua proposta da Foucault si trova proprio nel pensare, oltre questa
dicotomia, l’inestricabile intreccio di soggetto e potere e la radicale immanenza delle
norme. Il rifiuto di seguire fino in fondo la coimplicazione, il chiasma che
l’ambiguità della posizione foucaultiana indica 80, invece, conduce inevitabilmente al
dualismo. Negri, così, pensa l’affermatività della vita, l’emancipazione futura della
moltitudine, non riuscendo a rinunciare del tutto a quello che il filosofo francese ha
chiamato il beneficio del locutore 81. Beneficio, quest’ultimo, che uno studioso deve
assolutamente cercare di evitare ma che non può non essere nella cassetta degli
attrezzi del militante come dell’uomo politico. È proprio dentro quest’ultima
ambiguità che va forse colto il senso dell’opera di Negri e della sua lettura
ostinatamente affermativa della biopolitica.
contemporanee, Roma: DeriveApprodi, Revel, J. (2004), Fare moltitudine, Soveria Mannelli: Rubettino.
Tale categoria ha una forte connotazione spinoziana e si lega direttamente agli studi negriani sul
filosofo olandese: Negri, A. Spinoza , cit.; Negri, A. (2007), Moltitudine e singolarità nello sviluppo del
pensiero politico di Spinoza , in Caporali, R., Morfino, V., Visentin, S., Spinoza: individuo e
moltitudine, Cesena: Il Ponte Vecchio, pp. 287-297.
78 Ad esempio, Bazzicalupo, L., Biopolitica , cit.
79 Intorno alla strutturazione negativa delle categorie politiche e ad una diversa modalità di pensare
politica, affermazione e negazione si veda: Esposito, R. (2018), Politica e negazione. Per una filosofia
affermativa , Torino: Einaudi. L’autore propone in questo studio una lettura delle opere di Spinoza e
Deleuze differente rispetto a Negri, volta a conservare la coimplicazione di affermazione e negazione.
80 Un interessante studio che affronta questa tematica del chiasma in Foucault è presentato in:
Revel, J. (2015), Foucault avec Merleau-Ponty. Ontologie politique, présentisme et histoire, Parigi: Vrin.
81 «Ma c’è forse una ragione che ci rende così gratificante formulare in termini di repressione i
rapporti fra sesso e potere, ed è quel che potremmo chiamare il ‘beneficio del locutore’. Se la sessualità
è repressa, cioè destinata alla proibizione, all’inesistenza ed al mutismo, il solo fatto di parlarne, e di
parlare della sua repressione, ha un tono di trasgressione deliberata. Colui che adopera questo
linguaggio si mette in una certa misura al di fuori del potere, attacca la legge; anticipa, foss’anche di
poco, la libertà futura», Foucault, M., La volontà di sapere, cit., p. 12.
�127
Etica & Politica / Ethics & Politics, XX, 2018, 1, pp. 127-143
ISSN 1825-5167
TALPA O SERPENTE?
POPOLO, CLASSE, MOLTITUDINE
E LI A Z A RU
Scuola Normale Superiore
Classe di Scienze Umane
elia.zaru@sns.it
ABSTRACT
This essay aims at clarifying the concept of «multitude» through a comparison between Negri’s
work and some of the critiques addressed to his thought. In the first part of the paper, I will
consider the relationship between multitude and the individual, in order to confute those who
think that the category of «multitude» is a liberal one. Then, I will analyze the connection between
the multitude and class-working class, so as to highlight that in Negri’s theory there is not an
opposition between those categories. Finally, the last paragraph will examine the forms of the
«multitudinarian class struggle» and the hiatus existing between will and potentiality of the
multitude related to the issue, still not resolved, of its organization. That is, the long-standing issue
of the relationship between theory and «practice» of the multitude.
KEYWORDS
Negri, multitude, class, working class, politics
Nel dibattito filosofico-politico contemporaneo la categoria di «moltitudine»
occupa, da almeno due decenni, un ruolo centrale. Tra gli autori che hanno
contribuito in modo decisivo alla sua diffusione globale c’è, senza dubbio, Antonio
Negri. Nel pensiero del filosofo padovano tale concetto prende forma a partire dagli
studi degli anni ’80 su Spinoza 1. Sebbene, proprio a seguito del suo apparire in un
contesto spinozista, la moltitudine sia stata vista come l’alternativa al popolo di
Oggi raccolti in Negri, A. (1998), Spinoza , Roma: DeriveApprodi. Sulla lettura negriana di Spinoza
cfr. Macherey, P. (2007), Negri’s Spinoza: From Mediation to Constitution, in Murphy, T.S., Mustapha,
A., The Philosophy of Antonio Negri, vol. II, Revolution in Theory , Londra: Pluto Press, pp. 7-27;
Read, J. (2007), The Potentia of Living Labor: Negri and the Practice of Philosophy , in Murphy, T.S.,
Mustapha, A., The Philosophy of Antonio Negri, cit., pp. 28-51; Goddard, M. (2011), From the
Multitudo to the Multitude: The Place of Spinoza in the Political Philosophy of Antonio Negri, in
Lamarche, P., Sherman, D., Rosenkrantz, M., Reading Negri. Marxism in the Age of Empire, Chicago:
Open Court, pp. 171-192; Caffentzis, G.C. (2011), How Savage Was Spinoza? Spinoza and the
Economic Life of Seventeenth-Century Holland, in Lamarche, P., Sherman, D., Rosenkrantz, M.,
Reading Negri, cit., pp. 193-210; Morfino, V. (2014), The Multitudo According to Negri: On the
Disarticulation of Ontology and History , in «Rethinking Marxism», 26, 2, pp. 227-238.
1
�128
E LIA Z A RU
matrice hobbesiana (dunque un concetto di teoria e di filosofia politica), è piuttosto
in relazione a specifiche categorie operaiste che deve essere letta (e dunque su uno
sfondo più direttamente sociale e politico). La «moltitudine» va compresa allora in
una riflessione che trova le sue radici nella concezione di «composizione di classe» 2,
in rapporto a due figure centrali del marxismo operaista e dei suoi sviluppi:
l’«operaio massa» e l’«operaio sociale» 3. Non è possibile sviluppare qui una analisi di
queste categorie e del loro rapporto 4. Per semplificare (a rischio di una
banalizzazione), si potrebbe però ricondurre ogni figura al suo campo d’azione.
Diremmo, allora, che l’operaio massa si muove nello spazio delimitato dalla fabbrica
fordista, l’operaio sociale nella metropoli degli anni ’70, e la moltitudine nel mondo
globale e globalizzato. Quest’ultima, infatti, viene definita «controimpero» 5, cioè
come contropotere nel contesto dell’«impero» 6. Non a caso, la categoria di
«moltitudine» si è imposta alla discussione proprio a seguito della pubblicazione di
Empire 7 e nel vasto dibattito seguito alla pubblicazione dell’opera essa si è trovata al
centro di diverse critiche (tanto da spingere Negri, e Hardt con lui, alla pubblicazione
di Multitude 8 – cui sono seguiti Commonwealth 9 e, di recente, Assembly) 10. La
Cfr. Meriggi, M.M. (1978), Composizione di classe e teoria del partito. Sul marxismo degli anni
’60, Bari: Edizioni Dedalo; Wright, S. (2002), Storming Heaven. Class Composition and Struggle in
Italian Autonomist Marxism , Londra: Pluto Press; trad. it. (2008), L’assalto al cielo. Per una storia
dell’operaismo, Roma: Edizioni Alegre; Pozzi, F., Roggero, G., Borio, G. (2005), Gli operaisti, Roma:
DeriveApprodi; Trotta, G., Milana, F. (2008) (a cura di), L’operaismo degli anni Sessanta. Da
«Quaderni Rossi» a «Classe operaia», Roma: DeriveApprodi; Maltese, P. (2014), La classe come
metodo. Appunti per una rilettura composizionista , in «Metodo. International Studies in
Phenomenology and Philosophy», 2, 1, pp. 255-268.
Cfr. Negri, A. (2017), Postoperaismo? No, operaismo, intervento a Cambridge, 25 aprile,
http://www.euronomade.info/?p=9189; Negri, A. (1979), Dall’operaio massa all’operaio sociale.
Intervista sull’operaismo, Milano: Multhipla edizioni (ripubblicato nel 2007 dall’editore Ombre Corte
di Verona);
Cfr. Montefusco W., Sersante M. (2016), Dall’operaio sociale alla moltitudine, Roma:
DeriveApprodi.
Cfr. Hardt, M., Negri, A. (2000), Empire, Cambridge: Harvard University Press, pp. 205-218, 393413; trad. it. (2002), Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione, Milano: Rizzoli, pp. 197-208, 364380.
Per una chiarificazione sul concetto di «impero» e sul dibattito generato dalla pubblicazione di
Empire si veda Zaru, E. (2016), «Impero» e «imperialismo». Michael Hardt e Antonio Negri nel
dibattito internazionale (2000-2015), in «Scienza&Politica», 28, 54, pp. 147-161.
Hardt, M., Negri, A. (2000), Empire, cit.; trad. it. (2002), Impero, cit. Se da un lato Empire ha
contribuito alla rinascita di interesse nei confronti dell’operaismo, dall’altro ha alimentato, suo
malgrado, la diffusione dell’«equazione, da parte dei lettori anglofoni, tra operaismo e Autonomia da
una parte, e Negri e i suoi stretti collaboratori dall’altra» (Wright, S. (2002), Storming Heaven, cit., p. 2;
trad. it. L’assalto al cielo, cit., p. 17), equazione che nasconde le differenze che hanno segnato
l’operaismo nel corso di tutto il suo sviluppo.
Hardt, M., Negri, A. (2004), Multitude. War and Democracy in the Age of Empire, New York:
Penguin Books; trad. it. (2004) Moltitudine, Milano: Rizzoli. Negri ricorda che «Multitude non era in
programma. […] Poi è seguito il dibattito, al cui interno il concetto di ‘moltitudine’ era ed è per noi
molto caro. Quindi è ricominciato il lavoro, ma parecchio tempo dopo; prima mi sono fatto ancora
2
3
4
5
6
7
8
�129
Talpa o serpente? Popolo, classe, moltitudine
«moltitudine» rappresenta, in questo quadro, «l’insieme degli sfruttati e dei
sottomessi» 11 nel contesto «imperiale». Dunque, in senso marxiano, nel pensiero di
Negri assume il ruolo di possibile agente della rivoluzione.
Eppure, da più parti dentro il marxismo si sono levate critiche aspre, spesso frutto
di interpretazioni fuorvianti, segnate da polemiche che eccedono la natura teorica
del concetto e ne riducono lo spessore filosofico a scapito di una lettura più
immediatamente politicista e d’occasione. Questo intervento si propone di chiarire il
concetto di «moltitudine» tramite un confronto tra il lavoro di Negri e alcune di
queste posizioni critiche, emblematiche della mancata comprensione di questa
categoria. L’obiettivo, dunque, è quello di scavare a fondo nella moltitudine negriana.
Per arrivare a questo risultato, è necessario chiarire cosa la moltitudine non è. Verrà
quindi considerato il rapporto tra moltitudine e individuo, al fine di confutare quelle
posizioni che identificano la «moltitudine» come una categoria situata nel solco della
tradizione dell’individualismo liberale. Quindi, verrà analizzato il legame tra
«moltitudine» e «classe», e tra la prima e la «classe operaia». Diversi interpreti, infatti,
pensano una opposizione tra queste coppie concettuali, e considerano la categoria di
«moltitudine» inutile e dannosa da un punto di vista tanto analitico quanto praticopolitico. In realtà, questa opposizione non esiste nel pensiero di Negri e la
moltitudine non costituisce una liquidazione della classe, tantomeno della classe
operaia. Una volta chiarita la natura della moltitudine, cosa essa è, l’ultima parte
verrà infine dedicata a una analisi delle forme che assume la «lotta di classe
moltitudinaria» e allo iato che esiste tra volontà e potenzialità della «moltitudine» in
relazione al problema, ancora non risolto, della sua organizzazione. Ovvero, l’annosa
questione del rapporto tra teoria e «prassi» politica della moltitudine.
1. WE, THE MULTITUDE
Senza pretese di esaustività nei confronti di un dibattito di tale ampiezza, è utile
fare alcuni esempi emblematici e rappresentativi di un modo di intendere la
moltitudine «da sinistra» come una categoria di stampo individualista. Secondo
Samir Amin, il concetto di moltitudine non è altro che una riaffermazione
dell’individuo come soggetto ultimo della storia 12. Si tratta, in sintesi, di una categoria
alcuni anni di carcere. Comunque no, non c’era un progetto» (Zaru, E. (2016) (a cura di), Quindici anni
Empire. Intervista ad Antonio Negri, in «Filosofia italiana», 1, p. 8,
http://www.filosofiaitaliana.net/wp-content/uploads/2017/11/Zaru_Negri.pdf).
Hardt, M., Negri, A. (2009), Commonwealth, Cambridge: Harvard University Press; trad. it. 2010,
Comune. Oltre il privato e il pubblico, Milano: Rizzoli.
Hardt, M., Negri, A. (2017), Assembly , Oxford: Oxford University Press.
Hardt, M., Negri, A. (2000), Empire, cit., p. 393; trad. it. Impero, cit., p. 364. Negri, A. (2002),
Intervento al Social Forum Europeo di Parigi, http://www.generation-online.org/t/negriESF.htm.
Amin, S. (2005), Empire and Multitude, in «Monthly Review», 57, 6, p.3; trad. mia.
dopo
9
10
11
12
�130
E LIA Z A RU
incapace di ereditare il compito della rivoluzione proletaria. In questo senso, sostiene
Amin, l’idea di moltitudine costituisce un ostacolo a un’analisi «di classe» del
capitalismo contemporaneo: «secondo Hardt e Negri siamo giunti a un punto di
svolta storico […] in cui le classi (così come le nazioni o i popoli) non sono più i
soggetti della storia. Al loro posto, ci sono gli individui» 13, che reclamano diritti
«formali» e non, come nella logica della lotta tra classi, una rottura sistemica tra
dominanti e dominati 14. Per questo motivo, Amin contrappone alla categoria di
moltitudine l’idea di una «proletarizzazione generalizzata» 15. È vero, sostiene Amin,
che il capitalismo contemporaneo ha operato un disfacimento della categoria di
classe, ma l’individualizzazione che ne è seguita non porta con sé le possibilità di
emancipazione progressiva che Negri considera incluse nella categoria di
moltitudine, ma quelle regressive proprie di assembramenti umani in cui manca
coscienza di classe (plebi, masse). Lungi dall’esprimere una potenza rivoluzionaria, la
moltitudine contemporanea si configura, per Amin, come il risultato di tre elementi
tra loro combinati: «lo status di proletario imposto a chiunque, l’estrema
segmentazione di questo proletariato generalizzato […] e l’estrema centralizzazione
del controllo del capitale» 16.
Néstor Kohan e Pietro Di Nardo avanzano una critica analoga. Secondo il primo,
«il concetto di ‘moltitudine’ viene a sostituire la nozione di lotta di classe» 17, tanto che
«in Impero si tende ad usare l’espressione ‘desiderio della moltitudine’ in antitesi alla
nozione di lotta di classe di ispirazione marxista» 18. Di Nardo sostiene che «per Negri
il militante diventa un individualista che fronteggia il sistema capitalista in modo
‘creativo’, e che concepisce la sua forza rivoluzionaria a partire dalla propria unicità e
capacità personale» 19. Al contrario, afferma Di Nardo, il militante genuinamente
marxista è in grado di mettere la propria individualità al servizio degli interessi
rivoluzionari della classe operaia: il punto di partenza, in questo caso, non è «l’unicità
13
Ibidem , trad. mia.
Secondo Amin, «le ‘aspirazioni’ della moltitudine su cui dovrebbe poggiare la forza costitutiva del
futuro si riducono a molto poco: la libertà, in particolare di migrare, e il diritto a un reddito sociale
garantito. Nell’indubbia attenzione a non avventurarsi al di fuori di ciò che viene permesso dal
liberalismo americano, il progetto ignora deliberatamente tutto ciò che potrebbe essere qualificato
come eredità del movimento operaio e socialista, in particolare l’uguaglianza rifiutata dalla cultura
politica degli Stati Uniti. È difficile credere nella forza trasformatrice di una cittadinanza globale (ed
europea) emergente, mentre le politiche che vengono attuate privano sostanzialmente la cittadinanza
della sua efficacia» (Ivi, pp. 4-5). La questione relativa alle rivendicazioni della moltitudine verrà
affrontata nel dettaglio più avanti.
15 Amin, S. (2014), Contra Hardt and Negri: Multitude or Generalized Proletarianization?, in «Monthly Review»,
66, 6, pp. 1-12.
Ivi, p. 4.
Kohan, N. (2002), Toni Negri y los equívocos de Imperio, Buenos Aires; trad. it. (2005), Toni
Negri e gli equivoci di Impero, Bolsena: Massari Editore, p. 111.
Ivi, p. 121.
Di Nardo, P. (2003), The Empire does not exist: a critique of Toni Negri’s ideas, in «In Defence of
Marxism», trad. mia.
14
16
17
18
19
�131
Talpa o serpente? Popolo, classe, moltitudine
e capacità personale» del militante in quanto individuo, ma in quanto appartenente a
una classe sociale 20.
In realtà, l’eterogeneità interna della moltitudine non è diretta contro
l’omogeneità della classe 21, ma del popolo. Se si vuole parlare di un «ritorno
dell’individualità», è bene osservare che in Negri la contrapposizione non è tra
individuo e classe ma, semmai, tra individuo e popolo. La moltitudine in quanto
coalescenza di singolarità (torneremo a breve su questo termine) e pluralità non
intende reintrodurre l’individuo al posto della classe, ma contrapporsi alla reductio
ad unum propria della creazione di un popolo:
Innanzi tutto, è importante sottolineare che la nozione di popolo è molto
diversa da quella di moltitudine. Nel XVII secolo, Hobbes era già perfettamente
consapevole di questa differenza e del suo rilievo nella costruzione dell’ordine
sovrano. […] La moltitudine è una molteplicità, un piano di singolarità, un
insieme aperto, né omogeneo né identico a se stesso, che genera una relazione
indeterminata e inclusiva con coloro che stanno al di fuori. Il popolo tende
invece all’identità e all’omogeneità interna e fissa la sua differenza per escludere
ciò che rimane al di fuori. Mentre la moltitudine è una relazione costitutiva
inconclusa, il popolo è una sintesi costituita adeguata alla sovranità. Il popolo
fornisce un’azione e una volontà uniche indipendenti in conflitto con le volontà
e le azioni della moltitudine. Ogni nazione deve fare di una moltitudine un
popolo .
22
In modo analogo, in Moltitudine si afferma che
Per comprendere il concetto di moltitudine nella sua accezione concettuale più
astratta e generale occorre in primo luogo contrapporla all’idea di popolo. Il
popolo è uno: mentre la popolazione è costituita da individui differenti e da
diverse classi, il popolo sintetizza o riduce le differenze sociali a un’unica
identità. La moltitudine, al contrario, non può essere unificata, resta plurale e
molteplice. Questa è la ragione per cui, secondo l’indirizzo predominante del
pensiero politico, è il popolo – e non la moltitudine – a esercitare la sovranità. La
moltitudine è composta da un complesso di singolarità, ove per singolarità
intendiamo soggetti sociali le cui differenze non possono essere ridotte ad alcuna
identità: differenze che restano differenti. Le componenti del popolo sono di per
sé indifferenti nei riguardi della loro unità: confluiscono in un’unità negando o
Afferma Di Nardo, in riferimento al militante marxista: «questo tipo di attivisti non agisce mai
sulla base della propria individualità, ma sa connetterla con le individualità di altri attivisti e metterla
al servizio della rivoluzione. Il militante politico non è per niente una sorta di tetro guastafeste, ma è la
forza motrice di una intera classe, il proletariato» (ivi).
Il rapporto tra moltitudine e classe verrà analizzato nel prossimo paragrafo.
Hardt, M., Negri, A. (2000), Empire, cit., pp. 102-103; trad. it. (2002), Impero, cit., pp. 106-107.
20
21
22
�132
E LIA Z A RU
mettendo da parte le loro differenze. Le singolarità plurali della moltitudine si
contrappongono punto per punto all’unità indifferenziata del popolo .
23
Se si osserva la contrapposizione tra moltitudine e altri aggregati umani (folla,
masse e plebe) si comprende ulteriormente perché tacciare la moltitudine negriana
di individualismo è errato:
I componenti delle masse, della plebe e della folla non sono singolarità, e ciò
emerge chiaramente osservando come le loro differenze interne vengano
facilmente assorbite dall’indifferenza dell’intero. Inoltre, questi soggetti sociali
sono fondamentalmente passivi – non possono cioè mai agire autonomamente –
e dunque devono essere guidati in qualche modo. La folla, la plebe e la massa
possono produrre effetti sociali – spesso orribilmente distruttivi – ma non
possono agire accordandosi di loro iniziativa, e questa è la ragione per la quale
sono così facilmente manipolabili dall’esterno. Il termine moltitudine, al
contrario, designa un soggetto sociale attivo che agisce sulla base di ciò che le
singolarità hanno in comune. La moltitudine è intrinsecamente differente, un
soggetto sociale molteplice, la cui costituzione e le cui azioni non sono deducibili
da alcuna unità o identità (più o meno indifferente), ma da quello che i soggetti
che la compongono hanno in comune .
24
Il termine chiave per comprendere l’eterogeneità della moltitudine è «singolarità»,
non «individualità» 25. Il fatto che le differenze delle singolarità permangano nella
moltitudine non implica la scomparsa della dimensione collettiva, né un
Hardt, M., Negri, A. (2004), Multitude, cit., p. 99; trad. it. (2004) Moltitudine, cit., p.123. Sulla
contrapposizione tra moltitudine e popolo si veda anche Virno, P. (1996), Virtuosity and Revolution:
The Political Theory of Exodus, in Virno, P., Hardt, M. (a cura di), Radical Thought in Italy ,
Minneapolis: University of Minnesota Press, pp. 189-210, particolarmente le pp. 199-203; Virno, P.
(2002), Grammatica della moltitudine. Per una analisi delle forme di vita contemporanee, Roma:
DeriveApprodi, particolarmente la Premessa , pp. 9-35; Bascetta, M. (2002), Moltitudine, popolo, massa ,
in AA.VV., Controimpero: per un lessico dei movimenti globali (a cura di Nicola Montagna), Roma:
Manifestolibri, pp. 67-80.
Hardt, M., Negri, A. (2004), Multitude, cit., p. 100; trad. it. pp. 123-124. Sulla differenza tra massa
e moltitudine in Spinoza si veda Del Lucchese, F. (2004), Tumulti e indignatio. Conflitto, diritto e
moltitudine in Machiavelli e Spinoza , Milano: Edizioni Ghibli: «La sua [della massa] debolezza e i vizi
che la caratterizzano non dipendono dal molteplice in quanto tale, ma dall’individuale che pretende di
farsi universale, cioè dal prevalere degli elementi disgiuntivi – che isolano l’individuo producendo una
molteplicità seriale – su quelli connettivi, che fanno invece della moltitudine il luogo della relazione e
dello scambio – anche conflittuale – tra individui che interagiscono. Proprio in quanto ognuno crede di
poter fare e sapere da solo ogni cosa la massa diventa mutevole e fluttuante come le onde del mare. È
un fenomeno inverso – ma analogo – al timore della solitudine. Se è vero, infatti, che la paura è
principalmente legata alla dimensione della solitudine, i suoi effetti perversi si saldano con l’estremo
opposto, cioè con la solitudine individuale che pretende di affermarsi in modo universale» (p. 344).
Cfr. Negri, A. (2007), Moltitudine e singolarità nello sviluppo del pensiero politico di Spinoza, in
Caporali, R., Morfino, V., Visentin, S., Spinoza: individuo e moltitudine, Cesena: Il Ponte Vecchio, pp.
287-297, in particolare le pp. 288-289; Hardt, M., Negri, A. (2009), Commonwealth, cit., pp. 338-339;
trad. it. 2010, Comune, cit., pp. 336-337).
23
24
25
�133
Talpa o serpente? Popolo, classe, moltitudine
ripiegamento sull’individuo liberale, come invece sostengono le critiche presentate in
precedenza. La moltitudine, secondo Negri, identifica una coalescenza di singolarità
e collettività. Questo concetto viene ribadito dal filosofo padovano in più di
un’occasione: «il termine moltitudine (e quello che contiene) rappresenta una
posizione di radicale anti-individualismo politico. Impero implica il rifiuto della
tradizione possessiva» 26 poiché la moltitudine è «’un insieme di singolarità’ […]
differenti, mai identificate nell’insieme, e neppure mai sostanzializzate come
individui separati. La singolarità è fatta dall’insieme e fa l’insieme» 27. Non solo,
dunque, la dimensione collettiva non sparisce, ma essa viene a costituire il
fondamento della moltitudine come comune:
Che cosa significa costruzione del comune? Significa due cose. In primo luogo,
presa di coscienza delle condizioni comuni del lavoro, cioè della costruzione del
valore, della ricchezza, così come oggi si danno. Sono la cooperazione dei
soggetti produttivi e l’innovazione delle singolarità a costituire la rete efficace dei
processi produttivi. […] Ma non basta definire la presa di coscienza della
condizione comune del lavoro sfruttato per permettere una cosciente costruzione
del comune per la moltitudine e per il nuovo proletariato. Questa comune
coscienza emergerà e si porrà come tendenza solo quando sarà atta alla
costruzione di obiettivi comuni della lotta, da parte della moltitudine. Innanzi
tutto contro le forme di organizzazione, del tutto omologhe, della proprietà
privata e di quella pubblica nella generalizzazione dei processi di sfruttamento.
Al privato e al pubblico si oppone il comune, si oppone la rivendicazione del
comune .
28
Le critiche circa l’individualismo insito nella categoria di «moltitudine» non
tengono conto di questo costituirsi «nel comune» della moltitudine. Per chiarire
meglio il significato di tale espressione, è utile un rimando – seppur sintetico –
all’origine spinoziana del termine multitudo 29 e al suo legame con il concetto di
«transindividuale» 30. In questo senso, sull’opposizione tra Hobbes e Spinoza (tra
popolo e moltitudine) si inserisce la dicotomia Descartes/Spinoza, ovvero la
contrapposizione tra intersoggettività e transindividualità. Laddove la prima si pone
il problema della relazione tra soggetti dati (individui), la seconda pensa la
costruzione della soggettività a partire dalla relazione. La differenza fondamentale
26
Negri, A. (2003), Guide. Cinque lezioni su impero e dintorni, Milano: Raffaello Cortina Editore, p.
31.
Ivi, p. 125.
Negri, A. (2006), Movimenti nell’Impero. Passaggi e paesaggi, Milano: Raffaello Cortina Editore,
p. 60. Cfr. Hardt, M., Negri, A. (2009), Commonwealth, cit.
Cfr. Negri, A. (1998), Spinoza , cit., in particolare i capp. 6-7-8 de L’anomalia selvaggia , pp. 167-264.
Cfr. Balibar, E. (1985), Spinoza et la politique, Paris: P.U.F.; trad. it. (1996), Spinoza e la politica,
Roma: Manifestolibri; Balibar, E. (2002), Spinoza. Il transindividuale, Milano: Ghibli; Balibar, E.,
Morfino, V. (a cura di) (2014), Il transindividuale. Soggetti, relazioni, mutazioni, Milano: Mimesis.
27
28
29
30
�134
E LIA Z A RU
risiede nel punto di partenza: l’individuo nel primo caso, la relazione nel secondo.
Pensiamo a un disegno in cui una serie di punti sono collegati da linee.
L’intersoggettività assume i punti come elementi dati, introflessi, e a partire da essi si
pone il problema della congiunzione; in questo senso, prima vengono i punti, poi le
linee che (eventualmente) li collegano. Al contrario, la transindividualità pensa
insieme punti e linee, e considera le linee di relazione come parte integrante della
costruzione di questi stessi punti che, altrimenti, non sarebbero tali. «Spinoza
afferma che il pensiero non è l’attributo essenziale di una sostanza individuale (il
cogito), ma un reticolo di passioni e idee che attraversa e costituisce gli individui
come grumi temporanei» 31. Multitudo è il termine che Spinoza utilizza per definire
questa trama complessa di relazioni, e con questo concetto egli esprime la sua
«ontologia della relazione» 32 pregna di un anti-individualismo che si oppone tanto a
Hobbes e Descartes quanto a Locke 33.
Proprio gli studi di Negri su Spinoza contribuiscono in modo importante a
definire questo carattere anti-individualistico della moltitudine:
La natura […] è un’entità collettiva, un processo che vede l’individualità umana
costituirsi essa stessa come entità collettiva. […] La determinazione materialistica
del processo costitutivo viene infatti caratterizzata da questa ulteriore modalità:
il collettivo, la moltitudine. Dal punto di vista storico, la rottura con il rigido
individualismo delle concezioni generalmente diffuse nel pensiero seicentesco, e
in particolare con quella hobbesiana, diviene totale. Dal punto di vista
sistematico, la determinazione spinoziana del collettivo ha effetti poderosi: essa
infatti permette alla concezione della potenza di svilupparsi in maniera integrale.
Supponiamo che lo sviluppo della vita passionale e sociale non sia
immediatamente articolato allo sviluppo del collettivo: ne deriverebbe una
configurazione etica e sociale nella quale, all’efficacia costitutiva della potenza, si
opporrebbe validamente, come unica possibilità determinata, l’unificazione
logica o politica, comunque trascendentale, del processo delle individualità. Ma
questo è contro le premesse spinoziane: il processo costitutivo non è
immaginabile fuori dall’ipotesi di una sua interna qualificazione collettiva .
34
Si tratta di «considerare queste singolarità come un punto di arrivo, non come un
dato da cui partire; come l’esito ultimo di un processo di individuazione, non come
atomi solipsistici» 35. Tacciare di individualismo la categoria di «moltitudine» significa
non riconoscerne la complessità e ignorare il fatto che una tale proposta teoricoBalibar, E., Morfino, V. (a cura di) (2014), Il transindividuale, cit., p. 19.
Cfr. Morfino, V. (2014), Immaginazione e ontologia della relazione: note per una ricerca , in «Etica
& Politica», XVI, 1, pp. 142-161.
Cfr. Balibar, É. (1998) (ed.), John Locke Identité et différence. L’invention de la conscience, Parigi:
Seuil; Del Lucchese, F. (2004), Tumulti e indignatio, cit., p. 345.
Negri, A. (1981), L’anomalia selvaggia. Saggio su potere e potenza in Baruch Spinoza , Milano:
Feltrinelli, in Negri, A. (1998), Spinoza , cit., p. 181.
Virno, P. (2002), Grammatica della moltitudine, cit., p. 68.
31
32
33
34
35
�135
Talpa o serpente? Popolo, classe, moltitudine
politica intende precisamente scardinare dal binomio singolare/collettivo quei tratti
oppositivi tramandati nella modernità 36: «il nostro problema» – afferma Negri – «non
è mettere insieme individui isolati, ma piuttosto quello di costruire in maniera
cooperativa forme e strumenti di comunanza e di condurre al riconoscimento
(ontologico) del comune» 37.
2. TALPA O SERPENTE? MOLTITUDINE È CLASSE
Nel 18 Brumaio Marx identifica il proletariato con la figura della talpa che scava i
suoi cunicoli nel solco della storia fino a emergere nel momento della rivoluzione. La
crisi della modernità rappresentata dalla costruzione «dell’impero» segna, per Negri,
la morte della talpa marxiana 38. Al suo posto, compare la figura del «serpente» 39, i cui
movimenti ondulatori incarnano meglio la dinamica delle lotte perpetuate dalla
moltitudine. Questa metamorfosi viene giustificata a partire dal fatto che «il soggetto
del lavoro e della rivolta è profondamente mutato. La composizione del proletariato
si è trasformata» 40. «Con proletariato», proseguono gli autori di Empire, «intendiamo
un’ampia categoria che comprende tutti coloro il cui lavoro è direttamente o
indirettamente sfruttato […]. In un’epoca precedente, la categoria di proletario era
identificata e, in una certa fase, realmente sussunta dalla classe operaia industriale» 41.
Ora la classe operaia è stata «detronizzata dalla sua posizione privilegiata
nell’economia capitalistica e dalla sua posizione egemonica nella composizione di
classe del proletariato» 42. C’è un nuovo proletariato, afferma Negri, che corrisponde
alla figura del serpente e prende il nome di moltitudine 43.
Questa «detronizzazione» ha suscitato critiche molto accese 44. Per Olsson sostiene
che individuare nella moltitudine e non nella classe operaia la forza di opposizione al
Cfr. Revel, J. (2004), Fare moltitudine, Soveria Mannelli: Rubbettino, in particolare le pp. 5-8.
Negri, A. (2003), Guide, cit., p. 31. Cfr. Negri, A. (2008), Fabbriche di porcellana. Per una nuova
grammatica politica, Milano: Feltrinelli, p. 40: «La moltitudine deve dunque essere necessariamente
pensata come una molteplicità non organica, differenziale e potente».
Hardt, M., Negri, A. (2000), Empire, cit., p. 57; trad. it. Impero, cit., p. 68.
Il salto dalla talpa al serpente va di pari passo con quello dalla società disciplinare alla società del
controllo. Su questo, Negri e Hardt seguono Deleuze e il suo Poscritto sulle società di controllo
(Deleuze, G. (1990), Pourparlers 1972-1990, Parigi: Minuit; trad. it. Pourparler, Macerata: Quodlibet,
pp. 234-241).
Hardt, M., Negri, A. (2000), Empire, cit., pp. 52-53; trad. it. Impero, cit., p. 64.
Ibidem .
Ibidem .
«La moltitudine fa sì che il concetto di proletariato guadagni la sua definizione più piena,
comprendendo tutti coloro che lavorano e producono sotto il comando del capitale», in Hardt, M.,
Negri, A. (2004), Multitude, cit., p. 107; trad. it. Moltitudine, cit., p. 131.
Negri e Hardt rispondono a parte di queste critiche in Multitude, cit., pp. 223-227; trad. it. pp. 258263.
36
37
38
39
40
41
42
43
44
�136
E LIA Z A RU
capitale significa «alienare i lavoratori dal movimento anti-capitalista» 45. Olsson
afferma l’inutilità della nuova categorizzazione poiché il concetto di classe operaia si
estende già di per sé oltre le mura della fabbrica fordista: «i socialisti si sono sempre
detti contrari a una definizione della classe operaia limitata ai lavoratori industriali.
Si tratta di uno stereotipo, una definizione rigida che ha poco a che fare con il
marxismo». Per questa ragione, pensare la moltitudine oltre la classe operaia
significa, secondo Olsson, tacere «la forza di azione collettiva» della classe operaia:
«la […] definizione di tutti gli oppressi come parte della ‘moltitudine’ rappresenta, nel
migliore dei casi, solo un altro modo di ridurre la classe operaia a un ruolo ausiliario
nelle lotte future» 46. In modo analogo, secondo Pietro Di Nardo questo cambio di
prospettiva – dalla classe operaia alla moltitudine – origina dalla trasformazione di
«un livello secondario del sistema capitalista, ovvero il piano della riproduzione e del
consumo, in un livello di importanza primaria» 47. Se invece, come vuole Di Nardo, si
ristabiliscono le «gerarchie» tra i piani del capitale si può vedere che «la talpa di
Marx» è viva, vegeta e sfruttata, tanto che «il proletariato industriale sta aumentando
in tutto il mondo» 48.
Secondo Alex Callinicos il limite più grande del concetto di «moltitudine» – e più
in generale del pensiero di Negri – risiede nel mancato riconoscimento del fatto che
«solo la mobilitazione di massa della classe operaia organizzata può contrastare il
potere dello Stato capitalista» 49. Per questa ragione, afferma Callinicos, è errato
toglierle la centralità che merita: «in analisi come quelle di Hardt e Negri la classe
operaia […] viene o dissolta nella moltitudine amorfa, oppure stigmatizzata come
aristocrazia lavorativa privilegiata» 50. Callinicos pensa una opposizione netta tra
moltitudine e classe operaia, e ritiene che considerare la moltitudine come agente del
processo rivoluzionario sia stata la causa principale del fallimento del movimento
altermondialista che tra la fine del XX e l’inizio del XXI secolo contestava la gestione
neoliberista della globalizzazione 51. In particolare, le azioni delle «Tute Bianche» 52
durante le mobilitazioni contro il G8 di Genova nel 2001 hanno rivelato, secondo
Callinicos, i limiti della teoria negriana (e, in generale, del marxismo autonomo),
45
Olsson, P. (2002), Not the Communist Manifesto, in «Socialism Today», 62, trad. mia.
46
Ibidem .
Di Nardo, P. (2003), The Empire does not exist, cit., trad. mia.
Ibidem .
Callinicos, A. (2003), Toni Negri in Perspective, in Balakrishnan, G. (a cura di), Debating Empire,
Londra, New York: Verso, p. 140, trad. mia.
Ivi, p. 139, trad. mia.
Ivi, pp. 139-140, trad. mia.
Il termine «Tute Bianche» viene utilizzato da Callinicos per indicare in modo generico le azioni
contro il summit del G8 a Genova nel luglio del 2001 da parte della rete dei «Disobbedienti». Cfr. della
Porta, D., Andreatta, M., Mosca, L., Reiter, H. (2006), Globalization from Below. Transnational
Activists and Protest Networks, Minneapolis-Londra: University of Minnesota Press; Fumagalli, A.,
Lazzarato, M. (1999) (a cura di), Tute bianche: disoccupazione di massa e reddito di cittadinanza ,
Roma: DeriveApprodi.
47
48
49
50
51
52
�137
Talpa o serpente? Popolo, classe, moltitudine
tanto che «l’influenza delle sue idee costituisce un ostacolo allo sviluppo di un
movimento vittorioso contro il capitalismo globale» 53.
In realtà, affermare – come fa Negri – che la moltitudine non è solo classe operaia
non significa sostenere che essa sia contro quest’ultima. Esiste una distinzione 54, ma
non c’è una nessuna opposizione tra i due termini. Il «nuovo proletariato» non è «una
nuova classe operaia industriale» poiché «‘proletariato’ è il concetto che comprende
tutti coloro il cui lavoro è sfruttato dal capitale, l’intera moltitudine cooperante»,
laddove «la classe operaia industriale rappresentava un momento soltanto parziale
nella storia del proletariato e delle sue rivoluzioni, e cioè nel periodo in cui il capitale
era ancora in grado di ridurre il valore alla misura» 55. Il ragionamento rimanda allora
al dibattito circa le mutazioni del modo di produzione capitalistico. A prescindere
dalle questioni che riguardano l’esistenza o meno di una crisi della legge marxiana
del valore 56 e il paradigma del capitalismo «cognitivo» 57 (nonché eventuali limiti di
Callinicos, A. (2003), Toni Negri in Perspective, cit., pag. 140, trad. mia.
«Occorre infine distinguere la moltitudine anche dalla classe operaia. Il concetto di classe operaia
è finito per diventare una nozione esclusiva a cui è affidato il compito non solo di distinguere i
lavoratori dai padroni […], ma anche di separare la classe operaia da altri lavoratori. Nel suo significato
più ristretto, questo concetto viene impiegato per indicare i lavoratori dell’industria separandoli dai
lavoratori dell’agricoltura, dei servizi e di tutti gli altri settori; nella sua accezione più ampia, la classe
operaia indica invece tutti i lavoratori salariati separandoli però dai poveri, da chi lavora in casa senza
essere pagato e da tutti coloro che non ricevono un salario. La moltitudine, al contrario, è un concetto
aperto e inclusivo, pienamente in sintonia con i più recenti e rilevanti mutamenti dell’economia
globale: da un lato, la classe operaia industriale, malgrado la sua dimensione non sia numericamente
ridotta a livello mondiale, non svolge più un ruolo egemonico nel quadro dell’economia globale;
dall’altro, al giorno d’oggi, la produzione non può più essere concepita in termini meramente
economici, ma più ampiamente, come produzione sociale – non solo, dunque, di beni materiali, ma
anche di comunicazione, relazioni e stili di vita. La moltitudine è potenzialmente composta da tutte le
differenti figure della produzione sociale» (Hardt, M., Negri, A. (2004), Multitude, cit., pp. xiv-xv; trad.
it. Moltitudine, cit., pp. 12-13.
Hardt, M., Negri, A. (2000), Empire, cit., p. 402; trad. it. Impero, cit., p. 372.
Cfr. Negri, A. (1979), Marx oltre Marx, Milano: Feltrinelli; Negri, A. (1992), Valeur-travail: crise et
problèmes de reconstruction dans le postmoderne, in «Futur Antérieur», 10; Vercellone, C. (2009),
53
54
55
56
Crisi della legge del valore e divenire rendita del profitto. Appunti sulla crisi sistemica del capitalismo
cognitivo, in Fumagalli, A., Mezzadra, S., Crisi dell’economia globale, Verona: Ombre Corte, pp. 71-99;
Vercellone, C. (2012), La legge del valore nel passaggio dal capitalismo industriale al nuovo
capitalismo, in «UniNomade», http://www.uninomade.org/vercellone-legge-valore; Pasquinelli, M.
(2012), Il numero della bestia collettiva. Sulla sostanza del valore nell’era della crisi del debito, in
«UniNomade»,
http://www.uninomade.org/numero-della-bestia-collettiva/;
Gorz,
A. (2003),
L’immatériel. Connaissance, valeur et capital, Parigi: Èditions Galilée, trad. it. (2003), L’immateriale.
Conoscenza, valore e capitale, Torino: Bollati Boringhieri.
Cfr. Corsani, A., Dieuaide, P., Lazzarato, M., Monnier, J.M., Moulier-Boutang, Y., Paulré, B.,
Vercellone, C. (2002), Le capitalism cognitif comme sortie de la crise du capitalisme industriel; Un
programme
de
recherche,
CNRS
–
Université
Paris
1,
http://vadeker.net/humanite/prospective/capitalisme_cognitif/le_capitalisme_cognitif_comme_sortie_d
e_la_crise_du_capitalisme_industriel.pdf; Moulier-Boutang, Y. (2002) (a cura di), L’età del capitalismo
cognitivo. Innovazione, proprietà e cooperazione delle moltitudini, Verona: Ombre Corte; Cfr.
Vercellone, C. (2006) (a cura di), Capitalismo cognitivo. Conoscenza e finanza nell’epoca postfordista ,
57
�138
E LIA Z A RU
tale formulazione – su cui non è possibile soffermarsi qui 58), se si accetta la possibilità
che negli ultimi decenni il capitale abbia modificato i suoi connotati, allora è
necessario riconoscere un mutamento anche nella forza lavoro, e dunque nella
soggettività sfruttata. Il concetto di «moltitudine» risponde a questa esigenza. Inoltre,
per via della sua natura inclusiva esso è in grado di ampliare la platea dei soggetti
della valorizzazione capitalistica e, dunque, dei potenziali rivoluzionari – al contrario
delle definizioni sociologistiche del termine «classe operaia».
Questo è vero dal momento in cui Negri concepisce la moltitudine come concetto
di classe 59, un raggruppamento che raccoglie «l’insieme degli sfruttati e dei
sottomessi» 60 a partire dalla dichiarata estensione del regime di fabbrica a tutta la
società 61:
Moltitudine è un concetto di classe. […] Il concetto di classe è un concetto di
raggruppamento, di sfruttamento e interesse economico. Ha una composizione
sempre mutante: non esiste un concetto di classe fisso, esiste un concetto di
classe in quanto si è sfruttati dentro certi sistemi meccanici, dentro certi rapporti
tra storia e natura. Il concetto di classe è completamente e storicamente
determinato e definito. Questo l’ho sempre sostenuto. Il concetto di moltitudine
si definisce come un concetto di classe perché questa moltitudine è
fondamentalmente determinata da rapporti economico-politici, che nella
condizione attuale diventano biopolitici. È questo che definisce la moltitudine.
La moltitudine contro l’impero, contro il comando è questo: un insieme di forze
e potenze introdotte nel processo produttivo, sfruttate singolarmente ed
espropriate collettivamente, che formano un contesto di resistenza, nel quale
però non bisogna mai dimenticare le differenze .
62
Se si pone la moltitudine come concetto di classe, la nozione di sfruttamento si
definirà come sfruttamento della cooperazione: cooperazione non degli
Roma: Manifestolibri; Boutang, Y.M. (2007), Le capitalisme cognitif: la nouvelle grande
transformation, Parigi: Amsterdam Editions; Fumagalli, A. (2007), Bioeconomia e capitalismo
cognitivo. Verso un nuovo paradigma di accumulazione, Roma: Carocci.
Si segnalano qui solo alcuni interventi critici: Caffentzis, G. (2005), Immeasurable Value? An essay
on Marx’s Legacy , in «The Commoner», 10, pp. 87-114; Thompson, P. (2005), Foundation and Empire:
A critique of Hardt and Negri, in «Capital & Class», 86, pp. 73-98; De Angelis, M., Harvie, D. (2006),
Cognitive capitalism and the rat race: how capital measures ideas and affects in UK Higher Education,
in «Historical Materialism», 17, 3, pp. 3-30; De Angelis, M. (2007), The Beginning of History. Value
Struggles and Global Capital, Londra: Pluto Press.
Cfr. Hardt, M., Negri, A. (2004), Multitude, cit., p. 103; trad. it Moltitudine, cit., p. 127.
Hardt, M., Negri, A. (2000), Empire, cit., p. 393; trad. it. Impero, cit., p. 364. Negri, A. (2002),
Intervento al Social Forum Europeo di Parigi, http://www.generation-online.org/t/negriESF.htm.
Hardt, M., Negri, A. (2000), Empire, cit., p. 243; trad. it. Impero, cit., p. 230; Negri, A. (2006),
Movimenti nell’Impero, cit., pp. 52, 57; cfr. Negri, A. (2008), Dalla fabbrica alla metropoli. Saggi
politici, Roma: Datanews.
Zaru, E. (2016) (a cura di), Quindici anni dopo Empire. Intervista ad Antonio Negri, cit., p. 9,
http://www.filosofiaitaliana.net/wp-content/uploads/2017/11/Zaru_Negri.pdf.
58
59
60
61
62
�139
Talpa o serpente? Popolo, classe, moltitudine
individui, ma delle singolarità, sfruttamento dell’insieme delle singolarità, delle
reti che compongono l’insieme e dell’insieme che comprende le reti .
63
La moltitudine di Negri non è «la forma dell’essere sociale spaesato di fronte al
mondo come luogo da percorrere», caratterizzata da sentimenti che «più che dal
senso di rivolta e conflitto, sono segnati da paura e angoscia» 64. Al contrario, essa è
una moltitudine contro «l’impero», è il «ControImpero» che fa esperienza dello
sfruttamento del lavoro vivo da parte del capitale (quale che sia la natura di questo
lavoro) e può, dunque, agire nel solco della lotta di classe. In questo senso, essa si
configura come classe nel significato «storico» e conflittuale che Thompson ha
attribuito a questo concetto 65.
3. COSA PUÒ UNA MOLTITUDINE?
Cosa vuole la moltitudine? Strategicamente, essa punta a una forma assoluta di
democrazia 66, «concepibile e possibile nella misura in cui tutti condividono e
partecipano insieme al comune» 67. Tatticamente, il suo «programma politico» 68 viene
definito intorno a tre rivendicazioni principali: cittadinanza globale, salario sociale
(reddito universale garantito), diritto alla riappropriazione 69. Si tratta, secondo alcuni,
Negri, A. (2003), Guide, cit., p. 130.
Bonomi, A. (1996), Il trionfo della moltitudine. Forme e conflitti della società che viene, Torino:
Bollati Boringhieri, p. 84.
Thompson, E.P. (1966), The Making of the English Working Class, New York: Vintage Books.
Una comparazione tra Negri e Thompson si può trovare in Fraser, I. (2007), Dialectics of the Self:
Transcending Charles Taylor, Exeter: Imprint Academic; Del Valle Alcalà, R. (2013), A Multitude of
Hopes: Humanism and Subjectivity in E.P. Thompson and Antonio Negri, in «Culture, Theory and
Critique», 54, 1, pp. 74-87.
Negri, A. (2002) [1992], Il potere costituente. Saggio sulle alternative del moderno, Roma:
Manifestolibri, p. 337: «La democrazia è il progetto della moltitudine, in quanto forza creativa, in
quanto dio vivente». Cfr. Hardt, M., Negri, A. (2004), Multitude, cit., pp. 328-358; trad. it Moltitudine,
cit., pp. 378-411.
Hardt, M., Negri, A. (2009), Commonwealth, Cambridge: Harvard University Press, p. viii; trad. it.
2010, Comune. Oltre il privato e il pubblico, Milano: Rizzoli, p. 7.
Hardt, M., Negri, A. (2000), Empire, cit., p. 399; trad. it. Impero, cit., p. 369.
«Riappropriazione significa libero accesso e controllo della conoscenza, dell’informazione, della
comunicazione e degli affetti, in quanto mezzi primari della produzione biopolitica. […] Il diritto di
riappropriazione è il diritto della moltitudine all’autocontrollo e a un’autonoma autoproduzione» (ivi,
pp. 406-407; trad. it. p. 376).
63
64
65
66
67
68
69
�140
E LIA Z A RU
di rivendicazioni riformiste 70. In realtà, esse vanno inserite in quadro più generale che
comprende una quarta figura, quella dell’«esodo», che rappresenta la forma
conflittuale della moltitudine stessa 71: «lo spettro delle migrazioni di massa si aggira
per il mondo» 72. Anche l’idea di «esodo» come forma della lotta di classe ha suscitato
diverse perplessità 73, ma, ancora una volta, è mancata nei critici una visione
d’insieme. «Esodo» inteso come mobilità, «nomadismo» 74, unito all’idea di
«cittadinanza globale» significa sfidare l’idea di «confine» – uno dei pilastri della
modernità – e l’effettiva moltiplicazione di segmentazioni geopolitiche nel mondo
globale 75. Inoltre, in termini negriani «esodo» significa anche fuga dallo sfruttamento
– rifiuto del lavoro. In questo senso, connettere l’esodo al salario sociale e al diritto
alla riappropriazione pone la moltitudine in contrapposizione a un altro elemento
fondamentale della modernità capitalistica: la proprietà privata dei mezzi di
produzione, conditio sine qua non per la valorizzazione del capitale.
Ma cosa può una moltitudine? La risposta a questa domanda implica un
ragionamento circa la sua forma politica, e rende manifesta una problematica
tutt’oggi non risolta. Anche in questo caso, è opportuno considerare alcune critiche.
Il primo gruppo di osservazioni si articola intorno alla questione della «capacità della
Fotopoulos, T., Gezerlis, A. (2002), Hardt and Negri’s Empire: a new Communist Manifesto or a
reformist welcome to neoliberal globalisation?, in «The International Journal of INCLUSIVE
DEMOCRACY», 8, 2; Panitch, L., Gindin, S. (2002), Gems and Baubles in Empire, in «Historical
Materialism», 10, 2, pp. 17-43; Zizek, S. (2001), Have Michael Hardt and Antonio Negri Rewritten the
Communist Manifesto for the Twenty-First Century?, in «Rethinking Marxism», 13, 3/4, pp. 190-198;
Boron, A. (2002), Impero & Imperialismo. Una lectura critica de Michael Hardt y Antonio Negri,
Buenos Aires: CLACSO; trad. it. (2003), Impero e imperialismo. Una lettura critica di Michael Hardt e
Antonio Negri, Milano: Punto Rosso.
70
«Mentre nella modernità essere contro significava, per lo più, un’opposizione diretta e/o dialettica
tra forze, nella postmodernità, l’efficacia dell’essere contro si manifesta assumendo posizioni oblique e
diagonali. Le battaglie contro l’Impero possono essere vinte con la sottrazione e la defezione. La
diserzione non ha luogo: è evacuazione dai luoghi del potere» (Hardt, M., Negri, A. (2000), Empire, cit.,
p. 212; trad. it. Impero, cit., p. 203); «[…] possiamo azzardare una prima ipotesi: nel contesto biopolitico,
la lotta di classe ha la forma di un esodo. Con la parola esodo intendiamo, in prima battuta, una
sottrazione dal rapporto di capitale mediante l’attualizzazione dell’autonomia potenziale della forza
lavoro» (Hardt, M., Negri, A. (2009), Commonwealth, cit., p. 152; trad. it. p. 157). Sull’esodo si veda
anche Virno, P. (1990), Ambivalenza del disincanto, in AA.VV., Sentimenti dell’aldiqua.
Opportunismo paura cinismo nell’età del disincanto, Roma-Napoli: Theoria, pp. 13-41, in particolare le
pp. 35-41.
Hardt, M., Negri, A. (2000), Empire, cit., p. 213; trad. it. Impero, cit., p. 203.
Mishra, P.K. (2001), The Fall of the Empire or the Rise of the Global South?, in «Rethinking
Marxism», 13, 3/4, pp. 95-99; Panitch, L., Gindin, S. (2002), Gems and Baubles in Empire, cit.; Bull, M.
(2004), Smooth Politics, in Passavant, P.A., Dean J. (a cura di), Empire’s New Clothes, New York:
Routledge, pp. 217-230.
Hardt, M., Negri, A. (2000), Empire, cit., p. 213; trad. it. Impero, cit., p. 202.
Cfr. Mezzadra, S., Neilson (2013), Border as Method, or, the Multiplication of Labor, Durham:
Duke University Press; trad. it. Confini e frontiere. La moltiplicazione del lavoro nel mondo globale,
Bologna: Il Mulino.
71
72
73
74
75
�141
Talpa o serpente? Popolo, classe, moltitudine
moltitudine di essere soggetto di un’azione politica coerente» 76, e raccoglie le
posizioni di Pierre Macherey ed Ernesto Laclau 77. Ciò che qui si contesta è la
possibilità che la moltitudine mantenga la sua eterogeneità e riesca al contempo a
farsi portatrice di un’azione politica unitaria, indirizzata verso un unico fine. Un
secondo gruppo di critiche riguarda invece «non tanto la possibilità da parte della
moltitudine di agire politicamente, quanto la direzione e il senso delle sue azioni
politiche» 78. Ovvero, non si può dare per scontato che la moltitudine agisca
necessariamente in senso progressivo e liberatorio. Per dirla con le parole di Paolo
Virno ed Étienne Balibar, la moltitudine «è al contempo una forza creativa e un
pericolo per sé stessa» 79, può prendere la direzione della democrazia assoluta, oppure
«può diventare fascista» 80. In terzo luogo, quella che potremmo definire una «critica
etno-antropologica» 81 ritrova nel concetto di moltitudine – nonostante la sua
eterogeneità dichiarata – un universalismo incapace di dare conto delle diversità,
divergenze finanche 82 presenti all’interno della stessa moltitudine. Il problema, in
altre parole, è quello di un «soggetto moltitudine» pensato come universale 83.
Parallelamente, Alberto Moreiras e Malcom Bull si chiedono come la moltitudine
possa diventare un soggetto politico 84.
Tuttavia, è possibile rovesciare tale questione, e chiedersi se non sia piuttosto l’idea
stessa di «soggetto» a portarci in un vicolo cieco 85. Non è questo il luogo in cui
Hardt, M., Negri, A. (2009), Commonwealth, cit., p. 166; trad. it. (2010), Comune, cit., p. 171.
Macherey, P. (2004), Présentation, Chitéphilo, Palais des Beaux Arts, Lille, 19 novembre 2004;
Laclau, E. (2005), On populist reason, Londra: Verso.
Hardt, M., Negri, A. (2009), Commonwealth, cit., p. 167; trad. it. (2010), Comune, cit., p. 172.
Balibar, É. (2017), De la victoire du capitalisme à la défaite de la démocratie? Entretien avec
Étienne Balibar, in «Revue International et Strategique, 106; trad. it. Democratizzazione o dedemocratizzazione: la dimensione transnazionale. Intervista a Étienne Balibar, in «Tysm», 17 ottobre
2017, http://tysm.org/democratizzazione-o-de-democratizzazione-la-dimensione-transnazionale.
Intervista a Paolo Virno, 21 aprile 2001, https://www.autistici.org/operaismo/virno/index_1.htm,
ora in Pozzi, F., Roggero, G., Borio, G. (2002), Futuro anteriore. Dai «Quaderni rossi» ai movimenti
globali: ricchezze e limiti dell’operaismo italiano, Roma: DeriveApprodi. Cfr. anche Virno, P. (1990),
Ambivalenza del disincanto, cit., pp. 24-29.
Wilson, A. (2012), Anthropology and the radical philosophy of Antonio Negri and Michael Hardt,
in «Focaal – Journal of Global and Historical Anthropology», 64, pp. 3-15.
Tampio, N. (2005), Can the Multitude Save the Left?, in «Theory & Event», 8, 2; Bensaïd, D.
(2005), Multitudes ventrílocuas, in «Herramienta», 23 marzo, http://www.herramienta.com.ar/revistaherramienta-n-28/multitudes-ventrilocuas-proposito-de-multitud-de-hardt-y-negri.
Problema sollevato anche da Laclau (Laclau, E. (2001), Can Immanence Explain Social Struggles,
in «Diacritics», 31, 4, pp. 2-10; Laclau, E. (2000), Identity and hegemony: the role of universality in the
constitution of political logics, in Butler, J., Laclau, E., Zizek, S., Contingency, hegemony, universality.
Contemporary dialogues on the left, Londra-New York: Verso, pp. 44-89).
Moreiras, A. (2001), A line of Shadow: Metaphysics in counter-Empire, in «Rethinking Marxism»,
13, 2/4, p. 224; Bull, M. (2005), The Limits of the Multitude, in «New Left Review», 35, p. 38.
Cfr. Ansaldi, S. (2001), The Multitude in Empire: Biopolitical Alternatives, in «Rethinking
Marxism», 13, 3/4, pp. 137-143.
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
�142
E LIA Z A RU
affrontare una riflessione storica e teorico-politica di tale concetto 86. Va però
sottolineata la natura bivalente – circolare, come la definisce Judith Butler – del
rapporto tra «soggetto» e «assoggettamento» 87. È lecito, insomma, chiedersi quali
implicazioni politiche derivino dal fatto che «la parola soggetto indica sia quel
processo di sottomissione al potere, sia il processo del divenire soggetto. Che ciò
avvenga per interpellazione, come direbbe un Althusser, o per produttività
discorsiva, come direbbe invece un Foucault, il soggetto si origina comunque
mediante una sottomissione al potere» 88. Per uscire da questo dilemma, si può
pensare la moltitudine oltre la categoria di «soggetto» come «congiuntura» 89 e
«intersezionalità» 90:
Spinoza sostiene che esistono infiniti attributi attraverso cui si esprime la
sostanza. Gli umani ne percepiscono e ne conoscono solo due: il pensiero e
l’estensione, la mente e il corpo. Allo stesso modo, potremmo dire che,
nonostante siamo in grado di riconoscerne un numero limitato, nella nostra
società esistono infinite traiettorie della lotta e della liberazione. La pluralità, ma
anche solo un numero esorbitante, non è un problema. Il problema è come
articolarle lungo linee parallele in un programma comune .
91
Ma «congiuntura» e «intersezionalità» costituiscono solo il punto di partenza, e da
sole non risolvono i problemi sollevati circa la capacità politica della moltitudine, né
l’orientamento dei suoi atti. Per evitare teleologismi e accuse di determinismo come
quelle sollevate da Slavoj Žižek, Chantal Mouffe e Jacques Rancière 92, occorre
sgombrare il terreno dall’idea che la moltitudine sia orientata ontologicamente verso
Per un lavoro di questo tipo cfr. Balibar, É., Cassin, B., de Libera, A. (2004), Sujet, in Cassin, B.
(ed.), Vocabulaire européen des philosophies: Dictionnaire des intraduisibles, Parigi: Seuil; Pirillo, N.
(2005), Soggetto, in Esposito, R., Galli, C., Enciclopedia del pensiero politico. Autori, concetti, dottrine
(I ed. 2000), Roma-Bari: Laterza, pp. 790-792.
Butler, J. (1997), The Psychic Life of Power, Stanford: Stanfor University Press, p. 11, 83; cfr.
anche Balibar, É. (1994), Subject and Subjectivation, in Copjec, J., Supposing the Subject, Londra-New
York: Verso, pp. 1-15.
Butler, J. (1997), The Psychic Life of Power, cit., p. 2; trad. it. (2013), La vita psichica del potere.
Teorie del soggetto (a cura di Zappino, F.), Milano: Mimesis, pp. 41-42.
Cfr. Morfino, V. (2009) Che cos’è la moltitudine? , in Del Lucchese, F. (a cura di), Storia politica
della moltitudine. Spinoza e la modernità, Roma: DeriveApprodi, p. 84.
Hardt, M., Negri, A. (2009), Commonwealth, cit., p. 340-341; trad. it. p. 338-339.
Hardt, M., Negri, A. (2009), Commonwealth, cit., p. 343; trad. it. p. 341.
Mouffe, C. (2005), On the Political, Londra, New York: Routledge, p. 111; trad. it. (2007), Sul
politico. Democrazia e rappresentazione dei conflitti, Milano: Mondadori, p. 128; Rancière, J. (2005),
La haine de la démocratie, Parigi: La fabrique éditions, pp. 105-106; trad. it. (2007), L’odio per la
democrazia , Napoli: Cronopio, pp. 115-116; Slavoj Žižek (2007), Multitude, Surplus and Envy , in
«Rethinking Marxism», 19, p. 53.
86
87
88
89
90
91
92
�143
Talpa o serpente? Popolo, classe, moltitudine
la rivoluzione. Proprio questo è il punto in cui essa incontra le difficoltà maggiori,
ereditate dalla «tendenza» di matrice operaista 93.
Accettare le ambiguità della moltitudine significa costruire politicamente le sue
potenzialità di emancipazione. Se da un lato, come insegna Machiavelli, la libertà
nasce dai tumulti 94 e il conflitto è parte integrante della politica 95, dall’altro lato non
dobbiamo dimenticare l’importanza dell’organizzazione. In questo senso, sebbene
non completamente risolutivo, il rovesciamento del rapporto tra tattica e strategia
che Negri ha sviluppato di recente 96 costituisce un avanzamento importante in questa
direzione. Timothy S. Murphy suggerisce di pensare Negri come «teorico […] di un
tempo a venire» 97, e i suoi lavori con Hardt come «opere aperte, nel senso in cui
Umberto Eco intendeva degli artefatti che, nella costruzione del loro significato,
richiedono la partecipazione del proprio pubblico» 98. Su questa partecipazione,
possibile ma non necessaria, deve innestarsi la politica come organizzazione,
intervento strategico nella congiuntura, costruzione di egemonia. Solo con questo
innesto la convergenza di teoria e prassi della moltitudine potrà dispiegarne
pienamente la potenza.
Tomba, M., Bellofiore, R. (2012-2013), Letture del Frammento sulle macchine. Prospettive e limiti
dell’approccio operaista e del confronto dell’operaismo con Marx, in «Quaderni Materialisti», 11-12,
pp. 145-161.
Cfr. Raimondi, F. (2013), Libertà, sicurezza e tumulti: Machiavelli e la «corruzione» di Firenze, in
Caporali, R., Morfino, V., Visentin, S., Machiavelli: tempo e conflitto, Milano: Mimesis, pp. 185-198.
Cfr. Del Lucchese, F. (2004), Tumulti e indignatio, cit., parte II: Conflitto, pp. 141-290.
Negri, A. (2017), Lenin: dalla teoria alla pratica , convegno “Penser l’émancipation”, Paris 8 –
Saint-Denise, 15 settembre, http://www.euronomade.info/?p=9675; Hardt, M., Negri, A. (2017),
Assembly , cit.
Murphy, T.S. (2012), Antonio Negri. Modernity and Multitude, Cambridge: Polity Press, p. 234,
trad. mia.
Ivi, p. 232, trad. mia.
93
94
95
96
97
98
�144
�145
Etica & Politica / Ethics & Politics, XX, 2018, 1, pp. 145-159
ISSN 1825-5167
COMPOSITION, AUTONOMIE,
SÉPARATION. LES FORMES-PARTI
D’ANTONIO NEGRI
La constitution de la classe hors du capital n’est pas le dépassement du parti, mais la
condition de sa fondation.
Thèses Panzieri-Tronti
FRÉ DÉ RI C MO NFE RRA ND
Université de Nanterre
Laboratoire Sophiapol
fmonferrand@gmail.com
ABSTRACT
According to the dominant narrative, italian workerism ought to be credited for its rejection of
«the party form» as a mode of political organisation. The aim of this article is to challenge this
narrative. Starting with a brief account of the recent reassessment of the party in Hardt and
Negri’s Assembly, it articulates a reading of Negri’s reflection on political organisation in the
1970’s. Resulting from this reading is a distinction of three models of the «party form» – the party
of composition, the party of autonomy and the party of separation – which all represent various
ways of articulating a political ontology of social being with an ontological politics of social
emancipation.
KEYWORDS
Workerism, Antonio Negri, party-form, political ontology
1. RETOUR VERS LE FUTUR: DE « L’EXODE » AU « PARTI DES
MOUVEMENTS »
�146
F RÉ DÉ RIC M ONTFE RRAND
On crédite souvent l’opéraïsme d’avoir su rompre avec la conviction selon laquelle
le parti constituerait la forme d’organisation politique indispensable à l’émancipation
des opprimés. La phrase citée en exergue de cet article – extraite d’un texte co-rédigé
en 1962 par Raniero Panzieri et Mario Tronti auquel on se réfère parfois sous le nom
de « Thèses sur le parti 1 » – incite cependant à relativiser cette assomption. Certes, il
est indéniable que l’opéraïsme se soit constitué en rupture avec la politique de cogestion ouvrière du développement capitaliste promue par le Parti communiste
italien et ses relais syndicaux. Mais il est tout aussi indéniable que ce soit par un
travail de réinvention plutôt que de rejet de la « forme-parti » que les membres des
Quaderni rossi puis de Classe operaia ont cherché à accompagner les luttes
autonomes qui se développaient alors aux marges du mouvement ouvrier officiel.
Dès lors, c’est sans doute au succès rencontré par un ouvrage auquel on doit en
grande partie la vitalité actuelle de l’opéraïsme qu’il faut attribuer les connotations
« spontanéistes » associées à ce courant hétérodoxe du marxisme italien. Nous
pensons évidemment à Empire, publié par Michael Hardt et Antonio Negri au
sommet de la vague altermondialiste.
Dans cet ouvrage qui a fait date, les deux philosophes développent une ontologie
politique impressionnante où le repérage d’une nouvelle forme de domination
politique (l’Empire) s’appuie sur l’analyse d’un nouveau mode d’exploitation
économique (le capitalisme cognitif) et ouvre sur l’identification d’une nouvelle
figure de l’antagonisme (la multitude). Pour Hardt et Negri, les coordonnées
politiques inédites que dessinent ces concepts rendent caduques les options
stratégiques et organisationnelles traditionnellement attachées à l’activité partidaire.
Dans la mesure où la constitution impériale s’étend de manière réticulaire à
l’ensemble de la planète, expliquent-ils en effet, la perspective de la « prise du pouvoir
d’État » devient sans objet. Et dans la mesure où l’accumulation capitaliste dépend
de plus en plus de l’appropriation des connaissances mobilisées dans la production
sociale par la multitude, il devient contre-productif de soumettre les mouvements de
cette dernière à la direction extérieure d’une volonté centralisée. Dans ces conditions,
la seule option politiquement praticable serait celle de « l’exode » ou de la
« désertion ». Intégralement socialisée par des réseaux de coopération permettant le
partage et la production autonomes de savoirs, d’affects et de désirs communs, la
multitude expérimenterait déjà le communisme. Il lui suffirait donc d’affirmer la
puissance qui anime ses luttes et son travail quotidien pour s’extraire du pouvoir que
lui impose l’Empire et devenir ce qu’elle est : une essaim de singularités prenant
directement en charge les conditions matérielles et sociales de sa croissance et de son
expansion 2.
Les « Thèses Panzieri-Tronti » sont disponibles ici : https://libcom.org/library/panzieri-tronti-theses
Nous résumons ici Michael Hardt et Antonio Negri, Empire, trad. D.-A. Canal, Paris, UGE 10/18,
2000, p. 263-268.
1
2
�147
Composition, autonomie, separation. Les formes-parti d’Antonio Negri
Pourtant, les réflexions développées quelques années plus tard dans Multitude
témoignent déjà d’une prise de distance avec cet élan spontanéiste. La question est en
tout cas posée de savoir si la multitude doit être politiquement construite par un
cadre organisationnel adéquat ou si elle est ontologiquement donnée dans l’ensemble
des pratiques constitutives du monde social 3. À lire la production récente de Hardt et
Negri, il semble que la première solution doive être privilégiée. Commonwealth
s’ouvre en effet sur un appel au « devenir-Prince de la multitude », c’est-à-dire à
l’invention d’une organisation politique de type nouveau, capable d’assurer le
« gouvernement de la révolution ». Sur le plan tactique, la fonction de cette nouvelle
organisation ne serait ni de représenter la multitude auprès d’elle-même ou des
institutions impériales, ni d’unifier les différences qui en sont constitutives, mais de
faire durer la rencontre entre des foyers de contestation irréductiblement pluriels et
hétérogènes. Sur le plan stratégique, sa fonction serait d’assurer la transcroissance du
processus destituant qui anime ces foyers de contestation en un processus constituant
visant à instituer le libre usage, la production collective et l’accès égal aux ressources
nécessaires à la vie en commun 4. Publié récemment, Assembly confirme clairement
le tournant organisationnel annoncé dans Commonwealth. Hardt et Negri y réitèrent
certes la critique des conceptions avant-gardistes de l’organisation. Mais ils n’hésitent
plus à penser l’articulation entre tactique de la rencontre et stratégie de l’institution
sous le concept de « parti », recodifé en « parti des mouvements ». S’il revient à
l’intelligence immanente aux mouvements d’élaborer la planification à long terme de
l’institution du commun, expliquent-ils en effet, la coordination à court terme des
actions de la multitude doit en revanche être assurée par un organe de décision
centralisé. Variable dans sa composition et circonscrit à des moments déterminés, cet
organe de direction représente l’élément de verticalité permettant d’appliquer
efficacement la stratégie élaborée horizontalement par la multitude à une
conjoncture en constante transformation. Le mot d’ordre, significativement
emprunté au Tronti d’Ouvriers et Capital, est dorénavant le suivant : « la stratégie
aux mouvements, la tactique à la direction 5 ». De l’« exode » promu dans Empire au
« parti des mouvements » invoqué dans Assembly, on assiste donc à une très nette
revalorisation de la « forme-parti ».
L’objectif de cet article est de faire la généalogie de cette revalorisation. À partir
d’une relecture de ses textes des années 1970, nous voudrions montrer que les
élaborations récentes de Negri renouent le fil des réflexions qu’il consacra au parti
lors de la séquence ouverte par la dissolution de Potere operaio dans l’ « Aire de
Michael Hardt et Antonio Negri, Multitude. Guerre et démocratie à l’âge de l’Empire, trad. N.
Guilhot, Paris UGE 10/19, 2004, p. 257-264.
4 Michael Hardt et Antonio Negri, Commonwealth , Cambridge, MA et Londres, Harvard
University Press, 2011, p. vii-xiv, 325-375.
5 Michael Hardt et Antonio Negri, Assembly , New York, Oxford University Press, 2017, p. 18-24.
3
�148
F RÉ DÉ RIC M ONTFE RRAND
l’Autonomie » 6. Nous proposons plus précisément de distinguer trois moments au
sein de cette séquence, qui ne représentent certes pas des phases aux frontières bien
délimitées, mais n’en marquent pas moins des infléchissements significatifs dans la
trajectoire militante du philosophe italien. Le premier moment est celui de
l’élaboration, dans L’usine de la stratégie (1973), d’une matrice théorico-politique qui
fait du parti l’instance de traduction organisationnelle de la composition de classe du
prolétariat. Le second moment est celui de la constitution, dans Crise de l’État-plan
(1971) et dans Parti ouvrier contre le travail (1973), d’une théorie du parti comme
instrument de consolidation de l’autonomie acquise par la classe ouvrière au sein de
la société capitaliste. Enfin, le troisième et dernier moment est celui de l’institution,
dans Prolétaires et État (1975) et Domination et sabotage (1977), du parti en point
d’appui de la séparation du prolétariat d’avec la société capitaliste 7. Ce troisième
moment annonce les thèmes de « l’exode » et de la « désertion » que nous avons
relevé dans Empire et clôt ainsi la séquence composition – autonomie – séparation
que nous nous proposons maintenant de parcourir.
2. LÉNINE AU-DELÀ DE LÉNINE : LE PARTI DE LA COMPOSITION
Composé de « trente-trois leçons sur Lénine » publiées en 1973, mais qui furent
pour certaines rédigées dix ans plus tôt, L’usine de la stratégie constitue le véritable
laboratoire de la réflexion negrienne sur la « forme-parti ». Dans un contexte marqué
par l’émergence d’un nouveau cycle de luttes dont les acteurs ne sont plus seulement
les ouvriers, mais aussi les femmes, la jeunesse scolarisée et les minorités, le
philosophe italien opère un retour à Lénine dont l’objectif est de pousser Lénine audelà de Lénine, c’est-à-dire de fixer les conditions d’une fidélité à l’héritage léninien
qui rompe avec les principes du léninisme. Il ne s’agit donc pas dans ces leçons
d’extraire des textes du dirigeant bolchévik un ensemble de règles organisationnelles
(le centralisme démocratique), de recommandations tactiques (la construction
d’alliances de classe) ou de perspectives stratégiques (la construction étatique du
socialisme) à validité transhistorique, mais de tracer une ligne de conduite politique
adaptée à la situation italienne du début des années 1970. Ce que Negri cherche chez
On trouve une excellente reconstruction intellectuelle de cette séquence dans Timothy S. Murphy,
Antonio Negri. Modernity and the Multitude, Cambridge et Malden, MA, Polity Press, 2012, p. 77-103.
7 Tous ces textes – dont il faut ici rappeler qu’ils furent cités à charge contre Negri lors de son
procès – sont réunis dans Antonio Negri, Books for burning. Between Civil War and Democracy in
1970’s Italy , trad. A. Bove, E. Emery, T. S. Murphy et F. Novello, Londres et New York, Verso, 2005.
Nous renvoyons à cette édition anglophone par souci d’accessibilité.
6
�149
Composition, autonomie, separation. Les formes-parti d’Antonio Negri
Lénine n’est en d’autres termes pas l’unité d’une doctrine, mais l’efficace d’une
méthode :
La méthode, typiquement marxienne mais profondément renouvelée par Lénine est la
méthode de la tendance qui saisit la contradiction à son plus haut point et décrit la
réalité du capital de l’intérieur de l’exaspération violente, du point de vue ouvrier, d’un
stade particulier de son développement, retournant ainsi sa déterminité en projet
d’offensive ouvrière. La matérialité de la tendance se transforme en matérialité du
projet 8.
Dans le vocabulaire qui sera le sien à partir des années 1980, on peut dire de la
« méthode de la tendance » que Negri attribue à Lénine qu’elle comporte un versant
ontologique et un versant politique 9. Sur le plan ontologique, elle consiste en une
lecture dynamique du réel, qui appréhende ce dernier comme un processus de
production de formes sociale objectives et de comportements subjectifs. Sur le plan
politique, elle consiste à anticiper la direction que prend ce processus, à se placer,
comme dirait Lénine, « un pas en avant » des transformations sociales
empiriquement constatables et des conflits politiques auxquels elles donnent lieu, de
manière à en infléchir ou en accélérer le cours. La « méthode de la tendance »,
précise ailleurs Negri, est donc une « aventure de la raison » qui ne peut s’autoriser
que de sa capacité à provoquer les changements qualitatifs qu’elle voit émerger de la
dynamique même de l’être social 10. Elle se distingue cependant d’un simple pari sur
l’avenir par le fait de placer, entre l’ontologie de la production qu’elle suppose et la
politique d’anticipation qu’elle permet, le moment médiateur d’une phénoménologie
de la composition de classe du sujet auquel elle s’adresse : le prolétariat. C’est en effet
cette phénoménologie qui permet de transformer « la matérialité de la tendance » en
« matérialité du projet ».
Pour saisir la « matérialité de la tendance », c’est-à-dire la direction qu’emprunte
l’accumulation capitaliste à un moment donné de son développement, explique ainsi
Negri, c’est vers la « composition technique » de la classe ouvrière qu’il faut se
tourner. Cette composition technique articule l’ensemble des moyens technologiques
et organisationnels par lesquels la force de travail est concrètement incorporée au
procès de valorisation. Elle détermine à ce titre les besoins et les aspirations du
prolétariat qui constituent le matériau de sa « composition politique », laquelle
Antonio Negri, Factory of Strategy. Thirty-Three Lessons on Lenin, trad. A. Bove, New York,
Columbia University Press, 2014, p. 248.
9 Nous pensons ici à L’anomalie sauvage, ouvrage dans lequel Negri élabore le vocabulaire
ontologique largement mobilisé dans les ouvrages co-écrits avec Michael Hardt. Antonio Negri,
L’anomalie sauvage. Puissance et pouvoir chez Spinoza, trad. F. Matheron, Paris, Amsterdam, 2007.
10 Antonio Negri, «Crisis of the Planer-State: Communism and Revolutionary Organization» in
Books for burning, op. cit., p. 27.
8
�150
F RÉ DÉ RIC M ONTFE RRAND
articule dès lors l’ensemble des formes de luttes et de résistance que la classe ouvrière
invente au contact de l’exploitation. C’est à travers ses formes de luttes que s’esquisse
la « matérialité du projet » auquel le parti doit imprimer un cadre organisationnel
adéquat 11. Comme l’écrit Massimo Cacciari à propos de Lénine dans un passage que
cite favorablement Negri au début de L’usine de la stratégie :
Le discours de Lénine traduit en termes organisationnels une structure de classe réelle.
Cette structure exprimait matériellement le caractère d’avant-garde que revêtait encore
la classe ouvrière industrielle. Elle exprimait son isolement. Le rapport de production
du capitalisme avancé – et donc la reproduction matérielle de la force de travail et de la
classe ouvrière – était isolé, il était l’avant-garde. […] Voilà le sens de la stratégie
léniniste : renforcer du point de vue organisationnel et matériel une classe ouvrière
consciente de son isolement objectif – et renverser cet isolement en avant-garde 12.
La composition technique à laquelle se confronte Lénine présente deux
caractéristiques principales : d’un côté, la classe ouvrière est concentrée dans les
grandes usines de quelques centres urbains (Moscou, Petrograd) et se trouve par là
même isolée du reste de la population laborieuse soumise à des formes d’exploitation
semi-féodales. De l’autre côté, elle est segmentée de l’intérieur par la hiérarchie
existant entre une élite d’« ouvriers professionnels » disposant d’un savoir technique
qui leur confère un certain pouvoir sur l’organisation de la production et une masse
d’ouvriers non-qualifiés réduits au statut de simples exécutants. C’est cette extériorité
relative de l’ouvrier professionnel à l’égard des autres couches du prolétariat russe
que Lénine traduirait alors en termes organisationnels dans la célèbre formule de
Que faire ? : « La conscience politique de classe ne peut être apportée à l'ouvrier que
de l'extérieur, c'est-à-dire de l'extérieur de la lutte économique 13 ».
« Traduire » : le terme mérite qu’on s’y attarde, car il revient inlassablement sous
la plume de Negri et indique que le passage de la « tendance » au « projet » n’est
jamais mécanique. Comme tout processus de traduction, il implique en effet la
compréhension des mouvements spontanés de la classe, l’interprétation de leur
signification politique et leur expression dans le langage de l’organisation. Dire que
Lénine a « traduit » la composition technique de la classe ouvrière revient alors à dire
qu’il l’a transformé en le transposant sur le plan des formes et des fonctions du parti
bolchévik. En ce qui concerne sa forme, le parti reproduit en effet les structures de
l’usine : concentration de forces dans une organisation hiérarchisée, division du
11 Pour la définition spécifiquement negrienne du concept de composition de classe, voir Antonio
Negri, «Archeology and Project : The Mass Worker and the Social Worker» in Revolution Retrieved.
Writings on Marx, Keynes, Capital Crises and New Social Subjects (1967-83), Londres, Red Notes,
1988, p. 105.
12 Massimo Cacciari, cité dans Antonio Negri, Fabric of Strategy , op. cit., p. 52.
13
Vladimir
I.
Lénine,
Que
faire?,
disponible
en
ligne
sur
https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1902/02/19020200.htm
�151
Composition, autonomie, separation. Les formes-parti d’Antonio Negri
travail entre une direction centralisée et un ensemble de cellule exécutant des tâches
d’agitation et de propagande. En ce qui concerne ses fonctions, il traduit l’hégémonie
que « l’ouvrier professionnel » exerce sur la masse de travailleurs non-qualifiés dans
les termes de celle qu’exercent les « révolutionnaires professionnels » sur la masse du
peuple réunie en soviets. Par là, le parti poursuit enfin un double objectif : d’une part,
étendre au maximum le pouvoir des soviets sur la société de manière à saper les bases
matérielles de la domination étatique. D’autre part, accumuler les forces nécessaires à
la prise insurrectionnelle du pouvoir d’État, afin d’ouvrir la voie à la transition
« socialiste » vers une nouvelle société 14.
Or, au moment où Negri professe ses « trente-trois leçons sur Lénine » cette
séquence insurrection – construction étatique du socialisme – communisme est
définitivement close. Face à la menace représentée par la Révolution d’octobre,
explique en effet le philosophe italien, les États capitalistes occidentaux se sont euxmêmes employés à « interpréter », à « récupérer », à « reconfigurer » 15, bref à traduire
la composition de classe du prolétariat révolutionnaire dans les termes de réformes
keynesiennes visant à faire fonctionner les luttes de classe comme moteur du
développement capitaliste. Le slogan « à chacun son travail » a ainsi été interprété
dans le cadre de politiques monétaires d’indexation des salaires sur les taux de
productivité. L’exigence de maîtrise démocratique de « l’anarchie du marché » a
quant à elle été transposé dans les termes du plan. Et la revendication d’une
« libération du travail » a finalement pris la forme d’une déqualification massive de la
force de travail affectée à des tâches parcellaires et par là même « libérée » de toute
maîtrise sur le procès de travail comme de tout attachement aux moyens de
production 16. Politique des salaires, planification, industrialisation : l’intégralité du
programme socialiste censé permettre la transition au communisme a donc été réalisé
par l’ « État-plan » dans les limites du mode de production capitaliste. Mais cet Étatplan devait lui-même rapidement entrer en crise, libérant ainsi de nouveaux besoins,
de nouvelles formes de radicalité et de nouvelles perspectives que Negri s’emploie dès
lors à traduire dans un langage organisationnel renouvelé.
3. DEUX, TROIS…DE NOMBREUX MIRAFIORI : LE PARTI DE
L’AUTONOMIE
Antonio Negri, Factory of Strategy , op. cit., p. 36, 123-136 et 216-223.
Antonio Negri, «Crisis of the Planner-State», art. cit., p. 25.
16 Pour des développements plus précis sur la traduction keynesienne des revendications de
l’ouvrier professionnel, voir Antonio Negri, «Keynes and the Capitalist Theory of the State Post-1929»
in Revolution Retrieved, op. cit., p. 5-148.
14
15
�152
F RÉ DÉ RIC M ONTFE RRAND
Des réflexions negriennes sur la traduction étatique de la composition de classe du
prolétariat, il ressort que l’État ne saurait être conçu ni comme une superstructure
reflétant passivement la dynamique qui affecte la base économique de la société, ni
comme un instrument que chaque classe pourrait alternativement mettre au service
de ses intérêts. Il doit bien plutôt être analysé comme la forme politique de la
reproduction des rapports de production dans les sociétés capitalistes. Comme en
témoignent les réformes keynesiennes que nous venons d’évoquer, l’État remplit en
effet une fonction économique d’organisation du procès social de production. Mais
comme le précise Negri dès 1964, il remplit également une fonction politique de
commandement sur les populations. Dans Le travail dans la constitution, le
philosophe analyse ainsi l’article premier de la constitution italienne de 1948 –
« L’Italie est une république démocratique fondée sur le travail » – comme la forme
légale que prend ce commandement dans le capitalisme keyneso-fordiste. En
constitutionnalisant le travail, l’État ne se contente en effet pas de prendre acte de la
massification de la production industrielle et de la généralisation du statut de
travailleur salarié. D’un côté, la codification juridique des pratiques sociales dans la
catégorie de « travail » participe de leur transformation en moments fonctionnels du
développement capitaliste. De l’autre côté, l’interpellation des sujets productifs en
sujets de droit, des travailleurs en citoyens et de la classe ouvrière en peuple –
interpellation qui s’incarne concrètement dans la transformation des partis ouvriers
en partis de gouvernement – contribue à mystifier l’antagonisme inhérent à ce
développement 17.
Or, c’est précisément cette mystification que percent à jour les luttes menées par
l’ « ouvrier-masse » entre la fin des années 1960 et le début des années 1970. En
exigeant la déconnexion des salaires d’avec la productivité, en érigeant, donc, le
salaire en « variable indépendante », les ouvriers déqualifiés des grandes usines du
Nord de l’Italie rompent l’état d’équilibre entre le travail fourni et les revenus reçus
qu’exprime la « loi de la valeur ». En utilisant les institutions du Welfare telles que
l’assurance-chômage pour fuir ou refuser le travail, ils sapent les bases matérielles
d’où l’État-plan tire sa légitimité. Et en constituant des comités de lutte autonomes
dans les usines, ils se désolidarisent concrètement de la politique de co-gestion menée
par les partis et les syndicats. D’un mot, l’ouvrier-masse porte la crise au cœur du
dispositif économico-politique de l’ « État-plan », le contraignant par là même à
engager un processus de restructuration de ses fonctions. Sur le plan de
l’organisation économique de la production sociale, l’État répond ainsi au pouvoir
accumulé par la classe ouvrière dans les usines par la dissémination des unités
productives sur l’ensemble du territoire social et par la promotion des
investissements financiers dans le secteur tertiaire. Sur le plan du commandement
Antonio Negri, «Labor in the Constitution» in Michael Hardt et Antonio Negri, Labor of
Dyonisus. A Critique of the State-Form , Minneapolis, Londres, University of Minessota Press, 1994, p.
17
53-138.
�153
Composition, autonomie, separation. Les formes-parti d’Antonio Negri
politique qu’il exerce sur les populations, il répond à la crise de la loi de la valeur et à
la perte de légitimité qu’elle occasionne par une gestion de plus en plus violente de la
contestation sociale. L’ « État-plan » se transforme ainsi en « État-crise » étendant sa
domination sur un nouveau terrain que Negri cartographie comme suit :
Le capital dresse l’usine, en tant que point de valorisation du circuit social de la
production, contre la société en tant qu’aire de la dévalorisation et site de massification.
En même temps, il dresse la société, en tant qu’image de la machine sociale de
production, contre l’usine en tant que site privilégié du refus du travail et d’offensive
contre le taux de profit 18.
Reprenons rapidement les termes de cette description du Kampflatz sur lequel se
déroulent les luttes de classe à l’heure de la « crise de l’État-plan ». D’un côté, on
trouve l’usine comme principal espace productif transformé par la rigidité des
revendications salariales en véritable place forte de l’autonomie ouvrière. C’est
l’époque où « à Mirafiori, à Rivalta et dans tous les départements de la FIAT, la grève
à outrance se transforme en occupation armée 19 ». De l’autre côté, on voit se déployer
un territoire social parcouru de pratiques subversives qui expriment un désir
d’expérimentation de formes de vies libérées de la contrainte du travail productif.
C’est l’époque où, dans les quartiers populaires des principales métropoles italiennes,
se développe un vaste mouvement d’ appropriation directe de la richesse sociale dont
les « autoréductions » des factures de gaz et d’électricité, des biens de consommation
et des loyers sont l’incarnation la plus visible. Tout le problème est alors d’articuler
les luttes d’usine pour l’égalité salariale et les luttes métropolitaines contre le travail.
Un problème qu’à suivre Negri, seule la construction d’un « parti d’avant-garde de
masse 20 » permet d’affronter.
L’expression « d’avant-garde de masse » témoigne du méta-léninisme des textes
que nous commentons. Conformément à sa lecture de Lénine, le philosophe rappelle
en effet que le parti doit traduire les articulations internes à la composition de classe
du prolétariat. Dans l’Italie du début des années 1970, ces articulations internes
placent l’ouvrier-masse dans une position hégémonique analogue à celle qu’occupait
l’ouvrier professionnel dans la Russie du début du XX° siècle. Sa concentration
industrielle lui confère le pouvoir d’attaquer le capital là où il est le plus faible – dans
les usines, au point de production où se joue la fixation du rapport entre travail
nécessaire et surtravail – et le met ainsi à l’avant-garde de la lutte de masse contre le
Antonio Negri, «Workers’ Party Against Work» in Books for burning, op. cit., p. 77.
Antonio Negri, «Articolazioni organizzative e organizzazione complessiva: il Partito di Mirafiori»
(1973), cité dans Nanni Belestrini et Primo Moroni, La horde d’or. La grande vague révolutionnaire et
créative, politique et existentielle. Italie 1968-1977, trad. J. Revel et J.-B. Leroux, P.-V. Cresceri et L.
Guilloteau, Paris, L’éclat, 2017, p. 411.
20 Antonio Negri, «Workers’ Party Against Work», art. cit., p. 93.
18
19
�154
F RÉ DÉ RIC M ONTFE RRAND
travail qui se développe dans la société 21. Contrairement à Lénine, Negri précise
cependant que la traduction organisationnelle de cette position avant-gardiste ne
saurait prendre la forme d’une regroupement de militants professionnels séparés de
la classe qu’ils sont censés diriger. D’une part, parce que les luttes d’usine ont atteint
un degré d’autonomie tel à l’égard du développement capitaliste et des institutions du
mouvement ouvrier qu’elles ne sont plus prêtes à déléguer leur pouvoir à une
quelconque forme de représentation 22. D’autre part, parce que les pratiques
d’appropriation immédiate de la richesse sociale mise en œuvre dans la métropole
présentent déjà un contenu communiste que nul « programme de transition »
socialiste ne saurait canaliser 23. C’est donc à l’intérieur de ces mouvements que le
parti doit se situer pour en réaliser l’articulation. Son caractère de masse dépendra de
sa capacité à ouvrir l’usine sur son dehors social, selon un double processus de
transformation des luttes métropolitaines en bases arrières du pouvoir ouvrier et de
transformation des comités d’usine en pointe avancée du refus du travail qui
s’exprime dans la société. La question que ne peuvent manquer de susciter ces
réflexions programmatiques est dès lors la suivante : si « le processus d’unification
[du prolétariat] ne peut plus être conduit ‘‘du dehors’’ mais seulement par en bas, de
l’intérieur 24 », y a-t-il encore un sens à penser l’organisation de ce processus sous le
concept de « parti » ?
Parti ouvrier contre le travail offre trois réponses à cette question, qui sont autant
d’occasions pour Negri de préciser la forme que doit prendre « l’avant-garde de
masse » et les fonctions qu’elle doit remplir. La première réponse est que le parti est
nécessaire pour démystifier les distinctions rigides entre travail productif et
improductif, entre production de survaleur et reproduction sociale, entre usine et
société, que le capital reproduit au sein du prolétariat pour le décomposer Par ses
mots d’ordre et son programme, l’organisation révolutionnaire renvoie en effet aux
travailleurs l’image de l’unité de classe sous-jacente aux différentes formes de lutte
dans lesquelles ils sont engagés et constitue à ce titre « l’autoréflexion de la
spontanéité 25 ». La seconde réponse est alors que seul le parti peut offrir à ces
différentes formes de lutte un espace de communication leur permettant de se
renforcer mutuellement et de s’inscrire ainsi dans la durée, de sorte qu’il fonctionne
comme une « courroie de transmission 26 » entre les différents fronts de la contestation
sociale. La troisième réponse est enfin qu’à elles seules, ni les occupations d’usine ni
les autoréductions ne disposent de la force nécessaire pour affronter un « État-crise »
ayant érigé l’usage de la violence contre les populations en technique de
21
22
Ibid., p. 80.
Ibid., p. 99.
Antonio Negri, Factory of Strategy , op. cit., p. 255-264.
Antonio Negri, «Workers’ Party Against Work», art. cit., p. 82.
25 Antonio Negri, Factory of Strategy , op. cit., p. 32.
26 Antonio Negri, «Workers’ Party Against Work», art. cit., p. 93.
23
24
�155
Composition, autonomie, separation. Les formes-parti d’Antonio Negri
gouvernement. Le parti est alors nécessaire, non pas en tant qu’organe de direction
stratégique du mouvement révolutionnaire, mais en tant qu’instrument de lutte aux
mains de ce mouvement, qui doit en faire un usage tactique pour défendre
l’autonomie conquise par l’ouvrier-masse dans les usines ainsi que les bases rouges
ouvertes par le prolétariat dans la métropole 27. Comme on peut le lire dans Crise de
l’État-plan : « dans la jungle de l’usine sociale les avant-gardes peuvent aujourd’hui
construire des foyers de luttes insurrectionnelle autour desquels la masse des
exploités se rassembleront 28. »
4. DANS LA JUNGLE DE L’USINE SOCIALE : LE PARTI DE LA SÉPARATION
Bien qu’elle rompe avec toute conception élitiste du rapport entre organisation
politique et mouvements sociaux, la réflexion de Negri à l’époque de Parti ouvrier
contre le travail reste dominée par deux thèses typiques du mouvement ouvrier du
XX° siècle : la thèse de la centralité politique de la classe ouvrière industrielle et celle
de la nécessité stratégique d’une opposition frontale au pouvoir d’État. La fonction du
« parti d’avant-garde de masse » est en effet bien de renforcer l’autonomie ouvrière
en y articulant toutes les luttes sociales afin de construire une force capable de partir
à l’assaut de l’État-crise. La critique du « compromis historique » menée dans
Prolétaires et État va cependant provoquer la décomposition de ce modèle politique.
Pour Negri, le compromis historique et sa sublimation théorique dans le
vocabulaire de « l’autonomie du politique » reposent sur la croyance selon laquelle il
serait possible de séparer l’État d’une société civile dominée par le capitalisme, de
manière à réformer ce dernier depuis une position politique d’extériorité. Or, pour
l’auteur de Prolétaires et État, cette stratégie d’occupation des institutions étatiques
est non seulement théoriquement naïve, mais aussi politiquement rétrograde. Elle est
politiquement rétrograde, en effet, car elle vise à recomposer un État-plan que se sont
pourtant évertuées à détruire « les luttes ouvrières dans tous les pays du capitalisme
avancé depuis plus de quarante ans 29. » Et elle est théoriquement naïve car elle
méconnait la nature réelle du rapport que l’État entretient à la société capitaliste. Ce
rapport, rappelle en effet Negri, n’est ni mécanique (l’État comme effet d’une
causalité socio-économique qui lui serait extérieure), ni expressif (l’État comme forme
de manifestation des conflits sociaux), encore moins antagonique (l’État comme
rempart contre la marchandise), mais bel et bien organique : « l’État capitaliste [est]
27
Ibid., p. 87-88 et 103.
Negri, «Crisis of the Planner-State», art. cit., p. 35.
Antonio Negri, «Proletarians and the State: Toward a Discussion of Workers’ Autonomy and the
Historic Compromise» in Books for burning, op. cit., p. 136.
28Antonio
29
�156
F RÉ DÉ RIC M ONTFE RRAND
la forme autoritaire du rapport capitaliste 30 », l’organe même de restructuration des
rapports de production. En conséquence, la classe ouvrière n’est ni hors de l’État, ni
face à l’État, mais dans et contre l’État. D’une part, parce que la crise de la loi de la
valeur provoquée par les luttes de l’ouvrier-masse a transformé le salaire en pure et
simple forme de domination politique, qui individualise une force de travail
intégralement socialisée selon des hiérarchies de revenus arbitraires. D’autre part,
parce que cette forme de domination politique s’est étendue, via la gestion étatique
de la dépense publique qui accompagne la décentralisation de la production, de
l’usine au tout de la société. De cette « subsomption réelle » de la totalité sociale sous
le commandement capitaliste, il résulte que toutes les formes de conflictualité
peuvent dorénavant prétendre à la radicalité d’une lutte pour le pouvoir, de sorte que
la distinction entre luttes ouvrières pour le salaire et luttes prolétariennes contre le
travail qui structure la stratégie politique élaborée dans Parti ouvrier contre le travail
n’a plus lieu d’être.
Au moment où il rédige Prolétaires et État, Negri considère en effet que l’usine et
la société ne constituent plus deux fronts de lutte à articuler, mais une seule et même
réalité. De 1973 à 1975, « l’usine sociale » passe ainsi du statut de slogan à celui de
concept opératoire de la critique de l’économie politique, permettant de comprendre
que la tendance à la dissolution des frontières entre travail directement productif et
travail indirectement productif s’est transformée en état de fait. À cette « unification
productive du social 31 » correspond alors l’émergence d’une nouvelle composition de
classe du prolétariat : « l’ouvrier social ». Cette nouvelle composition de classe réunit
des figures aussi différentes que le scientifique employé par l’usine pétrochimique de
Porto Marghera, l’ouvrière récemment enrôlée sur les chaînes d’assemblage de la Fiat
pour remplacer les anciens O.S devenus petit-entrepreneurs ou travailleurs à
domicile, le jeune chômeur, l’étudiant précaire quoique hautement diplômé et
jusqu’aux différents acteurs des mouvements contre-culturels. On s’étonnera sans
doute de voir une telle hétérogénéité subsumée sous une même catégorie. C’est que
l’unité à laquelle l’ouvrier social peut aspirer n’est pas sociologique, mais ontologique
et politique – donnée comme virtualité dans la dynamique de l’être social et produite
comme projet de lutte par des moyens organisationnels adéquats – conformément
aux deux versants de la « méthode de la tendance » que nous avons identifiés dans la
lecture negrienne de Lénine.
Dans Prolétaires et État, c’est sous le concept marxien d’Arbeitsvermögen qu’est
thématisée cette virtualité ontologique immanente à la nouvelle composition de
classe du prolétariat 32. Dans les Grundrisse, ce concept désigne une puissance d’agir
générique que le capital actualise comme travail productif en l’incorporant aux
Antonio Negri, «Domination and Sabotage: On the Marxist Method of Social Transformation» in
Ibid., p. 234.
31Antonio Negri, «Proletarians and the State», art. cit., p. 143.
32 Ibid., p. 150-153.
30
�157
Composition, autonomie, separation. Les formes-parti d’Antonio Negri
moyens de production 33. Pour Negri, cette puissance d’agir constitue à la fois le reste
inaliénable de toute aliénation et la possibilité de toute lutte contre l’aliénation,
quelque chose, donc, comme une « potentialité communiste 34 ». La subsomption
réelle du social sous le capital, soutient-il en effet, n’est pas telle qu’elle réduirait les
individus à l’impuissance ou condamnerait la conflictualité à n’être qu’un moyen de
la reproduction des rapports de production capitalistes. Elle révèle au contraire le fait
que cette reproduction dépend de la capacité du capital à fonctionner comme
appareil de capture de la puissance de travail, de traduction de sa force productive en
travail productif, de sorte que toute activation de l’Arbeitvermögen qui refuse son
inscription dans la forme-travail ou en excède les coordonnées peut être envisagée
comme un sabotage du rapport capitaliste. Le problème de Negri est dès lors le
suivant : comment renverser le refus du travail en autovalorisation, activer la
puissance de travail en force-invention, radicaliser l’antagonisme en séparation ?
Autovalorisation, force-invention, séparation. Ces trois concepts constituent la
grammaire générative du langage politique élaboré dans Domination et sabotage. Le
premier renvoie à l’ensemble des pratiques par lesquelles l’ « ouvrier social » satisfait
et développe ses besoins hors de la médiation de l’échange marchand, aux différentes
activités militantes ou culturelles qui contribuent à la reproduction d’une « société
prolétarienne 35 » immanente et antagonique à l’usine sociale. Le second concept
désigne quant à lui la créativité, l’inventivité, la vitalité qui s’expriment dans toutes ces
activités : il est le genre dont elles sont les espèces, l’universel concret dont elles sont
les instanciations particulières, voire le commun dont elles sont les moments
singuliers. Enfin, le troisième concept, modulé dans Domination et sabotage en
« dialectique » et en « logique de la séparation » rend compte du processus de
subjectivation collective par lequel l’ouvrier social se produit comme acteur politique
dans le mouvement même par lequel il révèle la vacuité du commandement
capitaliste sur la société 36. Car ce commandement, soutient Negri, n’a plus d’autre
contenu que la répression qu’il exerce sur la série de comportements subversifs à
travers laquelle se profile le « mouvement effectif qui abolit l’état de chose
existant 37 ».
On le voit, la « dialectique de la séparation » implique une redéfinition du
communisme comme processus de production de subjectivités communistes. Mais ce
processus ne saurait être confondu avec une quelconque forme de retrait utopique
hors du monde du capital. Il implique en effet l’élaboration d’un programme de lutte
Voir Karl Marx, Manuscrits de 1857-1858 dits « Grundrisse », trad. J.-P. Lefebvre et alii, Paris,
Éditions sociales, 2011, p. 252-254.
34 Antonio Negri, «Proletarians and the State», art. cit., p. 155.
35 Antonio Negri, «Domination and Sabotage», art. cit., p. 272.
36 Ibid ., p. 236-238.
37 Karl Marx et Friedrich Engels, L’Idéologie alllemande, trad. H. Augier, G. Badia, J. Baudrillard et
R. Cartelle, Paris, Éditions sociales, 1976, p. 33 (trad. mod.).
33
�158
F RÉ DÉ RIC M ONTFE RRAND
comprenant un ensemble de mesures communistes, parmi lesquelles Negri cite
notamment la réduction drastique du temps de travail et l’instauration d’un salaire
social également distribué à tous les prolétaires quelle que soit la position qu’ils
occupent dans le procès de production 38. Ce salaire social n’est cependant pas la fin,
ou l’objectif stratégique, que visent les luttes de l’ouvrier social, mais un simple
moyen, ou un moment tactique favorisant sa recomposition au même titre que ces
autres moments que sont la grève et les autoréductions, l’offensive armée ou les
occupations. C’est à ce niveau que ressurgit le « problème du parti », que Negri
envisage dorénavant comme l’indice d’une « contradiction réelle » 39 dont on peut
restituer les termes comme suit.
D’un côté, le parti rassemble une série de fonctions nécessaires à la lutte
révolutionnaire : alignement des objectifs stratégiques et des moments tactiques,
élaboration et diffusion d’un programme, circulation des informations entre
différents foyers de contestation sociale. D’un autre côté, sa verticalité et ses tendances
centralisatrices risquent toujours de le transformer en obstacle au processus expansif
de l’autovalorisation, dont le caractère ouvert est d’autant plus puissant qu’il laisse
plus de place à l’inventivité et à l’autonomie. Mais surtout, précise Negri, il n’est
aucune des fonctions partidaires que nous avons listées (alignement de la tactique et
de la stratégie, formulation du programme, circulation des informations) qui ne
puisse être directement prise en charge par une « enquête de masse » menée par
l’ouvrier social sur lui-même 40. Rapportée à Domination et sabotage, cette « enquête
de masse » annoncée à la fin de Prolétaires et État apparaît comme un organe de
liaison entre des « mouvements révolutionnaires individuels » autonomes, c’est-à-dire
comme l’infrastructure d’un « réseau diffus de pouvoirs » progressivement étendu à
l’ensemble de l’usine sociale 41. Dans cette perspective, que Negri n’hésite pas à
qualifier de « pluraliste », il ne semble plus guère y avoir de sens à mobiliser le
concept de « parti ». Lorsque toutes les médiations qui lui sont traditionnellement
associées sont fluidifiées par l’enquête, lorsque celle-ci n’est plus la condition de
l’organisation, mais sa matérialité même, il n’y a en effet plus de parti, mais un
processus d’auto-organisation réticulaire, au sein duquel émergent ponctuellement
ces fonctions de type partidaire que restent pour Negri les moyens défensifs et
offensifs dont use parfois l’ouvrier social pour assurer la continuité de sa séparation
d’avec la société capitaliste 42.
5. EN GUISE DE CONCLUSION
Antonio Negri, «Proletarians and the State», art. cit., p. 162-163.
Antonio Negri, «Domination and Sabotage», art. cit., p. 275.
40 Antonio Negri, «Proletarians and the State», art. cit., p. 169.
41 Antonio Negri, «Domination and Sabotage», art. cit., p. 279.
42 Ibid ., p. 277.
38
39
�159
Composition, autonomie, separation. Les formes-parti d’Antonio Negri
Que peut-on retenir de la séquence composition – autonomie – séparation que
nous avons parcourue dans cet article ? Assurément pas des modèles d’organisation
transposables tels quels dans le présent, tant les conditions économiques, sociales et
politiques qui conféraient un sens à cette séquence ont changé. Tant, aussi, nous
avons appris de Negri lui-même que la validité d’un concept théorique et la valeur
d’une hypothèse politique dépendent de leur capacité à donner prise sur les
tendances qui se disputent la direction du présent. À une époque comme la nôtre, où
le marxisme semble osciller entre l’exaltation vertueuse de la résistance au capital et
la description complaisante de son absolutisme, il n’est dès lors sans doute pas inutile
de retenir de Negri ce qu’il retenait lui-même de Lénine : une méthode de lecture du
réel et d’intervention dans la conjoncture qui, toujours, s’efforce de concevoir
ensemble et de manière dynamique les transformations de l’État, les mutations du
capitalisme et les possibilités ouvertes à la praxis. À cet égard, la proposition
stratégique sur laquelle nous avons clôt nos réflexions, qui fait de l’enquête militante
la médiation entre ontologie de la production et projet collectif de libération,
pourrait constituer un piste de recomposition politique digne d’être réexplorée 43.
Pour l’esquisse d’un programme d’enquête politique ajusté au présent, voir Davide Gallo Lassere
et Frédéric Monferrand, «Autonomia e soggettività: l’inchiesta ieri e oggi», Primo Maggio, n°30, 2018,
p. 70-79, disponible en ligne sur http://www.fondazionemicheletti.eu/altronovecento/files/PrimoMaggio_Numero-speciale.pdf
43
�160
�161
Etica & Politica / Ethics & Politics, XX, 2018, 1, pp. 161-186
ISSN 1825-5167
DALLO STATO PIANO AL NUOVO
ORDINE DELLA GLOBALIZZAZIONE.
LA SOVRANITÀ IN ANTONIO NEGRI
PAO LO S CA NGA
paolo.scanga@gmail.com
ABSTRACT
Antonio Negri’s thought is a reflection on the concept of sovereignty. Since the end of the 1950s
until the most recent texts, Negri works on and against the concept of sovereignty, identifying
limits, breaches and advances through the critique of political economy. In this paper we consider
some texts of a very large production, that allow us to highlight these crucial elements. From the
essays of philosophy of law in La Forma Stato, passing through the pamphlets contained in I libri
del rogo, from the intellectual production during 1980s and 1990s, until Empire. These are phases
that coincide with the end of the – so called by Negri – planner-State and with the birth of the
Stato-crisi, stages whose latest development is the emersion of a new global order after the fall of
the Sovietic Union and the end of the Cold War.
KEYWORDS
State, Empire, Governance, Costitution
1. INTRODUZIONE
In termini preliminari intendiamo sostenere che il lavoro filosofico e politico di
Antonio Negri possa essere interpretato come un enorme corpo a corpo con la
questione della sovranità, la quale rappresenta il fil rouge che accompagna tutta la
sua produzione. Trattandosi di un lavoro troppo ampio per essere ripreso nella sua
interezza, quello che proponiamo sarà provare ad individuare e far risaltare, anche se
in modo schematico e sicuramente parziale la continuità di ragionamento, i salti, le
cesure presenti nel discorso negriano.
Vorremmo, inizialmente, partire da un testo peculiare. Si tratta del lemma
«sovranità» che scrisse per l’enciclopedia Feltrinelli-Fischer, in cui Negri fa emergere
come la genesi del concetto moderno di sovranità sia strettamente legata alla genesi
�162
P A OLO S C A NGA
dello Stato. In esso è presente una formulazione sintetica del concetto di sovranità,
che reputiamo utile attraversare per cercare di fissare e mettere in luce elementi che
andremo ad esaminare e sviscerare durante il lavoro. Fin dagli albori della modernità
vi è stata una lotta tra Stato-macchina e società civile, ma nella metà del Settecento
essa raggiunge la sua maturità. È nella radicale definizione di Rousseau che il
concetto di sovranità viene a rappresentare «la figura pienamente sviluppata
dell’egemonia borghese sulla società, concetto produttivo, organico, trionfale nel
momento in cui coglie ed interpreta la pienezza del processo rivoluzionario borghese
verso la conquista dello Stato» 1 . In questi termini il concetto di sovranità ha
rappresentato l’elemento centrale della definizione dello Stato. Si è articolato in
riferimento agli aspetti ed alle vicende fondamentali della storia delle istituzioni
statuali ed è stato nella formalizzazione del suo contenuto che il concetto di sovranità
ha sviluppato la dimensione giustificatrice della forza statuale della borghesia. Nel
corso del XX secolo il concetto di sovranità entra in crisi per via del coordinato
movimento del concetto di sovranità nazionale che va superandosi e quello di
sovranità popolare che va svuotandosi. Quella fattispecie di determinazione di potere
che cercava in sé la sua giustificazione e la trovava nell’egemonia borghese sullo
Stato, non rinviene più un terreno adatto al proprio affermarsi. D’altra parte,
sia il superarsi del concetto verso la sovranazionalità, sia il processo della sua
formazione sono effetto delle trasformazioni indotte dalla lotta di classe: la
sovranazionalità copre l’effettività di una ordinazione generale del movimento
del potere capitalistico a livello internazionale nel tentativo di fare di questo
terreno di scontro e di vittoria sui movimenti internazionali di classe; la
formazione allude ad una possibilità di uso sovrano della forza che è puramente
repressivo,- diretto annichilimento politico della pressione di classe sullo Stato.
L’obsolescenza del concetto di sovranità è del tutto connessa- come del resto
avviene per tutte le situazioni giuridiche- all’obsolescenza dei rapporti reali che
registra. La natura borghese del concetto di sovranità viene così chiarita
soprattutto dall’avvertimento della sua crisi 2.
Brevi battute che ci consegnano delle importanti linee di ricerca. In particolar
modo, quello che ci proponiamo di fare è mettere in luce il punto di vista di Negri
nel riflesso del concetto di sovranità. Il metodo che Negri fa proprio è quello
operaista, approfondendolo assume il posizionamento marxiano di contrapposizione
tra operai e capitale, facendone risaltare il carattere antagonistico. Il suo sarà sempre
il punto di vista operaio e proletario, il punto di vista dell’operaio sociale e della
moltitudine. La celebre definizione che diede di Stato, nell’introduzione
dell’Enciclopedia, ci consente di esplicitare la sua postura. Alla scienza accademica lo
Stato, definito sempre in relazione alla sovranità moderna, si è presentato
1
2
Negri, A. (1970), Scienze Politiche 1. Stato e politica, Milano: Feltrinelli, p. 483.
Ivi, pp. 485-486.
�163
Dallo Stato piano al nuovo ordine della globalizzazione.
La sovranità in Antonio Negri
costantemente come un concetto ambiguo. Di fatti, da un lato, tende ad essere
rappresentativo del potere in quanto tale, dall’altro appare come il limite di una serie
di connotazioni: lo Stato come sovranità, come diritto o come politica fiscale e
assistenziale. Dentro queste considerazioni, lo Stato appare come un orizzonte, un
insieme inconcluso eppure effettivo, che solo l’insieme dell’esperienza politica può
permettere di definire. Per la scienza accademica quindi si trae la conseguenza di una
indefinibilità dello Stato. Ma non è per questa indefinibilità, ci dice Negri, che
lo Stato viene considerato una realtà che l’uomo nuovo, prodotto dello sviluppo
capitalistico, quest’uomo che sa natura e storia non come un nesso oscuro ma
come sua propria realtà, costruita e offerta nel lavoro e nello sfruttamento che
l’organizzazione del lavoro determina, sente come un’impostura da distruggere,
distruggendo tutte le forme attraverso le quali lo Stato si fa realtà di dominio.
Quasi rispondendo ad una lunga e dolorosa quanto terribile domanda degli
oppressi di tutti i tempo, il proletariato moderno, reso padrone del mondo da un
modo di produzione alienante e mostruoso, capisce ormai lo Stato insieme come
suo prodotto e come sua alienazione, tutto dentro la produzione e l’alienazione
del lavoro . Il suo rapporto al potere è un rapporto che solo l’odio e l’ansia di
distruzione sanno caratterizzare 3.
Lo Stato è ancora un limite, quindi, non più astratto ma terribilmente concreto, di
distruzione pratica. Vedere come funziona è sapere quello che esso è: la prassi nutre,
in questo caso, la teoria per imporle la propria dissoluzione. Attraverseremo, con il
nostro lavoro, una selezione di testi che ci permetteranno di porre in risalto questa
lettura. Ci muoveremo in senso diacronico, adoperando testi che hanno segnato il
dibattito politico, accademico e militante del lungo Sessantotto italiano, passando per
la galera e l’esilio parigino, anni difficili ma importanti, in cui continua la ricerca
teorica. Fino agli ultimi tre decenni iniziati con la nascita di una rivista come «Futur
Antérieur» e proseguiti con la pubblicazione di testi, scritti insieme a Michael Hardt,
che hanno avuto una rilevanza internazionale, come Impero 4.
2. GLI ANNI SESSANTA E LA COSTITUZIONE.
Per il nostro lavoro gioca un ruolo fondamentale quella raccolta di saggi, di articoli
prodotti tra il 1964 e il 1977, La forma Stato. Una magnifica opera di filosofia del
diritto, di critica dell’economia politica della Costituzione, di indagine sulle
Ivi, p. 10.
Si vedano i due volumi di biografia curati da G. De Michele Negri, A. (2015), Storia di un
comunista , Milano: Ponte alle Grazie; Negri A. (2018), Galera ed esilio. Storia di un comunista, Milano:
Ponte alle Grazie.
3
4
�164
P A OLO S C A NGA
trasformazioni dell’amministrazione, dei soggetti e della forma dello Stato. Nella
metà degli anni Sessanta Negri approfondisce l’opera marxiana, la pratica politica
diventa centrale. Il punto di vista per una lettura della Costituzione materiale e
formale è quello del militante. Rappresenta un fondamentale punto di rottura nella
teoria negriana, in quel momento «muore Hegel, finisce la dialettica». La critica
operaia è la scoperta del terreno e della forma dello scontro, non può più essere
rappresentato come un mondo dialettico. Il lavoro nella Costituzione, pubblicato per
la prima volta nel 1964, è il primo testo con cui Negri rompe con il pensiero di
Lukács. Si tratta di un lavoro già molto distante rispetto alla sua opera del ’62, Alle
origini del formalismo giuridico5, in cui auspicava l’urgenza di un opera dialettica sul
diritto, cercando in essa la risoluzione di una serie di problemi che il formalismo non
era capace di risolvere. Speranza che ne Il lavoro nella Costituzione diventa vana, il
formalismo diventa reale, il diritto si radica nella realtà. A questo punto diventa
chiaro a Negri, che solo la critica rivoluzionaria, la critica dall’interno delle cose e
degli eventi della realtà, è di aiuto 6.
Le lotte operaie in Italia, nella metà dei Sessanta, si innestano dentro un ciclo di
sviluppo consistente e iniziano a segnare una prima grande frattura all’interno della
capacità di governo borghese, scrive Negri:
nella società-fabbrica la distinzione tra costituzione economica e costituzione
politica cade; l’unificazione nel capitalista collettivo, nel capitale sociale non
esige più mediazioni di sorta; perciò la regola dell’accumulazione, la sua interna
gerarchia, la sua disciplina, insomma il lavoro come processo lavorativo e come
processo di valorizzazione del capitale, vengono assunti quale scheletrico
sostegno della intera organizzazione sociale del potere. Tutte le alternative
privatistiche che i singoli capitalisti possono esprimere vengono ora bruciate non
dalle leggi di sviluppo ma dalla legge politica direttamente espressa e
direttamente efficace del capitale collettivo. Lo Stato si configura come organo
esecutivo del capitale collettivo, come diretto gestore della produzione sociale 7.
Il lavoro nella Costituzione si presenta come il tentativo di verificare l’attualità
della Carta costituzionale alla luce delle profonde trasformazioni intervenute nel
capitalismo italiano a quindici anni dalla sua entrata in vigore e ci consegna anche
uno studio estremamente prezioso sulle trasformazioni che stavano travolgendo la
forma Stato e i meccanismi della sovranità. L’analisi non riguarda la logica dei
sistemi o delle forme, ma quella dell’economia politica. L’esame è condotto secondo
un apparato categoriale nuovo rispetto al marxismo scolastico: capitale e Stato
sociale, costituzione materiale e formale, riformismo capitalistico e lotte operaie e,
Negri, A. (1962), Alle origini del formalismo giuridico. Studio sul problema della forma in Kant e
nei giuristi kantiani tra il 1789 e il 1802, Padova: Cedam.
6 Negri, A. (1977), La forma stato. Per la critica dell’economia politica della Costituzione, Milano:
5
Feltrinelli, p. 110.
7 Ivi, p. 33.
�165
Dallo Stato piano al nuovo ordine della globalizzazione.
La sovranità in Antonio Negri
soprattutto, il concetto di lavoro produttivo. Si inaugura, con questo testo, il terreno
specifico su cui è possibile considerare il lavoro dal punto di vista della produzione
dei processi istituzionali e costituzionali, cioè della teoria dello Stato.
Lo Stato di diritto presupponeva, pur velandola nella misura in cui formalizzava
lo Stato e il diritto, una sua costituzione materiale economica, ovvero quella
dell’autoregolazione degli interessi individuali capitalistici. Ora, nella prospettiva di
queste nuove esigenze di gestione del capitale sociale, lo Stato sociale non è Stato
garantista. Se mette in atto elementi repressivi, lo fa contro chi non accetta
l’integrazione, contro chi si oppone all’obiettività capitalista della regola di partizione
del prodotto sociale. Questa contraddizione presente nello Stato di diritto, ora, viene
eliminata dallo Stato sociale: lo sviluppo capitalistico risponde positivamente,
facendo dell’intera società il medium dell’appropriazione e trasmutando l’oggetto
dello sfruttamento in soggetto della gestione dell’accumulazione sociale 8. È dentro
questo panorama che viene a definirsi l’unità sociale del capitale come un fine e non
come una premessa. Ciò rappresenta una conquista e una costruzione
sull’antagonismo di classe che sempre si riapre, la continua ricomposizione al
proprio interno della forza-lavoro, fino al limite della sua costituzionale collocazione
nella struttura sociale del capitale. Quando il capitalismo industriale diviene
egemone nella società contemporanea, quando il capitale si struttura a livello sociale
sviluppando in termini altrettanto generali il processo di accumulazione,
cominciamo a vedere la legge piegarsi a queste esigenze: vengono affermandosi
prima una legislazione previdenziale legata ad una concezione produttivistica, poi
addirittura una legislazione di protezione sociale 9 . Si rientra in fabbrica, ma per
incontrare l’operaio come «forza lavoro». Quello che Negri cerca di registrare, come
abbiamo detto, è l’adeguatezza della Costituzione del ’48 al movimento complessivo
del capitale, ma anche quella crisi prodotta e aperta dalle lotte operaie. Con
l’esaurimento dello Stato di diritto cade il velo ideologico che nascondeva la reale
funzione degli articoli costituzionali e il lavoro diventa il principio costitutivo della
forma dello Stato10. La costituzionalizzazione della forza lavoro si presenta quindi in
un processo mai concluso, la sua collocazione nella struttura sociale del capitale è
sempre precaria, sempre a rischio. Il modello statuale trova l’inveramento nello Stato
sociale, che è sempre pianificato, Stato-piano11. La realizzazione della costituzione
8
Ivi, p. 46.
Ivi, pp. 53-54.
10 Sersante, M. (2012), Il ritmo delle lotte. La pratica teorica di Antonio Negri (1958-1979) , Verona:
Ombre Corte, p.54.
11 «Lo Stato di diritto assume la forma sociale che il capitale sempre produca quali che siano le modalità
del suo sviluppo empirico. Lo Stato di diritto è già Stato sociale perché la forma della garanzia giuridica è
direttamente contraddittoria con il suo contenuto particolare. Lo Stato di diritto è Stato di guarentigie
private, è Stato che recepisce e garantisce, nella forma del diritto, quando il mondo economico sociale
spontaneamente produce». Negri, A. (1970), p. 82
9
�166
P A OLO S C A NGA
laborista segna il passaggio allo Stato sociale e alla società-fabbrica. La
costituzionalizzazione del lavoro non è solo oggettivamente data dalla socializzazione
della forza-lavoro, ma è da questa soggettivamente imposta. Difatti, al massimo di
intensità formale dell’unificazione dello sviluppo nel modello non può non seguire
un massimo di unificazione attorno al valore-lavoro. Lo Stato sociale pianificato
viene a costituire dentro questa cornice appena descritta, la forma compiuta. Si
presenta come unità del progetto, articolazione processuale della sua realizzazione,
adeguata organizzazione dell’intero movimento. La critica dell’economia politica
ritorna fondamentale quanto più il capitale a livello sociale si sviluppa e tanto più si
afferma compiutamente l’unicità del valore-lavoro nel determinare il processo di
valorizzazione. L’unicità del processo di valorizzazione attraverso il lavoro rivela- nel
ventennio del dopoguerra- l’intensità del progetto capitalistico di unificazione sociale.
Il modello, nella misura in cui è anche un progetto, rivela il meccanismo di
realizzazione del valore nel mondo sociale. Pianificare, quindi, significa assumere il
lavoro a fondamento unico del valore sociale e ricostruire l’intero ordinamento
giuridico, sociale e politico12 . La cattura della classe operaia nelle istituzioni del
capitale non può che essere resa possibile dalla trasformazione della forza lavoro
sociale in popolo, ovvero della sua assunzione come prerequisito della societàfabbrica e della forma di repubblica democratica. La costituzionalizzazione della
forza lavoro si risolve in questo processo mai concluso. Il rapporto tra la società e lo
Stato non è più attraversato da mere contraddizioni facilmente risolvibili e la
conflittualità si mostra per quella che effettivamente è: puro antagonismo. Siamo,
come sottolineavamo precedentemente, al di là della dialettica. Non è più sufficiente,
ci dice Negri, il riformismo del capitale per far fronte a questa conflittualità
permanente. Entrano in gioco altri elementi, il principio di autorità si palesa e si
esprime. Il compito è svolto direttamente dallo Stato che assume la nuova
qualificazione di Stato sociale in quanto capitalista collettivo, garante della tenuta del
processo di valorizzazione nella sua globalità. Ogni conflitto tra i due livelli- dal
giuridico al materiale- deve essere risolto, qui dentro, in favore dell’elemento
economico: il contenuto della soluzione dei conflitti è condizionato e subordinato a
quel criterio. Se i conflitti toccano semplicemente la forma dell’accumulazione, essi
sono ammessi, infatti, tanto più il processo si perfeziona, quanto più il conflitto
diviene la forma stessa dell’accumulazione. Ma se il conflitto si trasforma in
antagonismo e tocca l’accumulazione nella sua sostanza materiale, ecco che la
coazione viene fatta intervenire. Tali sono le leggi del capitale. Siamo ormai «oltre la
12 «Si
capisce come la normazione pianificatoria produca non solo una modificazione degli elementi
particolari della struttura dello Stato ma addirittura una nuova configurazione della sua forma politica. Ciò
avviene perché l’attività pianificatoria, in quanto realizza l’unicità del processo di valorizzazione attraverso il
lavoro, è in sé un’attività diffusa, e in quanto diffusiva, globale. Non può che esserlo e deve perciò
strutturarsi in modo che tale globalità sia reale». Ivi p.95.
�167
Dallo Stato piano al nuovo ordine della globalizzazione.
La sovranità in Antonio Negri
speranza della conciliazione pacifica e graduale» 13, oltre ogni possibile riformismo.
Negri è arrivato a maturare la consapevolezza della parzialità del punto di vista
operaio sulla totalità del sistema.
3. IL LUNGO SESSANTOTTO.
L’analisi operaista nella prima metà degli anni Sessanta aveva mostrato il
riassorbimento della borghesia nella rivoluzione capitalistica. Con la sua sussunzione
reale nel nuovo Stato del capitale sociale, anche la storia della borghesia come classe
ideologica e politica si conclude. Uno dei testimoni di questo passaggio cruciale, per
Negri, è stato Keynes, ultimo erede della «ragionevole ideologia» di Cartesio. La
risposta dell’economista ha ricalcato, per molti versi quella definita nel Seicento:
allora si trattò dello Stato macchina, ora dello Stato sociale o dello Stato-piano14. Lo
Stato che nasce dopo la crisi del 1929 conclude la storia dello Stato liberale
ottocentesco ma anche, in generale, la storia dello Stato moderno iniziata nel
Seicento, di cui lo Stato di diritto può essere considerato l’ultima tappa. Al posto
della borghesia, a occupare la società è la classe operaia, mentre la società civile è
diventata una società-fabbrica. Quindi, per Negri, il ’68 si presenta come il capolinea
del 1929: dal momento che non si limita a registrare la socializzazione dello sviluppo
economico, ma lo pianifica, è contro lo Stato piano che la classe operaia muove
l’assalto 15.
Questo capolinea, conclusosi nel ’69 in Italia, rilancia un ciclo di lotte cominciato
dieci anni prima, forzando le avanguardie di classe a scelte di tipo organizzativo. Nel
1971 scrive Crisi dello Stato-Piano come relazione del convegno nazionale di Potere
Operaio. Da questo momento i Grundrisse prendono il posto del Capitale. Dai
lineamenti di Marx Negri prende in considerazione il concetto di denaro come
capitale, perché esso allude al mondo della ricchezza privata e della concorrenza
capitalistica, cioè a quel mondo attraversato da contraddizioni e crisi. Basta non
perdere di vista quel rapporto che intercorre tra il denaro e la produzione. La
riflessione marxiana sulla tendenza serve al Negri militante per fissare il programma
di cui l’organizzazione deve farsi carico. Il comunismo è attuale, ogni passaggio
Ivi, pp. 104-105.
Fondamentale è il testo John M. Keynes e la teoria capitalistica dello stato nel ’29 . Gli altri lavori in cui
legge in chiave di storia del pensiero politico e di critica marxista delle istituzioni filosofi ed economisti sono:
Negri, A. (1967), Problemi di storia dello stato moderno. Francia:1619-1650 , in «Rivista critica di storia della
filosofia», II; Negri, A. (1970), Descartes politico o della ragionevole ideologia, Milano: Feltrinelli; Marx sul
ciclo e la crisi che si trova, insieme al testo su Keynes, in Bo logna, S., Rawick, G. P., Gobbini, M., Negri, A.,
Ferrari Bravo, L., Gambino, F., (1972) Operai e stato. Le lotte operaie e riforma dello stato capitalistico tra
rivoluzione d’Ottobre e New Deal, Milano: Feltrinelli.
13
14
15
Sersante, M. (2012), op. cit., p. 80.
�168
P A OLO S C A NGA
intermedio va bruciato, la lotta di classe punta direttamente e immediatamente
contro lo Stato. «Ma dobbiamo dimostrarlo all’interno del movimento della tendenza
perché questo metodo ha importanti conseguenze sulla definizione del modello
organizzativo, sul nesso tra programma e organizzazione. Questo è il significato del
materialismo dialettico: saper riportare, anzi nutrire dell’analisi reale la crescita del
soggetto storico rivoluzionario, e non solo nelle questioni generali»16. Allo Stato è
attribuito un ruolo egemone nella sequenza impresa-piano-Stato, la fabbrica si è
subordinata allo Stato che deve garantire le condizioni fondamentali del
funzionamento del sistema, del sistema delle fabbriche in primo luogo. Attraverso lo
Stato il valore di scambio ha trovato una garanzia a valere come legge generale di
riproduzione delle condizioni produttive. Questo meccanismo ha smesso di
funzionare: è stata rotta, a partire dalla fabbrica fino a investire tutta la società, la
legge che lo Stato doveva garantire. Nelle lotte massificate dell’operaio-massa, il
lavoro si è sganciato dal valore del lavoro. È qui che avviene il rovesciamento della
sequenza Stato-piano-impresa. Se fin qui lo Stato aveva coperto un ruolo egemone,
rappresentando e garantendo l’equivalenza nel movimento dei fattori, la caduta della
norma di equivalenza subordina la funzione dello Stato rispetto a quella dell’impresa.
Se fino a questo punto lo Stato aveva ordinato tutte le condizioni della produzione
sociale, l’attacco operaio le svaluta tutte e impone alla coscienza capitalistica
l’affidamento all’unica condizione che non può venire meno: il comando d’impresa
nell’estrazione del pluslavoro. Attraverso il meccanismo dell’inflazione la crisi del
sistema si è fatta crisi dello Stato. A livello di mercato mondiale, lo Stato-crisi si
presenta oggi come crisi dello «Stato nazionale» rispetto alla forma dell’impresamultinazionale- del comando capitalistico17. Il progetto capitalistico, scrive nel ’71,
non interpreta solo la forza dell’impatto operaio sulla struttura dello Stato
pianificato: tenta di interpretarne anche la forma, la figura cioè in cui esso si è
sviluppato, la figura dell’operaio-massa. Centrale diviene il passaggio da Stato-piano
allo Stato-crisi, che è- data la simultaneità di crisi e ristrutturazione- anche lo Statoimpresa. Questa la situazione dentro cui l’organizzazione deve muoversi:
l’appropriazione è il rivelarsi di una nuova figura di soggetto storico rivoluzionario, è
il lavoro astratto fattosi insieme generalità e individualità e riconoscimento che le
forme della produzione passano sempre più dalla contraddizione all’antagonismo
con le forze sociali della produzione. Il programma- dentro questa composizione di
capitale e quindi di classe- non può che svilupparsi dentro il terreno
dell’appropriazione generalizzata 18.
Nel 1974 esce su «Critica del diritto» Su alcune tendenze della più recente teoria
comunista dello Stato: rassegna critica, un altro importante testo che ha come suo
centro il concetto di sovranità, in primis analizzato nel contesto del dibattito pubblico
Negri, A. (2006), I libri del rogo, Roma: DeriveApprodi, p. 36.
Ivi, p. 41.
18 Ivi, p. 48.
16
17
�169
Dallo Stato piano al nuovo ordine della globalizzazione.
La sovranità in Antonio Negri
di quegli anni. L’abbiamo visto, il grande capitale monopolistico, questa necessaria
escrescenza dello sviluppo capitalistico, assume su di sé il comando sui movimenti
dello Stato, in modo continuo e puntiforme. Lo Stato perviene a fusione con il
grande capitale monopolistico, come parte specifica e delimitata del capitale
complessivo, ed è a quest’ultimo subordinato. L’eventuale modificazione delle
strutture giuridiche- che siano gestionali e/o proletarie- del grande monopolio non
incide, sul rapporto di subordinazione dello Stato, anzi accentua la compenetrazione
delle élite dirigenti e ribadisce il carattere e la direzione del comando monopolistico.
Il rapporto strumentale di subordinazione non è neppure modificato- anzi semmai
accentuato- dallo sviluppo di una organizzazione sovranazionale e/o multinazionale
dei monopoli di Stato 19 . A quella teoria del capitalismo monopolistico di Stato
sembra, invece, completamente sfuggire la qualità del rapporto tra capitale e Stato, il
fatto cioè che la loro articolazione si sviluppa sul piano della società intera, che viene
assorbita, nella sua complessità, dalle esigenze di riproduzione del capitale. Da
questo punto di vista la teoria del capitalismo monopolistico di Stato si presenta
come una variante delle teorie élitiste dello Stato, e dimentica- nell’ambito stesso
dell’analisi dello specifico statale- alcuni consistenti elementi della materialità
dell’organizzazione statale-la legalità, la «sua» giustizia, il richiamo al «consenso», la
continuità ed efficacia dei meccanismi di mediazione. Dal punto di vista
metodologico questa teoria muove insieme da una neutralizzazione estrema delle
categorie del marxismo e dell’estremizzazione del feticismo dell’ideologia,
dell’autonomia dell’ideologia e della volontà politica delle masse 20. Negri sottolinea
come in Marx sia tra i Grundrisse e il Capitale che avviene la sintesi della società
politica nella forma dello Stato. Lo Stato- scrive Negriviene man mano interiorizzando la mediazione attraverso l’organizzazione
della società: l’emancipazione dello Stato dalla società civile è solo la condizione
di un successivo ripiegamento dialettico e mediatorio sulla, nella società civile,
dentro il suo tessuto conflittuale, alla stregua della lotta di classe. La mediazione
della dialettica fra funzione repressiva ed organizzatoria diviene figura, vita e
progresso dello Stato capitalista. Lo Stato è, da questo punto di vista, un capitolo
del Capitale 21.
Negli anni Sessanta, la critica marxista ha posto questa tematica in modo
soddisfacente. L’insistito richiamo alla metodologia marxiana della astrazione
determinata della tendenza e della totalità concreta ha permesso di ridefinire il
corretto orizzonte della definizione marxista dello Stato. L’analisi strutturale dello
Stato capitalistico si fonda sul livello della produzione di merci, come momento
Negri, A. (1977), op. cit. 196.
Ivi, pp. 198-199.
21 Ivi, p. 201.
19
20
�170
P A OLO S C A NGA
essenziale dell’antagonismo capitalistico. Il «doppio carattere» del processo
produttivo- come segno dell’antagonismo di classe che presiede all’organizzazione
capitalistica del processo lavorativo diretto- investe l’intero ambito della circolazione
del capitale ed è impossibile definire fasi o momenti che si rendano, nel campo del
processo complessivo, indipendenti o autonomi rispetto all’antagonismo iniziale. Un
tentativo di definizione dello Stato dovrà ridiscendere –seguendo un cammino
marxiano- dall’ambito della circolazione del capitale (e della sua socializzazione)
come ambito di riproduzione allargata degli antagonismi produttivi, all’ambito della
produzione diretta. «Il concetto di Stato emerge, quindi, dialetticamente dal
contrasto antagonistico, laddove sia il meccanismo di continua tendenziale ideale
unificazione del controllo, sia del processo di profonda radicale estraneazione
dell’emergenza di classe, cooptano la realtà dello Stato- sempre più- a figura di
organizzatore complessivo dello sfruttamento» 22 . È dal punto di vista delle lotte
operaie che si assiste ad un duplice processo: da un lato lo Stato è costretto ad
intervenire sempre più pesantemente nella produzione, a configurarsi come
rappresentante del capitale sociale, a trasformare in realtà la sua tensione ad
impersonificare il «capitalista collettivo ideale»; dall’altro, nella misura in cui questo
avviene sul ritmo della lotta di classe, sempre più lo Stato riconquista una relativa
autonomia di comportamento. Non però nei confronti della classe dei capitalisti, non
nel confronto con la regione di sfruttamento dello sviluppo capitalistico, bensì a
fronte delle ragioni di valore e di progresso che contraddittoriamente legittimavano
lo sviluppo capitalistico stesso. Lo Stato diviene rappresentante collettivo del capitale,
sostituto del rapporto automatico del capitale sociale, partito della borghesia in senso
pieno, quando le lotte operaie incidendo sul rapporto di capitale, ponendosi in crisi,
svalorizzandone i contenuti, lo costringono a ciò 23.
Questa analisi strutturale dello Stato viene completata con un’analisi della crisi,
con una definizione- e lo vedremo maggiormente nel dettaglio in seguito- della
composizione tecnica e politica del proletariato, che riqualifica, in questo senso, la
teoria marxiana del valore24. Tutta la struttura dello sfruttamento aumenta dentro il
salto qualitativo che il capitale e Stato compiono. La rilevanza dei momenti
soggettivi, l’emergenza del punto di vista soggettivo di classe divengono allora
l’elemento decisivo, a partire dal quale l’analisi può essere sviluppata e completata.
Lo sviluppo della teoria dello Stato, fra Keynes e New Deal,- come abbiamo
sottolineato precedentemente- è stato condizionato da una riflessione sulle cause
della grande crisi capitalistica del ‘29. La concezione che ne deriva è fondata, oltre
che su un gigantesco sforzo di ristrutturazione tecnica della composizione di classe
(dall’operaio professionale all’operaio-massa), sul tentativo di fare dello Stato una
macchina dinamica di mediazione pianificata e riformista dello sviluppo
22
23
24
Ivi, pp. 208-209.
Ivi, p. 210.
Ivi, p. 221.
�171
Dallo Stato piano al nuovo ordine della globalizzazione.
La sovranità in Antonio Negri
capitalistico. Il concetto di capitale si ricostruisce sullo Stato, il concetto di valore non
è più né sostanza né misura ma semplicemente espressione della volontà di
mediazione degli antagonismi sociali, espressa dallo Stato25. Ora, invece, si presenta
la Crisi dello Stato-piano, ovvero la crisi di queste procedure di pianificazione. Ciò
non significa che la progressione verso la figura dello Stato come totale
rappresentante del capitale collettivo venga meno. La crisi dello Stato-piano si
presenta come un incentivo ad un ulteriore passo in avanti, ad un nuovo salto
qualitativo del rapporto Stato-produzione capitalistica. In questa forma, la necessità
di un intervento statale sui grandi aggregati della produzione capitalistica viene
spinta al massimo, la determinazione delle condizioni della produzione e la
fissazione di funzioni transattive sulla circolazione delle merci vengono ampliate e
consolidate 26.
Questa crisi- che significa crisi dello Stato keynesiano, come progetto di intervento
dello Stato per lo sviluppo capitalistico- è soprattutto determinata dall’insufficiente
presenza dello Stato all’interno del meccanismo economico e dell’insufficiente
automatismo dell’intervento. Ha di fronte un livello di lotte operaie e proletarie che
sfruttano il terreno pianificato sia in termini di semplice e diretta rottura politica
(qualità delle rivendicazioni) sia in termini di rottura delle proporzioni capitalistiche
dei processi di riproduzione (quantità delle rivendicazioni). Di fatto, alla caduta del
saggio di profitto che è tipica conseguenza dello sviluppo del modo capitalistico di
produrre, s’è così unito un attacco di massa al profitto che, oltre a colpire
direttamente i meccanismi della valorizzazione, ha determinato la fine di tutte le
vecchie vie percorse per ristabilire saggio e massa del profitto. Dentro questo tipo di
crisi e dentro questi rapporti di forza fra le classi- di conseguenza- l’unica via che il
capitale ha davanti consiste nell’approfondire ancor più il nesso fra Stato e capitale
complessivo. La manovra di ristrutturazione può essere portata avanti solo nella
misura in cui lo Stato, superando i suoi equilibri keynesiani con il capitale
complessivo, accentua la sua presenza all’interno della macchina produttiva stessa,
accetta cioè di «rafforzare» i processi di valorizzazione con l’intero strumentario della
propria figura. La «valorizzazione» politica rende reale la valorizzazione del capitale.
Nuove tecniche di programmazione stanno formandosi a partire da questo nuovo
tessuto di potere: programmare non per grandi aggregati in termini di riassunzione
socialista del consenso ma programmare per linee interne, attraverso una puntuale
Fra Keynes e Sraffa si compie un itinerario teorico che, mentre conferma la realtà pianificata dello
Stato come unica alternativa alla disgregazione del mercato, di questa totalitaria realtà statale rivela, sempre
maggiormente, con sempre minori illusioni, la natura antago nistica. La soggettività operaia e proletaria come esogeneità totale ma sempre presente al sistema- è l’elemento che la scienza borghese del processo
economico e della sua rego lazione statale deve sempre più sussumere e rivelare.L’intervento democratico
newdealistico è da questo punto di vista un esperimento keynesiano nel diritto, la sua differenza
dall’interventismo tradizionale, sia dei regimi liberali sia dei regimi fascisti, è radicale. Ivi, p. 224.
26 Ivi, p. 226.
25
�172
P A OLO S C A NGA
ricerca di consenso che discrimini- in termini puramente politici- strati di lavoratori
da altri strati, selezioni e controlli nella misura stessa in cui organizza e riorganizza la
produzione sociale27. Lo Stato come capitalista collettivo si presenta, quindi come il
gestore dello sfruttamento, è il pianificatore di tutto lo sfruttamento secondo una
funzione della legge del valore che ne prevede una trasformazione socialista, una
gestione in termini di profitto medio (tendenzialmente eguagliato al plusvalore). Ma
se lo Stato è tale, lo è perché costretto a questo da una situazione di lotte operaie mai
registrata prima nella storia del capitale. Bisogna chiedere alla critica (dell’economia
politica) una rilettura della teoria del valore a livelli sui quali il suo azzeramento
comincia a presentarsi come orizzonte reale, dove l’aggressione operaia alla vigenza
della legge del valore è massiccia. Non esiste lotta operaia che non sia
immediatamente lotta sul terreno della transizione, lotta per il comunismo, lotta per
l’estinzione dello Stato 28.
Nell’estate del 1975 mentre l’assetto del sistema capitalistico è scosso dalla crisi
aperta due anni prima, Negri scrive il saggio Proletari e Stato. La fine dell’esperienza
organizzativa di Potere operaio può essere interpretata come un suo sintomo. Negri
torna sul «partito di Mirafiori» per leggervi i tratti di una svolta nuova, una nuova
composizione sociale. È l’autonomia operaia di fronte alla catastrofe e alla crisi che,
con l’aumento del prezzo del petrolio e l’impatto sui consumi, minaccia direttamente
lo stile di vita delle metropoli occidentali ed entra nella vita quotidiana. Il capitale si
riorganizza in funzione antioperaia. L’attualità della tendenza marxiana è
rappresentata non solo dal fatto che la caduta del saggio di profitto è divenuta la
ragione essenziale della congiuntura critica, con effetti nuovi e determinanti, ma
anche dal fatto che la caduta del saggio di profitto è moltiplicata dall’insorgenza
soggettiva- strutturale tuttavia e irreversibile- della lotta di classe operaia e proletaria,
come rivolta della massa dello sfruttamento contro il saggio di profitto, come iniziale
ma definitiva inadempienza della classe proletaria a rappresentarsi quale mera forzalavoro 29 . La legge della caduta del saggio di profitto assume dunque questa
paradossale figura: da un lato il capitale è costretto a spingere il processo di
socializzazione perché solo in questo modo il comando capitalistico sulla produzione
può oggi essere mantenuto, e cioè solo a condizione di mistificare, attraverso la
socializzazione, la finzione del lavoro vivo, solo a condizione di determinare un così
alto grado di compenetrazione organizzativa di produzione e società da mostrare la
funzione di comando come necessaria e socialmente legittima. Ma
contemporaneamente, dentro questa socializzazione capitalistica, si abbassano la
proporzione e il valore del lavoro vivo erogato perché il processo di socializzazione e
27
28
Ivi, pp. 227-229.
Ivi, p. 230.
Lo studio marxiano delle controtendenze alla caduta del saggio di profitto è sostanzialmente fondato
sull’identificazione del tentativo capitalistico di scaricare, nel momento della crisi, la densità della
composizione organica. Negri, A. (2006), op. cit., p. 142.
29
�173
Dallo Stato piano al nuovo ordine della globalizzazione.
La sovranità in Antonio Negri
il processo di lotte operaie crescono assieme30. Dopo che il proletariato si era fatto
operaio, ora il processo è inverso: l’operaio si fa operaio terziario, operaio sociale,
operaio proletario, proletario. Il comando sulla crisi non può rappresentarsi come
comando nella crisi. Se il blocco del profitto si ripete anche a fronte dell’innovazione,
se la modificazione della composizione organica del capitale riproduce e massifica a
livello sociale la pressione «di classe» del proletariato, se quindi la pianificazione
capitalistica dello sviluppo diviene pianificazione della crisi, allora è dentro questo
involucro che la figura del comando deve essere definita. Attraverso il denaro, il
capitale tenta oggi di riconquistare forza di mediazione fra crisi e ristrutturazione,
ponendosi come regola selettiva funzionale alla determinazione del comando, come
razionalità e progetto rispetto alla composizione organica e come terrorismo rispetto
alla composizione politica del proletariato. Sulla nuova composizione di classe si
scarica tutto il peso della crisi attraverso il ricorso alla strumentazione monetaria. Al
«denaro-moneta» si sostituisce il «denaro-Stato»: la categoria è comunque confermata
come categoria di mediazione dello scambio delle merci31. Nella misura in cui la
realizzazione del profitto è imputata allo Stato, la società civile scompare e la
Socializzazione, la terziarizzazione e la flessibilità ridisegnano la fisionomia della
società italiana. La classe operaia ne esce indebolita e stravolta. Il blocco statale deve
disarticolare ogni aggregazione sociale potenzialmente ostile e riaggregarla in
relazione allo schema del funzionamento complessivo e pianificato del capitale. Il
consolidamento del capitale complessivo nella figura dello Stato avviene dentro la
riorganizzazione del mercato mondiale. Anche la figura dello Stato ne risulta
sconvolta. L’azione delle multinazionali si infiltra nello Stato nazionale, innerva
oggettivamente componenti della sovranità, innalzando e spostando i punti di
riferimento dell’azione statale e le fonti di legittimazione.
Siamo intravedendo una nozione, quella di capitale sociale, che getta nuova luce
sulla società capitalistica. Negri con Dall’«estremismo» al «Che fare?» riprende quel
filo inaugurato dalla stagione dell’operaismo per tessere una nuova trama. È come se,
ora, nella lunga storia del capitalismo si fosse prodotta una cesura, una discontinuità.
L’integrazione di produzione e circolazione, la sussunzione della seconda nella
prima, socializzano il processo di estrazione del plusvalore, qui dentro, la stessa forza
lavoro diviene sociale 32 . Passo ulteriore si compie quando viene eliminata la
separazione tra produzione e consumo: al livello del capitale sociale la sfera del
consumo è ricondotta a quella della produzione e della riproduzione dei rapporti
30
Ivi, p. 144.
Ivi, p. 147.
Si tangano presenti quelle importanti lezioni che Negri tenne sui Grundrisse all’Ecole Normale
Supérieure nella primavera del 1978 sotto l’invito di Althusser, pubblicate con il titolo Negri, A.,
(1998), Marx oltre Marx, Roma: ManifestoLibri.
31
32
�174
P A OLO S C A NGA
capitalistici e di conseguenza viene attraversata dalla stessa logica antagonista33. Il
termine autovalorizzazione, impiegato da Marx per spiegare i movimenti del
capitale, viene ad assumere un significato nuovo. «Il rifiuto del lavoro definisce modi
di autovalorizzazione operaia nella riproduzione, esige salario differito e/o indiretto –
che non vuole più realizzarsi sul terreno della produzione, determina contropotere e
si mostra ben disposto ad esercitarlo»34. Il lavoro operaio comincia qui a configurarsi
come lavoro liberato, quindi come rifiuto del lavoro nella forma della sussunzione
sociale capitalistica. L’antagonismo è la chiave di volta della liberazione del lavoro.
La liberazione del lavoro comincia a configurarsi quando, a un certo livello dello
sviluppo capitalistico, la mediazione capitalistica del rapporto di produzione e
riproduzione va sistematicamente in crisi: la mediazione, il rapporto di capitale è
incapace di chiudersi 35 . L’operaio sociale 36 si colloca fuori dal capitale, in una
posizione antagonistica rispetto al processo di riproduzione, che è produzione non
solo di merce e plusvalore ma anche e soprattutto del rapporto capitalistico stesso.
L’analisi della crisi della forma Stato- come abbiamo visto- iniziata con Crisi dello
Stato-piano, si arricchisce ora di nuovi elementi: da strumento tecnico del dominio a
capitale complessivo che esalta la sua funzione di comando rivestendo i panni
dell’impresa. I processi di riproduzione, nella misura in cui divengono sede e canale
della moltiplicazione dell’antagonismo di classe, debbono essere riconvertiti- sempre
più strettamente- nei meccanismi dell’amministrazione. Lo Stato insomma si fa
carico di condurre la lotta di classe dal punto di vista del capitale. Lo Stato è il
partito, la dittatura di partito del capitale. L’amministrazione è l’esercizio della
volontà dello Stato dei padroni37. La soggettività è dal punto di vista del capitale
innestata in maniera strettissima ai problemi dello sviluppo, e quindi alla struttura
del capitale38. Il problema dello Stato, dal punto di vista dell’organizzazione, è il
problema del partito. Non può che avvenire, a questo punto di intensità delle lotte,
uno spostamento dal problema dello Stato come problema del partito del capitale al
problema del partito come problema dello Stato di classe operaia, dell’anti-Stato, del
potere operaio.
Sersante, M. (2012), op. cit., p. 80.
Negri, A. (2006), op. cit., p. 201.
35 Ivi, p. 216.
33
34
36 Si veda l’importante intervista fatta da Pozzi e Tomassini, Negri, A. (2007), Dall’operaio massa
all’operaio sociale. Intervista sull’operaismo , Verona: OmbreCorte. Ma anche Archeo logia e progetto.
L’operaio massa e l’operaio sociale in Negri, A. (1982), Macchina tempo. Rompicapi, liberazione,
costituzione, Milano: Feltrinelli.
La critica dell’economia politica del processo amministrativo rileva: «a)la norma dispotica
dell’amministrazione; b) la duplicità dei suoi contenuti; c) la ri gidità di classe dell’amministrazione e d) le
regole di accelerazione della rigidità e/o discontinuità dell’amministrazione; e) la forma totalizzante del
processo amministrativo e f) lo spessore dell’antagonismo». Ivi, p. 225
38 Ivi, p. 225.
37
�175
Dallo Stato piano al nuovo ordine della globalizzazione.
La sovranità in Antonio Negri
4. LA GALERA, L’ESILIO. GLI ANNI OTTANTA E L’INCHIESTA SUL
GENERAL INTELLECT.
Gli anni Settanta si concludono con l’arresto di Negri e di migliaia di militanti
dell’area autonoma. Sono gli anni della sconfitta, della galera e dell’esilio, gli anni
più duri della vita militante di Negri ma estremamente produttivi dal punto di vista
della ricerca filosofica. Periodo di «autocritica» e di rielaborazione dei limiti della
ricerca soprattutto sul tema del soggetto. Sono gli anni dell’incontro con Spinoza e la
filosofia poststrutturalista francese. Ma sono anche gli anni della rivoluzione
neoliberista e della crisi delle politiche keynesiane in tutto l’occidente capitalistico. Si
apre l’epoca post-moderna, l’epoca della sussunzione reale che Negri analizza e
descrive in testi fondamentali come Macchina tempo e Fabbriche del soggetto 39 .
Nonostante il carcere, la sconfitta dei movimenti e delle opzioni organizzative e la
violenta reazione messa in piedi attraverso politiche neoliberali, Negri non ha mai
smesso di riflettere intorno alla composizione produttiva e politica.
Sarà però solo durante l’esilio parigino, con la ripresa del lavoro di inchiesta
militante sulle trasformazioni del tessuto produttivo metropolitano, che Negri potrà
rimettere mano all’analisi e ad un apparato concettuale nuovo. In particolare saranno
i quindici giorni di lotta contro il progetto di riforma universitaria e
dell’insegnamento liceale, tra il novembre e il dicembre dell’86 a costituire, per
Negri, l’evento che segna la conclusione di un intero periodo storico e alla necessità
di rimettere a fuoco uno sguardo capace di definire i contorni di un paesaggio
mutato 40. Se l’enfasi dei lavori precedenti sulla produzione di soggettività- che, per
quanto determinata dal potere, è sempre qualificata dal lato della resistenza- gli ha
evitato la deriva, e la definizione del potere costituente ha permesso un primo passo
verso la ricostruzione di una nuova prospettiva ontologica aperta alla
contemporaneità, diventa centrale per Negri spostarsi sul piano concreto del
costituirsi dell’attualità, tenendo un occhio fisso sulle nuove lotte. Infatti, quello che
le giornate parigine lasciano è la possibilità di una critica del presente a partire
dall’identificazione di una nuova forza soggettiva.
Il nuovo soggetto è un dispositivo: la sua coscienza si dispone, attraverso la
materialità delle condizioni, verso la soggettività, verso un’articolazione
costitutiva dei bisogni nel reale. E subito possiamo aggiungere: l’attività che
determina quest’articolazione è intellettuale. È forza lavoro eminentemente
intellettuale. Lavoro astratto, massificato in quanto lavoro estremamente astratto,
Negri, A., (2013), Fabbriche del soggetto. Archivio 1981-1986, Verona: Ombre Corte.
Montefusco, W., Sersante, M. (2016), Dall’operaio sociale alla moltitudine. La prospettiva
ontologica di Antonio Negri (1980-2015), Roma: Derive Approdi, p. 79. Non saranno più gli studenti a
ricercare gli operai, ma sarà la classe operaia che cercherà di costruire alleanze con un una nuova classe
sociale intellettualizzata.
39
40
�176
P A OLO S C A NGA
attributo di moltitudini ma nello stesso tempo singolarizzato in quanto capace di
un massimo di potenzialità determinate, specifiche- lavoro che tende a
presentarsi come attività, semplicemente come tale 41.
Il nuovo soggetto si forma e anche l’ambiente della sua azione viene a modificarsi:
l’operaio sociale vive nella macchina ecologica, in essa colloca la sua potenzialità
operativa e attraverso di essa costruisce e ricostruisce il mondo. L’economia trainante
ha finito di rappresentarsi come «economia-mondo», singolare, nella quale si
formavano figure produttive che poi lo sviluppo si incaricava di propagare. Siamo di
fronte a un sistema di vasi comunicanti, determinazione fondamentale per quanto
riguarda l’operaio sociale. Nel decennio 1971- ’82, l’economia-mondo, il mercato
mondiale diviene il tessuto schizoide della costituzione storica compiuta dall’operaio
sociale. Il capitale si mangiava la società e diveniva sociale, altrettanto avveniva sul
livello mondiale: il capitale si mangiava il mondo e diventava mondiale. Ma se il
«vecchio» imperialismo lo possiamo considerare finito non perciò è venuto meno il
rapporto di sfruttamento imperialistico - questo sfruttamento è ancora più terribile e
diffuso: un nuovo imperialismo- partecipativo, liberale, paritario- è apparso.
Condizione essenziale della mondializzazione del capitale sociale, dello sfruttamento
dell’operaio sociale, è il fatto che la forma politica del comando sia divenuta
preminente per il capitale. Il capitale spinge all’estremo il suo dominio, nella forma
politica- solo in questa forma esso sarà capace di trasformare la conoscenza delle
interconnessioni produttive (della cooperazione) a livello mondiale, in rete di
controllo, eventualmente di repressione, sempre di sfruttamento. Lo schema
transnazionale di comando si presenta sempre e solo come politico42. Il valore sfugge
dappertutto al controllo del capitalista, tracima e si presenta tanto abbondantemente
quanto irregolarmente, si diffonde tra fabbriche e metropoli. Solo politicamente la
mondializzazione dei rapporti di capitale è possibile: la quota politica, nell’ambito
della produzione sociale è preminente. Il comando capitalistico non esige una
unificazione formale, per linee interne ma la colonizzazione capitalistica del mercato
mondiale è integrale, trasversale ed esteriore 43. È a partire dal «fordismo periferico»
che si ridisegna la carta industriale del mondo. I paesi del fordismo periferico
entrano a far parte dell’economia-mondo dell’operaio sociale. L’esempio più
importante che Negri pone per seguire questo processo di integrazione è quello della
vicenda monetaria, che ha determinato compenetrazioni profonde e strutture sempre
più omogenee. Ma una volta che questa integrazione si è data, una volta costruita la
struttura e ad essa è riconosciuta sostanza sociale, gli strumenti monetari vengono
meno. Ogni tentativo di restaurare vecchi schemi di controllo- gli schemi
imperialistici classici, funzioni gerarchiche, modelli conosciuti di divisione
Negri, A. (2005), Fine Secolo. Un’interpretazione del Novecento, Roma: ManifestoLibri, p. 18.
Ivi, pp. 83-84.
43 Ivi, p. 87.
41
42
�177
Dallo Stato piano al nuovo ordine della globalizzazione.
La sovranità in Antonio Negri
internazionale del lavoro- non reggono più: le economie periferiche non accettano
queste misure proprio perché non sono più periferiche. Esse sono integrate nella
struttura economica che ha le dimensioni del mondo sviluppato. L’economia-mondo
dell’operaio sociale comincia a presentarsi con il nuovo volto: gli strumenti che
hanno presieduto la genesi vanno in crisi davanti alla maturità dell’integrazione. La
forza dell’integrazione segna il limite del dominio44. Non viene meno però neanche in
questo sviluppo, ci dice Negri, un punto di crisi. Una crisi che tocca il sistema e ne
attraversa le nervature più sensibili: l’economia-mondo dell’operaio sociale si rivela
come una dimensione completamente, radicalmente antagonistica. È un
antagonismo che si storicizza sulla scena dell’economia-mondo, cioè del mercato
mondiale strutturalmente unificato. Il radicalismo non attiene al concetto ma al
reale 45.
Va notato che nel lavoro di inchiesta che Negri svolge in quegli anni, e
maggiormente dagli anni Novanta in poi partendo proprio da quella importante
rivista parigina che fu Futur Antérieur, emerge come anche il mezzo di lavoro viene
cambiando e modificandosi. Le ricerche militanti sul lavoro immateriale e l’analisi
delle lotte avevano messo in rilevo le connessioni con la nuova forma di produzione I
due aspetti della produzione umana, la trasformazione della natura e il rapporto con
il mondo storico- hanno bisogno del linguaggio: «l’utensile è il linguaggio» 46. Accanto
a questo vi è un'altra questione che vorremmo affrontare per arrivare infine
all’ultima parte di questo saggio: siamo passati dalla produzione di soggettività
direttamente alla produzione della vita e da quest’ultima direttamente al «politico».
Soggetto, vita e politica diventano definitivamente indistinguibili. In Kairos, Alma
Venus, Multitudo insiste sul fatto che questo insieme di produzione e comunicazione,
di mondo della natura e di artefatti, la densità di relazioni produttive, che prende il
nome di biopolitica è sempre in movimento47. La moltitudine ne è l’artefice, il che
significa che l’ontologia diventa qui subito costitutiva, ovvero politica di liberazione 48.
Lo sfruttamento capitalistico non si concentra più su un singolo lavoratore ma, come
Ivi, p. 90.
Ivi, p. 91.
46 Negri, A. (2000), Kairòs, Alma Venus, Multitudo. Nove lezioni impartite a me stesso, Roma:
Manifestolibri, p. 76. Già in Fine secolo, scrive: «Il capitale si insinua ovunque e ovunque vuole
acquisite il potere di coordinare, di comandare, di recuperare valore. Ma la materia prima
fondamentale nella quale l’operaio sociale impianta la propria altissima produttività, quella sola
materia prima adeguata alla forza lavoro intellettuale e inventiva che conosciamo, essa è la scienza
comunicazione, comunicazione di conoscenze. Il capitale deve appropriarsi della comunicazione, deve
espropriare la comunità, deve sovrapporsi all’autonoma capacità di gestire il sapere e di farne il
dispositivo di ogni intrapresa dell’operaio sociale». Negri A. (2005), op. cit., p. 98.
47 Negri, A. (2000), op. cit., p. 78.
48 Montefusco, W., Sersante, M. (2016), op. cit., p. 100. Si veda anche un altro testo importantissimo
di Negri, A. (2002), Il potere costituente. Saggio sulle alternative de moderno, Roma: Manifestolibri.
44
45
�178
P A OLO S C A NGA
abbiamo visto, sull’insieme della forza lavoro. È qui che la moltitudine incontra il
dominio del capitale, nella forma del controllo biopolitico49. Si mostra qui l’elemento
antagonistico, in primis come esigenza soggettiva, poi come un atto politico. Il
general intellect, questo corpo linguistico che si è fatto macchina biopolitica si
identifica con il lavoro immateriale, intellettuale e scientifico.
Ci stiamo apprestando alle soglie degli anni Duemila, Negri ha, come abbiamo
visto, alle spalle la storia dell’esilio parigino che è stata caratterizzata da un’intensa
attività di studio e da una produzione teorica complessa. Tra Fine secolo e Kairos,
Alma Venus, Multitudo esce un testo altrettanto importante Il lavoro di Dioniso,
prima opera scritta insieme a Michael Hardt 50. Questa produzione teorica permette
una mappatura del mondo nuovo che veniva a sorgere dalle ceneri dell’Unione
Sovietica e dalla conseguente fine della guerra fredda ma soprattutto, come abbiamo
visto, dalle lotte dei nuovi lavoratori dell’economia informatizzata e della rete. Sarà
con Empire, però, che ciò assumerà una forma narrativa adeguata e che irromperà
nel dibattito politico e accademico internazionale. Per il nostro lavoro questo testo
rappresenta un punto fondamentale per l’analisi della ridefinizione della sovranità,
infatti Empire rappresenta un passo in avanti per sbarazzarsi della nostalgia delle
strutture di potere che l’hanno preceduta e per rifiutare strategie politiche che
implichino ritorni a vecchi ordini, come il tentativo di far risorgere lo Stato-nazione
come protezione nei confronti del capitale globale. Ciò su cui Negri e Hardt hanno
insistito è il fatto che insieme al mercato mondiale e ai circuiti globali della
produzione ha visto la luce un «nuovo ordine globale, una nuova logica e una nuova
struttura di potere: in breve, una nuova forma di sovranità»51. Di fatto l’Impero viene
a rappresentare il nuovo soggetto politico che regola gli scambi mondiali, il potere
sovrano che governa il mondo. La tesi di fondo del libro è che la sovranità ha assunto
una forma nuova, composta da una serie di organismi nazionali e sovranazionali
uniti da un’unica logica di potere e questa nuova forma è ciò che chiamano Impero.
Il declino della sovranità dello Stato-nazione non significa che essa, in quanto tale, sia
in declino. L’Impero emerge dal crepuscolo della sovranità europea e al contrario
dell’imperialismo,- come in parte abbiamo già visto- non stabilisce alcun centro di
potere e non poggia su confini e barriere fisse. Si tratta di un apparato di potere
decentrato e deterritorializzante che progressivamente incorpora l’intero spazio
mondiale all’interno delle sue frontiere aperte e in continua espansione. Il nuovo
ordine globale, in termini costituzionali, non è solo uno stato di cose ma una fonte di
«Che cos’è il controllo biopolitico? È la misura (organizzazione e limite) portata sul tempo della
vita. Il controllo fluisce sul tempo; il diritto è, nel controllo, procedurale; il controllo è immesso
nell’ontologia temporale del comune, cioè della vita». Negri, A. (2000), op. cit., p. 167.
50 Hardt, M., Negri, A. (1995), Il lavoro di Dioniso. Per la critica dello Stato postmoderno, Roma:
Manifestolibri.
51 Hardt, M., Negri, A. (2010), Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione, Milano: Bur-Rizzoli, p.
13.
49
�179
Dallo Stato piano al nuovo ordine della globalizzazione.
La sovranità in Antonio Negri
definizioni giuridiche che tende a determinare un’unica configurazione del potere
politico sovranazionale. Il mutamento giuridico in cui si incorre è uno dei sintomi
delle trasformazioni che investono la costituzione materiale biopolitica delle nostre
società. Attraverso le attuali trasformazioni del diritto sovranazionale, il processo
della costituzione imperiale tende, sia direttamente che indirettamente, a penetrare e
a riconfigurare il diritto interno degli Stati-nazione; in tal modo, il diritto
sovranazionale determina dall’alto la configurazione del diritto interno 52 . Dentro
questa dimensione, il potere che si afferma impone un comando effettivo sull’intera
vita della popolazione solo nel momento in cui diviene una funzione vitale e
integrale che ogni individuo comprende in sé e riattiva volontariamente. Questo
biopotere è una forma di potere che regola il sociale dall’interno, inseguendolo,
interpretandolo, assorbendolo e riarticolandolo. Per questa ragione i due autori
hanno usato, per rappresentare l’Impero, l’immagine di un’aquila a due teste, che
però si rivolgerebbero l’una contro l’altra per attaccarsi. La prima testa dell’aquila
imperiale rappresenta la struttura giuridica e il potere costituente costruiti dalla
macchina imperiale biopolitica. Sia il processo giuridico sia la macchina imperiale si
presentano sempre come soggetti a crisi e contraddizioni: il processo giuridico della
costituzione dell’Impero vive una continua crisi che viene considerata il prezzo del
suo sviluppo. L’altra testa, invece, indica la moltitudine plurale delle soggettività
creative e produttive della globalizzazione che hanno appreso a navigare in un mare
sconfinato. È per questa ragione che ogni evento insurrezionale, ogni momento di
rottura, che erompe all’interno dell’ordine imperiale scuote l’intero sistema. Da
questo punto di vista, il quadro istituzionale all’interno del quale viviamo è
caratterizzato da una contingenza e da una precarietà radicali, o meglio, da inedite
sequenze di eventi, sequenze che da un punto di vista temporale sono sempre più
brevi e più compatte e sempre meno controllabili 53.
Questo scarto, questo passaggio può essere compreso solo attraverso una
genealogia del concetto moderno di sovranità che permette di far risaltare i punti di
rottura e/o di continuità rispetto al nuovo ordine della globalizzazione. Pensiamo sia
importante per il nostro lavoro riprenderlo sommariamente anche perché funzionale
ad un riepilogo del lessico politico-filosofico presente nel nostro autore. Negri e
Hardt individuano, in Empire, tre momenti nella costituzione dell’Europa moderna,
che articolano di riflesso la configurazione del concetto di sovranità: la scoperta
rivoluzionaria del piano di immanenza; la reazione contro le forze dell’immanenza e
la crisi nella forma dell’autorità; la parziale e temporanea risoluzione di questa crisi
mediante la formazione dello Stato moderno come sede della sovranità che trascende
e media le forze del piano di immanenza. Ne emerge che, nel corso della sua
52
53
Ivi, p. 33.
Ivi, p. 70.
�180
P A OLO S C A NGA
evoluzione, la storia dell’Europa moderna è inseparabile dal principio di sovranità.
La sovranità moderna non può essere altro che un concetto europeo nel senso che si
è sviluppato inizialmente in Europa, coordinandosi con l’evoluzione della stessa
modernità. La trascendenza e la rappresentanza hanno definito la sovranità: da un
lato, la trascendenza del sovrano non è fondata su un punto di appoggio teologico
esterno, ma esclusivamente sulla logica immanente delle relazioni umane; dall’altro,
la rappresentanza, che ha la funzione di legittimare il potere sovrano, priva
completamente del potere la moltitudine dei soggetti. È l’atto di nascita del moderno
concetto di sovranità nel suo stato di purezza trascendentale. Il contratto di
associazione è intrinseco e inseparabile dal contratto di soggezione. Questa teoria
della sovranità rappresenta la prima soluzione politica alla crisi della modernità54.
Come abbiamo visto in testi precedenti, alla base della moderna teoria della
sovranità vi è un altro elemento molto importante, un contenuto che riempie e
sostiene la forma sovrana dell’autorità. Tale contenuto è costituito dallo sviluppo
capitalistico e dall’affermazione del mercato come fondamento dei valori della
riproduzione sociale 55 . La modernità europea è inseparabile dal capitalismo. La
sovranità moderna è una sovranità capitalistica, una forma di comando che
sovradetermina la relazione tra individualità e universalità come funzione dello
sviluppo del capitale. Quando la sintesi tra sovranità e capitale è definitivamente
compiuta e la trascendenza del potere si è completamente trasformata in un esercizio
trascendentale dell’autorità, la sovranità diviene una macchina politica che domina
la società intera. Sotto l’azione della macchina della sovranità la moltitudine viene in
ogni momento trasformata in una totalità ordinata. È da questa posizione che si può
vedere come lo schema trascendentale sia un’ideologia che funziona concretamente e
in cui si può rilevare in che misura la sovranità moderna è diversa da quella
dell’ancien régime. La sovranità è potere di polizia e il compimento della sovranità
moderna è segnato dalla la nascita del biopotere56. Se prendiamo in considerazione la
genealogia del concetto di sovranità nell’Europa del XIX e XX secolo risulta che,
nella modernità, dapprima la forma dello Stato si è degradata in quella di Stato
nazione e, quindi, la forma della Stato-nazione si è a sua volta degradata in una lunga
serie di barbarie. Sotto il dominio della nazione e del suo popolo- sostengono i due
autori- la crisi della modernità rimane ancora assolutamente aperta. L’idea moderna
di nazione fu ereditata dal corpo patrimoniale dello Stato monarchico e reinventata
in una forma nuova. La nuova organizzazione del potere venne strutturata, da un
lato, dai processi produttivi del capitalismo e, dall’altro, dalle antiche reti
dell’amministrazione assolutista. Questa difficile relazione strutturale fu stabilizzata
dall’identità nazionale: un’identità culturale integrante, fondata sulla continuità
biologica dei legami di sangue, una continuità spaziale del territorio e una
Ivi, p. 92.
Ivi, p. 93.
56 Ivi, pp. 94-96.
54
55
�181
Dallo Stato piano al nuovo ordine della globalizzazione.
La sovranità in Antonio Negri
comunanza linguistica. La nazione è una sorta di scorciatoia ideologica con cui si
tenta di liberare i concetti di sovranità e di modernità dall’antagonismo e dalla crisi.
La sovranità nazionale sospende i conflitti che stanno alle origini della modernità e
chiude con quelle alternative che, dall’interno della modernità stessa, avevano
rifiutato di cedere i loro poteri all’autorità dello Stato. La trasformazione del concetto
di sovranità moderna in quello di sovranità nazionale richiedeva alcune nuove
condizioni materiali. Richiedeva un nuovo equilibrio tra accumulazione capitalistica
e strutture di potere. Dietro il profilo ideale della nazione c’erano raggruppamenti di
classe che dominavano l’accumulazione.
Sarà la fine del colonialismo e la crisi delle nazioni a mettere al centro quel
passaggio di grande portata dal paradigma della sovranità statuale a quello della
sovranità imperiale. L’Impero ha eliminato quelle forme moderne della sovranità a
cui abbiamo accennato e afferma le differenze per farle giocare attraverso i confini. Il
processo che ha portato alla formazione della sovranità imperiale è stato lungo e
laborioso. Un passaggio storico fondamentale che ha comportato l’emersione di
questo concetto è da collocarsi nella complessa e articolata storia costituzionale
americana 57. In primis, si ridefinisce un’idea cardine come quella di scarsità- che
insieme a quella di guerra- ha occupato il centro della sovranità europea moderna.
Essa viene espulsa dal processo costitutivo dell’esperienza americana. La Rivoluzione
americana rappresenta un momento di grande innovazione e rottura nella
genealogia della sovranità moderna. Essa riscopre l’umanesimo rivoluzionario del
Rinascimento perfezionandolo in una scienza politica costituzionale. La sovranità
viene esercitata all’interno di un vasto orizzonte di attività che la articolano senza
negarne l’unità e che la subordinano al continuo movimento creativo della
moltitudine58. La prima caratteristica della sovranità americana è che, in opposizione
alla trascendenza della sovranità europea, essa afferma l’immanenza del potere.
L’immanenza si collega al tema della produttività. Immanenza senza produttività
impedirebbe alla società di diventare politica. La moltitudine che costituisce la
società è produttiva. Il potere non è qualcosa che incombe su di noi, è qualcosa che
facciamo 59 . Quando si espande, la sovranità immanente non si annette e non
distrugge i poteri che affronta, ma, al contrario, si apre per integrarli nella sua rete.
La sovranità, come potere che si espande in rete, si trova sulla cerniera che collega la
repubblica democratica all’Impero. L’Impero può essere rappresentato soltanto come
una repubblica universale, una rete di poteri e contropoteri strutturati da
57
Negri, A. (2002), Il potere costituente. Saggio sulle alternative del moderno, Roma: Manifestolibri.
«La moltitudine è una molteplicità, un piano di singolarità, un insieme aperto, né omogeneo né
identico a se stesso, che genera una relazione indeterminata ed inclusiva con coloro che stanno al di fuori. Il
popolo tende invece all’identità e all’omogeneità interna e fissa la sua differenza per escludere ciò che
rimane al di fuori. Mentre la moltitudine è una relazione costitutiva inconclusa, il popolo è una sintesi
costituita adeguata alla sovranità» Hardt, M., Negri, A. (2010), op. cit., p. 107.
59 Ivi, p. 158.
58
�182
P A OLO S C A NGA
un’architettura inclusiva e illimitata. Contro l’imperialismo, l’Impero estende e
consolida il modello della rete dei poteri. Quindi la caratteristica fondamentale della
sovranità imperiale è che il suo spazio è sempre più aperto. Mentre la sovranità
moderna risiede nei limiti, nella concezione imperiale la logica del potere viene
rinnovata e ricreata nel corso dell’espansione. Questa Costituzione si definisce
imperiale e non imperialista proprio perché il progetto costituzionale americano è
concepito per realizzare un programma di articolazione di uno spazio aperto e di
continua reinvenzione di molteplici e singolari relazioni che si intramano in reti
attraverso un campo illimitato. L’idea contemporanea di Impero è nata nel corso
dell’espansione su scala globale del progetto interno alla Costituzione americana. È
nel corso dell’espansione dei processi costituzionali interni che inizia la fase
costituente dell’Impero. La sovranità imperiale, a differenza di quella moderna, di
conseguenza, non gravita su un solo conflitto centrale, ma si organizza attraverso una
rete flessibile di micro conflitti. Piuttosto che quello di crisi, il concetto che qualifica
la sovranità imperiale potrebbe essere quello di onnicrisi, oppure come preferiscono
gli autori, di corruzione. Senza una connotazione morale però: esso va inteso come
processo più generale di decomposizione e mutazione. Affermare che la sovranità
imperiale è caratterizzata dalla corruzione significa, da una parte, dire che l’Impero è
impuro e ibrido e dall’altra, che il comando imperiale opera attraverso rotture. La
società imperiale crolla in ogni momento e ovunque, ma questo non vuole dire che
vada in rovina 60. Abbiamo visto come la sovranità moderna si sia presentata come
trascendenza, in opposizione e conflitto rispetto alle forme di immanenza che il
capitale ha assunto. Però da un punto di vista storico, nonostante la contraddizione
apparente, il processo capitalistico si è sempre avvalso della sovranità- delle sue
strutture giuridiche e della sua forza. L’intera storia della modernità che abbiamo
ricostruito può essere intesa come l’evoluzione del tentativo di negoziare e di
mediare questa contraddizione. Ma il processo storico della mediazione non è
riducibile a un equo do ut des, bensì a un movimento unilaterale che, a partire dalla
trascendenza della sovranità, conduce al piano dell’immanenza del capitale 61. Nel
movimento della sovranità verso il piano di immanenza, il crollo dei confini si è
verificato sia all’interno dei singoli contesti nazionali sia su scala globale:
l’affermazione della società globale del controllo che spiana le striature tracciate dalle
precedenti frontiere nazionali, è accompagnata dalla realizzazione del mercato
mondiale e dalla sussunzione reale della società globale sotto il comando del capitale.
Il mercato mondiale richiede uno spazio liscio su cui possono correre flussi non
codificati e de-territorializzati, differentemente da quella macchina produttrice di
meccanismi di gerarchizzazione, di segmentazione e di esclusione che è stato il
colonialismo. Il capitale ha saputo imporre sia la mobilità spaziale sia la flessibilità
60
61
Ivi, p. 173.
Ivi, p. 305.
�183
Dallo Stato piano al nuovo ordine della globalizzazione.
La sovranità in Antonio Negri
temporale. La sconfitta delle rigidità e delle resistenze della forza lavoro è divenuta
un processo inequivocabilmente politico finalizzato al trionfo di quella forma di
menagement volta alla massimizzazione del profitto. La politica imperiale del lavoro
è indirizzata verso la riduzione del costo del lavoro, si tratta di una riedizione
dell’accumulazione originaria e di un processo di nuova proletarizzazione 62.
Quando il potere diviene immanente e la sovranità si trasforma in
governamentalità, le funzioni di comando e i regimi del controllo devono crescere
lungo un continuum che appiattisce le differenze su un unico piano. L’integrazione
imperiale determina nuovi criteri di separazione e di segmentazione che interessano
differenti strati della popolazione. Il problema dell’amministrazione imperiale è
quindi quello di una forma di gestione dell’integrazione capace però anche di sedare,
di mobilitare e controllare le forze sociali separate e segmentate. La specificità
odierna- secondo Negri e Hardt- consiste nel fatto che, mentre nei regimi moderni
della sovranità nazionale l’amministrazione operava nel senso di un’integrazione
lineare dei conflitti avvalendosi di un apparato coerente in grado di reprimerli- cioè
mentre esse portavano avanti una razionalizzazione normalizzatrice del sociale in
funzione dei due fondamentali obiettivi amministrativi dell’equilibrio e dello
sviluppo delle riforme- nel contesto imperiale l’amministrazione diviene «frattale» nel
senso che integra i conflitti senza imporre un apparato, ma controllando le
differenze 63 . Il primo principio per comprendere l’amministrazione imperiale, ci
dicono Hardt e Negri, è che la gestione degli obiettivi politici tende a essere
dissociata dalla gestione degli strumenti burocratici. Il problema
dell’amministrazione, in questo caso, è quello della multifunzionalità dello
strumento, non quella dell’unificazione. Il secondo principio invece è che essa agisce
come dispositivo differenziale e de-territorializzante: in questo modo
l’amministrazione tende a mettere in funzione procedure specifiche che consentono
al regime di confrontarsi direttamente con le singolarità sociali. L’azione
dell’amministrazione diviene sempre più autocentrata e funzionale solo in relazione
a problemi specifici. L’autonomia e l’unità dell’azione amministrativa viene
conformata alle logiche strutturali in funzione della costruzione dell’Impero.
Tuttavia, l’amministrazione non è strategicamente orientata alla realizzazione delle
logiche imperiali. Si sottomette a essa nella misura in cui esse animano i grandi
strumenti militari, monetari e comunicativi. Il terzo principio quindi è che l’azione
amministrativa è diventata non strategica e la sua legittimazione fa leva su una serie
di mezzi eterogenei e indiretti. Oltre a questi tre principi «negativi» ve ne è un
quarto, il quale fa sì che non scoppino continuamente violenti antagonismi sociali.
Emerge qui la positività dell’amministrazione, la matrice unificante e il valore
62
63
Ivi, p. 314.
Ivi, p. 316.
�184
P A OLO S C A NGA
prevalente dell’amministrazione imperiale consistente nella sua efficacia locale 64 .
Però mentre nei regimi politici della modernità l’amministrazione era linearmente
collegata al comando, il comando imperiale resta separato dall’amministrazione.
Esso è il risultato di un’eruzione sociale che ha rovesciato tutti i rapporti che
costituivano la sovranità. Difatti non si esercita secondo le modalità disciplinari dello
Stato moderno ma secondo quelle del controllo biopolitico. Quelle modalità hanno
come base e oggetto una moltitudine produttiva che non può essere irreggimentata e
normalizzata ma che comunque occorre governare nella sua autonomia. La
moltitudine viene governata dagli strumenti del sistema capitalistico postmoderno
nel quadro delle relazioni sociali della sussunzione reale. In questa produzione la
moltitudine può essere governata per linee interne, ovvero nel contesto biopolitico
della sua esistenza. Ciò che il comando si propone essenzialmente di proteggere e di
salvaguardare in funzione dello sviluppo capitalistico è l’equilibrio generale del
sistema globale65. D’altra parte l’Impero genera un potenziale rivoluzionario assai più
grande di quello creato dai moderni regimi di potere, poiché ci mostra, accanto alla
macchina di comando, un’alternativa effettiva: l’insieme degli sfruttati e dei
sottomessi, una moltitudine che è direttamente, e senza alcuna mediazione, contro
l’Impero.
In conclusione, vorremmo insistere su alcuni passaggi che pensiamo fondamentali
per comprendere il concetto di sovranità, far emergere ulteriormente quel «dentro e
contro» del pensiero negriano nella forma Impero. La crisi del concetto di sovranità
moderna, in quanto legato al concetto di capitale, si dà nella misura in cui quell’unità
che Stato sovrano e capitale presupponevano, si presenta ora interrotta sia dal punto
di vista spaziale, sia dal punto di vista della regolazione del tempo di lavoro: è nella
organizzazione temporale che la forza lavoro cognitiva rompe ogni tradizionale
struttura del comando. Lo sviluppo capitalistico nella sua forma industriale, dal
punto di vista della critica dell’economia politica, si confaceva allo Stato nazionale,
ora viceversa, ne deborda i limiti. Il modo nuovo per contenere una forza-lavoro che
eccede sia i limiti spaziali che quelli temporali dello Stato nazione, consiste nel
trasferimento dei processi di decisione dal livello industriale a quello finanziario. In
secondo luogo, frammentazione ed eccedenza si mostrano dal punto di vista della
teoria dello Stato: il passaggio dal government alla governance rappresenta un
passaggio che frantuma la regolazione unitaria del sistema del diritto pubblico. Un
altro terreno sul quale si dà il rapporto tra frammentazione ed eccedenza è quello
etico-politico di definizione del soggetto giuridico. Questa eccedenza produce
singolarità e il singolare si inscrive nel comune. L’insieme di questi punti va riportato
alla crisi della rappresentanza politica. È nella crisi dei rapporti strutturali interni al
Ivi, pp. 316-317.
Tre sono gli strumenti assoluti e globali attraverso cui si dispiega il comando imperiale: la
bomba, il denaro e l’etere. Ivi, p. 320.
64
65
�185
Dallo Stato piano al nuovo ordine della globalizzazione.
La sovranità in Antonio Negri
concetto di capitale ed al concetto di diritto pubblico, ci dice Negri, che si colloca la
frammentazione della rappresentanza politica 66.
Le linee di fuga sorgono nei momenti di crisi del concetto trascendentale della
sovranità moderna, che vengono inseguite- riappropriate e risistemate da macchine
di government, dice Negri- e sempre più segnate da esperimenti di governance. La
governamentalità si presenta ora come una necessità, non più una possibilità. Si
tratta però di una necessità molto particolare, poiché, in questa contingenza la
governance tenta di approssimare, attraverso e contro questa frammentazione
dell’ordinamento giuridico, la ricomposizione dell’ordinamento con strumenti nuovi,
quelli propri della governance. Però quando ciò non si dà, avviene che la governance
si presenta sistematicamente come eccezione, decisione sull’eccezione, prodotta
dunque da attori e poteri d’eccezione67. Guardando questi processi dal punto di vista
del diritto interno, un punto di vista intensivo, riconosciamo che la crisi si esprime
sui nodi della mediazione interrotta. Se nelle strutture moderne del diritto statuale i
criteri
di
mediazione
dei
sistemi
normativi erano
quelli
della
interpretazione/consuetudine/analogia e della proiezione giurisprudenziale espansiva
delle regole esistenti, ora non si da più possibilità di mediazione interpretativa e
progressiva. La mediazione giuridica crolla, interviene la governance per costrire
ibridi che, attraversando le frammentazioni, tentano di metterle in rete e nello stesso
tempo propongono nuovi terreni di autonomia68. Ciò vale anche in riferimento al
diritto internazionale, dal punto di vista estensivo. Così fra le figure del diritto
interno e quelle del diritto internazionale scorrono processi fluidi e non
determinabili. Dopo la crisi dell’unilateralismo non vi è un ritorno all’ordine
westfaliano, si presenta invece un ibrido comunitario che compone le differenze
senza raccogliere le eccedenze. Il dark side della governance si presenta quindi come
il tentativo di soluzione «eccezionale» della «mediazione interrotta», però in una
prospettiva temporale. Salta in questo caso la distinzione classica fra «effettività» e
«legittimità» del diritto, si presenta, essa stessa, direttamente come crisi.
Diversamente dalla storia moderna del diritto dove, affinché un sistema funzioni,
queste due determinazioni si sovrappongono, in questo nuovo ordine globale esse si
mostrano come dispositivi aleatori, frammischiati e indistinguibili. Ciò che
legalmente vale non è concretamente/effettivamente afferrabile. In questa
prospettiva, la sovranità- invece che darsi in termini autoreferenziali- si trascrive in
termini apertamente negoziali. La scienza politica, sottolinea Negri, per descrivere la
governance ha preferito evidenziate l’ottica di regolazione bottom-up, presentando
un quadro di maggiore collaborazione fra Stato e attori non statuali. Vediamo peròNegri, A. (2009), Dentro/contro il diritto sovrano. Dallo Stato dei partiti ai movimenti della
governance, Verona: Ombre Corte, pp. 201-204.
66
67
68
Ivi, p. 206.
Ivi, p. 207.
�186
P A OLO S C A NGA
ed era già presente in Impero- come la frammentazione si presenti come il punto più
alto di un’eccedenza dark side: la corruzione. Essa- insistendo su una concezione
negativa- si presenta dentro questa discontinuità inafferrabile e multilaterale dei
processi giuridici, non solo come dêbâcle morale dinnanzi alla prepotenza del potere
e del denaro, ma come determinazione intrinseca e funzionale alla governance, un
vero e proprio aspetto di una ontologia perversa della governance 69. Alcuni autori
hanno interpretato questo sentimento d’impotenza come tipico della sensibilità postmoderna, ma se invece di osservare le eccedenze che vengono contenute, catturate e
bloccate dalla governance, rovesciando la prospettiva, ci concentriamo su quelle che
si definiscono in forma costituente prende vita l’ipotesi positiva negriana, ovvero che
le eccedenze positive si rivelino come resistenze e conseguente potenza di produzione
politico-istituzionale. Questa emergenza si dà sul medesimo terreno che a lungo
abbiamo descritto come governance, come sistema di biopoteri. Siamo usciti dalla
modernità, viviamo un periodo di transizione. L’analisi negriana ci spinge verso
un’epoca nuova, la contemporaneità: il «salto qualitativo» c’è stato. Il solo fenomeno
della globalizzazione, come abbiamo visto, spazza via ogni ipotesi di ritorno alla
coscienza giuridica, trattenuta dallo Stato-nazione. Viceversa, conclude Negri, in
questo contesto la governance sociale contemporanea è costretta ad assumere ed a
rappresentare, lungo diagrammi nuovi, pretese giuridiche e potenze politiche che i
nuovi movimenti hanno espresso: questi movimenti non sorgono dal nulla ma da
un’accumulazione di esperienze che ha trasformato le stesse condizioni e strutture
antropologiche del diritto. Nella transizione i movimenti si determinano come forze
politico-istituzionali. Il margine frammentario dei sistemi può essere attraversato,
oggi, da dispositivi costituenti 70.
69
70
Ivi, p. 209.
Ivi, p. 212.
�187
Etica & Politica / Ethics & Politics, XX, 2018, 1, pp. 187-204
ISSN 1825-5167
STORIA, POLITICA, FILOSOFIA.
INTERVISTA AD ANTONIO NEGRI
V I T TO RI O MO RFI NO
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”
vittorio.morfino@unimib.it
E LI A Z A RU
Scuola Normale Superiore
Classe di Scienze Umane
elia.zaru@sns.it
Morfino, Zaru: In questa intervista vorremmo fissare l’attenzione sugli aspetti più
strettamente filosofici del tuo pensiero, consci del fatto che il tuo è uno di quei casi in
cui è difficile, se non impossibile, scindere la teoria dalla prassi, la filosofia dalla
politica. Per prima cosa, ci piacerebbe che tu ricostruissi la prima fase della tua
formazione filosofica, una fase che in una intervista con Cesare Casarino hai definito
«dialettico-umanistica» e «hegeliana». Che anni sono, e quali sono gli autori che ti
hanno maggiormente influenzato?
Negri: Ho fatto la mia prima tesi sullo «storicismo tedesco da Dilthey a Max
Weber» e ho lavorato in particolare su Dilthey: questo è il fondo di quella prima tesi,
quello che mi è rimasto più profondamente impresso, in particolare il concetto di
storicità, la Geschichtlichkeit, in polemica con Heidegger. Mi appariva decisamente
significativa la polemica tra una teoria dell’espressione storica sviluppata da Dilthey
e la onto-teologia pessimista da Heidegger sviluppata in una prima fase del suo
pensiero. Devo dire che il concetto diltheiano di Geschichtlichkeit mi è rimasto
impresso in modo forte, tanto più che la seconda tesi, quella sul giovane Hegel, nasce
proprio da Dilthey, poiché studiando Dilthey leggo la Jugendgeschichte Hegels. È
opera fondamentalmente sbagliata poiché riporta il pensiero del giovane Hegel
esclusivamente a fonti teologiche sveve, trascurando quelle economiche e politiche,
ma che mi aveva allora interessato ed entusiasmato. Tanto più che in quel momento
è uscito in italiano Il giovane Hegel e i problemi della società capitalistica di Lukács,
un Lukács che conoscevo già in quanto qualche anno prima avevo letto Storia e
�188
V ITTORIO M ORFINO – E LIA Z A RU
coscienza di classe. Certo, l’avevo letto come un libro mitico senza una più chiara
consapevolezza della sua importanza e dell’influenza che avrebbe avuto su di me
successivamente. Qui dunque, sono diventato hegeliano, però di un hegelismo
immediatamente bloccato, per così dire, sul giovane Hegel, che è arrivato fino al
periodo jenese del suo pensiero. Avevo così fatta mia l’idea di una dialettica
fortemente materialista, legata essenzialmente allo sviluppo di categorie economiche,
in particolare il lavoro, il lavoro del corpo, delle mani e dello spirito, in quel Hegel
profondamente legati l’uno all’altro. In quel periodo traduco il Sistema dell’eticità e
Le maniere di trattare scientificamente il diritto naturale, scritti hegeliani del 1802:
per farlo studio bene gli scritti jenesi che sono citati sistematicamente nella
traduzione per comprendere e seguire lo sviluppo del pensiero di Hegel. Si tratta di
una concezione della dialettica – di questo me ne accorgo dopo – antikojeviana, cioè
contro l’idea che il lavoro si emancipi attraverso il riconoscimento, nella società
civile, quindi inserendosi in una dialettica che ha nell’Aufhebung un superamento
glorioso della fatica dello sfruttamento: finalmente il lavoratore diventa anch’egli
padrone, diventa un borghese! (Su questa linea nasce il primo Habermas). In altre
parole, rimango molto legato al metodo dialettico, ma espressivo, diltheyano al
limite, già fuori da quello che potrebbe essere un qualsiasi schema di neohegeliano.
Vi parlo del periodo fine anni Cinquanta inizio anni Sessanta. La traduzione esce nel
’62. Il Giovane Hegel 1 è del ’58.
Morfino, Zaru: Per quale editore è uscita la traduzione?
Negri: Per Laterza, nella collana dei «Classici della filosofia». La traduzione mi era
stata affidata da Garin, dopo che aveva letto le bozze del mio Giovane Hegel e ne era
rimasto contento. Un lavoro prestigioso: sono quelle cose che mi hanno permesso di
andare in cattedra rapidamente. Fra queste, aggiungerei l’altro grosso lavoro che ho
fatto allora, il libro sul formalismo kantiano 2, completamente legato a questo
passaggio: un libro nel quale, studiando le direzioni in cui era stato sviluppato il
formalismo giuridico kantiano nel periodo postrivoluzionario, dopo il 1789, aprivo
ad un’iniziale definizione delle «alternative del moderno». Tutto questo lavoro l’ho
fatto dopo la laurea a Padova, una laurea totalmente indipendente, formalmente
firmata da Padovani, una specie di Bontadini in piccolo, che professava a Padova, un
uomo molto simpatico per infiniti versi, un cattolico svitato, come allora se ne
trovavano spesso. Devo riconoscergli però il merito di avermi fatto leggere Heidegger,
da subito negli anni Cinquanta. Sono quelle cose che non mi hanno mai perdonato
Negri, A. (1958), Stato e diritto nel giovane Hegel, Padova: CEDAM.
Negri, A. (1962), Alle origini del formalismo giuridico: studio sul problema della forma in Kant e
nei giuristi kantiani tra il 1789 e il 1802, Padova: CEDAM.
1
2
�189
Storia, politica, filosofia. Intervista ad Antonio Negri
in molti, il fatto di aver conosciuto Heidegger prima e meglio di loro, negli anni
successivi, quando Heidegger ormai troneggiava.
Morfino, Zaru: Heidegger è una presenza negativa nel tuo pensiero, una sorta di
costante antagonista.
Negri: Sì, un «babau». Più seriamente, ciò che non bisogna mai diventare. Quando
ho conosciuto Heidegger mi era stato presentato come esistenzialista negativo. Credo
che in questa riduzione ci sia del vero. Più che filosofo dell’ontologia, è filosofo
esistenzialista, del tipo di Kierkegaard, di una soggettività malata e stanca. Una
patologia di crisi, un irrazionalismo disperato che convive con il fascismo ed
un’escatologia negativa. Questa è l’immagine che mi è rimasta sempre in testa. Il
giudizio su Heidegger e l’urgenza della critica sono diventati ancor più pesanti
quando la presenza di Heidegger si è incrociata ad un’altra importante influenza che
ho subito, quella della scuola di Francoforte: quando cioè le conclusioni della scuola
di Francoforte mi sono sembrate convergere con quelle heideggeriane. È lì che si è
drammatizzato ulteriormente il quadro, quando un certo marxismo sociologistico e
oggettivante concludeva a posizioni di negazione dell’essere. Lukács avrebbe
chiamato tutto ciò «distruzione della ragione».
Morfino, Zaru: Su questo torniamo a breve. Intanto, la fase «dialettico-umanistica»
e «hegeliana» termina con la fine degli anni ’50; la necessità di rompere con la
dialettica ci pare arrivi in coincidenza con l’inizio della militanza politica attiva. In
che modo ha inciso questo sulla tua «precedente coscienza filosofica»?
Negri: Esco dal cattolicesimo senza in realtà aver mai attraversato una riflessione
teologica sul cristianesimo, esco dal cattolicesimo in quanto esperienza giovanile fatta
in un ambiente cattolico estremamente maggioritario (il Veneto di allora) nel quale
sia destra che sinistra non si riconoscevano quasi più. A Padova il PCI era
inesistente, il partito socialista aveva un deputato, mentre il mondo culturale era
sfiorato da venticelli di cattolicesimo liberale. Infine, c’era il 99% di cattolicesimo
duro. La sinistra a Padova era formato da un gruppetto di liceali: Gianfranco Poggi,
un sociologo che poi lavorerà negli Stati Uniti, Laura Balbo, che sarà ministro del
governo D’Alema e Paolo Ceccarelli che poi diventerà preside ad Architettura per
molti anni. Questa era il nostro gruppetto di «cattolici». Siccome eravamo intelligenti
e carini, ci hanno buttato dentro all’amministrazione centrale della Gioventù Italiana
Azione Cattolica, e ci siamo inconsapevolmente trovati dentro ad una crisi che pare
sia stata fondamentale nella storia dell’Azione Cattolica e del Vaticano II: da una
parte, noi che dicevamo che l’educazione dei giovani andava fatta seguendo la loro
collocazione di classe (contadini, studenti, operai, alla francese) e dall’altra chi
sosteneva che andava seguito il livello della sessualità (bambini, adolescenti, giovani
�190
V ITTORIO M ORFINO – E LIA Z A RU
ammogliati o da ammogliare etc.). Che bestiario! Abbiamo fatto questa battaglia e ci
hanno buttato subito fuori, siamo tornati a Padova, ci siamo iscritti al Partito
Socialista. Era il 1954. Ho passato gli anni successivi a studiare, sono stato per un
anno all’Istituto Croce a Napoli; poi nel ’58 mi sono messo a far politica, ho
incontrato Panzieri e sono entrato nel suo giro. Ho cominciato a far politica, e di
questo devo forse ringraziare i cattolici, in maniera non ideologica – perché
l’ideologia reazionaria non era fatta per me – ma immediatamente di massa. Mi
mandavano nelle parrocchie a parlare con i giovani di non mi ricordo più cosa, certe
volte anche in occasione delle elezioni per convincere a votare per la Democrazia
Cristiana. Ho avuto modo di comprendere che la politica non si faceva a chiacchere,
ma muovendo delle coscienze collettive.
Non so bene come questo sia avvenuto e se significhi l’abbandono di una filosofia
dialettica e borghese. Certo è che non ho mai più considerato la filosofia se non come
terreno dove formare dei dispositivi linguistici e critici che permettano il contatto tra
me e il collettivo. Non credo di aver mai avuto una concezione della filosofia come
costruzione della verità interiore, né tantomeno come costruzione di un modello di
pensiero che illumini il mondo e garantisca la verità. Ho sempre considerato la
filosofia come uno strumento di rapporto, di costruzione della verità fra gli uomini,
laicamente, nella società, nel lavoro. Queste sono la sua natura politica e la sua
storicità.
Morfino, Zaru: Hai affermato di essere stato «comunista prima che marxista». Da
un punto di vista politico, questa frase è chiara: come si può interpretare da un punto
di vista filosofico? Quando hai incontrato Marx nel tuo percorso, qual è stata la
rilevanza di questo incontro e quale Marx ha influito maggiormente sulla tua
formazione?
Negri: L’incontro con Marx nasce al liceo quando ancora ingenuamente si parlava
del lavoro e dello sfruttamento. Tuttavia, Marx ha rappresentato un’influenza per me
secondaria per molti anni. Bisogna tenere presente che sono anni nei quali Marx è il
Marx del PCI, inagibile per me, è un Marx teologico che ci dice come è fatto il
mondo e come siamo fatti noi dentro una realtà della quale possiamo diventare i
sacerdoti che guidano le masse. Si trattava di commentare religiosamente passi di
Marx, questo era il tono. Se dubitavi: «Marx ha detto questo, quindi devi stare zitto».
Morfino, Zaru: Tu non hai mai avuto questo rapporto con il testo di Marx.
Negri: No, assolutamente. D’altra parte però non va dimenticato che in quegli
anni c’era un altro Marx, veramente infame, il Marx giovane, il Marx di Iring
Fetscher e tanti altri. Qui Marx veniva trasformato (operazione tedesca ma anche in
�191
Storia, politica, filosofia. Intervista ad Antonio Negri
parte francese) in un moralista e lo si spacciava per un hegeliano di sinistra – per ben
che andasse – soprattutto preoccupato della sofferenza e dell’alienazione.
Alienazione, una parola magica, che però per me non significava nulla. Oltre tutto,
per noi giovani di povera estrazione, che entravamo negli «anni gloriosi»
dell’aumento del tenore di vita, il fatto di essere alienati era quasi un gaudio e non
una pena. Ci si poteva finalmente comprare la televisione e, chi aveva più soldi di
noi, si comprava anche la Cinquecento.
Per me la scoperta di Marx coincide con l’entrata nel PSI e l’incontro con alcuni
compagni molto bravi, Guido Bianchini, Francesco Tolin, rimasti amici per tutta la
vicenda politica che percorro Poi, naturalmente, l’incontro con Panzieri e con i
«Quaderni Rossi». Da Panzieri – più che da Tronti, con cui ho all’inizio un rapporto
abbastanza distante – comincio a capire la maniera in cui accostare i testi marxiani,
dal basso, dall’inchiesta, della ricerca operaia. Tenete presente che allora siamo negli
anni nei quali la sociologia riappare come disciplina accademica, dopo che il vecchio
positivismo sociologico era stato spazzato via e, durante il fascismo, la sociologia
intera. Per me questo passaggio non è drammatico. Quando ero all’Università con il
mio piccolo gruppo, avevamo cominciato a parlare di sociologia con un professore di
Filosofia del diritto, Gigi Caiani, amico di Bobbio e del gruppo che stava
reintroducendo la sociologia in Italia. Siamo alla fine degli anni Cinquanta. Venendo
dallo storicismo, accosto immediatamente Weber e Simmel, e poi quella sociologia
che poi si sposta – come anche la scuola di Francoforte – negli Stati uniti e ivi
costruisce un grosso blocco di pensiero sociologico. C’è un’idea di modernizzazione
del sapere che allora si collega direttamente all’inchiesta sociologica, poi all’inchiesta
operaia.
In quel periodo (seconda metà anni ’50) dirigo il giornale degli studenti di Padova,
«il Bo», e lì facciamo già una serie di inchieste sociologiche. All’interno
dell’Università abbiamo un centro politico culturale, dove, oltre a chiamare Enzo
Paci, Lucien Goldmann, Jean-Marie Domenach, allora direttore di «Esprit»,
scopriamo anche la sociologia, cominciamo a leggere Robert K. Merton e Mannheim
e in generale la sociologia sistematica. Il concetto di inchiesta è per noi
fondamentale, rappresenta l’urgenza di dare senso alla dialettica, un’istanza di
immanenza. Mi fa un piacere enorme vedere come oggi questo concetto qui a Parigi
stia diventando un elemento centrale nei dibattiti universitari dei giovani comunisti:
nel disorientamento attuale, costruiscono quelle stesse vie di fuga, che per noi erano
state essenziali. Quest’approccio sociologico va dunque sottolineato perché mi aiuta a
divenire marxista. Perché per me diventare marxista significò prendere in mano il
primo libro del Capitale e andare a vederlo funzionare in fabbrica. E, dal momento
che sono diventato marxista, mi iscrivo al partito socialista, in una sezione (di
Padova) dove sono tutti bolscevichi. Non mi iscrivo al PCI, quindi non sono
obbligato a nessun tipo di ortodossia, ed ho in più il vantaggio di vivere in una
situazione in cui il PCI è minoritario rispetto ai socialisti, e quindi avrò direttamente
�192
V ITTORIO M ORFINO – E LIA Z A RU
contatto con i dirigenti degli organismi di massa, anch’essi socialisti (camera del
lavoro, cooperative, Federbraccianti e FIOM). Comincio il lavoro di inchiesta
immediatamente, ed in questi anni metto in piedi una rivistina, il «Progresso
veneto», attorno alla quale si forma il gruppo veneto da Luciano Ferrari Bravo, a
Mario Isnenghi, al piccolo De Michelis, che diventa presidente l’Ugi nazionale (allora
era lombardiano), a Massimo Cacciari.
Morfino, Zaru: Quali erano i tuoi rapporti con Lombardi?
Negri: Lombardi era molto simpatico, l’abbiamo fatto venire una volta al nostro
circolo culturale intitolato a Labriola, come anche Foa: però è Panzieri che comanda
fin da principio sulla nostra scelta di lotta di classe. Io non ho conosciuto il
socialismo riformista se non come avversario.
Comunque, quando il segretario della Federazione diventa deputato, io in quanto
vicesegretario comincio a fare funzione di segretario della Federazione. È allora che
stabilisco un contatto con Porto Marghera, dove svolgerò la mia attività politica. Nel
’61-62 do le dimissioni dal partito socialista – ero anche consigliere comunale – e
comincio a fare semplicemente il militante «operaista». E poi ho la grande fortuna di
diventare professore nel ’63 e questo mi toglie la preoccupazione di sopravvivere,
perché per sopravvivere dovevo lavorare: facevo tutti i lavoretti intermittenti, nella
scuola, traducevo cose ininteressanti.
L’ingresso nell’attività politica non riesco dunque a teorizzarlo se non ricordando
una serie di coincidenze fortunate che mi permettono di attraversare il movimento
operaio senza prenderne alcuna malattia, e di avere un contatto diretto con le
fabbriche, con il lavoro produttivo immediato, così da confrontare la mia lettura del
Capitale alla realtà operaia.
Morfino, Zaru: Quindi è il Capitale il testo fondamentale?
Negri: Il testo fondamentale è il primo libro del Capitale, questo è fuori di dubbio.
Morfino, Zaru: Ai Grundrisse ci arrivi dopo?
Negri: Ai Grundrisse ci arrivo successivamente. Li leggo malamente in tedesco
perché è un testo pesante, collaboro alla traduzione di Grillo, che uscirà per la Nuova
Italia. Il lavoro di traduzione comincia nel ’62-63 e man mano che la traduzione va
avanti anch’io approfondisco la lettura. Va detto che il «Frammento sulle macchine»
è già tradotto da Solmi nel ’62.
Morfino, Zaru: Sui «Quaderni Rossi».
�193
Storia, politica, filosofia. Intervista ad Antonio Negri
Negri: Circolava già tradotto all’interno dei «Quaderni rossi» prima d’esser
pubblicato, lo leggevamo. Ma era l’illuminazione di un’utopia, non avevamo la
capacità di inserirlo nel contesto marxiano della lotta di classe, nel modo in cui allora
la vedevamo. E tuttavia ci spingeva a sviluppare il nostro interesse per l’inchiesta in
termini sempre più, lo dico con parole foucaultiane, di «produzione di soggettività» –
allora certamente non l’avrei detto in questa maniera, però lo sentivo in questa
maniera. Questo tipo di approccio nasce in maniera fortuita e, però, è preparato dalle
letture di cui parlavamo, da un certo modo di interpretare la storicità e di leggerla
dialetticamente. È chiaro che, per esempio, nell’accostamento alla lotta di classe è
centrale l’interesse per la sua trasformazione perché in questo c’è un’idea della
storicità che vince – senza dimenticare che nel primo volume del Capitale le fasi
dello sviluppo capitalistico sono stabilite con precisione. Così, una delle cose per me
centrali, fin da subito (come lo era d’altra parte per i compagni che frequentavo di
più dal punto di vista teorico – Alquati e Gasparotto e altri cosiffatti dentro ai
«Quaderni Rossi») era la ricerca del momento di innovazione della composizione di
classe, dopo aver verificato i movimenti e la qualità dell’operaio massa. Si cercava la
nuova dinamica che si stabiliva tra lavoro e macchina, che trasformava dall’interno la
composizione di classe, e quale fosse la storia implicita all’autonomia di classe.
Queste cose emergono in modo esplicito nel lavoro di inchiesta che facevamo, un
lavoro assolutamente teorico, più ed oltre la raccolta di materiali e di rapporti operai.
Questo è il modo in cui Marx entra nel mio discorso, il marxismo non è mai stato
per me un’ideologia.
Morfino, Zaru: Parallelamente alla corrente operaista italiana si è sviluppata in
Francia la declinazione althusseriana del marxismo; l’impressione è che siano stati
due fiumi paralleli che non si sono incontrati, è corretto?
Negri: Althusser era un uomo di partito, noi eravamo degli autonomi, dei cani
sciolti, ma dentro la massa operaia, non eravamo dei ragazzini che raccontavano
storie. Quando dieci anni più tardi (nella seconda metà dei ’70) vedevo Althusser, mi
chiedeva come stava Rossana [Rossanda] o Ingrao, che erano per lui il modello del
politico. Nei ’70, era convinto che Ingrao fosse quello che ispirava le Brigate Rosse:
insomma tutto doveva avvenire all’interno del Partito.
Badate bene, non sottovaluto minimamente il suo pensiero per il fatto che fosse un
uomo di partito e facesse lotta di partito. Era diverso da noi… Ma si tratta di due
filoni di ricerca all’interno di un medesimo orizzonte. Dopo il ’56 la ricerca di
innovazione del marxismo rispetto alla dogmatica sovietica rappresentò un’ondata
fortissima. Il ’56 è stato una rottura epocale nel modo di leggere Marx, fu il momento
in cui la lettura di Marx fu filtrata attraverso la critica piuttosto che attraverso
l’internazionale comunista. Dopo il ’56, si aprono varie linee, caratterizzate da varie
�194
V ITTORIO M ORFINO – E LIA Z A RU
esperienze. È fuor di dubbio che in Italia l’esperienza innovativa nell’interpretazione
del marxismo da parte del Partito comunista – pur attribuendogli enorme
importanza – è un’esperienza che finisce con le prime nuove lotte operaie, quelle dei
metalmeccanici milanesi del ’58-59, e il ’60 genovese, e i «morti di Reggio Emilia»…
Bene, tutto questo fa saltare qualcosa di più dell’egemonia ideologica del PCI. Apre
nuove strade, poi c’è piazza Statuto… Il grande merito di Panzieri è di aver tracciato
questo passaggio da protagonista. I compagni attorno a lui erano espressi dalle lotte
di Milano e Torino. Poi c’è l’esperienza veneta, un’esperienza fatta in provincia. Io
l’ho sempre considerata tale, pur riconoscendo (come ormai tutti fanno) che è stata
probabilmente la più grossa organizzazione autonoma che si sia mai data in Italia –
un’esperienza di provincia, relativamente indenne da pressioni partitiche, ma forte
ed originale. Il Veneto, il Nord Est è stato sempre sconosciuto in Italia, sconosciuto
quando è diventato «industriale» di colpo – chi se lo immaginava?; quando si è
«deindustrializzato» per primo ed ha creato i «distretti»; quando è diventato per
primo «tedesco» e ha cominciato a basare tutta la sua produzione sulle esportazioni.
Noi abbiamo vissuto in questa nicchia dove abbiamo avuto la possibilità di fare
grosse esperienze, anche filosofiche, nella lotta di classe. Siamo stati bene per dieciquindici anni, fino al ’79. Se Althusser avesse avuto la possibilità di lavorare con noi a
Porto Marghera sarebbe stato più felice che a Rue D’Ulm e forse i fiumi,
incrociandosi, sarebbe stati più difficilmente interrotti. Per concludere: di
profondamente diverso fra operaismo e althusserismo c’è l’impianto epistemico, che
per Althusser si pianta nell’ideologia, per gli operaisti si sviluppa nell’inchiesta e
nella costruzione di dispositivi pratici di intervento. La filosofia althusseriana è una
politica di partito, la filosofia operaista è una politica dell’autonomia di classe.
Morfino, Zaru: Un altro marxismo con cui hai intrattenuto un rapporto duraturo
– seppur sempre molto critico – nel corso di tutta la tua produzione teorica è la
Scuola di Francoforte. Come e quando sei entrato in contatto con la Scuola di
Francoforte? Come è cambiato nel tempo, se lo ha fatto, il tuo modo di leggere i
francofortesi?
Negri: Ho raccontato che la mia prima esperienza filosofica autonoma è la tesi
sullo storicismo, storicismo che va da Dilthey a Weber. Ho pubblicato subito il primo
volume – non c’era ancora La G. G. Feltrinelli, editore fu allora l’Istituto Feltrinelli –
che era su Dilthey e Meinecke, perché all’Istituto storico avevo incrociato Chabod
con il quale avevo discusso il mio lavoro e lui mi aveva convinto a lavorare su
Meinecke, il suo maestro. Fu imprudente, perché avevo pronti materiali pubblicabili
su Weber e Troeltsch e anche su Simmel. Questi materiali dovevano costituire i
quattro grossi capitoli del libro. Utilizzando i materiali su Weber ho scritto una
decina di anni dopo un saggio sulle nuove letture di Weber dopo la biografia di
�195
Storia, politica, filosofia. Intervista ad Antonio Negri
Marianne Weber – letture che metteva in luce il Weber nietzscheano. L’ho pubblicato
sugli «Annali di filosofia del diritto». Essendo a conoscenza di questo mio lavoro, Dal
Pra mi commissionò il capitolo sulla filosofia tedesca tra il XIX e il XX secolo del
suo manuale. Dal Pra era un tipo molto simpatico, estremamente serio, un
compagno. Sulla «Rivista critica di Storia della filosofia» di Dal Pra ho scritto quel
grossissimo saggio sul concetto di Stato moderno.
Francoforte, siamo alla fine degli anni Cinquanta, è un po’ il tessuto nel quale
anche noi ci siamo formati. La scuola di Francoforte ha una posizione di sinistra
filosofica, non dico comunista, ma radical-socialista – liberal anglosassone. Credo di
aver letto tutto. Metodologicamente, queste letture sono state essenziali. Dal punto di
vista filosofico, il testo che resta in testa è la Dialettica dell’illuminismo, però anche
Dialettica negativa, man mano che queste cose uscivano o che si trovavano in
tedesco. Più tardi studierò anche l’Horkheimer giovane e seguirò l’Adorno americano
e quindi le ricerche sulla personalità autoritaria. Direi che però che quest’ultime
letture rimangono marginali rispetto alla dialettica negativa e alla dialettica
dell’illuminismo in particolare.
Questo è dunque il quadro di riferimento. Per uno che era nato alla filosofia
traducendo la critica dello storicismo finalistico o spiritualista nella scoperta della
storicità come definizione dell’essere, la Geschichtlichkeit francofortese, che ha la
pesantezza della Geschichtlichkeit heideggeriana, pur se non ne conosce il destino, è
un elemento fondamentale rimasto nella mia esperienza filosofica. Tuttavia rimane
sullo sfondo il problema della dialettica: si trattava di decidere se la dialettica dovesse
rappresentare un concetto di lotta o un telos catastrofico. Se il comunismo fosse un
processo costitutivo o qualcosa di distruttivo. Questa scelta, nel ’68, mi allontanerà da
Francoforte.
Morfino, Zaru: A noi pare che il tuo modo di leggere i francofortesi vada
compreso alla luce del rapporto problematico tra dialettica e soggettività, cioè della
necessità che tu sollevi di lasciare l’oggettività della dialettica in favore della
potenzialità del soggetto. Su questo binario si possono leggere le tue critiche ad
Adorno e Horkheimer, il «recupero» di Marcuse – soprattutto gli scritti sul ’68 – e,
infine, la consonanza con Krahl. Non è un caso che sia Marcuse sia Krahl abbiano
lavorato molto su questa questione della «nuova soggettività» e della «nuova classe
operaia».
Negri: Mi sembra giusta la vostra lettura del rapporto problematico fra dialettica e
soggettività, irrisolto – a mio parere – nella scuola di Francoforte. La dimensione
pessimistica, quasi heideggeriana, della scuola di Francoforte, compare nel suo
autunno, ad esempio nella polemica di Adorno contro il ’68. La mia lettura dei
francofortesi era avvenuta all’inizio del mio lavoro filosofico: c’è un professore di
Estetica (Bettini) che mi fa leggere l’estetica viennese ed i francofortesi.
�196
V ITTORIO M ORFINO – E LIA Z A RU
Dall’entusiasmo iniziale passo alla critica a contatto con la lettura di Marx ed in
particolare dei Grundrisse. Il «frammento sulle macchine» rappresenta il luogo
centrale nella polemica con i francofortesi: è sulla questione della tecnica che non c’è
possibilità di intesa. Molto migliore è il rapporto con Marcuse. In quello splendido
libro Ragione e rivoluzione. Hegel e il sorgere della «teoria sociale», il suo primo
testo, un testo in cui è già antiadorniano, in Marcuse c’è una concezione della
«dialettica negativa», probabilmente non corretta se pretende comprendere tutto il
pensiero di Hegel, ma certamente molto efficace. Quel libro lo conoscevo bene.
Quando è arrivato il Marcuse di L’Uomo a una dimensione. tutto il giro dei
compagni con cui lavoravo, da Ferrari Bravo a Cacciari, lo presero con sufficienza,
con quell’arroganza che ci caratterizzava in quegli anni. Ci sentivamo quelli che
avevano capito tutto. Comunque, il Marcuse de L’Uomo a una dimensione e quello
successivo degli affetti e dei desideri, credo di averlo considerato – ho fatto anche
l’introduzione ad una delle riedizioni delle sue opere, gli scritti sul Sessantotto 3 – da
una parte con sufficienza, dall’altra cogliendo quella che è la dimensione di novità
che è la riconquista dei corpi. Con Krahl l’accordo fu invece pieno.
Morfino, Zaru: Il Marcuse «biopolitico».
Negri: Oggi diciamo «biopolitico», certamente negli anni ’60 non si diceva. È fuor
di dubbio che, a partire dagli anni ’70, in particolare attorno alla tematica del salario,
la tematica biopolitica diventa sempre più centrale. Questo non vale solo,
ovviamente, per le lotte operaie. Vale per la scoperta del «salario sociale» e
dell’«operaio sociale». L’elemento decisivo in questo processo sono le lotte delle
donne, le femministe del «salario e lavoro domestico», che stanno dentro il mio
istituto. Maria Rosa dalla Costa è la mia prima assistente, ed è lì a Padova che viene
elaborato quel discorso (attraverso Ferruccio Gambino che aveva contatti inglesi con
Selma James, la compagna di C. L. R. James). Viene dunque fuori questa dimensione
del lavoro femminile come lavoro sfruttato e quindi una prima socializzazione del
lavoro non più legato al lavoro produttivo immediato: questo spunto diventa una
delle chiavi più importanti del discorso operaista, centrale sia per le donne sia per gli
studenti e il lavoro scientifico. È lì che si formano l’ideologia del potere operaio e
quella nostra lettura dell’operaio sociale. E comincia a svilupparsi l’analisi della
socializzazione del lavoro. Lì si passa al secondo e al terzo volume del Capitale e ad
una piena lettura dei Grundrisse. Questa dimensione «biopolitica» passa dunque
essenzialmente attraverso l’analisi del lavoro domestico come punto critico del
«lavorismo» tradizionale. Questo è il modo in cui entra Marcuse nel nostro discorso.
Negri, A. (2005), Postfazione, in H. Marcuse, Scritti e interventi, (a cura di R. Laudani), Vol. 1,
Oltre l’uomo a una dimensione, Roma: Manifestolibri.
3
�197
Storia, politica, filosofia. Intervista ad Antonio Negri
Dopo Marcuse, c’è la scuola ungherese dei bisogni, la ripresa di un certo Lukács.
Questo tipo di cose, se la vuoi mettere in filosofia, erano state in parte introdotte in
Italia dal pensiero fenomenologico. La fenomenologia introdotta in Italia è
profondamente diversa da quella che si studia in Germania e in Francia, è una
fenomenologia che passa attraverso il filtro da un lato della psicologia
fenomenologica tedesca, dall’altro attraverso Merleau Ponty. E poi, attraverso Paci e
l’esplorazione dell’archivio di Lovanio... Anche questa è una linea importante che si
consolida attorno a via Sirtori a Milano, dove c’è la comune in cui Paci fonda «Aut
Aut» – e dove si può incontrare Filippini – un uomo di una simpatia e di
un’intelligenza straordinaria, fenomenologo completamente aperto alla critica
francese merleau ponty-foucaultiana – è lui che traduce La crisi delle scienze
europee. C’è dunque questa ibridazione, che (fra parentesi) non viene colta nella
costruzione della Italian Theory di Esposito. E a non cogliere queste profonde
ibridazioni si rischia di non cogliere strani tessuti di pensiero, carichi tuttavia di
conseguenze teoriche e politiche di grande forza.
Morfino, Zaru: Che rapporti hai avuto con Enzo Paci?
Negri: Ho conosciuto Paci perché veniva spesso a Padova, invitato da Piovesan, il
traduttore del secondo Wittgenstein, e lì ci siamo visti. Poi ci siamo incontrati a
Roiaumots ad un convegno su Hegel: lui tornava da Lovanio dove aveva cominciato
a lavorare sui manoscritti husserliani ed era nella fase in cui pensava insieme Marx e
Husserl. Siamo diventati amici e ci siamo rivisti spesso. Va aggiunto che non ho mai
avuto un rapporto accademico con lui.
Morfino, Zaru: Ai tempi di «Aut Aut»?
Negri: No, ai tempi di «Aut Aut» vedevo Veca e Rovatti, nel primo periodo, e poi
Rovatti da solo. Rovatti, si può dire, era allora un militante dell’autonomia.
Morfino, Zaru: Ci sembra che Spinoza – forse non tanto nell’Anomalia selvaggia,
ma sicuramente in Spinoza sovversivo – costituisca una risposta ontologica alla
sconfitta del movimento operaio. Nella pagina di apertura del primo articolo il
ragionamento pare condurre all’equiparazione di rivoluzione ed essere, laddove
dall’altra parte la sconfitta si qualifica come divenire, quindi con i caratteri della
transitorietà del divenire.
�198
V ITTORIO M ORFINO – E LIA Z A RU
Negri: Senza dubbio è così. Io sposterei questo ragionamento anche sull’Anomalia
selvaggia 4. Questa idea racchiude un po’ tutto il mio approccio a Spinoza. L’idea e la
facitura del libro nascono in galera: dunque con l’ovvia consapevolezza che sconfitta
c’era stata. Non mi facevo illusioni sulla continuità della lotta. In galera il clima non
era bello – si sviluppò un dibattito feroce, costato anche dei morti, tra dissociazione
dalla e continuismo della lotta armata. Io mi sono messo a studiare Spinoza per
cercare una ragione non della continuità, ma della sostanziale omogeneità del
pensiero della trasformazione, della rivoluzione. Un tentativo di mediazione
filosofica di epoche storiche (la crisi dell’inizio della modernità e la crisi dell’apparire
postmoderno) che si presentavano tuttavia in maniera molto differente; una ricerca
per approfondire il senso dell’ontologia storica della liberazione dell’uomo. E poi,
indubbiamente, la «scoperta» del concetto di potenza, di potenzialità. Lì confluiva un
certo Deleuze, quello che aveva teorizzato il rapporto tra virtualità e potenza. Su
questo, Deleuze mi ha influenzato. Nel 1978-79, durante una prima fase del mio
esilio, a Parigi ebbi un primo contatto con il suo pensiero. Era il periodo di Marx
oltre Marx 5, lezioni tenute all’ENS di Ulm in quegli anni, contemporaneamente
stringevo rapporti con Gilles e Felix [Guattari], con cui poi sono rimasto in rapporti
fraterni fino alla sua morte. La riflessione di Deleuze è stata dunque per me
importante nell’interpretazione di Spinoza. Certo, credo che nessuno possa dire che
il mio Spinoza è un testo deleuziano; però, sul concetto di potenza, effettivamente
esiste una connessione. Su questo aspetto ci sono state ad esempio discussioni con
Giorgio Agamben, che allora viveva a Parigi. Il suo discorso sulla potenza era
aristotelico, io invece credo che nella figura della potenzialità spinoziana si possa
riconoscere la dimensione marxiana della potenza del lavoro vivo. Un’altra questione
molto importante affrontata nel libro è la costruzione teorica del filone MachiavelliSpinoza-Marx (preceduta peraltro dal lavoro fatto nel mio Descartes politico 6).
L’archeologia storica dell’Anomalia selvaggia, l’analisi della rottura rinascimentale
del pensiero, la scoperta dell’immanenza e la modernità della crisi, avevo già cercato
di costruirle in Descartes politico. Insomma, sono qui rispecchiate l’ideologia politica
della borghesia e le forme politiche della modernità capitalista: lo Stato assoluto, le
alternative della governance nell’accumulazione primitiva del capitale, prime forme
di pensiero democratico e radicale, i blocchi e i nodi di questa storia. Su queste
questioni avevo ragionato ancora a partire dalle lezioni e dalle discussioni con
Chabod all’Istituto Croce. Questa continuità della ricerca è per me molto
importante, ed è segnata dalla lettura di Machiavelli, dal suo concetto di «potenza»
come potenza democratica e dalla sua opposizione al potere: tutto ciò diventa
Negri, A. (1981), L’anomalia selvaggia: saggio su potere e potenza in Baruch Spinoza , Milano:
Feltrinelli.
Negri, A. (1979), Marx oltre Marx: quaderno di lavoro sui Grundrisse, Milano: Feltrinelli.
Negri, A. (1979), Descartes politico o della ragionevole ideologia, Milano: Feltrinelli.
4
5
6
�199
Storia, politica, filosofia. Intervista ad Antonio Negri
centrale in questo momento, nella dimensione storica del concetto di ontologia. Sia
chiaro che, in quanto marxista, «dimensione ontologica» significa modo di
produzione. Attorno a questo avevo già lavorato anche su Grossman 7 e sul dibattito
(marxista-occidentale) sulla transizione.
Dopo il lavoro su Spinoza, sempre in carcere, mi metto a lavorare a Macchina
tempo 8. Ne avevo scritto l’Introduzione e i Prolegomeni, quando (a Trani a fine anno
- 1980) è scoppiata la rivolta e le guardie carcerarie mi hanno distrutto la cella e tutto
quello che c’era dentro, a me e a tutti gli altri. Mi hanno poi trasferito a Roma, dove
ho riscritto il manoscritto.
Morfino, Zaru: Hai riscritto tutto a memoria?
Negri: Sì praticamente sì.
Morfino, Zaru: Come descriveresti il tuo rapporto con Foucault?
Negri: C’è un articolo del 1978, pubblicato su Aut Aut 9 e poi raccolto in Macchina
tempo, in cui registro – fino a Sorvegliare e punire – la produzione di Foucault. La
mia tesi è che è un lavoro formidabile, ma che gli manca la soggettività: deve
ritrovarla, concludevo. In effetti è stato così. Questo articolo coglieva il punto – non a
caso è stato ripubblicato in un’importante raccolta di saggi su Foucault (L’Herne,
2011), a dimostrazione che effettivamente anticipava la direzione nella quale Foucault
si orienterà negli anni successivi. La mia idea – forzata, se si vuole, ma non troppo –
è che in Foucault ci sia un «marxismo segreto», un larvatus prodeo fondamentale. Si
tratta, in particolare, di un’impronta marxista legata ai suoi studi storici e ad autori
che erano alla base anche delle mie ricerche sulla genesi dello Stato moderno –
Porchnev, Lucien Febvre e altri – centrali nella costruzione di un quadro storico in
cui i movimenti «dal basso» costituiscono istituzioni. Da questo punto di vista ritrovo
in Foucault delle analogie sorprendenti, estremamente profonde, con la fondazione e
lo sviluppo dell’«operaismo» italiano. Foucault è, per certi versi, un «operaista»
francese! Discontinuità creativa dei processi storici: con questa idea di una
soggettivazione continua delle formazioni storiche. Foucault sicuramente non è mai
stato uno strutturalista, ogni sfondo strutturale doveva piuttosto essere rotto da un
nuovo movimento di soggettivazione e questa dimensione ontologica costruiva
dispositivi di ricerca, ovvero una metodologia dal basso di analisi storica, prodotta
dalle soggettività in movimento. Da questo punto di vista, mi pare che anche
Borkenau, F., Grossmann, H., Negri, A. (1978) Manifattura, società borghese, ideologia. Una
famosa polemica sul rapporto struttura-sovrastruttura (a cura di P. Schiera), Roma: Savelli.
Negri, A. (1982), Macchina tempo: rompicapi, liberazione, costituzione, Milano: Feltrinelli.
Negri, A. (1978), Sul metodo della critica della politica, in «Aut Aut», 167-168, pp. 197-212. Ora in
Negri, A. (1982), Macchina tempo, cit., pp. 70-84.
7
8
9
�200
V ITTORIO M ORFINO – E LIA Z A RU
Foucault sia l’espressione di un fondo solido, importante, di pensiero rivoluzionario
negli anni Sessanta. Questo pathos lo accomuna all’operaismo.
Concludendo a proposito dell’incontro, durante l’esilio francese, con il pensiero di
Guattari, Deleuze e Foucault, debbo dire che l’impatto è stato indubbiamente
importante. Prima con Guattari e Deleuze, trovando nel loro pensiero una conferma
di alcune rotture filosofiche (con la dialettica in particolare) e soprattutto una
fondamentale apertura critica. Meglio, non solo critica ma utopica, innestata
all’analisi delle strutture culturali e politiche prodotte dall’«evento ’68» e della crisi
post ’68. Siamo all’origine del neoliberismo: Deleuze e Guattari comprendono
perfettamente la rottura del ciclo storico legato a fordismo e keynesismo, e
comprendono come questa rottura non venga solo dall’esterno ma dall’interno del
mondo del lavoro, dal «mondo della vita», da un nuovo regime del desiderio, che
non possono chiusi in sistemi disciplinari. Cercano dunque di costruire un
dispositivo filosofico e politico che comprenda – contro il liberismo – la nuova
potenza proletaria. Questo mi permette di rimettere mano all’operaismo, di andar
oltre le basi (luminose ma limitate) delle prime intuizioni di Tronti. Trovo una
coincidenza tra quello che ero venuto elaborando durante la galera, e prima, e il
modo in cui Guattari e Deleuze considerano la fase storica. È chiaro che qui noi tutti
imputiamo alla sinistra (ed in particolare alla sinistra comunista) il fatto di non aver
capito questo passaggio e di aver dato, per così dire, via libera alla ricomposizione
liberale del dominio, sopra e contro i nuovi regimi di desiderio che il ’68 aveva
prodotto.
Morfino, Zaru: Se volessimo «tagliare con l’accetta» il tuo pensiero, ci pare di
poter individuare tre fasi principali, in continuità tra loro: la prima, che ha come asse
centrale lo studio di Marx, culmina con l’elaborazione di Marx oltre Marx; la
seconda, in cui Spinoza è il punto di riferimento, trova il suo apice ne L’anomalia
selvaggia e Il potere costituente, mentre la terza, in cui risultano fondamentali
Foucault, Deleuze e Guattari, si apre a partire da Empire – opera in cui peraltro si
riscontra una piena convergenza delle fasi precedenti. Ti ritrovi in questa scansione,
per quanto semplicistica e sommaria? O ci sono altri passaggi che secondo te sono
stati maggiormente determinanti?
Negri: Si, mi sembra che questo schema sia corretto. Ovviamente va sempre
considerato che la presenza di Marx tiene unite tutte queste fasi. E che si verificano
delle grosse variazioni del punto di vista da una fase all’altra. La seconda è già una
fase in cui il livello di astrazione è molto alto, poiché (sono in galera!) manca ormai
un rapporto diretto e dinamico con l’inchiesta. Questa mancanza qualifica l’intera
riflessione: parlo di «potere costituente» senza più poter parlare di esperienze
costituenti. Non si tratta di una rottura semplicemente scientifica, ma che si dà anche
�201
Storia, politica, filosofia. Intervista ad Antonio Negri
nelle condizioni generali del pensiero, del sapere – vi è stata una sconfitta e la si paga
anche teoricamente… «eppur si muove».
Morfino, Zaru: Abbiamo costruito il numero di questa rivista attorno ad alcune
parole chiave con l’intento di costruire una sorta di lessico fondamentale per
comprendere la tua filosofia: ontologia, temporalità, materialismo, produzione,
biopolitica, moltitudine, sovranità, partito, confini. Ti ritrovi in questo lessico e puoi
darci una breve definizione di come intendi queste categorie e il loro utilizzo?
Negri: Di «ontologia» abbiamo parlato a lungo in questa intervista. Se volessimo
fissare una definizione, direi di considerare l’ontologia come storicità, ontologia
storica, dunque, contesto della lotta di classe, consistenza materiale della
composizione sociale. Ogni discorso sulla composizione sociale dei soggetti è
ontologico. Il discorso diventa complesso quando si pensano le tematiche del
comune, poiché qui c’è un rapporto dinamico tra sfondo ontologico della
cooperazione sociale e costruzione del comune (una tensione interna alla lotta di
classe). Questa ontologia aperta deve essere cioè percorsa da dispositivi di
produzione dell’essere. Questo è il comune: il punto centrale in cui la pluralità, la
solidarietà, la produttività, la moltitudine, questi valori si mettono insieme. Tutto
questo è ontologia e comune, una coppia mediata dalla moltitudine, che possiede la
potenza di essere aperta, dinamica e produttiva.
Per quanto riguarda la «temporalità», il mio discorso parte dalla critica della teoria
del valore-lavoro, e cioè dalla critica della pretesa che essa possa anche costituire
misura del valore; e cerca poi di comprendere l’altro aspetto della temporalità, ossia
quello creativo, lo Jetztzeit produttivo – che, in realtà, costituisce sempre il plus del
processo produttivo e la sua ricchezza ontologica. La temporalità non è durata, vive e
si distende dentro la base ontologica. Kairos contro chronos: questa temporalità, vista
dal punto di vista ontologico, è discontinuità, produzione e pluslavoro, plusvalore.
Questo plus è la determinazione centrale di questa definizione della temporalità. Di
nuovo, kairos contro chronos, dove il secondo costituisce un limite, il primo un
avanzamento. Questa è la tematica che ho sviluppato sia nella critica della teoria
marxiana del valore, sia in quel progetto filosofico (che pur muove dalla critica delle
temporalità) sviluppato in Kairos, Alma Venus, Multitudo 10(non a caso nella
traduzione inglese di Time for revolution i saggi di Macchina tempo e quelli di
Kairos sono stati tradotti insieme). Il problema, ovviamente, è quello di gettare ponti
al di là o in continuità con l’esperienza kairotica della temporalità. Capire cosa
significa produzione di soggettività posta su questo limite estremo, su kairos; su come
questo limite possa essere coscientemente, attivamente prodotto e sviluppato; come
Negri, A. (2001), Kairòs, Alma Venus, Multitudo. Nove lezioni impartite a me stesso, Roma:
Manifestolibri.
10
�202
V ITTORIO M ORFINO – E LIA Z A RU
su questo limite debba essere esercitata una pressione infinita. Questo ci riporta al
concetto di «potenza». Potenza e temporalità si incrociano, in una interpretazione che
vorrebbe andare oltre la «potenza» spinozista. Non è detto che non ci riesca.
Comunque la «potenza» spinozista resta come sfondo: se c’è qualcosa di
propriamente spinoziano che qui si trova (e che possa esser riferito a quell’«oltre») è
l’idea di eternità.
Sul concetto di «produzione», darei due definizioni: una sociologica e una
filosofica. Dal punto di vista sociologico, la produzione di soggettività è legata alla
trasformazione del lavoro: non più solo attività materiale, ma progettazione
immateriale, che comporta una radicale soggettivazione dell’attività stessa. Quindi
produzione come produzione di linguaggi, codici, forme di cooperazione. È in questo
regime che oggi la produzione di soggettività si determina. Da un punto di vista
filosofico – meta-sociologico – il concetto di produzione come produzione di
soggettività tocca di nuovo la dimensione della potenzialità e del tempo, definendo
un rapporto soggettività-materia della trasformazione che deve essere definito in
termini ontologici come progetto creativo. «Produzione di soggettività» si definisce
dentro un processo che va dalla produzione alla creazione. Anche in questo caso il
processo è completamente aperto, e però può essere utilizzato nell’analisi delle forme
creative del lavoro, nell’estetica, nelle questioni legate all’ideazione, all’innovazione –
alla scienza e alla tecnologia. Va comunque tenuto presente che produzione di
soggettività è termine del tutto «materiale», anche nelle sue espressioni cosiddette
«immateriali». Le combinazioni tra i due terreni sono estremamente vaste, alla fine
convergono nel biopolitico.
Occorre allora soffermarsi su queste due categorie: «materialismo» e «biopolitica».
«Materialismo» credo sia sinonimo di immanenza. Occorre scarnificare, meglio,
incarnare la tradizione classica, meccanicista, illuminista del materialismo. Esso è
«biopolitico». Spinoza è la definizione del materialismo, non certo le caricature che
gli idealisti ne costruiscono. Spinoza, Machiavelli, Marx, ecco il materialismo. Questa
presa di coscienza ci fa respirare un po’. Diciamolo con chiarezza: se dovessimo
catalogare il materialismo secondo le classiche, scolastiche concettualizzazioni della
storia della filosofia, il concetto di materialismo non si capirebbe mai cosa sia, dove
inizia e dove finisce. È qui il caso di insistere sul disagio che producono le categorie
teleologiche (divenute usuali, quasi mainstream) della storia della filosofia. E bisogna
sviluppare una diffidenza estrema nei confronti delle sue serie continuistiche, del
continuo riferimento autarchico nelle transizioni da un filosofo all’altro,
dall’antichità a oggi. Questa storia della filosofia è idealismo puro e totale
mistificazione. Di contro, non si può fare storia della filosofia se non riportando ogni
filosofo alla sua epoca, così come si fa per ogni pensatore o letterato o artista. O
uomo che lotta o uomo che soffre. Da questo punto di vista, Le parole e le cose è
un’arma fondamentale per sradicare qualsiasi concezione di quel tipo di storia della
�203
Storia, politica, filosofia. Intervista ad Antonio Negri
filosofia. Se ciascun pensiero è piantato in una episteme specifica, anche la
trasformazione radicale che esso subisce, deve essere così intesa, quando l’uso dei
termini venga modificato dalla realtà linguistica nella quale ogni determinazione
filosofica si costituisce. «Materialismo», penso sia il termine più stupidamente
costruito in termini ideologici. E quando dico «ideologia» intendo un termine
negativo, una finzione costruita non per corrispondere alla realtà, ma per
mistificarla.
Quanto a «biopolitica», è un’altra formula per dire «sussunzione reale».
Biopolitica: è una lettura che ci permette una sintesi produttiva del reale che viviamo.
Il modello di analisi sostenuto dal concetto di «sussunzione reale» è infatti parziale (il
che non significa che sia meno vero). Quando invece noi traduciamo la sussunzione
in termini biopolitici, ne abbiamo un’immagine vera – cioè l’immagine di una realtà
ontologica, attraversata dalla storicità, dai corpi, dalla loro dialettica, da ragioni e da
passioni. Ma con l’enorme vantaggio di osservare la corporeità al centro dell’analisi,
del dibattito, dell’inchiesta. Una filosofia dei corpi nella loro molteplicità, e del
comune, costruita fuori da qualsiasi identità, naturalismo o immagine preliminare
della loro comunanza, sempre in termini costruttivi. Quindi biopolitica e
sussunzione reale, apparizione e sussunzione dei corpi.
E giungiamo alla categoria di «moltitudine». Anche in questo caso, come per
«produzione», darei due definizioni, una sociologica e una filosofica. Quella
sociologica è una definizione che segue la trasformazione del «modo di produzione».
Il concetto di «classe operaia» si trasforma qui in concetto di «moltitudine», di classe
moltitudinaria, classe plurale – è la classe produttiva. Oggi infatti la classe è costituita
da un insieme di singolarità soggettivizzate che cooperano in maniera autonoma alla
produzione, cioè con un surplus di autonomia rispetto al comando che su di loro
viene esercitato. Moltitudine è un insieme di singolarità corporali, di classe, di
genere, inter-nazionali e inter-razziali; la loro composizione corrisponde o traduce il
concetto di classe operaia nell’attuale modo di produzione, che prevede questa
simbiosi e questa singolarizzazione delle operazioni produttrici di valore. Questa è la
definizione sociologica. Per quanto riguarda l’aspetto filosofico-politico, moltitudine
è un concetto di molteplicità che non può essere riassunto in termini trascendentali
sotto la categoria di «popolo», può solo essere costruito in termini di «comune» o di
«repubblica». Qui si verifica un’alternativa radicale: si tratta di definire l’insieme dei
cittadini sotto la categoria del comando oppure sotto quella della liberazione.
Moltitudine significa repubblica contro popolo, Spinoza contro Hobbes.
Contro, dunque, la sovranità. Su questo, direi, si tratta di un concetto che si sta
consumando nell’agonia del XX secolo, insieme ai concetti di «confine» e
«proprietà». Tutto il XX secolo ha assunto questi concetti, intimamente legati tra
loro. Da un punto di vista più generale costituiscono infatti la stessa cosa. Ora, queste
determinazioni partecipano dell’agonia del XX secolo. La sovranità nazionale come
teoria del confine e della proprietà (privata o pubblica) è una mistificazione del
�204
V ITTORIO M ORFINO – E LIA Z A RU
comune, del modo di produzione che diventa invece sempre più cooperativo,
solidale, comune appunto. Che questa triade – sovranità, confine, proprietà – sia oggi
in fase agonica è dimostrato dalla ricerca continua che si fa del comune nella lotta di
classe, nei movimenti migratori, nelle lotte delle donne. Questo non significa che
sovranità, confine e proprietà non vengano riproposti dal potere in termini
continuamente cangianti, ma sempre feroci nelle sofferenze e nell’ingiustizia che
determinano – ovunque nel globo. Ma sono concetti che non reggono più, nemmeno
sperimentalmente, alla verifica dell’inchiesta. Non dimentichiamo mai che inchiesta
significa sapere e che sapere è potere.
�205
Simposio
F er di na do
Per
G .
M eng a ,
L o sca nda lo del f ut uro .
una giust izia int ergenera zio na le
�206
�207
Etica & Politica / Ethics & Politics, XX, 2018, 1, pp. 207-221
ISSN 1825-5167
IL DIRITTO DI CHI NON C’È: TRA
ONTOLOGIA DELLA POSSIBILITÀ E
PRINCIPIO DELLA GENERATIVITÀ
MI CH E LE I LLI CE TO
Facoltà Teologica di Bari
illicetomichele@libero.it
ABSTRACT
This paper discusses Menga’s book on intergenerational justice (Lo scandalo del futuro. Per una
giustizia intergenerazionale, Roma 2016) by proposing a fourfold extension of its conceptual
categories: by means of an ontology of possibility; by addressing an ontology of relationality; by
underscoring the category of generativity; and by analyzing the importance of a u-topian (much
more than an a-topian) responsibility for future generations.
KEYWORD
Not-yet, utopia, generativity, debt, relation
MOTIVI DEL PRESENTE ITINERARIO
Il presente articolo discute la proposta fatta da Ferdinando Menga nel suo libro Lo
scandalo del futuro ponendosi dai seguenti punti di vista.
Il primo punto riguarda la necessità di ripensare la struttura della temporalità.
Infatti, se in gioco entrano anche le future generazioni, quale schema temporale
bisogna assumere? Si tratta di vedere se è possibile dare al futuro, cioè al tempo che
non c’è, al tempo che “ancora” non c’è, lo stesso peso etico che viene assegnato al
presente. È in rapporto a tale questione che si gioca l’eventualità di attribuire
(giustificandoli) probabili diritti a chi non esiste. In altri termini: ha (o ha più) diritto
solo chi vive il presente o anche chi abita il futuro? Quanto pesa il futuro nella
distribuzione dei diritti? E, soprattutto in quale misura chi viene dal futuro
responsabilizza chi si trova nel presente, imponendo decisioni giuste? Come ha ben
sottolineato Menga, utilitarismo e contrattualismo estromettono il futuro nelle
decisioni etiche relative al presente, perché chi è nel futuro non partecipa né alla
�208
M IC H E LE I LLIC ETO
contrattazione né alla definizione di ciò che è utile. Le categorie di utilità e di
contratto abbracciano solo la sfera temporale del puro presente, e pertanto risultano
inadeguati a soddisfare l’esigenza di fare entrare sulla scena etica i diritti di chi non
ancora c’è. In definitiva, la logica contrattuale usa una semantica «connotata dalla
temporalità del presente, dalla topologia della compresenza e dalla simmetria delle
parti» 1.
Il secondo punto, che riguarda una discussione squisitamente ontologica, ha come
posta in gioco il diritto che il futuro ha nel contribuire alla costituzione ontologica
del soggetto chiamato a decidere nel suo presente. In altri termini, si tratta di vedere
se anche al futuro si può attribuire la categoria dell’essere o meno. C’è un’ontologia
del futuro? E di quale tipo di futuro, visto che Waldenfels, citato da Menga, parla di
un doppio futuro: primario e secondario. 2 E ancora, il futuro ha una dimensione
ontologica, o è solo immaginativa e possibilitativa? Se la risposta a tali questioni è
positiva, bisogna poi chiedersi quale tipo di essere si può assegnare al futuro. Infatti,
se il futuro “è”, è necessario vedere quale modalità d’essere gli spetta. Se invece “non
è”, bisogna definire il modo in cui intendere tale non-essere. La questione allora la
possiamo porre nei seguenti termini: come va interpretato il “non-essere” di chi non
c’è nella modalità delle future generazioni rispetto all’essere di chi invece c’è nella
modalità delle presenti generazioni? Si tratta di vedere se le future generazioni non
sono affatto (come sostengono i sostenitori dell’utilitarismo e del contrattualismo) o il
loro non-essere va letto come un non-essere che si dà nella forma di un non-essereancora? E se tale non-essere-ancora non si dà come una forma assoluta di non-essere,
ma come sua forma relativa, come va intesa questa sua relatività? Il relativo ha il
diritto di contribuire a fondare qualcosa che poi deve essere assunto come giusto in
modo assoluto? E che significa non-essere relativo se non un non-essere che viene
definito tale in rapporto a chi già c’è e che si è autoconferito il diritto di assolutizzare
la forma d’essere al presente, che il proprio modo d’essere a partire dal quale ogni
forma altra viene definita e fatta essere? Ed è qui che le due questioni si intrecciano:
il non-essere relativo del futuro non relativizza forse anche il non-essere assolutizzato
del presente di chi si è autoconferito il potere di moncare la temporalità?
A questo punto si apre la strada ad un terzo passaggio che fa entrare in scena una
terza categoria: quella della possibilità. Infatti, secondo una certa tradizione, che va
da Aristotele a E. Bloch, passando per Kierkegaard, il non-ancora è il modo d’essere
della possibilità. Bisogna quindi chiedersi: come viene modificato lo statuto
epistemologico dell’etica se si fa entrare in gioco l’ontologia della possibilità? Detto
altrimenti, in che modo l’ontologia della possibilità può sostenere e fondare un’etica
della responsabilità che riguardi anche le future generazioni? Questo elemento ci fa
fare un altro guadagno: lasciare da parte l’ontologia della sostanza (foriera di un
1
Cfr. F. G. Menga, Lo scandalo del futuro. Per una giustizia intergenerazionale, Edizioni di Storia e
di Letteratura, Roma 2016, p. 100.
2
Cfr. ivi, p. 108.
�209
Il diritto di chi non c’è: tra ontologia della possibilità e principio di genratività
pensiero forte ormai non più sostenibile), per obbligarci a sposare un tipo di
ontologia (quella della possibilità) che ci consente anche di evitare la deriva di un
pensiero debole ammaliata dalla scelta del nichilismo.
Un quarto aspetto della questione è quello che ci porta a domandarci se esiste o
meno un legame tra chi non è – nella forma delle generazioni future – e chi invece è
nella forma della generazione presente. E se tale legame esiste, vedere su quale
principio esso poggia e in che modalità esso si configura. Un tale principio noi lo
abbiamo trovato nel principio della generatività.
Da ultimo – non certo per importanza – tutto questo discorso presuppone
l’acquisizione del punto di vista della filosofia dell’alterità, abbondantemente
utilizzata da Menga per giustificare, tramite una fondazione e legittimazione di
natura fenomenologica post-husserliana, la responsabilità nei confronti delle future
generazioni. In altri termini, qui la questione riguarda la possibilità di classificare le
generazioni future come una forma di alterità: un’alterità di natura temporale.
In definitiva, con questo nostro intervento, accanto alle argomentazioni proposte
da Menga per legittimare una responsabilità nei confronti delle future generazioni, si
vogliono apportare ulteriori motivazioni per rafforzare tale proposta. Lo si farà
discutendo brevemente i punti elencati sopra: 1) presentare un nuovo schema della
temporalità dove il rapporto tra il presente e il futuro venga rivisitato alla luce della
categoria del “non-ancora”; 2) delineare un’ontologia della possibilità seguendo
soprattutto la filosofia di un pensatore purtroppo oggi troppo presto dimenticato,
quale è E. Bloch; 3) introdurre il principio della generatività per ripensare in modo
nuovo il rapporto intergenerazionale; 4) approfondire e allargare il principio
dell’alterità allo scopo non solo di attribuire alle future generazioni la forma
dell’alterità (in chiave temporale), ma anche di esplicitare meglio in che modo l’altro
che viene dall’altrove del futuro mi riguarda in termini di responsabilità.
Queste motivazioni – che non fanno che completare e supportare l’impianto
costruito da Menga – rappresentano ulteriori proposte teoretiche che rendono
possibile procedere ad una giustificazione e fondazione della responsabilità delle
generazioni di oggi nei confronti di quelle future.
L’ONTOLOGIA DELLA POSSIBILITÀ
In aiuto alle argomentazioni esposte da Menga, e per aggiungere agli autori da lui
utilizzati (Lévinas, Ricoeur, Derrida e Waldenfels) per giustificare l’etica della
responsabilità verso le future generazioni, forse possono servire alcune riflessioni che
si possono fare a partire dall’ontologia della possibilità così come è stata delineata dal
�210
M IC H E LE I LLIC ETO
filosofo E. Bloch nel suo Das Prinzip Hoffnung 3, un testo purtroppo dimenticato e
volutamente messo da parte, liquidato come ormai atopico perché troppo utopico.
Eppure una delle tesi di fondo utilizzate da Menga è il fatto che non possiamo
appiattire l’esistenza umana e naturale sul solo presente e sulla sola dimensione di
ciò che è attuale, nel senso di “in atto”. Bisogna allargare l’orizzonte dell’essere, e
delle decisioni etiche, alla dimensione della possibilità.
Che l’uomo non sia fatto di solo presente, è una delle tesi difese da Bloch, laddove
afferma che «l’uomo è ciò che ha ancora molte cose davanti a sé» 4. A parere di Bloch
non è heideggerianamente il problema dell’essere (la Seinsfrage) la grande questione
caduta in oblio – il tema vero dimenticato dalla filosofia –, ma, al contrario, la
categoria della possibilità:
[…] è stupefacente quanto poco il poter-essere sia stato meditato e reso
accessibile. La categoria del possibile, sebbene tanto nota e usata ogni momento,
sul piano logico è stata una croce. Questa categoria è rimasta fino a ora
certamente la più indeterminata fra i concetti che nel corso dei secoli la filosofia
ha elaborato e ha portato alla nettezza. Certo essa è quella che meno è stata
perseguita ontologicamente; perciò tradizionalmente la si incontra quasi soltanto
nella logica formale 5 .
Ma che cosa è la possibilità e come essa partecipa al presente non solo a livello di
costituzione ontologica ma anche nelle decisioni etiche? Tra le varie definizioni,
Bloch riporta come abbastanza adeguata quella di Sigwart, per il quale essa è «ciò
che avviene al singolo nella misura in cui contiene la ragione parziale di ciò che
sarà» 6. Ciò-che-è contiene la ragione di ciò che ancora-non-è e la cui realizzazione
dipende da fattori interni ed esterni:
Possibilità significa qui infatti sia un potere interno, attivo, sia un poter-esserfatto, esterno, passivo; dunque il poter-essere-diversamente si scinde nel poterfare-diversamente e nel poter-diventare-diverso. Non appena questi due
significati sono concretamente distinti, la condizione parziale interna si produce
come possibilità attiva, cioè come facoltà, potenza e la condizione parziale
esterna come possibilità in senso passivo, come potenzialità 7 .
Ora per Bloch il poter-essere ha delle conseguenze al pari dell’essere. Solo che tali
conseguenze sono anticipate nello stesso essere, tanto che laddove questo è possibile,
possono essere pre-viste. Le conseguenze del poter-essere quindi sono retrospettive, o
3
E. Bloch, Das Prinzip Hoffnung [1954-1959], Il principio speranza , trad. it. di E. De Angelis e T.
Cavallo, “Introduzione” di R. Bodei, 3 voll., Garzanti, Milano, 1994.
4
Ivi, vol. I, p. 289.
5
Ivi, p. 283.
6
Ivi, p. 284.
7
Ivi, p. 272.
�211
Il diritto di chi non c’è: tra ontologia della possibilità e principio di genratività
meglio “retroattive” e non proiettive. All’indietro sono anticipabili, e se sono
anticipabili fanno parte del presente. Nessuna decisione (etica) fatta nel presente può
ignorare le conseguenze anticipabili che, in virtù del possibile non ancora attuato,
possono essere intraviste. Infatti così egli scrive: «Il poter-essere non significherebbe
quasi nulla se restasse privo di conseguenze» 8.
Se ciò è vero, allora di fronte a tali conseguenze bisogna rendere conto in anticipo.
Bisogna che qualcuno risponda. Rispondere senza aspettare che il poter-essere si
trasformi in essere, ma farlo nel momento in cui questo poter-essere si dà come
implicitamente inscritto nel nostro stesso essere che è tipico del nostro esserepresente. Certo, come dice Bloch, questo possibile è sempre sospeso:
Nell’uomo come nel mondo, l’autentico è sempre in sospeso, in attesa, sempre
nel timore di venir vanificato, sempre nella speranza di riuscire. Infatti ciò che è
possibile può diventare sia nulla sia essere: in quanto non completamente
condizionato, il possibile è il non già sicuro. Perciò appunto di fronte a questo
essere in sospeso reale, di primo acchito è adeguata, se l’uomo non interviene,
sia la paura sia la speranza, la paura nella speranza e la speranza nella paura 9 .
In tal modo il presente viene dal futuro come quella possibilità che se effettuata lo
farà durare e lo porterà a compimento. Infatti, l’«effettualmente possibile comincia
con il germe in cui è disposto ciò che verrà» 10. La differenza tra ciò che è e ciò che
non-è-ancora non è quantitativa, ma solo temporale: esso si da come differimento. Il
possibile è solo un differito che comincia ad esistere già nel non differito del presente:
«il realmente possibile nel germe e nella disposizione non è mai qualcosa di bell’e
compiuto e incapsulato, cui non resterebbe che crescere come qualcosa di presente in
piccolo» 11. Il possibile è l’oltre del già dato. Esso esige un oltrepassamento quale
forma del vero pensiero che è capacità di trascendere la fattità del puro presente:
Pensare significa oltrepassare (denken ist überschreiten). Ma in modo che
quanto è semplicemente presente non venga accantonato, e che non si scantoni.
Non nelle sue ambasce e nemmeno nel movimento per uscirne. Non nelle cause
dell’ambascia, e nemmeno nelle avvisaglie di svolta che vi maturano. Perciò un
reale oltrepassamento non va mai a finire nel vuoto pneumatico di un davanti-anoi, dedito solo a esaltazioni e descrizioni astratte. Ma comprende il nuovo come
mediato nel presente in movimento, sebbene per essere posto in libertà il nuovo
sia estremamente esigente sul fatto che lo si voglia. Un oltrepassamento reale
conosce e attiva la tendenza, che è dialettica nel suo decorso, insita nella storia.
Nelle sue aspirazioni ogni uomo vive in primo luogo nel futuro, il passato viene
solo in seguito e un vero presente non c’è ancora proprio quasi per niente. Il
8
Ivi, p. 275.
Ivi, pp. 289-290.
10
Ivi, pp. 278-279.
11
Ivi p. 279.
9
�212
M IC H E LE I LLIC ETO
futuro contiene quel che si teme o quel che si spera; dunque secondo le
intenzioni umane, qualora non le si frustri, contiene solo quel che si spera […] 12 .
In tal modo il futuro mette in movimento il presente come presente chiamato a
rispondere. La responsabilità dell’estasi temporale è generata da un atto di
oltrepassamento di cui il pensiero, inteso come trascendimento del puro dato della
datità temporale, si fa garante. Se nel rapporto al passato, il pensiero si dà nella
forma heideggeriana del «Denken ist Danken» 13, nel rapporto con il futuro il
pensiero si dà nella forma blochiana del «denken ist überschreiten» 14.
E così l’ontologia della possibilità libera il tempo, e l’essere che in esso si dà,
dall’ipoteca di un presente che vorrebbe rispondere sol di sé solo in termini
contrattualistici e utilitaristici. Per fare ciò è però necessario un altro passaggio che
anche a Bloch è mancato. Esso viene dal filone della filosofia della relazione.
LA RELAZIONE COME COSTITUTIVO ONTOLOGICO E COME
CRITERIO NORMATIVO ETICO
Come è noto, dietro ogni etica c’è sempre a suo fondamento una particolare
visione antropologica, un modello di antropologia filosofica che ispira l’impianto
etico. Che l’uomo sia definibile come un essere-in-relazione, ormai è un dato
accettato da tutti. Un essere-in-relazione oltre che un essere-di-relazione 15. Famosa a
riguardo è la definizione data da Heidegger: l’esserci è quell’essere nel cui essere vi è
una relazione d’essere con il proprio essere 16. Ma anche Buber, Ricoeur, Lévinas e
altri. In definitiva: l’essere della relazione caratterizza il modo di essere tipico
dell’uomo.
Ora la relazione è evento di alterità, perché nella relazione si dà l’altro. “Si dà” e
non “è dato”. Si noti la differenza: non “nella” relazione con l’altro (aspetto statico),
ma “in” relazione con l’altro (aspetto dinamico). Ma anche io sono un altro, in
quanto vengo da un altro. Vengo da un altro che non ho scelto e sono in relazione ad
un altro che non ho scelto. Questo vuol dire che io non scelgo l’altro, perché l’altro
mi si im-pone attraverso la relazione costitutiva del mio essere in rapporto a lui.
L’altro si presenta a me come un tale che mi si im-pone e non come un tale che viene
12
Ivi, p. 6.
M. Heidegger, Che cosa significa pensare?, trad. it. di U. Ugazio e G. Vattimo, SugarCo, Milano
1996, p. 92.
14
E. Bloch, Il principio speranza , cit., vol. I, p. 6.
15
Per un approfondimento del tema della relazione in chiave antropologica mi permetto di
rimandare a M. Illiceto, La persona: dalla relazione alla responsabilità. Lineamenti di ontologia
relazionale, prefazione di Attilio Danese, Città Aperta, Troina (EN) 2008.
16
M. Heidegger, Essere e tempo, tr. it. di P. Chiodi, Longanesi, Milano 1976, § 4, p. 28.
13
�213
Il diritto di chi non c’è: tra ontologia della possibilità e principio di genratività
“posto-da” me. Se da un lato non scelgo la relazione come modalità d’essere con
l’altro, è anche vero che posso invece scegliere se dare seguito e compimento a tale
relazione.
Tuttavia, contravvenendo alla relazione, io vado contro la mia natura di essere-inrelazione. Non scelgo di essere-in-relazione ma posso scegliere di entrare in relazione.
Scelgo cioè di passare dal semplice essere-in relazione all’essere nella relazione. Tale
scelta implica già un passaggio: dal piano ontologico al piano etico. E ciò che
permette tale passaggio è la responsabilità.
Questo ci dice che la relazione, se da un lato si pone come un dato di costituzione
ontologica, che mette mano ad una ontologia relazionale, la quale sostituisce la
vecchia e superata ontologia sostanziale, dall’altro fonda e giustifica la sua
coniugazione in chiave etica. Se sul piano ontologico siamo in relazione senza averlo
scelto di essere, sul piano etico siamo responsabili di ciò con cui siamo in relazione.
Secondo il famoso assioma di Lévinas, anche la responsabilità non la si sceglie. Noi
siamo responsabili perché siamo in relazione. È la relazione (ontologica) che fonda la
responsabilità (etica). In altri termini, la responsabilità traduce sul piano etico la
relazione che invece mi costituisce sul piano ontologico.
Il primato dell’etica sull’ontologia, così tanto voluto da Lévinas, è rintracciabile
solo a livello fenomenologico ma non a livello fondativo. La fenomenologia,
d’altronde, può fondare solo rivelando ciò che ontologicamente si nasconde. Noi
siamo responsabili di ciò con cui siamo in relazione per il semplice fatto che ciò con
cui siamo in relazione ci costituisce proprio tramite la medesima relazione. E se è
vero che ciò che ci istituisce ci vincola, la relazione diventa il criterio normativo a cui
deve sottostare ogni agire etico. La relazione normativizza la responsabilità,
fondandola.
Non esiste un soggetto irrelato. Né esiste un soggetto che prima si relaziona e poi si
scopre responsabile. La relazione, come elemento ontologico, inserisce già nel
fondamento originario di se medesima, la stessa responsabilità come evento etico che
la compie. L’etica della responsabilità si trova inscritta implicitamente nell’ontologia
relazionale, sì da porsi come dato costitutivo originario della soggettività, la quale si
trova, fin da subito, fondata – nella forma della intersoggettività – come intrisa di
responsabilità.
Nella relazione, come dice Lévinas, siamo esposti, siamo ostaggio. Prima che nella
responsabilità, è già nella relazione che l’altro di rende presente a me. Fin dentro di
me. Se la responsabilità trova l’altro fuori di me, la relazione mi fa trovare l’altro già
fin dentro di me. Prima che io risponda, l’altro rientra nel raggio della mia relazione:
non come altro catturato, ma come altro a cui rispondere, in quanto mi appella e mi
interpella per il semplice fatto che egli c’è.
In tale raggio il tempo non costituisce un limite. Esso potrebbe essere un limite
solo se si assumesse il punto di vista dell’utile e del contratto. Per tale ragione,
l’incapacità dell’utilitarismo e del contrattualismo a fondare un’etica per il futuro si
�214
M IC H E LE I LLIC ETO
ritrova nel fatto che in modo erroneo incapsulano la categoria della temporalità (di
per sé non incapsulabile) in quelle dell’utilità e della contrattualità. Contrattualità e
utilità sono categorie figlie di una temporalità appiattita sul solo presente. Ma se
facciamo entrare in scena la categoria della relazione e della possibilità tale schema
temporale risulta inadeguato a soddisfare l’intero statuto ontologico dell’essere
temporale dell’uomo.
Invece, dal nostro punto di vista che è quello del paradigma relazionale, anche
l’altro che si trova in un’estasi temporale diversa dalla mia, mi interpella, perché il
suo appello trascende il tempo in cui si darà. Anzi il suo appello stesso lo precede. Il
suo appello, che sembra dover venire dal futuro, in fondo viene dal mio presente: dalmio-presente-essere-per-lui. L’altro mi interpella a partire dal mio essere per lui e non
già dal suo essere, che di fatto ancora non è, e che non è solo perché non si è ancora
realizzato. In tal senso, l’altro, che è preceduto dal suo appello, in tal modo fonda la
mia responsabilità per lui.
A dire il vero questa operazione che stiamo qui proponendo è riscontrabile nelle
argomentazioni di Menga, specialmente quando propone di passare dalla teticità del
nominativo alla paticità dell’accusativo o del dativo 17.
Ma chi è l’altro? E in quante forme di alterità l’altro si coniuga? L’altro è l’altra
parte di me. Rispondere di lui e a lui è rispondere anche a me. L’altro mi interpella
già fin dentro il mio stesso io. Non siamo responsabili di ciò che scegliamo, ma siamo
chiamati a scegliere ciò di cui siamo responsabili. Per questo la responsabilità, come
dice Lévinas ben ricordato da Menga, precede la libertà.
Se si correla la responsabilità alla relazione, si finisce con il correlare la
responsabilità all’alterità, secondo il principio che può essere così formulato: tanta
relazione tanta responsabilità. Si può dire che dove c’è relazione ivi c’è responsabilità
solo se riconosciamo alla relazione il ruolo di svolgere una dimensione costitutivacostituente dell’uomo. Ed è proprio quello che fa Menga, sulla scia di Lévinas,
Ricoeur e Waldenfels 18.
E poiché non siamo in relazione solo con ciò che siamo “ora”, ma anche con ciò
che, nella forma della possibilità, sarà “domani”, ne deriva che siamo responsabili
non solo dell’essere nella forma attuale del presente, ma anche dell’essere che si dà
nella forma possibile del futuro. Che cosa sarebbe infatti un presente se non rendesse
possibile un futuro? Nel tempo non c’è limite alla responsabilità per il semplice fatto
che la responsabilità trascende le tre estasi temporali. Come a dire che come il nostro
essere-oggi è dovuto al comportamento (responsabile o irresponsabile) di chi ci ha
preceduto, allo stesso modo noi oggi siamo obbligati a porre la questione sul modo
(responsabile o irresponsabile) con cui dobbiamo comportarci nei confronti di chi
verrà dopo di noi. E perché questa esigenza? Per il semplice fatto che la relazione
deve avere un altro importante carattere: deve essere una relazione generativa.
17
18
F.G. Menga, Lo scandalo del futuro, cit., p. 101.
Ivi, p. 99.
�215
Il diritto di chi non c’è: tra ontologia della possibilità e principio di genratività
IL PRINCIPIO DELLA GENERATIVITÀ
Se accanto al principio della relazione facciamo entrare in scena un altro principio
ad esso strettamente collegato, la nostra tesi si rafforza. Si tratta del principio della
generatività che prendiamo in prestito dalle considerazioni che in questi ultimi anni
vanno facendo gli studiosi Mauro Magatti e Chiara Giaccardi 19. Secondo questo
principio si può affermare che tutto ciò che esiste, esiste perché è stato generato ed
esiste per generare. Si può dunque sostenere che, se da un lato il presente è tale
perché è stato reso possibile da un passato, dall’altro esso si compie solo se è capace
di garantirsi un futuro.
Accostando e intrecciando insieme i due principi si ha che se da un lato il
principio della relazione permette di individuare un nesso relazionale tra le varie
generazioni, a sua volta il principio di generatività permette alla relazione di
esplicitarsi come di fatto essa è: cioè una relazione generativa, la quale tende al
compimento di quel fine che consente ad ogni estasi temporale di non appiattirsi in
modo autoreferenziale nel proprio arco temporale. Siamo stati tutti generati e siamo
a nostra volta chiamati a generare. Nessuno ha il diritto, né il potere, di fermare il
processo della generatività al proprio essere stato generato. Il primo diritto delle
future generazioni è quello di essere generate, in quanto il processo di generatività si
estende anche a loro proprio attraverso la nostra attuale capacità di generare.
Se questa prospettiva ha una sua validità allora si può sostenere che i diritti
fondamentali oltrepassano la sfera temporale del puro presente. Sono ascrivibili ad
ogni forma di presenza umana. E se lo scopo del presente è avere un futuro, allora i
diritti che vengono dal futuro fondano i doveri di noi che abitiamo il presente.
Infatti, secondo il principio della generatività non si può non generare. Certo si
può anche non farlo, ma ciò sarebbe un andare contro la nostra natura, la quale ci
chiede di perpetuare la nostra specie. La facoltà di generare ci obbliga a farlo. Tale
obbligo ci mette davanti alla possibilità che le future generazioni – generate dalle
precedenti, cioè dalla nostra – abbiano il diritto ad essere generate. Si evince quindi
che il primo diritto delle future generazioni è quello di essere generate. È quello di
avere un presente. Se noi non fossimo capaci di farlo, non saremmo responsabili del
loro possibile non venire al mondo. Ma poiché siamo abilitati a farlo – almeno chi
per noi e tra noi lo è – allora non possiamo sottrarci a tale responsabilità che genera
in noi l’obbligo di dagli non solo un futuro, ma anche un futuro vivibile, all’altezza
della dignità umana. D’altronde, tale obbligo verso le future generazioni è un modo
per disobbligarci verso le precedenti generazioni, grazie alle quali noi oggi siamo al
19
M. Magatti, C. Giaccardi, Generativi di tutto il mondo, unitevi! Manifesto per la società dei liberi,
Feltrinelli, Milano 2014.
�216
M IC H E LE I LLIC ETO
mondo. Se è vero che il nostro venire al mondo è in perenne debito nei confronti di
chi ci ha preceduto, è ancor più vero che siamo in debito anche nei confronti di chi
dal futuro ci chiede (attraverso la categoria della possibilità) di dare loro quello che
noi a nostra volta abbiamo ricevuto.
Secondo il principio di generatività ogni generazione si trova ad essere investita di
un triplice debito: quello nei confronti della generazione che l’ha preceduta, quello
nei confronti di se medesima in quanto chiamata a rispondere del proprio presente, e
infine quello nei confronti della generazione che la seguirà, in quanto questa è
implicitamente già contenuta nella possibilità attuale che la generazione presente ha
di generare. Rompere o disconoscere questa relazione intergenerazionale potrebbe
essere considerato come un ulteriore elemento irrazionale tipico di questa nostra
epoca postmoderna, caratterizzata da narcisismo ed edonismo.
Se il nostro presente è stato reso possibile da un passato responsabile, nei
confronti del quale siamo in debito, allora il nostro presente è a sua volta
responsabile nei confronti di un futuro che è iscritto in noi nella forma della
possibilità generativa.
UNA NUOVA STRUTTURAZIONE DEL TEMPO: IL PARADIGMA
ADAMO/EVA
Per arrivare ad una giustificazione della responsabilità in chiave etica verso le
future generazioni è necessario anche un ripensamento dello schema temporale, o
meglio una «riconfigurazione etica della temporalità» 20.
Oltre alle ragioni apportate da Menga, ciò è reso necessario dal fatto che il potere
immenso che la tecnica 21 ci ha messo nelle mani è tale che le conseguenze dell’uso
che ne facciamo oggi in certi campi, ha conseguenze dirette ed immediate sul futuro.
La tecnica ha accorciato la distanza tra le tre estasi temporali, in modo particolare tra
presente e futuro. Per questa ragione alcuni hanno notato il cambio di rotta che nel
rapporto tra presente e futuro si è verificato, di come cioè il futuro da promessa si sia
trasformato in minaccia.
Tutte queste considerazioni esigono in modo ancora più urgente la necessità di
legittimare la responsabilità del presente verso ciò che è futuro. Allora la domanda è:
come il potenziale tecnico ha modificato il rapporto temporale tra presente e futuro?
E, in definitiva, quale struttura temporale adottare per un’etica della responsabilità
che abbracci anche le generazioni future?
Si tratta di ripensare il tempo a partire dal peso che ha il futuro nella costituzione
del soggetto. Infatti, il futuro è tale che «detiene una forza tale da irrompe nel nostro
20
21
Cfr. F.G. Menga, Lo scandalo del futuro, cit., p. 116.
Cfr. U. Galimberti, Psiche e techne. L'uomo nell'età della tecnica, Feltrinelli, Milano 1999.
�217
Il diritto di chi non c’è: tra ontologia della possibilità e principio di genratività
presente richiamandoci ad una responsabilità verso di esso» 22. Quello dell’altro
temporale costituisce, come dice Menga, citando Derrida, un luogo in cui risiede
«una domanda [che] proviene dall’avvenire» 23.
In tal modo, dare al non-ancora il diritto ad aver uno suo spazio ontologico nella
linea della temporalità significa, pensare «non un farsi incontro al futuro, ma un
futuro che viene dalla sua parte» 24. Qui vale la proposta, fatta da Waldenfels e
ripresentata da Menga, di articolare in modo diverso la temporalità, ripensando il
peso che può avere il futuro anteriore:
Solo sulla base di questa articolazione, infatti, l’appello del futuro non appare
più come un qualcosa di costituito a partire dal presente, ma piuttosto come ciò
che, essendoci già sopraggiunto dal futuro stesso in forma d’ingiunzione, ci ha
già anche costretti a una risposta immediatamente responsabile verso di esso 25 .
È chiaro, per fondare una nuova semantica della responsabilità che non risponda
del solo presente, ma anche di ciò che il presente stesso rende possibile (rendendolo
presente nella forma del non-ancora) come suo compimento che dona senso, è
necessario che il riferimento al futuro tenga conto della distinzione tra futuro
semplice e futuro anteriore:
Il futuro semplice o primario (Erstes Futur) consiste nel fatto che qualcosa
ancora non è o è ancora di là da venire, e ciò in chiara contrapposizione a ciò
che già è o non è più. Il futuro anteriore o secondario (Zweiter Futur) si
contraddistingue, invece, per il fatto che, nel mentre stesso io prendo le mosse,
già qualcosa sarà di me e già qualcosa è in moto. Questo futuro secondario, che
in fin dei conti è quello davvero primario, si ubica contemporaneamente davanti
a noi e dietro di noi 26 .
Come è noto, per discutere della temporalità, in Occidente noi abbiamo avuto due
schemi narrativi con i quali si è organizzata la temporalità: quello ebraico (e
successivamente cristiano) e quello greco. Soffermiamoci brevemente su qualche
considerazione a riguardo.
Nello schema ebraico delle grandi narrazioni c’è un inizio e una fine, un principio
e un fine, un cominciamento e un compimento, un “prima” e un “dopo”.
Apparentemente sembra che ciò che viene prima è più importante di ciò che viene
dopo, come se il dopo fosse figlio di ciò che viene prima. Eppure, a ben vedere, se
valorizziamo alcuni schemi narrativi della temporalità, si nota che ciò che viene dopo
in fondo viene prima. È sì una narrazione lineare, ma non tanto lineare da essere
necessariamente sequenziale. Secondo un metodo che definiremmo
22
23
24
25
26
F.G. Menga, Lo scandalo del futuro, cit, p. 105.
Ivi, p. 105.
Ivi, p. 105.
Ivi, p. 107.
Ivi, p. 108.
�218
M IC H E LE I LLIC ETO
dell’anticipazione posticipata, la linearità subisce un’interruzione, una sospensione.
Si intrufola una novità. Una sorpresa. Una quasi deviazione.
Ad esempio, si pensi alla creazione della donna nel secondo racconto del libro
della Genesi (Gn 2,21-22), dove si narra che la donna viene creata dopo di Adamo.
Eppure, se si legge bene questo versetto, si nota che, in fondo, proprio perché viene
dopo, la donna è come se venisse prima, perché porta a compimento non solo il puro
esserci solitario di Adamo, ma l’intera solitudine di tutto il creato. Non per nulla Dio
stesso si riposa solamente dopo aver creato Eva. Qui emerge uno schema temporale
secondo il quale il “dopo” non è affatto la semplice e diretta conseguenza di ciò che
lo precede, ma si pone rispetto ad esso in primo luogo come un’eccedenza, e in
secondo luogo come il compimento di ciò che viene “prima”.
Non si tratta solo di una sequenza lineare, dove il prima e il dopo sono collegabili
o staccabili. Adamo, infatti, non è la causa di Eva, mentre Eva certamente è la
sorpresa di Adamo. Nel tempo di Eva, Adamo è come sospeso. Nel tempo di Eva si
compie una retrocessione temporale di Adamo, per cui Adamo non ha più tempo. Un
“suo” tempo. Questa retrocessione temporale è indicata dalla metafora del “torpore”
che Dio fa cadere su Adamo. Adamo dorme, mentre Eva nasce. Gli nasce dentro. Gli
nasce oltre. Gli nasce venendo da Altrove. Eva era già scritta nella ferita della sua
mancanza. Nello spazio buio del suo desiderio di generare. Di farsi generazione
ospitale per chi non pensava sarebbe venuto. Un futuro sentito ma mascherato,
tracciato ma non reso ancora evidente. La futura Eva (il dopo non anticipabile) era
già collocata nel presente (apertamente posticipato) di Adamo. Ecco la nuova
struttura temporale che a nostro modo di vedere emerge da tale racconto: l’oltre –
come luogo dell’altro – è dentro. E il dentro non è chiuso, ma è un dentro aperto
all’oltre che lo eccede e lo sorprende.
Adamo – che qui viene da noi eletto a metafora di ogni generazione
impossibilitata a incapsularsi nella propria autoreferenzialità – non basta ad Adamo.
E quale generazione basta a se stessa? L’essenza di ogni generazione è essere
generativa e quindi di lasciare uno spazio in cui far venire l’altro che come possibilità
già ci interpella. La nuova strutturazione temporale esige che si cominci a pensare
non più soltanto ad un’ospitalità in senso spaziale ma anche ad un’ospitalità in senso
temporale. Per cui, da un tempo inchiodato al possesso del proprio presente si
dovrebbe passare ad un tempo ospitale, e quindi responsabile nei riguardi di
quell’eccedenza che ne costituisce la linfa vitale.
Ad un Adamo senza tempo, Eva, venendo, restituisce il tempo. Lo sveglia. È Eva
che restituisce ad Adamo il tempo che gli era stato sospeso. Nel tempo di Eva – che al
tempo di Adamo non c’era – torna anche il tempo di Adamo.
Ma lo schema temporale della relazione Adamo-Eva chiama in causa un terzo
elemento: l’azione del Creatore: Dio. L’elemento Dio – come elemento terzo – lo
possiamo ritradurre e identificarlo – seguendo Lévinas – con il terzo della
�219
Il diritto di chi non c’è: tra ontologia della possibilità e principio di genratività
responsabilità: «Se non rispondo di me, chi risponderà di me? E se rispondo solo per
me, sono ancora io? (Talmud di Babilonia, Trattato Avot 6 a)» 27.
In definitiva, nello schema ebraico-cristiano, il futuro interpella il presente, perché
il senso del presente è di avere un futuro.
In quella greca, la narrazione temporale è tale che ogni estasi temporale si dà nel
circolo dell’eterno ritorno (come l’ha definita Nietzsche), dove accade una sorta di
contaminazione tra passato, presente e futuro, fino a fare scomparire le tre estasi
temporali. Al contrario, in quella ebraica cristiana lo schema temporale che collega le
tre estasi temporali è tale che il senso – e il compimento – di ciò che viene prima si
trova in ciò che viene dopo. Questo significa che ciò che viene dopo riguarda sin
dall’inizio ciò che viene prima. Il futuro indebita il presente, a sua volta indebitato
con il passato. Il presente inoltre lega in modo indissolubile il futuro al passato, nel
momento in cui permette di agganciarsi ad un compimento che non si è ancora
attuato.
Nel chiudere questa breve riflessione sulla dimensione temporale della
responsabilità etica, e applicando questa impostazione al nostro discorso, emerge che
ogni generazione è dentro l’altra generazione, e per questo siamo responsabili di chi,
pur essendo oltre e altro, o addirittura in un altrove non ancora configurato, è tale
che noi ce lo portiamo dentro nella forma della possibilità. Siamo responsabili
dell’altro temporale che come futuro abita il nostro presente come colui che porterà a
compimento tutto ciò per cui ci stiamo dimenando e affaticando.
CONCLUSIONI APERTE. DALL’A-TOPIA ALL’U-TOPIA
Quali punti sono emersi fin qui? In primo luogo si impone la necessità di pensare
l’alterità nella forma della temporalità, per poter avere, da un lato, una fondazione
etica della stessa temporalità, e, dall’altro, arrivare ad una nuova semantica della
responsabilità che risponda anche di ciò che è puramente possibile. Questo sta a
significare che, un eventuale discorso circa la possibilità di trovare una legittimazione
a fondare la responsabilità nei confronti delle nuove generazioni, esige che accanto
alla alterità spaziale e prossimale (topica e atopica), venga collocata anche l’alterità
temporale (diacronica e asimmetrica). Infatti, fin quando l’appello dell’altro mi
giunge da una relazione sincronica e topologicamente raggiungibile, vanno bene le
varie argomentazioni finora apportate dalle etiche tradizionali. La questione sorge
quando ci imbattiamo in quel tipo di alterità che viene dal futuro: l’alterità che si dà
27
E. Lévinas, Umanesimo dell’altro uomo , a cura di A. Moscato, il melangolo, Genova1985, p. 131; sulla
massima ripresa da Levinas, cfr. Id.., Detti dei rabbini , introduzione, traduzione e note di A. Mello, Qiqajon,
Comunità di Bose, Magnano 1993, pp. 69-70.
�220
M IC H E LE I LLIC ETO
nella forma della temporalità e che Menga giustamente vede come caratterizzata
dalla diacronia e dall’atopia. In quest’ottica la natura dell’appello cambia del tutto 28.
Un secondo punto riguarda la necessità di vedere in un modo del tutto nuovo la
soggettività. Non più una soggettività autoreferenziale o egologicamente incentrata
sul proprio “io” eletto a luogo costitutivo-fondativo unico ed esclusivo. Seguendo
l’ermeneutica del sé proposta da Ricoeur in Sé come un altro 29, il soggetto non
scompare, né si impone. Infatti, afferma Menga: «la diacronia e l’atopia dell’appello
dell’altro non conducono alla scomparsa o dissoluzione del soggetto, ma piuttosto lo
configurano attraverso il doppio motivo del pathos e della risposta» 30.
Il soggetto non è chiamato a rispondere solo di ciò che ha posto, imponendo la
propria soluzione (modello impositivo tipico di in pensiero forte), ma è chiamato a
rispondere anche di ciò che è incatturabile e indisponibile, ma che comunque lo
riguarda, proprio a partire dal suo stesso originarsi, connotato da una costituzione di
tipo relazionale.
Terzo punto: un nuovo modo di intendere la temporalità. Ciò è reso necessario per
il fatto che la morale fino ad ora è stata sempre pensata come impostata sul primato
del presente topologico e cronologico. Ma poiché il futuro è diventato un elemento
fondamentale del presente, lavorare sul presente significa interrogarsi sul futuro. Il
potere tecnologico acquisito è tale che ogni scelta fatta oggi ha sempre degli effetti sul
domani. Proprio perché il legame tra presente e futuro è diventato sempre più
inestricabile e profondo, il modo di pensare la temporalità va rivisto al fine di
prendere in considerazione le nuove istanze etiche che da tale rivisitazione derivano.
Questo esige che il soggetto vada pensato come strutturato non solo dalla
contemporaneità e simultaneità, ma anche dalla diacronia e dalla atopia. Infatti,
Menga cita Waldenfels a proposito della diacronia in termini di potenza. Parla di
qualcuno che «ancora non è, eppure già si trova in potenza» 31. L’atopia e la diacronia
sono quindi originari. Si danno insieme all’adesso nella forma del non-ancora.
Proprio perché si danno insieme ci riguardano. Il fatto che siano nella forma del nonancora non ci dispensa dal fatto che essi ci riguardino in termini di responsabilità.
Noi non siamo solo responsabili di ciò che di compiuto si dà adesso, ma anche di
tutto ciò che l’adesso rende possibile attraverso il principio della generatività. Se ciò
che è possibile è presente nell’adesso, noi siamo responsabili, nel presente, di tale
possibile. Ecco allora una nuova categoria: la categoria della possibilità.
Questo però potrebbe apparire un modo mascherato per incapsulare la
diacronicità di ciò che ancora non si è dato nella sincronia dell’attualità di ciò che
invece è già dato. Infatti, l’estraneo che mi giunge dal futuro, trascende lo stesso
28
29
F.G. Menga, Lo scandalo del futuro, cit, p. 101.
P. Ricoeur, Soi-même comme un autre, Seuil, Paris 1990, trad. it. di D. Iannotta, Sé come un altro , Jaca
Book, Milano 1993.
30
31
F.G. Menga, Lo scandalo del futuro, cit, p. 102.
Si veda la nota 11 (ivi, p. 102).
�221
Il diritto di chi non c’è: tra ontologia della possibilità e principio di genratività
livello di possibilità, in quanto come dice Walfenfels egli può «trasgredire la cornice
delle possibilità date» 32. Se reputo originario la atopia e la diacronia finisco per
trasformarle in sincronia e sintopia.
Come si può superare tale difficoltà? Lasciando tutto questo nello statuto di
possibilità. Infatti, tra le possibilità io riconosco quella della stessa trasgressione delle
medesime possibilità. Il carattere di previsione delle possibilità non deve
depotenziare lo statuto del possibile come ciò che può essere trasgredito.
E qui la nostra proposta: aggiungere a tali categorie quella dell’utopia. Il soggetto
rimane eticamente esposto solo se all’atopia e alla diacronia aggiungiamo anche
l’utopia. È infatti il carattere u-topico che salva il carattere a-topico da un’eventuale
cattura calcolante o da un’eventuale rimozione deresponsabilizzante. La validità
della responsabilità etica da attribuire al soggetto costituito da una relazione, che non
è solo fenomenologica ma ancor più ontologica, esige la non disponibilità dell’altro
ad essere catturato in qualsiasi forma di previsione. È nell’u-topia che siamo esposti.
Per tale ragione, al di là della calcolabilità (in termini di contrattualità e di utilità),
non ci può essere vera etica senza esposizione, e quindi non c’è vera a-topia senza
autentica u-topia.
32
Ivi, p. 102.
�222
�223
Etica & Politica / Ethics & Politics, XX, 2018, 1, pp. 223-231
ISSN 1825-5167
TEMPO DELLE GENERAZIONI E
TEMPORALITÀ ETICA
MA RI O V E RGA NI
Università degli Studi di Milano Bicocca
Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione
mario.vergani@unimib.it
ABSTRACT
The article discusses Menga’s important book and it is divided in three parts: the first one
stresses the precise presentation and evaluation of the state of the art about the problem
“justice and next generations”; the second one aims at enhancing the passage proposed by
Menga from a classical approach to a phenomenological approach to this theme. Third, it
analyzes consequences and problems involved in the idea of a deformalization of the
temporality which is requested by the emergence of an injunction of justice from the future.
KEYWORDS
Phenomenology, ethics, justice, generations, future
Il libro di Ferdinando Menga condensa con chiarezza gli sviluppi di una sua
ricerca più vasta sul tema della responsabilità e della giustizia nei confronti
delle generazioni future e sulle sue implicazioni sia sul piano etico che politico.
Al pubblico più ampio presenta una sintesi ragionata e critica di modelli e
teorie che si oppongono, alternano o combinano nel dibattito filosofico, ai
filosofi invece propone una tesi netta sulla quale chiede di prendere posizione;
per questo ci permettiamo di dire che rappresenta un lavoro con il quale è
indispensabile confrontarsi. Come sempre accade, quanto ne fa un testo di
riferimento dipende dal fatto che viene visto con chiarezza lo snodo, a mio
avviso, dirimente, viene posta in modo adeguato la domanda. È in uso
correntemente l’alternativa opposta: una descrizione piuttosto standardizzata
delle trasformazioni storiche e sociologiche che fanno da cornice alla rottura
generazionale (trasformazione dei modi di vita conseguenti alla globalizzazione,
crisi demografiche, declino della trasmissione dell’eredità e degli istituti
�224
M A RIO V E RGA NI
familiari, fino alla crisi della partecipazione alla vita pubblica, alle conseguenze
della tecnica e dello sviluppo capitalistico e al loro impatto sull’ecosistema); ne
segue, d’abitudine, un elenco dei diversi profili di responsabilità verso le
generazioni future. Cosa oggi non possiamo più trascurare, di cosa dobbiamo
curarci: compatibilità tra organizzazione del lavoro e distribuzione della
ricchezza attuale e futura, tra sfruttamento delle risorse ed esistenza di un
mondo di domani che consenta una vita dignitosa ai futuri, e così via. Da
ultimo dunque la domanda sul come: come perseguire il compito di consegnare
a chi verrà dopo di noi un mondo abitabile e una società più giusta?
La mossa di valore qui proposta consiste nello spostare la domanda da questi
livelli a quello del perché: perché dovrebbe riguardarci non solo il futuro
prossimo, ma anche quello remoto? A differenza di approcci diversi e tuttavia
cumulabili, che invece impostano il tema nel senso dell’appello alla buona
volontà, in termini appunto volontaristici o prescrittivi, facendo ricorso in
genere, da ultimo, a figure quali il “senso della solidarietà” o la comune
appartenenza alla stessa umanità o ancora a ragioni di interesse aggregato, qui
si pone il problema della giustificazione, da una parte dell’esistenza di tale
forma di responsabilità riferita al futuro e d’altra parte anche della sua forza di
motivazione, assumendo correttamente che ragioni giustificatrici e motrici –
specialmente in casi come questi dove la dimensione della proiezione temporale
gioca un ruolo chiave – non coincidono. Né, come correttamente rileva Menga,
il ricorso a soluzioni che introducono l’idea dell’esistenza di una qualche
“intuizione morale” che sosterrebbe il cosiddetto “senso di responsabilità verso
le generazioni future” appare convincente, dato che tale idea risulta estrinseca
rispetto alle diverse teorie di riferimento che dovrebbero ospitarla. Di qui viene
introdotto un importante scarto che fa da sfondo all’impianto complessivo,
ovvero l’assunzione che risulti impossibile una risposta alla domanda sul
“perché” senza un ri-orientamento complessivo dell’asse teorico dal piano dei
diritti e della reciprocazione a quello dei doveri e della asimmetricità del
rapporto, o, detto ancora diversamente, senza porre una questione che prima
ancora di essere politica è strettamente etica (uno spostamento d’asse al quale,
come il libro ben documenta, anche la riflessione giuridica e politica più attenta
ai mutamenti in corso non è insensibile, quando introduce l’idea di un
costituzionalismo dei bisogni che si misuri con la distanza temporale – per
riassumere posizioni di cui si fanno portavoce ad esempio Rodotà e
Zagrebelsky). 1
1
Cfr. al riguardo il tema del “costituzionalismo dei bisogni” connesso al problema della
responsabilità verso il futuro in S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Laterza, Roma-Bari 2015, pp.
94-102 e pp. 175-177; sul superamento del presentismo nell’attribuzione dei diritti in vista di una
�225
Tempo delle generazioni e temporalità etica
Lo schema è dunque di opposizione: tra una prospettiva centrata sui diritti e
quella centrata sui doveri, concetto cerniera rispetto al cuore del problema che è
quello dell’obbligazione morale: il che corrisponde da ultimo anche a due linee
di pensiero, e qui ci sarebbe molto da commentare sul fatto che – ça va sans
dire – attualmente prevale quella di impianto liberale, riconoscibile nelle
direttrici dominanti nel dibattito. Anche questa opposizione al mainstream è un
punto totalmente condivisibile:
Come ho cercato di mostrare nel corso di queste pagine, a un tale compito
le teorie morali mainstream non sembrano aver fornito una risposta
davvero coerente e soddisfacente. Per questo motivo, la proposta che vorrei
qui avanzare è quella di segnalare come una prospettiva feconda possa
provenire da una riflessione che si congeda dalle premesse fondative di tali
teorie e si rivolge a un’impostazione fenomenologica genuinamente
improntata sul primato etico dell’alterità. 2
Detto di passaggio dei rischi che possono sorgere a seconda della effettiva
concettualizzazione del “primato etico dell’alterità”, operazione che merita una
grande prudenza in quanto può risolversi in un rovesciamento della figura della
sovranità, la lettura critica del mainstream è condotta con grande acutezza, al
fine di rilevare i nuclei teorici che ne rappresentano i punti ciechi e dunque i
presupposti inesplicitati eppure costitutivi, tali da rendere paradossali e irrisolte
le impostazioni di questa tradizione: il presentismo – la centratura sul presente
e la considerazione del futuro in termini di inclusione o estensione del presente
stesso (Jonas), spesso secondo figure finzionali che si concretizzano in veri e
propri esperimenti mentali (Parfit e Rawls) – e il continuismo, cioè l’idea che si
giustificherebbe l’esistenza di una responsabilità nei confronti delle generazioni
future solo in un regime di continuità – integrale o parziale – tra l’attuale ed
esse (Passmore). 3 Due presupposti, quelli della centratura sul presente e della
inclusione delle generazioni future, cfr. G. Zagrebelsky, Senza adulti, Einaudi, Torino 2016, pp.
85-86.
2
F.G. Menga, Lo scandalo del futuro. Per una giustizia intergenerazionale, Edizioni di Storia
e Letteratura, Roma 2016, p. 98.
3
Menzioniamo i passi delle opere classiche di Jonas, Parfit, Rawls e Passmore nei quali con
maggior evidenza emergono gli impliciti continuisti e presentisti: H. Jonas, Das Prinzip
Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation. Insel Verlag, Frankfurt a.M.
1979, tr. it. Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino 1990, in
particolare Sez. II Cap. II “Il dovere verso il futuro”, pp. 49-57; D. Parfit, Reasons and Persons,
Clarendon Press, Oxford 1984, tr. it. Ragioni e persone. il Saggiatore, Milano 1989, XVI “Il problema
della non-identità”, pp. 447-576; J. Rawls, A Theory of Justice, Harvard University Press MA-London
1971, tr. it. Una teoria della giustizia. Feltrinelli, Milano 1989, §. 44 “Il problema della giustizia tra
�226
M A RIO V E RGA NI
continuità – sviluppate in senso sia inter che intra generazionale – che si
combinano in diverse figure dell’unitarietà. Gli esiti paradossali sono riassunti
negli ostacoli della non-esistenza attale dei futuri e dunque dell’asimmetria
rispetto ad essi per quanto riguarda gli approcci contrattualisti e nell’ostacolo
della non-determinatezza del contenuto di responsabilità per le soluzioni di
impianto utilitarista.
Rispetto a questi, il libro propone una rottura, suggerisce la possibilità di
intraprendere una via radicalmente alternativa: «Ne consegue che l’adeguata e
genuina accoglienza del nucleo fondamentale di siffatta intuizione morale, ossia
l’appello a una responsabilità radicale e originaria verso il futuro e verso
individui futuri, debba essere ricercata necessariamente in un’impostazione
etico-filosofica radicalmente altra». 4 È necessario spostarsi sul piano
fenomenologico:
Pertanto, per quanto intuitivamente difficile da raffigurarsela, una forma
d’interpellazione provocata dal futuro, una “domanda [che] proviene
dall’avvenire” – per usare una formula di Derrida – deve essere assolutamente
contemplata. Soltanto così ci si mette in grado di cogliere i termini in cui il futuro
stesso detiene una forza tale da irrompere nel nostro presente richiamandoci a
una responsabilità verso di esso. 5
Ma allora decisivo risulta come viene compiuto lo spostamento sul piano
fenomenologico, cosa che, a mio avviso, significa chiedersi in che modo
l’interpellazione che proviene dal futuro riguarda me, in quanto apertura di
senso unica e inintegrabile. E come altrimenti, se non riconducendo il
problema delle generazioni a quello fenomenologico della nascita? Per pensare,
a partire dalla nascita, non il rapporto delle generazioni, ma il generare delle
generazioni attraverso il quale si produca una responsabilità che mi riguarda. In
tal modo presentismo e continuismo vengono criticati alla radice dalla
fenomenologia. L’affermazione che «deve essere contemplata una domanda che
proviene dall’avvenire» è fenomenologica nel momento in cui pone un tema
sviluppabile sul piano descrittivo anziché essere postulata da un punto di vista
logico, cosicché si possa mantenere l’idea tradizionale della responsabilitàgenerazioni”, pp. 241-248; J. Passmore, Man’s Responsibility for Nature, Duckworth, London 1974,
pp. 88-91.
4
F.G. Menga, Lo scandalo del futuro. Per una giustizia intergenerazionale, cit., p. 11. Sulla
necessità di un’impostazione che rompa con gli assunti continuisti e presentisti degli approcci
classici e che si confronta con le filosofie dell’alterità e della differenza, segnatamente con la
prospettiva derridiana, cfr. M. Frisch, La justice doit porter au-delà de la vie présente, in
“Sympostium” 21 (1) 2017, pp. 231-253.
5
F.G. Menga, Lo scandalo del futuro. Per una giustizia intergenerazionale, cit., p. 105.
�227
Tempo delle generazioni e temporalità etica
imputazione, ovvero retroflessa (senza la quale è difficile pensare la
responsabilità), e al tempo stesso riferirla a ciò che è da-fare anziché al già-fatto.
Di nuovo, questo richiede che l’indagine venga spostata in direzione di una
fenomenologia della generatività che appunto si spinge anche al di là degli
impliciti presentisti e continuisti che la fenomenologia classica husserliana
comunque conserva a causa del suo trascendentalismo; è necessario cioè
descrivere il generare delle generazioni plurali a partire dalla descrizione di un
presente e di una fase generazionale che siano già a loro volta fratturate e divise
al proprio interno e tra loro e quelle precedenti e seguenti. Allora, da un lato
descrivere la loro divisione interna (quanto hanno già indicato diversi pensatori
delle generazioni, da Dilthey a Schutz a Mannheim), 6 e tuttavia –
mantenendosi sempre a livello fenomenologico, ovvero descrittivo – far
emergere anche in che modo sono in relazione tra loro attraverso tale
separazione, pensando insieme la mortalità che separa l’uno dall’altro e che
scandisce la discontinuità delle generazioni. Potremmo dire con Levinas (che
rappresenta per Menga l’interlocutore costantemente sullo sfondo, come per
tutte le cosiddette filosofie dell’alterità, tra le quali nel libro emerge
principalmente la fenomenologia responsiva di Waldenfels) che spostarsi sul
piano fenomenologico riguardo al tema che qui ci interessa significa «non
definire l’altro per mezzo dell’avvenire, ma l’avvenire per mezzo dell’altro». 7
Viene prefigurata così l’operazione radicale che un approccio
fenomenologico al tema delle generazioni richiede e che consiste in una vera e
propria deformalizzazione della temporalità, valorizzando fino in fondo tutta
una serie di temi che è possibile riassumere attraverso la figura esposta da
Waldenfels (ma anche presente in altri, da Derrida a Jankélévitch e forse a
Benjamin) del “futuro anteriore”, un futuro che sta davanti a noi come il dafarsi. 8 Dunque non solo un’interpellazione che viene dal futuro, perché se
6
Per uno smontaggio dell’idea di generazione come unità compatta, cfr. W. Dilthey, Über das
Studium der Geschichte, der Wissenschaften, vom Menschen, der Gesellschaft und dem Staat (1875),
in GS V [1924], pp. 31-73, tr. it. Lo studio delle scienze umane, sociali e politiche, Morano, Napoli
1975, pp. 57-59; K. Mannheim, Essays on the Sociology of Knowledge 1893-1947 , Routledge, London
1952, tr. it. Le generazioni , il Mulino, Bologna 2008, F. “Collocazione di generazione, legame di
generazione, unità di generazione”, pp. 72-76; A. Schutz, Der sinnhafte Aufbau der Sozialen Welt,
Springer-Verlag, Wien 1960, tr. it. La fenomenologia del mondo sociale, il Mulino, Bologna 1974,
Cap IV: “Analisi della struttura del mondo sociale. Ambiente sociale, mondo dei contemporanei e
mondo dei predecessori”, pp. 199-310, in particolare: “La comprensione del mondo dei predecessori
ed il problema della storia”, pp. 297-310.
7
E. Levinas, Le Temps et l’Autre, Fata Morgana, Montpellier 1948 (1979), tr. it. Il Tempo e
l’Altro, il Melangolo, Genova 1987, p. 53.
8
Su questa figura del futuro connessa alla nozione di “diacronia” nella linea di pensiero qui
richiamata che fa riferimento alla triade Husserl-Levinas-Derrida, cfr. gli importanti studi di N.
De Roo, Futurity in Phenomenology. Promise and Method in Husserl, Levinas and Derrida ,
�228
M A RIO V E RGA NI
futuro e passato restassero ognuno al suo posto e separati dalla linea del tempo,
se non si trattasse che di pensare ad un appello che proviene dal futuro in
analogia con quello che riceviamo dal passato, allora forse questa descrizione
non sarebbe sufficiente a deformalizzare il tempo, se questo futuro non fosse
anche anteriore a noi («Questo futuro secondario, che in fin dei conti è quello
davvero primario, si ubica contemporaneamente davanti a noi e dietro di noi» 9).
In questo senso si può anche accettare la tesi del primato dell’altro – che sopra
abbiamo descritto come ambigua e scivolosa –, alterità dell’altro esattamente da
pensarsi come il fatto che sta davanti a noi, viene prima ed è al tempo stesso dafarsi, e questo a condizione che il presente sia diviso e incompiuto, ovvero che
in esso si esprima un appello di giustizia.
Seguono alcune attenzioni e precauzioni teoriche che per concludere pongo
all’autore di questo libro tanto importante quanto commisurato all’urgenza del
presente e in grado di spostare l’accento su domande oggi ineludibili, che
comportano da ultimo un ripensamento culturale complessivo e radicale. Se la
prospettiva che qui si apre è di rottura e se la rottura consiste nel ritornare alla
fenomenologia – in generale al di là delle descrizione in terza persona se non
addirittura dei riduzionismi – forse dobbiamo prestare la massima cautela per
evitare di pensare all’etica basata sul “primato dell’alterità” nel senso di una
figura rovesciata, dobbiamo cioè avere la massima attenzione rispetto a come
intendiamo questo primato, questa primazia, questo venire prima o questa
antecedenza; e in secondo luogo, qui la difficoltà diviene davvero iperbolica –
ma è quanto richiede la radicalità della domanda che Menga pone – non
possiamo cedere alla tentazione prescrittivistica, ma sempre ricondurci al piano
fenomenologico-descrittivo, e tuttavia cosa, da una parte, della fenomenologia è
irrinunciabile e come, dall’altra, è necessario invece slogarla perché vi sia spazio
in essa per un pensiero delle nascite, delle morti, delle generazioni? Per pensare
il tra-noi del tempo infinito del generare delle generazioni?
Accanto a queste due domande maggiori ve ne sono altre correlate che
sorgono alla lettura di certi spunti conclusivi del testo, questioni tra di loro
intrecciate. Mentre fino a qui abbiamo fatto riferimento al problema della
giustificazione fenomenologica dell’esistenza di una responsabilità riferita ai
futuri nel senso di un’ingiunzione di giustizia rispetto ad essi, torna ora la
domanda sul come, ma di nuovo spostata sul piano fenomenologico; dunque
Fordham University Press, New York 2013, “III. The Futurity of Diachrony”, pp. 82-85; E.R.
Severson, Levinas’s Philosophy of Time. Gift, Responsibility, Diachrony, Hope, Duquesne
University Press, Pittsburg 2013, pp. 264-265 e B. Liebsch, In der Zwischenzeit. Spielräume
menschlicher Generativität, Die Graue Edition, Ettingen 2016, pp. 31-32.
9
B. Waldenfels, Ortsverschiebungen, Zeitverschiebungen. Modi leibhaftiger Erfahrung,
Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2009, p. 198.
�229
Tempo delle generazioni e temporalità etica
non è il “che fare”, nel senso delle strategie da perseguire a fronte del compito
di consegnare a chi verrà dopo di noi un mondo abitabile e una società più
giusta, ma, retrocedendo un passo indietro, quali sono le condizioni che
rendono possibile l’esercizio di tale forma di responsabilità, in forza delle quali
essa risulta praticabile. Alcuni temi possono essere ricondotti a questo ultimo
tornante della salita di Menga, con riferimenti pertinenti ad autori che
effettivamente sviluppano tali temi – da Anders a Muers e in un certo senso
anche Jonas, fino alla Pulcini – ma che, bisogna anche dire, significativamente
sono anche spesso difficilmente integrabili con gli interlocutori maggiori
assunti da Menga di cui abbiamo già reso conto. L’appello che proviene dal
futuro richiede una serie di posture di risposta: «Questione molto più complessa
è invece quella di raffigurarsi come una medesima relazione etica possa
implicare anche una trasgressione estatica del presente esercitata a partire dal
futuro»; 10 «l’appello del futuro non è qualcosa che produciamo noi
contemporanei a bella posta, ma cio che ci costringe “ad un esercizio di
estensione della nostra immaginazione” (Muers)»; 11 «proprio lungo queste
coordinate si comincia a intravvedere la traiettoria di quanto già Günther
Anders definiva come la risposta al “compito morale determinante del giorno
d’oggi [che] consiste nello sviluppo della fantasia morale»; 12 «L’appello del
futuro, come abbiamo visto, implica invece il fatto che l’ingiunzione irrompe
nel presente a partire dal futuro stesso, con la conseguenza che soltanto una tale
irruzione provoca, sollecita o, addirittura, invoca una proiezione immaginativa
connotata da responsabilità e responsività». 13
La domanda che in questo caso è inevitabile porre verterà su un punto solo
al quale tutte le diverse formulazioni sopra riportate riconducono: quando
introduciamo questi termini (trasgressione estatica, estensione della fantasia
morale, proiezione immaginativa) non abbiamo già ricomposto il tempo,
anziché deformalizzarlo e non siamo già tornati ad una prospettiva proiettiva,
riguardo al futuro, quando invece la questione è che il tempo ci proviene
dall’altro e non è quello che noi dobbiamo immaginare per l’altro a rischio di
espropriarglielo? Com’è evidente, il tema del “futuro anteriore” rinvia
esattamente a questa idea di assenza di un orizzonte di prevedibilità della
futurizzazione radicale. Ora tutta questa dimensione è sviluppata nei punti
centrali del libro di Menga – sulla scorta in particolare delle riflessioni di
Waldenfels sulla distinzione tra il futuro semplice o primario (Erstes Futur) e il
10
11
12
13
F.G. Menga, Lo scandalo del futuro. Per una giustizia intergenerazionale, cit., p. 104.
Ivi, p. 106.
Ivi, p. 110.
Ivi, p. 114.
�230
M A RIO V E RGA NI
futuro secondario o anteriore (Zweites Futur) – 14 nei quali viene assunta la
posizione fondamentale che consente di pensare l’etica come pre-liminare
rispetto a ipotesi o presupposti ontologici o naturalistici, ovvero l’inversione
dell’intenzionalità. Ma proprio per questo, a maggior ragione, si tratta di
giustificare come si possa poi conciliare la prospettiva effettiva di rottura
suggerita con questo riassestamento dell’intenzionalità sul soggetto o, detto
altrimenti, se è corretto introdurre il tema della proiezione immaginativa per
chiudere il cerchio della giustificazione dell’esistenza di un dovere di giustizia.
Detto altrimenti si tratta di essere prudenti rispetto al rischio di interpretare
il futuro anteriore nel segno di una sorta di “illusione retrospettiva”, che figura
un avvenire fittiziamente passato per anticipazione, in tal modo impedendone
la venuta e immobilizzandolo, quasi inevitabile per chi intende leggere tale
lemma alla luce del tempo linearizzato, ovvero di una concezione ordinaria del
tempo. È altrettanto vero, d’altra parte, che il futuro anteriore è in grado – se
pensato altrimenti – di scardinare l’idea stessa di ordine della successione
lineare, una volta innestata sul modello della temporalità ordinaria una
descrizione dell’esperienza propriamente umana della temporalità, la
temporalizzazione etica del tempo. In un certo senso il futuro anteriore toglie il
presente, perché esso non sta – e dunque non è stato né sarà –, ma sarà stato,
insieme qui e non ancora: già qui perché sempre passato (passato irriducibile a
un presente-passato, mai stato presente e dunque mai sintetizzabile), ma non
ancora perché sempre a venire, incompatibile con ogni orizzonte che ne
prefiguri l’attesa. Di fatto implica la ripetizione – sarà stato – ma la singolarità
di questa ripetizione è che è la ripetizione di ciò che non ha mai avuto luogo, di
un passato che si dà solo nel futuro, che apre all’idea di una venuta senza che
nulla lo preceda. E tuttavia è anche ripetizione: come pensare la ripetizione
senza che abbia mai avuto luogo ciò che si ripete se non attraverso il paradosso
irriducibile dell’iterazione dell’irripetibile: l’esperienza dell’unicità dell’umano,
ogni volta unica e tuttavia plurale, generazioni di generazioni? 15
Un’ultima considerazione che spero non sembri estemporanea, per rilanciare
e proseguire il dialogo. Nel Trattato delle virtù Jankélévitch definisce l’amore
14
B. Waldenfels, Ortsverschiebungen, Zeitverschiebungen. Modi leibhaftiger Erfahrung, cit.,
187. Sulla struttura dell’“appello-risposta” in quanto “diastasi temporale” che rende possibile
pensare accanto al “futuro primario” anche un “futuro secondario”, in dialogo con il pensiero di
Waldenfels e, a monte, di Levinas, si vedano M. Vanni, L’impatience des réponses. L’éthique
d’Emmanuel Levinas au risque de son inscription pratique, CNRS Editions, Paris, 2004 e M.
Vergani, Responsabilità. Rispondere di sé, rispondere all’altro, Cortina, Milano 2015, pp. 111118.
15
Ci permettiamo di rinviare a M. Vergani, Dal soggetto al nome proprio. Fenomenologia
della condizione umana tra etica e politica, Bruno Mondadori, Milano 2007, “Il futuro
anteriore”, pp. 205-212.
�231
Tempo delle generazioni e temporalità etica
come «un’iterazione o ripetizione che è cominciamento continuato». 16
Potremmo dire che la sua sostanza non sta, non è stata né sarà, ma sempre sarà
stata, non consistendo in altro che nel suo promettere all’altro: “tornerò ad
amarti!”. Responsabilità e giustizia per le generazioni future. Da ultimo, per
pensare fino in fondo il legame che ci tiene all’altro nella separazione e perché
abbia senso l’idea di una responsabilità per le ingiustizie che non abbiamo
compiuto, da ultimo un dubbio: e se per tutto questo la parola vera non fosse
giustizia, ma prima di questa, dentro a questa un’altra? Non è forse dell’amore
che stiamo parlando? Non è attorno all’amore che stiamo girando? Un ponte
dalle arcate spezzate sull’abisso di morte che separa le generazioni, l’amore
forte come la morte? E se il legame, la slegatura segreta tra-noi – per il quale
fremiamo di fronte alle ingiustizie alle quali non siamo stati, né saremo presenti
– non avesse altro nome?
16
V. Jankélévitch, Traité des vertus, Flammarion, Paris 1983, tr. it. parziale, Trattato delle virtù,
Garzanti, Milano 1987, p. 90; sul tema del futuro anteriore nel pensiero di Jankélévitch e in generale
sulla deformalizzazione della temporalità etica, cfr. anche V. Jankélévitch, Henri Bergson, P.U.F.,
Paris 1959, tr. it., Henri Bergson, Morcelliana, Brescia 1991, in particolare “L’ottica retrospettiva e il
miraggio del futuro anteriore”, pp. 24-38 e Le Je-ne-sais-quoi et le Presque-rien, Seuil, Paris 1980, tr. it.
Il Non-so-che e il quasi niente, Marietti, Genova 1987, p. 53.
�232
�233
Etica & Politica / Ethics & Politics, XX, 2018, 1, pp. 233-237
ISSN 1825-5167
‘ALTRIMENTI CHE TEMPO’? QUALE
FUTURO PER LA GIUSTIZIA
INTERGENERAZIONALE
GA BRI E LLA BA PT I ST
Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia
Università degli Studi di Cagliari
baptist@unica.it
ABSTRACT
In his book Lo scandalo del futuro. Per una giustizia intergenerazionale Ferdinando Menga
suggests a phenomenologically founded ethics of responsibility towards the future generations,
with a special reference to the contemporary thinking of otherness, difference and strangeness.
The focus is on an urgent questioning of the future not only as another time, or the time of the
other, but also as the challenge of an “Otherwise than time”.
KEYWORDS
Time, future, phenomenology, Levinas, Waldenfels
È ormai scontata l’urgenza di porre il problema dell’impronta umana
sull’ambiente e sulla vita in generale a fronte delle minacce sempre più evidenti di
giungere in breve al punto di non ritorno dell’autodistruzione. Su questo sfondo
inquietante, che ha caratterizzato il pensiero della seconda metà del Novecento,
confrontato alle devastazioni irreversibili prodotte dalla politica e dalla tecnica e di
cui la Shoah e Hiroshima rappresentano l’emblema, la questione della responsabilità
verso le generazioni future, condannate in anticipo a condizioni potenzialmente
disumane, se non addirittura sacrificate senza troppi scrupoli dall’ingordigia miope
del presente, è spesso al centro della discussione etico-politica contemporanea, come
ben documenta il saggio di Ferdinando Menga, che in maniera acribica sonda le
diverse posizioni in campo, informando innanzitutto in maniera minuziosa sui più
recenti contributi di parte contrattualista, utilitarista, giusnaturalista, liberallibertaria, in genere solidali nello statuire una riduzione consistente, se non
�234
G A BRIE LLA B A PTIST
addirittura un azzeramento definitivo, di ogni obbligo verso il futuro 1. L’intenzione
ambiziosa è quella di fondare, a partire da un’impostazione fenomenologica, «una
responsabilità etica che trov[i] il suo motivo propulsore in un appello irriducibile da
parte dell’alterità» 2, soprattutto nel riferimento ad autori quali Emmanuel Levinas,
Paul Ricœur, Jacques Derrida, Bernhard Waldenfels. Si tratta per Menga di una
responsabilità originaria, non negoziabile in un contratto, né misurabile secondo un
computo di costi-benefici o una proiezione di reciprocità e neanche ipoteticamente
oggetto di concertazioni giurisprudenziali o accordi comunitari: i futuri non sono
esistenti e persino il diritto più avveduto, così come le democrazie più avanzate
peccano di ‘presentismo’ nel loro centrarsi sulla procedura deliberativa e sulla
sovranità popolare, sempre caratterizzati dal realismo di una mediazione e
concertazione simmetriche e compresenti. Quella che si profila è invece una
responsabilità per un altro del tutto estraneo anche e soprattutto nel tempo,
consegnata perciò al suo carattere iperbolicamente discronico e volutamente
asimmetrico.
Il sesto capitolo su “Il futuro dell’altro. Per una responsabilità intergenerazionale
in chiave fenomenologica” 3 costituisce il cuore del libro di Ferdinando Menga,
introdotto da una citazione nietzscheana dal Così parlò Zarathustra che esalta la
nobiltà dell’amore per quanto è remoto e futuro e accompagnato fin dall’inizio dal
proposito di prendere sul serio le impasse fondative dell’etica intergenerazionale e di
proporne un ripensamento radicale a partire dal primato etico dell’alterità. Menga si
colloca sulla scia di autori quali Hans Jonas, Karl Jaspers, Günther Anders, oltre ai
già citati pensatori della differenza, dell’alterità e dell’estraneità, accomunati
dall’essersi tutti formati ‘alla scuola della fenomenologia’, per riprendere un celebre
titolo ricœuriano, ma anche dall’aver tutti messo in questione la centralità di un
soggetto costituente, presente a se stesso e autoreferenziale, per il quale l’altro è solo
un alter ego, come notoriamente ricorda la Quinta Meditazione cartesiana di
Edmund Husserl 4. Atopia, diacronia e asimmetria caratterizzano quell’altro soggetto
eccentrico cui comunque non si rinuncia né si depone, ma che si profila come
estraneo a casa propria, interpellato da un tempo che non padroneggia nella
sincronia di un presente proiettato al futuro o che trattiene il passato, impossibilitato,
nel suo prospettarsi oltre a sé, ad ogni intenzione, anticipazione, programma,
previsione, elusione o propiziazione.
1
F.G. MENGA, Lo scandalo del futuro. Per una giustizia intergenerazionale, Edizioni di Storia e
Letteratura, Roma 2016.
2
Ivi, p. 9.
3
Ivi, pp. 97-111.
4
E. HUSSERL, Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge, a cura di S. Strasser, Husserliana ,
vol. I, Nijhoff, Den Haag 1950; trad. it. di F. Costa, Meditazoni cartesiane con l’aggiunta dei Dirscorsi
parigini, Bompiani, Milano 1994.
�235
‘Altrimenti che tempo’?: quale futuro per la giustizia intergenerazionale
Vorrei centrare l’attenzione in particolare sul tratto diacronico che Ferdinando
Menga esalta come il vero nocciolo di quell’inciampo rappresentato dallo scandalo
del futuro e che rappresenta un importante riferimento nel tentativo di fondare
un’etica della responsabilità intergenerazionale «a partire da un appello da parte di
un’alterità genuinamente connessa al futuro» 5. Ci si dovrà naturalmente chiedere:
quale futuro, se scardinato da ogni progetto? Quale tempo, se svincolato da ogni
temporalità o temporalizzazione? A ben vedere siamo nel cuore di quell’altra
temperie filosofica, iniziata dall’eresia fenomenologica di Martin Heidegger,
caratterizzata dalla decisa centratura sulla precedenza del futuro e altrimenti
declinata rispetto alla teleologia della ragione in Husserl 6, poi ulteriormente variata e
contestata nella seconda metà del Novecento.
Venuta meno la fiducia illuminista nel progresso, accantonato il calcolo ottimista
della felicità del maggior numero, abbandonata anche la rassicurazione idealista
sulla bontà del processo storico e sulle sue riconciliazioni, dopo la rottura
rappresentata dalla Grande Guerra e dalla fine traumatica dei sogni della Belle
époque nell’angoscia del declino, se non addirittura nella lacerazione
dell’imbarbarimento collettivo e nella regressione della società di massa, già la prima
metà del Novecento, ma poi soprattutto il pensiero del Secondo Dopoguerra sogna
una nuova chance per un’apologetica del futuro altrimenti connotata rispetto
all’autenticità ancora egotica dell’essere-per-la morte heideggeriano. Che sia il
materialismo messianico senza attesa della filosofia benjaminiana dopo la fine della
fede nella storia, che sia il chiliasmo eretico dell’utopia con il suo solidale passaggio
del testimone e la speranza rivoluzionaria in un ultimo salvatore di Ernst Bloch, che
sia il miracolo della seconda nascita nell’iniziativa etico-politica prefigurato da
Hannah Arendt, l’esaltazione di un essere-per-dopo-la-mia-morte di Emmanuel
Levinas o l’ipseità della promessa di Paul Ricœur, molte voci, spesso nel confronto
critico con Essere e tempo, hanno additato ad un futuro non anticipabile né
dominabile, ma dal quale al contrario viene un’ingiunzione vincolante. Si potrà dire
che si tratta di una sorta di messianismo filosofico riformulato come istanza etica, in
genere affrancato dalla sua provenienza teologico-religiosa o comunque fatto
deragliare dal suo indirizzo salvifico e certamente secolarizzato rispetto all’attesa
escatologica e apocalittica 7. Il confronto con il presente in questione e il suo passato
traumatico ha disegnato così altri futuri rispetto ai sogni o agli incubi di utopie e
distopie, ipotizzando non solo altri tempi e altri futuri, un tempo altro o dell’altro,
5
F.G. MENGA, Lo scandalo del futuro, cit., p. 11.
Si veda in particolare il § 65 di M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, Niemeyer, Tübingen 1927; trad. it.
di P. Chiodi, Essere e tempo, Longanesi, Milano 1976, secondo cui il futuro è il fenomeno primario
della temporalità originaria e autentica.
7
Si potrà vedere in proposito, per esempio, il numero monografico a cura di P. CIPOLLETTA,
Europa e Messia. Paure e speranze del XX secolo in eredità , in “B@belonline/print. Voci e percorsi
della differenza”, 2008, n. 4, pp. 9-290.
6
�236
G A BRIE LLA B A PTIST
ma addirittura un ‘altrimenti che il tempo’, che certamente è sotteso alle analisi
levinasiane sul tempo perso e sulla pazienza di Autrement qu’être 8 e che forse è uno
dei significati da intendere dietro quell’intraducibile «anderswann» di Bernhard
Waldenfels, evocato da Ferdinando Menga e da lui tradotto come un «tempo altro» 9.
Potremmo forse caratterizzarlo anche come un ‘altroquando’, che ai romani ricorderà
una libreria del centro barocco specializzata in cinematografia, rimando questo che
ben si addice sia alla passione per l’arte e la letteratura che sempre abita e inquieta la
riflessione filosofica di Levinas e Waldenfels – certamente gli autori di riferimento
teoricamente più presente nel saggio su Lo scandalo del futuro –, sia al rimando
ripetuto di Menga a un’intuizione morale che passa anche attraverso gli esercizi
dell’immaginazione. In fondo il racconto o la storia di finzione mettono in scena un
tempo uscito dai cardini, sospeso da ogni ordine e messo tra parentesi, come ricorda
Ricœur riferendosi a un tempo senza tempo e fuori tempo in Temps et recit 10.
Ma che cos’è l’‘altroquando’ che Bernhard Waldenfels affianca all’‘altrove’, per
esempio al termine del suo Ortsverschiebungen, Zeitverschiebungen. Modi leibhafter
Erfahrung? 11 Certo non un tempo pianificabile da un soggetto onnipresente anche là
dove non può più stare o non può ancora essere, piuttosto un tempo caratterizzato
dalla non sincronicità, neanche quella dell’associazione immaginativa o della
costruzione intuitiva, un tempo controtempo, intempestivo e inattuale. Per variare il
celebre titolo levinasiano: Altrimenti che tempo? Come siamo, se siamo, in questo
tempo che non fugge semplicemente né incalza dietro le nostre spalle o ci rende
ancora più vulnerabili invecchiandoci, e che non è neanche solo messo intanto nella
parentesi artistica e letteraria del ‘come se’, dove ancora si rapporta all’intemporale,
all’imperscrutabile e all’immemoriale? Un tempo che mescola i tempi e i riferimenti
come avviene nel futuro anteriore cui rimanda spesso anche Jacques Derrida? Si
8
Cfr. per esempio E. LEVINAS, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, Nijhoff, La Haye 1974,
pp. 11 e segg., 68 e segg.; trad. it. di S. Petrosino e M. T. Aiello, Altrimenti che essere o al di là
dell’essenza, Jaca Book, Milano 1983, pp. 13 e segg., 68 e segg. Come è noto, in questi contesti Levinas
fa riferimento in particolare alla Ur-impression e al presente vivente di Husserl, oltre che alla durata di
Bergson, e per sua stessa ammissione riconosce di aver sviluppato il problema del tempo
nell’indirizzarsi verso un passato pre-originale, più che secondo un futuro che chiama e reclama.
9
F.G. MENGA, Lo scandalo del futuro, cit., pp. 102 (nota 11) e 117.
10
P. RICŒUR, Temps et récit, in 3 voll., Seuil, Paris 1983-1985; trad. it. di G. Grampa, Tempo e
racconto, Jaca Book, Milano 1986-1988. Nel secondo volume, come è noto, Ricœur si confronta con gli
studiosi di letteratura che hanno tematizzato la funzione e la finzione del tempo in letteratura, con
particolare rimando agli studi di K. HAMBURGER, Die Logik der Dichtung, Klett, Stuttgart 1957 e di
H. WEINRICH, Tempus. Besprochene und erzählte Welt, Kohlhammer, Stuttgart 1964. Sull’anacronia
della narrazione e il suo additare ad una filosofia della storia aperta sia consentito rimandare a G.
BAPTIST, La memoria dell’irreale e le sue storie. A proposito di Tempo e racconto, in V. BUSACCHI, G.
COSTANZO (a cura di), Paul Ricœur e «les proches». Vivere e raccontare il Novecento, Effatà,
Cantalupa (Torino) 2016, pp. 163-171.
11
B. WALDENFELS, Ortsverschiebungen, Zeitverschiebungen. Modi leibhaftiger Erfahrung,
Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2009, p. 240.
2
�237
‘Altrimenti che tempo’?: quale futuro per la giustizia intergenerazionale
tratta di un tempo che non si conta come il tempo della physis, né si aspetta come il
tempo della psyche, ma dal quale si è invasi e addirittura sopraffatti nel patire
l’urgenza di un ‘non c’è più altro tempo che resta’.
È proprio questa la passione del futuro che guida l’indagine di Ferdinando Menga,
un’affezione che non ha più nulla di coscienzialmente trascendentale o esistenziale,
nulla di fenomenologicamente costituente, ma che si vuole come «una trasgressione
estatica del presente esercitata a partire dal futuro» 12, un futuro che ‘sopraggiunge’
come un ladro nella notte, secondo modelli che ricordano le narrazioni
neotestamentarie, il che forse spiega anche la chiusa del saggio nel rimando alla
pietra di scarto e alla testata d’angolo del vangelo di Marco 13.
Ci si potrà chiedere se la fondazione che Ferdinando Menga addita
nell’orientamento impossibile e non pianificabile a un futuro che non solo incalza,
ma che sorprende e spiazza, non si configuri come una sorta di nuovo messianismo
etico, senza profezia di salvezza e senza attesa di redenzione, senza speranza di
ricomposizione delle sconfitte, di emancipazione dalle condanne e dalle catastrofi:
nessun disvelamento, nessun approdo, ma un altro tempo alla fine di ogni egocrazia
autocentrata nella sua ‘topica’ e nella sua ‘cronica’, un tempo inquieto dello scacco
che fa impazzire ogni ordine incardinato nel qui e ora, un tempo eccedente ancora da
pensare nel risvolto etico del suo non essere in alcun modo disponibile e afferrabile,
un tempo che manca e che solo nel suo sottrarsi resta, fondamento paradossale e
necessariamente assente di un’etica della responsabilità per quell’altro e quegli altri
irrappresentabili che sono l’avvenire e le generazioni future.
12
13
F.G. MENGA, Lo scandalo del futuro, cit., p. 104.
Cfr. ivi, p. 118.
�238
�239
Etica & Politica / Ethics & Politics, XX, 2018, 1, pp. 239-247
ISSN 1825-5167
YET NOT ENOUGH TO SAY A BOMB
WILL FALL
TO MMA S O GA Z Z O LO
Dipartimento di Giurisprudenza
Università di Sassari
tommaso.gazzolo@libero.it
ABSTRACT
The paper, in dialogue with Ferdinando Menga’s book, is devoted to discussing some problems
about the issue of responsibility towards future generations. Especially, starting from a few points
about the danger of the “bomb”, one wonders how it is possible to be responsible for an act that,
among its consequences, will have the one of entirely extinguishing the very future human beings
as those to whom one is supposed to respond. The paradox will be that we never could answer for
the most criminal act, the one that will destroy humanity. For solving this illogicality, it is necessary
to think a new concept of responsibility.
KEYWORDS
Responsibility, future generations, bomb, Jonas, Gregory Corso, legal philosophy
1. THAT I CAN’T EXIST IN A WORLD THAT CONSENTS / A CHILD IN A PARK A MAN
DYING IN AN ELECTRIC-CHAIR 1 . «Per un atto che non lascerebbe più in vita nessuno
in grado di porre domande, non può esistere alcun genere di responsabilità» 2. È a
1
Ferdinando Menga si è servito, nel suo libro, di una serie di “innesti”, di citazioni, di epigrafi
nietzscheane, che separano un capitolo dall’altro, che costituiscono la logica sottile, forse, del suo modo
di ripensare il problema dei “venturi”, delle generazioni future. Avevo pensato di riprendere questo
“ritmo”, la strategia concettuale che implica (ed anzitutto un certo volgere in positivo l’irresponsabilità
– la grande invenzione di Nietzsche). Se ho preferito, invece, ricominciare dalla “bomba” – e da un
altro innesto, quello di Gregory Corso – è in fondo perché, come ha osservato Derrida, la «guerra
nucleare totale», in quanto «ipotesi o, se preferite, in quanto fantasma, condiziona tutti i discorsi e tutte
le strategie», forse anche quelle passate (anche la strategia nietzscheana, dunque). Siamo già da sempre,
allora, installati in un discorso – retorico, politico, etico, etc. – determinato dalla “bomba”, dalla sua
possibilità: è di questa “possibilità” che tenteremo, qui, di dar conto, nel suo rapporto con il problema
della responsabilità per le generazioni future.
2
H.M. Enzensberger, Riflessioni davanti a una gabbia di vetro , in Id., Politica e crimine. Nove saggi ,
trad. it. di D. Zuffellato, Torino, Bollati Boringhieri, 1998, p. 31.
�240
T OMMA SO G A ZZ OLO
partire da qui – da questa ipotesi limite, resa possibile da quella che Günther Anders
ha chiamato la «rivoluzione copernicana» della «situazione atomica» 3 - che il concetto
di responsabilità deve forse essere ancora ripensato sul piano dell’etica e del diritto.
Lo “scandalo”, ciò che mette radicalmente in questione la responsabilità, sarebbe che
il crimine – si pensi ad una guerra nucleare, ma non soltanto – che provocherebbe la
fine del genere umano, insomma, sarebbe per definizione un atto di cui nessuno
potrebbe essere ritenuto responsabile, poiché dopo il suo compimento non ci sarebbe
alcuno a poterlo giudicare, a testimoniare per esso: non sarebbe, a rigore, neppure un
crimine, pertanto. Nel momento stesso in cui è divenuto possibile compiere un simile
atto, un atto che escluda a priori la possibilità di chiederne conto, di risponderne, la
stessa nozione di responsabilità rischia di perdere ogni significato 4.
Almeno da Hiroshima, da quella «cosa-senza-nome» 5, la nostra “responsabilità”
verso le generazioni future appare incerta, almeno nella misura in cui potremmo
sempre far sì che non vi sia nessuno a cui respondere. Per questo Menga, del tutto
correttamente, ritiene essenziale un «ripensamento radicale» del discorso etico e
giuridico riguardante anzitutto il «futuro dell’altro» 6, dimostrando come una
autentica responsabilità rivolta al futuro non possa che essere pensata a partire dal
«primato etico dell’alterità». Si tratterà, cioè, di non pensare più il futuro a partire dal
presente, di fondare la nostra responsabilità per il futuro come proiezione verso
quest’ultimo, quanto di essere fatti responsabili dall’appello che sopraggiunge dal
futuro 7, dall’esposizione a ciò che avviene e ci ha da sempre preceduti.
Proseguire il discorso di Menga, farlo continuare e continuare ad interrogarlo, è
un impegno che riguarda, allora, anzitutto, il tempo della responsabilità, la
temporalità propria di una responsabilità intergenerazionale – sulla linea, in parte,
del passaggio da una responsabilità retrospettiva ad una responsabilità prospettica,
per servirsi di una distinzione di Moore 8, ed in cui l’etica della responsabilità per il
3
G. Anders, Diario di Hiroshima e Nagasaki. Un racconto, un testamento intellettuale, trad. it.
Milano, Ghibli, 2014, p. 7. Su Anders, e la tematica qui affrontata, si rimanda al bello studio di P.P.
Portinaro, Il principio disperazione. Tre studi su Günther Anders, Torino, Bollati Boringhieri, 2003.
4
Cfr. É. Benveniste, Le vocabulaire des istitutions indo-européennes, Paris, Minuit, 1969, trad. it. di
M. Liborio, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, II, Torino, Einaudi, 1976, pp. 442-451. Per
un’introduzione al concetto di responsabilità, rimando qui a M. Vergani, Responsabilità. Rispondere di
sé, rispondere all’altro, Milano, Cortina, 2015; M.A. Foddai, Sulle tracce della responsabilità. Idee e
norme dell’agire responsabile, Torino, Giappichelli, 2005; F. Miano, Responsabilità , Napoli, Guida,
2009; B. Giacomini (a cura di), Il problema responsabilità , Padova, Cluep, 2004.
5
G. Ceronetti, Hiroshima, la cosa-senza-nome, in Id., Cara incertezza , Milano, Adelphi, 1997, pp.
19-23.
6
F.G. Menga, Lo scandalo del futuro. Per una giustizia intergenerazionale, Roma, Edizioni di Storia
e Letteratura, 2016, p. 97.
7
F.G. Menga, Lo scandalo del futuro. Per una giustizia intergenerazionale, cit., p. 117.
8
Cfr. M.S. Moore, Law and Psychiatry: Rethinking the Relationship, Cambridge, Cambridge University
Press, 1984, p. 50. Si veda anche, a commento della distinzione introdotta da Hans Jonas tra “responsabilità
di” e “responsabilità per”, M.A. Foddai, Agire eticamente. Jonas e le nuove responsabilità, Napol, Jovene,
2017, p. 65: «La “responsabilità per” si differenzia sia dall’obbligo giuridico di rispondere dei propri atti, sia
�241
Yet not enough to say a bomb will fall
futuro di Jonas 9, ma anche di Apel, giocano certamente un ruolo essenziale.
Dovremo ricominciare allora da una serie di questioni e di problemi.
Che cosa significa responsabilità per le generazioni future? La prospettiva di
Menga mette, in fondo, in discussione l’idea che si tratti di una responsabilità
“retrospettiva”: l’idea stessa, cioè, di una responsabilità per ciò che è stato compiuto,
per qualcosa che è stato (di cui saremo chiamati a rispondere nei confronti delle
generazioni future). Di una responsabilità, cioè, di cui potremmo essere chiamati a
rispondere solo in futuro, ma per ciò che abbiamo compiuto nel passato. È questa
idea che va ripensata dopo la rivoluzione copernicana della “bomba” (ma the bomb,
come Corso spiegava, è sempre più e altro che il fungo atomico: i bambini
abbandonati nei parchi, le sedie elettriche, la vecchiaia, perché tutto, nell’età della
tecnica, mette in gioco non più la nostra possibilità di scomparire, ma di
sopravvivere).
La nostra responsabilità per le generazioni future non indica la nostra
responsabilità “nei confronti di esse”, la responsabilità che avremo o che potremmo
avere. Indica l’essere responsabili “in loro favore” o, al limite, “al loro posto”, affinché
le generazioni future – di cui nulla sappiamo, di cui nulla sapremo mai – possano
ancora venire. Non possiamo essere responsabili di fronte a loro (ostacolo della nonesistenza): siamo già da sempre responsabili, però, del loro a-venire, rispondiamo già
ora di tutto ciò che, se fosse compiuto, impedirebbe ad esse di giungere, di arrivare.
Questo significa, in ultima istanza, disporsi ad essere interpellati, ascoltare ciò che
esse hanno già ingiunto.
2. LO THE VISITING TEAM OF PRESENT / THE HOME TEAM OF PAST. In che termini
si potrà parlare, allora, di diritti delle generazioni future? Nella prospettiva che qui,
con Menga, seguiamo, essi non potranno essere considerati come correlativi di
obblighi nei confronti di persone future 10. Non sono, cioè, diritti che persone non
dal dovere morale di rendere conto, davanti alla propria coscienza o a un tribunale divino, delle proprie
azioni. “Esiste però ancora un concetto complementare diverso di responsabilità, dice Jonas, che non
riguarda la resa dei conti ex post facto per quanto è stato compiuto ma la determinazione del da-farsi,
rispetto al quale io mi sento responsabile in primo luogo non per il mio comportamento e le sue
conseguenze, bensì per la causa che m’impone di agire”. La differenza fondamentale tra una responsabilità
retrospettiva, basata sui principi della sanzione e della retribuzione, e una responsabilità prospettica, definita
dalla valutazione delle conseguenze, sta nel concetto giuridico e morale d’imputazione che non opera in
quello di responsabilità proposto da Jonas».
9
Per un’introduzione al tema, si rinvia a P. Becchi - K.-O. Apel - P. Ricoeur, Hans Jonas: il filosofo e
la responsabilità, Milano, Albo Versorio, 2004; P.B. Helzel, Il diritto di esistere delle generazioni
future. Alcune riflessioni su Hans Jonas, in E. Sgreccia – G.P. Calabrò (a cura di), I diritti della persona
nella prospettiva bioetica e giuridica, Lungro, Marco, 2002, pp. 315-325; P. Becchi, Hans Jonas e l’etica
applicata. Una visione d’insieme, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 2, 2011, pp. 419434. Si veda, per uno sguardo d’insieme sui problemi filosofici della responsabilità verso le generazioni
future, G. Pontara, Etica e generazioni future, Roma-Bari, Laterza, 1995.
10
Cfr. A. Gosseries Ramalho, Lo scetticismo sui diritti delle generazioni future è giustificato?, in R.
Bifulco – A. D’Aloia (a cura di), Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e
�242
T OMMA SO G A ZZ OLO
ancora esistenti potrebbero vantare nei nostri confronti, obbligandoci a compiere o
astenerci dal compiere determinate azioni o a rispondere per esse. Del resto, anche
solo parlando di “diritti” e di “persone” finiremmo per vincolare e predeterminare le
generazioni future ad una determinata concezione del diritto – e, con esso, dell’etica
–: nulla ci dice che i “venturi” rivendicheranno diritti; nulla ci dice che
continueranno a pensarsi a partire dal loro essere “persone”, o “soggetti di diritto” 11.
Assegnare ad essi dei “diritti” significherebbe già predeterminare la loro stessa
esistenza: significa interpellarli, chiamarli già con un nome, costituirli come soggetti,
con un’identità definita. Eppure il futuro è tale proprio in quanto esso non è un
presente non-ancora stato, futuro già da sempre presente, ma è il sempre a venire del
futuro stesso, l’avvento dell’avvenire che deve sempre essere mantenuto come
possibile, come qualcosa che non sarà mai presente.
Le “generazioni future” non sono, da questo punto di vista, le generazioni non
ancora esistenti (ma che sono già destinate a venire ad esistenza: i “nostri” figli, i
“nostri” nipoti): esse sono le generazioni a-venire, le generazioni, cioè, che devono
sempre poter essere altre e diverse rispetto a tutto ciò che noi, oggi, decidiamo nei
loro confronti («cosa sarebbe infatti il futuro se non potesse essere qualcosa di diverso
dal futuro?» 12).
3. COME WITH THY GOWN OF DYNAMITE GREEN. Quali obblighi, dunque,
abbiamo già assunto, in forza di questa responsabilità? Il problema, qui, è pensare il
senso del diritto a partire da questo impegno, da questa responsabilità di far sì che il
futuro possa continuare a-venire, a non essere semplicemente ciò che non-è-ancora
presente. Il diritto appare connotato dalla progettualità e, con essa, da una certa
concezione della temporalità: esso dispone per l’avvenire; determina, cioè, il senso di
ciò su cui ora dispone a partire dal primato dell’avvenire nel tempo, in vista di ciò
che sarà. Rispetto al problema delle generazioni future, è questo carattere di
“progetto”, tuttavia, che si trova a dover essere ripensato.
della responsabilità intergenerazionale, Napoli, Jovene, 2008, pp. 29-54. La letteratura giuridica in
materia è pressoché sterminata – di essa, peraltro, il testo di Menga dà conto in bibliografia. Aggiungo
unicamente il volume a cura dello stesso Ferdinando Menga e di Fabio Ciaramelli La responsabilità
verso le generazioni future. Una sfida al diritto, all’etica e alla politica, Napoli, Editoriale Scientifica,
2017. Mi limito invece a richiamare, per l’Italia, i contributi di S. Pratesi, Generazioni future? Una sfida
per i diritti, Torino, Giappichelli, 2007; R. Bifulco, Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della
responsabilità intergenerazionale, Milano, Franco Angeli, 2008; G. Palombella, Ragioni di giustizia,
diritti e generazioni future, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 84, 3, 2007, pp. 399-436;
C. Zanghi, Per una tutela delle generazioni future, in «Jus», 1, 1999, pp. 623-638.
11
Cfr., sul punto, U. Pomarici, Generazioni future, identità personale, umanità , in R. Bifulco – A.
D’Aloia (a cura di), Un diritto per il futuro, cit., pp. 141-160.
12
W. Hamacher, Lingua amissa . Il messianismo della lingua merce e Spettri di Marx di Jacques
Derrida , in J. Derrida, Marx&Sons. Politica, spettralità, decostruzione, trad. it. Milano, Mimesis, 2008,
p. 226.
�243
Yet not enough to say a bomb will fall
A partire dalla modernità questa “progettualità” si è caratterizzata per l’implicita
pretesa di progresso cui rimanda. In ogni decisione giuridica sarebbe, cioè, sempre
intrinseca la pretesa «ch’essa, la decisione, produca uno stato normativo “migliore”»,
che il mondo, dopo di essa, si presenterà come «progredito» rispetto alla situazione
antecedente 13. Pensata nei termini di un “progresso”, tuttavia, la progettualità rischia
di finire per identificarsi con una pretesa di determinare il futuro, inteso come quel
presente che non-è-ancora e che si intende far esistere, disponendo per esso, in un
certo modo. Diversamente, il problema delle generazioni future implica che il
presente sia determinato dall’avvenire; che il presente, cioè, si progetti come ciò che
non determinerà in anticipo ciò che verrà, ma che lo mantenga nella sua possibilità
di sopraggiungere anche diversamente da come lo si prevede o lo si desidera.
Solo fino a quando saranno, del resto, a-venire, le generazioni potranno dirsi
future: nel momento stesso in cui la loro venuta dovesse essere già determinata, prevista e progettata, essa cesserebbe di essere tale, per essere inscritta nella pretesa di
progresso propria del diritto presente, del diritto che non si fa che nel presente, per
quanto in vista del futuro. Ciò che occorrerebbe, allora, pensare – al di là, forse, di
ogni «legislazione», intesa nel suo significato moderno 14 – sarebbe un diritto che non
si faccia più “in vista” del futuro (guardando cioè ad esso, rendendolo visibile e
progettabile), bensì che possa esporsi al sopraggiungere di un avvenire il cui senso
deve restare indeterminato e imprevedibile. Il che non significa una rinuncia
all’azione (o un in dubio contra projectum 15); al contrario, significa farsi responsabili
di un’azione, di una pratica che sia essa stessa a rendere possibile – pur senza
saperne alcunché, pur senza mai pre-vedere ciò che sarà – la libertà delle generazioni
future, la loro stessa possibilità di giungere senza che nulla ne determini prima le
condizioni di esistenza. Che, tuttavia, possano (in una possibilità sempre possibile 16)
giungere, è ciò a cui impegna questa responsabilità
Il senso del diritto – della sua funzione sociale e istituzionale – si trova allora
esposto ad una trasformazione: se il diritto moderno non è pensabile che a partire
dalla sua pretesa di progresso (dal suo disporre-per l’avvenire), un diritto che si
determini a partire dalle generazioni future – dalla responsabilità cui esse ci
impegnano – non dovrebbe necessariamente rinunciare alla sua pretesa di essere, per
dirla con Troeltsch, «superamento del presente e fondazione del futuro»? Non
13
M. La Torre, L’evoluzione del diritto e la «pretesa di progresso». Per una modesta filosofia della
storia del diritto, in «Ragion Pratica», 48, 1, 2017, p. 198.
14
Sul punto, richiamerei anzitutto le riflessioni di A. Kojève, La notion de l’autorité (1942), Paris,
Gallimard, 2004; trad. it. a cura di M. Filoni, La nozione di Autorità , Milano, Adelphi, 2011, pp. 62-71.
15
Riprendo, qui, l’espressione di D. Böhler, Mensch und Natur. Verstehen, Konstruieren und
Verantworten. In dubio contra projectum , in «Deutsche Zeitschrift für Philosophie», 39, 1991, pp. 9991019.
16
Sul concetto di possibile-impossibile possibilità, cfr. V. Vitiello, Il Dio possibile. Esperienze di
cristianesimo, Roma, Città Nuova, 2002; Id., L’im-possibile. Discutendo con Massimo Cacciari, in «Aut
Aut», 245 1991, pp. 45-55.
�244
T OMMA SO G A ZZ OLO
sarebbe, in fondo, un diritto che si esponga alla possibilità che le generazioni future
giungano al di là da ogni anticipazione che avremmo potuto averne, da ogni nostra
“fondazione”? (Questione difficile: come sarebbe un diritto che non si pensi più come
mezzo attraverso cui progettare, rendere esistente, “fondare” un determinato futuro,
bensì come pratica mediante cui il presente si rende il passato di un avvenire di cui
non sappiamo ancora nulla, e che deve restare imprevedibile?)
4. THAT IN THE HEARTS OF MEN TO COME MORE BOMBS WILL BE BORN. Solo a ciò
siamo già impegnati: a che le generazioni future possano continuare a poter venire,
ad esporci alla loro possibile venuta, al loro sopraggiungere. Ma questo
sopraggiungere, per essere tale, non potrà che essere senza legge, senza, cioè, che sia
un diritto – nel suo progettarsi – a predeterminarlo, condizionarlo, anticiparlo. Che
fare, allora? Forse, sul piano di una pratica giuridica, si tratterebbe di pensare un
diritto che, anziché progettarsi in vista del futuro (di quel determinato futuro che esso
assume, in ogni decisione giuridica, come migliore), si determini proprio a partire
dall’idea che un futuro è tale solo se può non essere così come lo prevediamo. Il
diritto dovrebbe, da questo punto di vista, costituirsi come pratica orientata a
rendere possibile sempre più d’un futuro. Non a realizzare un certo futuro; al
contrario, a far sì che possa avvenire un futuro inatteso.
Significa esporsi all’incertezza o a rischi “incalcolabili”? Certamente sì. Significa,
cioè, non poter pretendere di fondare una volta per tutte – attraverso il ricorso alle
“generazioni future” – un imperativo di preservazione o protezione del paesaggio,
dell’ambiente, della salute, etc. 17 Le generazioni future non ci chiamano a preservare
l’esistente: per essere davvero tali, esse devono conservare il “diritto” di poter
sopraggiungere rifiutando radicalmente ogni eredità, tradizione, valore o lascito da
parte nostra.
Eppure una legge, un imperativo, resta: quello di far sì che queste generazioni
possano continuare a sopraggiungere – anche, eventualmente, per rifiutarci. Da
questo punto di vista, speranza e responsabilità – per servirsi di ciò che al limite
contrapporrebbe Bloch e Jonas, definirebbe la critica del secondo al primo 18 –
coesistono necessariamente: non c’è responsabilità, non c’è nulla di cui rispondere,
senza la speranza, senza ciò che apre all’avvento, al sopraggiungere dei venturi. Non
17
Correttamente ha osservato, sotto tale profilo, J.-L. Nancy, L’Équivalence des catastrophes (Après
Fukushima) , Paris, Galilée, 2012, p. 36: «Car une solution – qu’elle consiste à renoncer au nucléaire ou bien
à augmenter considérablement les mesures de protection – reste prise dans l’orbite de l’ensemble des
dispositions et des comportements techniques au sein desquels nos vies se déroulent - au sein desquels la
civilisation se déploie. La course aux techniques de substitution ou de contrôle reste dans l’horizon inchangé
d’une civilisation que, pour faire vite, je dirai ici “du progrès” et de la “maîtrise de la nature”».
18
Cfr., sul punto, R. Bodei, Principio speranza/Principio responsabilità , in «Iride», 6, 1991, pp. 231234; M. Löwy, Ernst Bloch’s Prinzip Hoffnung and Hans Jonas’s Prinzip Verantwortung, in H. TiroshSamuelson – C. Wiese (a cura di), The Legacy of Hans Jonas. Judaism and the Phenomenon of Life,
Leiden-Boston, Brill, 2008, pp. 149-158.
�245
Yet not enough to say a bomb will fall
sarebbe, in fondo, improprio affermare che è proprio di quella speranza che siamo
chiamati a rispondere, a farci garanti: che essa non cessi, che la nostra sopravvivenza
non vada disgiunta dalla sopravvenienza dei venturi.
5. THERE IS A HELL FOR BOMBS. Il problema diventa, allora, quello di capire se e in
che termini la responsabilità “per” le generazioni future possa definirsi
giuridicamente – ad esempio nei termini di obblighi cui determinati soggetti
sarebbero, ora, tenuti e vincolati. Pensare che la nostra responsabilità indichi il
nostro rispondere nei loro confronti per ciò che avremo fatto, continua a presupporre
una logica retrospettiva: implica, cioè, l’idea che si possa rispondere soltanto
dell’azione in quanto compiuta, passata. Eppure – ed è questo l’aspetto della
rivoluzione copernicana di cui parlava Anders – oggi è divenuto possibile
commettere crimini che rendono impossibile, per definizione, la loro punizione,
perché, una volta commessi, non lascerebbero in vita nessuno che la potesse disporre.
È il caso della “bomba”. Di crimini che non sono più crimini, se vengono
commessi. Cito ancora una riflessione di Enzensberger: «il fatto che questo crimine
possa essere giudicato solo finché rimane inattuato fa parte della sua natura
inconcepibile: una volta realizzato non lascerebbe in vita nessun giudice, imputato o
testimone» 19. Siamo di fronte, pertanto, ad un nuovo concetto di delitto, di crimine, e
con esso di responsabilità: di un delitto, cioè, di cui a rigore non si potrebbe
rispondere se non senza averlo compiuto; di un crimine che è un crimine – può cioè
essere giudicato come tale – unicamente se non viene commesso. Non si potrebbe
essere responsabili per aver lanciato la bomba atomica: lo si potrebbe, al limite,
essere solo finché, e alla condizione che, non la si sia lanciata. Derrida lo ha detto
benissimo: la guerra nucleare totale è per definizione un «non-evento» 20, non ha mai
avuto luogo come tale né – aggiungiamo – potrà mai propriamente avere luogo
(perché, accadendo, cancellerebbe il suo aver-luogo).
Ciò significa che non si potrebbe neppure, però, ritenere uno Stato obbligato a
non lanciare la bomba – perché, ove la lanciasse, esso non sarebbe responsabile di ciò
che ha fatto, la sua responsabilità sarebbe senza “conseguenze”. Il punto non
sarebbe, allora, quello di pensare una “responsabilità senza responsabilità”, che non
passi più per l’obbligo di rispondere di ciò che è stato fatto, ma per il farsi
responsabili del fatto di poter continuare a rispondere? Non si può, a rigore, essere
responsabili per aver lanciato la bomba, così come non lo si può essere per non averla
lanciata. Si può soltanto essere fatti responsabili della responsabilità stessa, della
possibilità di essere responsabili. E questa possibilità è davvero tale, è davvero
autentica possibilità, perché non si realizzerà mai, non diverrà mai “reale” (perché: se
19
H.M. Enzensberger, Riflessioni davanti a una gabbia di vetro, cit., p. 32.
J. Derrida, No Apocalypse, not now. A tutta velocità, sette missili, sette missive, in Id., Psychè.
Invenzioni dell’altro, vol. 1, trad. it. di R. Balzarotti, Milano, Jaca Book, 2008, p. 450.
20
�246
T OMMA SO G A ZZ OLO
l’atto non viene compiuto, non si è responsabili; se l’atto viene compiuto, esso stesso
impedisce che se ne possa rispondere).
Da questo punto di vista, non si tratta più di contrapporre – come ad esempio
avviene in Jonas – una responsabilità “retrospettiva”, rivolta al già-fatto ad una
“proiettiva”, che guarderebbe invece il da-farsi; quanto una responsabilità “reale” –
che cioè ponga degli obblighi esistenti, per il passato o per il futuro che siano – da
una responsabilità “possibile”, che non consista in altro che nel rendersi sempre
possibile, nel continuare ad essere possibile.
Resta, però, la questione: a quali condizioni una simile responsabilità potrebbe
essere definita giuridica – dove passerebbe la distinzione rispetto ad una
responsabilità etica o morale? Distinguere una responsabilità rivolta al passato da
una rivolta al futuro, non risolve, a nostro avviso, la questione. Piuttosto,
occorrerebbe poter pensare un diritto – e in ciò il concetto di responsabilità
diverrebbe proprio di una pratica giuridica – che non consista più nel realizzare il
futuro, ma nel renderlo possibile. Ed il possibile è tale non perché sia destinato a
realizzarsi, ma solo in quanto – ci serviamo qui di un’espressione di Sartre – si
“possibilizza”, non cessa di essere possibile (e quindi anche impossibile, al limite).
Pur nella brevità del presente intervento, mi sentirei allora di sottolineare ancora
un aspetto di questa concezione. Occorre poter “praticare” una responsabilità che sia
sempre possibile e che si mantenga come tale – e non una responsabilità che consista
nel far rispondere il soggetto per ciò che avrà fatto. Non risponderai mai, ma devi
sempre poter rispondere – ed è di questo che rispondi.
Non si tratta più di definire le conseguenze a cui una certa azione debba andare
incontro nel momento in cui sia o non sia realizzata, bensì di determinare le
condizioni che consentano che, per le azioni che si compiranno o meno, una
responsabilità sia sempre possibile. All’idea della responsabilità come conseguenza
(“Se A, allora deve essere B”), occorre forse affiancare l’idea di una responsabilità
come condizione per poter non cessare di essere fatti responsabili (“Affinché B possa
essere, allora A”). Non: “se si sgancia la bomba atomica, allora si è responsabili”, ma
“per poter essere responsabili della bomba atomica, allora non la si deve sganciare”.
Cosa cambia dal punto di vista dell’azione, dell’agire? In ultima istanza, direi che
cambia, se non altro, il punto di vista, la prospettiva concettuale della responsabilità.
Per affrontare il problema delle generazioni future, ciò appare essenziale: non si
tratta di chiedersi in che misura io sia responsabile delle mie scelte nei confronti
delle generazioni future, ma quali scelte mi consentano di poter continuare a
rispondere alle generazioni che sopraggiungeranno. Si dirà che quella della “bomba”,
della guerra nucleare totale, è solo un’ipotesi limite. È vero. O, più correttamente:
essa è l’estremo del concetto di responsabilità, è ciò a cui esso può sempre giungere.
�247
Yet not enough to say a bomb will fall
6. YOU ARE DUE AND BEHOLD YOU ARE DUE. La prospettiva qui indicata non si
risolve, tuttavia, nell’adozione di un principio di “conservazione” dell’esistente in
vista di un lascito, di un’eredità di cui risponderemmo verso le generazioni che
verranno ad esistenza. Il problema è, del resto, proprio questo: di non pensare più le
generazioni future come le generazioni che esisteranno in un prossimo o remoto
futuro – di pensare, cioè, la nostra responsabilità come se riguardasse l’esistenza di
una generazione in un futuro determinato. Poter continuare a rispondere
all’ingiunzione che viene dalle generazioni future significa, in fondo, il nostro
impegno a far sì che sia sempre possibile il loro sopraggiungere, di cui nulla
sappiamo. Non è un mondo (o questo mondo) che dobbiamo preservare e consegnare
alle generazioni future: è la possibilità che vi sia mondo, che esso non cessi mai di
poter divenire mondo. Più che progettare un futuro migliore, il diritto non dovrebbe
allora rendere-possibile un futuro diverso da quello prevedibile o determinabile, e
dunque sempre più d’un futuro?
Come e a quali condizioni – politiche, giuridiche, etc. – le generazioni future
esisteranno, dipende dalle nostre scelte, da ciò che faremo o non faremo. Dal punto
di vista della loro esistenza, è evidente che siamo noi a scegliere per esse, a
condizionarne e determinare il futuro. Ma la questione non è la stessa di quella che
abbiamo tentato qui di articolare, ossia a quali condizioni sia possibile il
sopraggiungere delle generazioni future. Quest’ultima inverte e rovescia, si potrebbe
dire, il senso della nostra responsabilità. Ciò di cui siamo responsabili, infatti, non è
di determinare un futuro che, in conseguenza delle nostre attuali o prossime scelte,
possa essere “migliore” o “non peggiore” del nostro presente. L’imperativo potrebbe
essere un altro: adotta quelle decisioni, compi quelle azioni che siano compatibili con
la possibilità che il futuro sia diverso, che possa giungere improvvisamente come
inaspettato e totalmente altro rispetto a quello prevedibile in base e in conseguenza
di quelle azioni stesse.
�248
�249
Etica & Politica / Ethics & Politics, XX, 2018, 1, pp. 249-264
ISSN 1825-5167
DA DOVE VENGONO I DIRITTI DELLE
GENERAZIONI FUTURE?
TO MMA S O GRE CO
Dipartimento di Giurisprudenza
Università di Pisa
tommaso.greco@unipi.it
ABSTRACT
After reconstructing the key arguments of Ferdinando Menga’s book Lo scandalo del futuro, the
present article draws upon the book’s conclusions to develop the theme concerning the
relationship with posterity and the responsibility that follows from it. It aims to advance some
arguments in support of the recognition of the rights of future generations.
KEYWORDS
Future Generations, responsibility, rights, duties
1. CRITICA DELLE TEORIE
I lavori che Ferdinando Menga sta dedicando da qualche tempo al tema dei diritti
delle generazioni future1 hanno l’intenzione (e ottengono l’effetto) di contribuire alla
messa in questione di alcune delle certezze che rappresentano — o almeno, sembrano
rappresentare — punti fermi del dibattito filosofico-giuridico. Da un certo punto di
vista, essi costituiscono una sfida nella sfida: perché non solo si occupano di un tema
che sfida queste certezze (come ebbe a scrivere John Rawls, il tema delle generazioni
future «sottopone qualunque teoria etica a prove severe se non addirittura
Oltre che a Lo scandalo del futuro. Per una giustizia intergenerazionale, Edizioni di Storia e
Letteratura, Roma 2016, cui è dedicato il forum all’interno del quale si inserisce il presente contributo,
mi riferisco agli scritti seguenti: Per una giustizia iperbolica e intempestiva. Riflessioni sulla
responsabilità intergenerazionale in prospettiva fenomenologica , in «Diritto & Questioni Pubbliche»,
2014, pp. 711-793; L’amore per i lontani e i futuri. Dalla misura della giustizia alla (dis-)misura della
misericordia , in «Endoxa – Prospettive sul presente», n. 4, 2016, pp. 71-81; Cose dell’“altro mondo”.
L’atopia della giustizia intergenerazionale quale sfida all’etica, alla politica e al diritto, in «Sociologia
del diritto», n. 3, 2017, pp. 21-57; Responsabilità e trascendenza: sul carattere eccentrico della giustizia
intergenerazionale, in F. Ciaramelli-F. Menga (a cura di), Responsabilità verso le generazioni future.
Una sfida al diritto, all’etica e alla politica, Editoriale Scientifica, Napoli 2017, pp. 197-214.
1
�250
T OMMA SO G RE CO
impossibili» 2), ma attaccano anche in maniera radicale gli argomenti con i quali altri
studiosi hanno trattato dello stesso soggetto, con l’obiettivo di condurci a un
ripensamento globale del nostro approccio a quei temi. Significativo, a questo
riguardo, proprio il volume Lo scandalo del futuro, nel quale Menga dedica la gran
parte delle pagine alla decostruzione critica delle teorie principali che si sono
occupate di diritti delle generazioni future per poter poi arrivare alla sua proposta
teorica.
Da un certo punto di vista, il problema affrontato da Menga non è diverso da
quello di cui si sono già occupati altri in passato, quando si è trattato di porre
all’ordine del giorno la questione dei confini della giustizia: fino a che punto, cioè, le
nostre concezioni morali e giuridiche sono in grado di dar conto di questioni che, per
la loro intrinseca natura, stanno appunto al di là dei confini consueti? Questi confini
sono di volta in volta territoriali, di specie, temporali, ed è proprio la loro esistenza a
determinare che alcuni temi e soggetti interessati non vengano presi in
considerazione nei discorsi che riguardano la giustizia, ad esempio quelli relativi a
una qualche ripartizione delle risorse disponibili, oppure ad una attribuzione di
diritti. Nel suo lavoro intitolato proprio Frontiers of Justice Martha Nussbaum, ad
esempio, si soffermava sulla disabilità, sul superamento della cittadinanza e sui diritti
degli animali proprio per evidenziare che la teoria classica della giustizia, rinnovata
con grande successo da John Rawls, non era capace di includere alcune delle più
urgenti questioni di giustizia poste dallo sviluppo della società contemporanea3.
La filosofa americana, tuttavia, pur criticando severamente la prospettiva
rawlsiana, presentava il suo contributo come volto ad allargarla e perfezionarla,
piuttosto che a superarla 4, mentre Menga prende invece le mosse dalla esplicita
intenzione di far vedere l’insufficienza delle prospettive etiche consolidate e consuete
ai fini della ricerca di una giustificazione e fondazione dei diritti delle generazioni
future 5.
Con questa decisa intenzione, dunque, Menga attacca frontalmente le due
principali teorie etiche contemporanee disposte a prendere sul serio la questione
delle generazioni future. Così, da un lato, mostra come il contrattualismo stenti ad
includere le generazioni future nell’ipotesi del contratto che fonda la società giusta
perché esse «sono per principio impossibilitate a negoziare, accordarsi e rivendicare
J. Rawls, A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge, Mass, 1971; ed. it. a cura di S.
Maffettone, Una teoria della giustizia , Feltrinelli, Milano 1993, p. 241.
Cfr. M.C. Nussbaum, Frontiers of Justice. Disability, Nationality, Species Membership, Harvard
University Press, Cambridge, Mass.-London 2006; tr. it. a cura di C. Faralli, Le nuove frontiere della
giustizia. Disabilità, nazionalità, appartenenza di specie, Il Mulino, Bologna 2007.
Cfr ad as. ivi, p. 27 e p. 87.
Lo stesso intento, realizzato in maniera più sintetica, muove le pagine del saggio su Responsabilità
e trascendenza: sul carattere eccentrico della giustizia intergenerazionale, in Ciaramelli-Menga (a cura
di), Responsabilità verso le generazioni future, cit., p. 197 ss.
2
3
4
5
�251
Da dove vengono i diritti delle generazioni future?
diritti» 6: l’ostacolo della non-esistenza, cui si aggiunge anche quello della asimmetria,
dovuto alla «evidente disparità fra il potere che la generazione attuale ha di incidere e
influire sul destino delle generazioni future e l’assente — o, comunque, assai ridotta —
capacità d’influenza di quest’ultime sulla prima» 7, sembra insormontabile. Anche
dall’altro lato, riguardante l’utilitarismo, Menga sottolinea come esso vada incontro a
un ostacolo altrettanto insormontabile, quello della non-determinatezza, dovuto alla
«difficoltà di stimare adeguatamente a partire dalla conoscenza presente sia ‘ciò che’,
sia anche ‘la misura di ciò che’ può essere valutato come utilità o danno in un futuro
remoto» 8. Il «primato della temporalità presente», in altre parole, rende entrambe le
teorie etiche incapaci di cogliere davvero quel «carattere di futurità, che costituisce il
nucleo stesso della questione di una responsabilità per il futuro e per i futuri» 9.
Non è qui possibile, e sarebbe ovviamente ridondante, ripercorrere i passaggi della
ricostruzione critica operata da Menga, peraltro basata su una quantità
impressionante di riferimenti bibliografici. Mi interessano invece le sue conclusioni,
perché sarà a partire da queste che cercherò di sviluppare qualche riflessione.
Dunque, anche quando facciano lo sforzo di considerare il tema delle generazioni
future, teorie mainstream come il contrattualismo e l’utilitarismo sono costrette,
secondo Menga, a forzare i loro elementi strutturali e a includere quello che per esse
non è altro che «un corpo estraneo», costringendole «ad aggiustamenti forzosi e
spesso a risultati dal carattere contraddittorio», come avviene ad esempio per Rawls
con il principio del ‘giusto risparmio’ e con il rinvio all’intento “naturale” «di
perseguire il proprio interesse estendendolo anche a beneficio dei propri figli e
immediati discendenti», ciò che a parere di Menga non solo finisce per inserire nella
teoria contrattualista elementi estranei (di sapore comunitaristico addirittura), ma
soprattutto non garantisce che le generazioni attuali si facciano carico della questione
generazionale relativa al futuro remoto e non immediato 10. La conclusione relativa a
questa teoria, formulata stavolta da Menga in riferimento alla versione datane da
David Gauthier nel volume Morals by Agreement del 1986, è che «se si vuole salvare
la teoria, è necessario negare la giustificabilità vera e propria di una responsabilità
intergenerazionale; se si vuole salvare invece l’evidenza di una tale responsabilità, si
dovrà allora ammettere che la sua vera base fondazionale — la si voglia chiamare
intuizione morale o in altro modo — è contenuta in un registro di pensiero distinto, a
cui il contrattualismo non riesce a dare adeguata espressione» 11. In altre parole,
quando vuole davvero includere la questione delle generazioni future, la teoria
contrattualista è costretta a fare riferimento a una sorta di intuizione morale, che
6
7
8
9
10
11
Menga, Lo scandalo del futuro, cit., p. 27.
Ibidem.
Ivi, p. 28.
Ivi, p. 29.
Cfr. ivi p. 46.
Ivi, p. 52.
�252
T OMMA SO G RE CO
però risulta essere ad essa estranea, nella misura in cui non deriva dalle premesse
della teoria medesima.
Altrettanto inadeguate risultano per Menga altre teorie etiche a partire dalle quali
si è tentato di giustificare l’esistenza di obblighi intergenerazionali, come quelle
metafisico-giusnaturalistiche, aventi o no matrice teologica, che rinviano a una
«comunanza di essenza o di genere», alle quali Menga rimprovera, con Levinas, di
non considerare «come il richiamo etico alla responsabilità verso altri insorga ancor
prima di ogni costrizione ontologica e definizione d’essenza» 12; o come quelle che
rinviano alla “teoria della reciprocità indiretta”, secondo la quale ogni generazione
ha l’obbligo di trasmettere alle generazioni future quanto ricevuto da quelle
precedenti, senza considerare però che «il fatto che una generazione abbia
beneficiato di un dono dalla generazione precedente non implica di per sé un
obbligo di restituzione verso i posteri» 13.
A maggior ragione, per Menga, non è possibile trovare aiuto nelle teorie che
esplicitamente negano l’esistenza di diritti delle generazioni future, o ne affermano
l’esistenza in maniera attenuata. È quest’ultimo il caso, ad esempio, della teoria della
chain of love di John Passmore, oppure della “comunità morale” cui fa riferimento
Martin Golding 14, entrambe disposte ad argomentare una qualche forma di
responsabilità nei confronti dei discendenti prossimi, ma non in grado di giungere a
forme di responsabilità nei confronti delle generazioni future più lontane. L’intento
dell’Autore, riconfermato anche nella ricostruzione di quella teoria ‘paradossale’
elaborata da Derek Parfit che va sotto il nome di Non-Identity Problem, è quello di
sottolineare l’ineludibilità di una intuzione morale, senza la quale, a suo parere, non
è possibile alcuna fondazione della responsabilità intergenerazionale.
2. CRITICA DEL SOGGETTO ED ETICA DELL’ALTERITÀ
Ed eccoci dunque alla proposta avanzata da Menga nel capitolo finale del suo
libro. Muovendo dalla consapevolezza che sia necessario un «ripensamento radicale»
della teoria etica, e constatata l’incapacità delle teorie mainstream di apportare un
contributo decisivo, Menga propone di rivolgersi ad una teoria che prenda congedo
definitivo dalle premesse delle teorie precedenti e si rivolga «a un’impostazione
fenomenologica genuinamente improntata sul primato etico dell’alterità» 15.
Considerato che l’approdo dovrà essere la fuoriuscita dalla prospettiva centrata sul
presente e sui soggetti che lo abitano, il primo passo non può non essere quello che
porta ad abbandonare l’idea di un soggetto autocostituito, autonomo e razionale, a
12
13
14
15
Ivi, p. 65.
Ivi, p. 71.
Cfr. ivi, pp. 79 ss.
Ivi, p. 98.
�253
Da dove vengono i diritti delle generazioni future?
favore di un soggetto caratterizzato dall’essere «connotato fin dall’inizio dalla sua
insuperabile condizione di intersoggettività», il che significa che egli «è già sempre
interpellato da e chiamato a rispondere alle istanze dell’alterità ancora prima di poter
pervenire pienamente a se stesso» 16. Se è la relazione a fondare il soggetto, e non
viceversa, allora questo soggetto si trova ‘esposto’ originariamente all’altro,
“inclinato” verso l’altro 17: presupposto indispensabile, questo, affinché possa
dischiudersi «una dimensione etica della responsabilità dal carattere originario e
irriducibile» 18.
Per quanto il punto di riferimento filosofico di Menga sia costituito dall’approccio
fenomenologico, che egli convintamente riprende e valorizza, nella discussione
filosofico-politica una considerazione del soggetto come di un essere-in-relazione non
può non far venire in mente quel modello aristotelico che, pur declinato in maniere
differenti, molta fortuna sta avendo proprio all’interno di quelle proposte teoriche
tese a sottolineare, sebbene con intenzioni ideologiche talora opposte, l’insufficienza
del soggetto moderno. Come ha scritto efficacemente Martha Nussbaum, una delle
protagoniste della rinascita dell’aristotelismo politico, anziché attardarsi nella
considerazione di soggetti liberi uguali e indipendenti, la filosofia pratica deve
imparare ad «usare una concezione politica della persona che riflette più da vicino la
vita reale», qual è quella presente nella prospettiva aristotelica dell’uomo come
animale politico. Se per la filosofia americana, che ha l’obiettivo di includere le
relazioni di cura all’interno della teoria della giustizia, ciò significa che egli è «non
solo un essere politico e morale, ma un essere che ha un corpo animale e la cui
dignità umana, piuttosto che essere opposta a questa natura animale, le inerisce nel
corso della sua esistenza temporale» 19, a noi interessa riprendere ciò che la medesima
autrice afferma quando rivendica al suo approccio basato sulle capacità il fatto che
esso includa «fin dall’inizio sentimenti benevoli rendendo conto della relazione fra le
persone e il proprio bene; e questo perché la sua concezione politica della persona
include l’idea di una fondamentale socievolezza e concepisce i fini condivisi come
parte degli obiettivi dei singoli», ponendo la compassione, che conduce a «valutare il
bene degli altri come parte importante del proprio schema di obiettivi e di fini»,
come «predominante fra i sentimenti morali» 20.
Ora, è proprio questa dimensione etica appena dischiusa attraverso la critica del
soggetto moderno a permettere di prendere sul serio quei caratteri della relazione
intergenerazionale — diacronia, atopia, asimmetria — che erano risultati impensabili
nella prospettiva contrattualistica e utilitaristica: «la situazione in cui si imbatte un
soggetto genuinamente interpellato — scrive Menga — è, in altri termini, quella di
16
17
18
19
20
Ivi, p. 99.
Cfr. A. Cavarero, Inclinazioni. Critica della rettitudine, Cortina, Milano 2013.
Menga, Lo scandalo del futuro, cit., p. 100.
Nussbaum, Le nuove frontiere della giustizia , cit., p. 104.
Ivi, p. 107.
�254
T OMMA SO G RE CO
trovarsi immancabilmente investito da una richiesta che gli giunge da un tempo altro
rispetto al suo presente (diacronia), da un luogo altro rispetto al suo luogo proprio
(atopia) e da una sollecitazione inevitabile, antecedente a qualsivoglia possibilità di
previsione, elusione o anche propiziazione (asimmetria)» 21. Il futuro che ci interpella
rappresenta la dimensione fondamentale verso la quale deve volgersi la nuova
soggettività, capace di ascoltare la «domanda che proviene dall’avvenire» 22. Non di
un futuro “semplice” deve trattarsi, peraltro, bensì di un futuro anteriore — così lo
chiama Waldenfels, richiamato consentaneamente da Menga — di un futuro cioè che
non si costituisca a partire dal presente, come un suo mero prolungamento, bensì
«come ciò che, essendoci già sopraggiunto dal futuro stesso in forma d’ingiunzione,
ci ha anche già costretti a una risposta immediatamente responsabile verso di esso» 23.
Un futuro, in altre parole, che non si aggiunge al presente, come un qualcosa che
segua all’oggi, ma che si attua insieme all’oggi e nell’oggi: «un futuro nel quale
anticipiamo noi stessi», secondo le parole di Waldenfels citate da Menga, e che
«dipende dal fatto di prendere in considerazione gli appelli e le richieste delle
generazioni e delle popolazioni future ancor prima che i loro rappresentanti siano in
grado di farne valere i diritti e le istanze» 24. Una forma temporale “paradossale”,
come la definisce Pomarici, «che si rivolge al futuro come se fosse già accaduto» 25.
3. ALTERITÀ, RESPONSABILITÀ, DOVERI
Le ultime affermazioni riportate sono estremamente significative e permettono di
puntualizzare una questione che forse, per la sua ovvietà, si potrebbe anche omettere
ma che invece ci serve per poter avanzare le poche considerazioni che seguiranno. E
la questione è la seguente: qualunque cosa diciamo a proposito delle generazioni
future siamo noi a dirla, e non la diciamo ad altri che a noi stessi, qui, oggi. Le
diremo anche ad altri — alle generazioni successive alla nostra, ad esempio, che
dovranno affrontare lo stesso problema — se, e nella misura in cui, l’avremo detto a
noi nel nostro presente.
Si tratta di una ovvietà, me ne rendo ben conto, ma che non può restare implicita,
nel momento in cui l’appello alla «responsabilità per il futuro» 26, che costituisce il
nucleo della proposta teorica di Menga, non può che essere un appello rivolto a noi,
con cui noi dobbiamo fare i conti, e al quale noi dobbiamo una risposta.
Menga, Lo scandalo del futuro, cit., p. 100-101.
Ivi, p. 105.
Ivi, p. 107.
Sono parole di Waldenfels citate da Menga a p. 109.
U. Pomarici, Verso nuove forme dell’identità? Generazioni future e dignità umana , in CiaramelliMenga (a cura di), Responsabilità verso le generazioni future, cit., p. 95.
Menga, Lo scandalo del futuro, cit., p. 117.
21
22
23
24
25
26
�255
Da dove vengono i diritti delle generazioni future?
Qui cominciano, per me, le sollecitazioni maggiori che ricevo dal testo di Menga.
Se dovessi sbrigarmela con una battuta che ha avuto anche troppa fortuna, direi con
Bobbio che il problema dei diritti delle generazioni future non è quello di trovare
loro un fondamento ma quello di garantirli, di renderli cioè in qualche modo
effettivi 27. Una battuta che non faccio mia perché credo convintamente (e lo credeva
in realtà anche Bobbio) che il discorso sui fondamenti faccia parte della lotta per i
diritti, ma che mi serve esclusivamente per dire che, una volta accolta la proposta
teorica di Menga e una volta che si sia acconsentito (e io vi acconsento pienamente e
convintamente) al suo approccio etico ed antropologico, si apre tutta una serie di
problemi, che sono precisamente i problemi con cui abbiamo a che fare se vogliamo
prendere sul serio la proposta con cui si chiude il volume che stiamo discutendo.
Problemi peraltro che non sono affatto assenti nelle pagine di Menga, ma che anzi
vengono adombrati, se pure non sviluppati sistematicamente.
Dunque, cosa significa — cioè, quali conseguenze ha il fatto — che noi siamo ciò
che siamo a partire dalla relazione con altri che ci interpellano dal futuro? Non può
significare altro che questo: si tratta di una relazione che ci carica di responsabilità —
come del resto avviene in ogni relazione, anche declinata ‘al presente’ — e che di
conseguenza ci consegna dei doveri cui adempiere. Il nesso relazione-responsabilitàdoveri è esattamente ciò che il ragionamento conclusivo di Menga ci mette davanti,
ed è su questo che vorrei ora proporre qualche riflessione.
Nell’affrontare questo tema, Menga sembra seguire Zagrebelsky là dove il
costituzionalista torinese, proprio nel negare la possibilità che si possa parlare di
diritti delle generazioni future, sposta il discorso sui doveri delle generazioni
presenti 28. Il ragionamento serve a Menga per avere ulteriore conferma del fatto che
serve «un’interrogazione preliminare e radicale di carattere “essenzialmente morale”
circa la giustificazione di obblighi intergenerazionali» 29. Si tratta tuttavia di un
ragionamento che nasconde, se non qualche equivoco, quanto meno alcuni
presupposti di carattere teorico che è preferibile portare alla luce e discutere nello
specifico.
Innanzitutto, e preliminarmente, credo vada ricordata la strutturale relazione tra
il diritto e il futuro: certo, il diritto vuole valere qui ed ora, ma si tratta di un “qui e
ora” proiettato sempre in avanti, in un futuro prossimo che nel farsi continuamente
presente rinnova se stesso aggiungendo al presente un qualcosa che gli sfugge sempre
e gli sta dinanzi, come un’ombra che venga proiettata davanti (da una luce che sta
costantemente dietro) e che siamo costretti a inseguire perennemente. Non c’è diritto
Il riferimento è alla nota tesi sostenuta da Bobbio a conclusione di un suo celebre saggio del 1964,
in base alle quale «il problema di fondo relativo ai diritti dell’uomo è oggi non tanto quello di
giustificarli, quanto quello di proteggerli. È un problema non filosofico ma politico» (Sul fondamento
dei diritti dell’uomo, in N. Bobbio, L’età dei diritti, Einaudi, Torino 1990, p. 16).
Cfr. Menga, Lo scandalo del futuro, cit., p. 32.
Ivi, p. 33.
27
28
29
�256
T OMMA SO G RE CO
che non pretenda di proiettarsi nel futuro e anzi si potrebbe dire — lo ha sottolineato
Fabio Ciaramelli — che è proprio il diritto a farsi carico di quella essenziale
propensione al divenire che è tipica dei gruppi umani e nella quale «consiste la loro
essenziale relazione all’alterità del futuro» 30. E se è vero che un ordinamento
giuridico è sempre «un ordinamento di questa specifica comunità giuridica», cioè di
una comunità giuridica del presente, è altrettanto vero che «quando il legislatore
stabilisce determinate norme di comportamento, egli prende un provvedimento
anticipato circa il futuro degli uomini che da quelle norme sono interessati. Egli
anticipa un tratto di futuro» 31. Ciò riguarda tutto il diritto, e a maggior ragione quelle
norme costituzionali che si esprimono attraverso i princìpi e le norme
programmatiche 32.
Su questa ineliminabile, perché strutturale, vocazione al futuro tipica del diritto si
dovrà certamente innestare un contenuto materiale delle norme diretto
esplicitamente alla tutela delle generazioni future 33, il cui obiettivo non può non
essere quello di tutelare i beni fondamentali da trasmettere alla posterità, in un
contesto difficile (addirittura ostile) per ragioni sia economiche che antropologiche 34,
e peraltro nella incertezza di cosa possa essere davvero importante per le generazioni
future 35. Se lo si potrà fare dipenderà dunque da quanto verrà sentita questa urgenza
(ne parlerò in conclusione di questo contributo): ma certo è che non si tratta di un
tema estraneo al diritto, che ne richieda e ne implichi quindi un qualche
ripensamento radicale, bensì di un tema che ha una connessione evidente e
F. Ciaramelli, Responsabilità per le generazioni future: la funzione del diritto, in F. Ciaramelli – F.
Menga (a cura di), Responsabilità verso le generazioni future, cit., p. 18.
G. Husserl, Diritto e tempo, a cura di R. Cristin, Giuffrè, Milano 1998, p. 4 e 21.
Cfr. A. D’Aloia, Costituzione e protezione delle generazioni future, in Ciaramelli-Menga (a cura
di), Responsabilità verso le generazioni future, cit., p. 294.
Nel contributo ricordato nella nota precedente, Antonio D’Aloia offre un quadro piuttosto ampio
teso a dimostrare che nel costituzionalismo moderno e contemporaneo sono molte le norme e le
istituzioni che hanno come scopo proprio la protezione delle generazioni future (in questa direzione,
cfr. anche A. Pisanò, Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana ,
Giuffrè, Milano 2012, pp. 154 ss). Di parere diverso sembra essere Raffaele Bifulco, secondo il quale
«l’osservazione del diritto positivo ci impedisce di affermare che esistono, ad oggi, veri e propri diritti
delle generazioni future», e tuttavia «alla luce degli intervenuti mutamenti di natura tecnologica,
bisogna prendere atto che la tradizionale funzione del diritto — permettere cioè che l’uomo conviva con
l’altro uomo garantendo così, al contempo, la sopravvivenza individuale e la pacifica convivenza — deve
arricchirsi della dimensione intertemporale e così svolgere questa funzione non più solo nei confronti
delle generazione presente, bensì anche nei confronti di quelle di là da venire» (R. Bifulco, Diritto e
generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale, FrancoAngeli, Milano
2008, p. 27 e p. 61).
Cfr. Ciaramelli, Responsabilità per le generazioni future, cit., p. 22.
Ad esempio: «può esistere e avere senso per noi qualcosa come la dignità dell’umanità futura?» (U.
Pomarici, Verso nuove forme dell’identità? Generazioni future e dignità umana, in Ciaramelli-Menga
(a cura di), Responsabilità verso le generazioni future, cit., p. 92).
30
31
32
33
34
35
�257
Da dove vengono i diritti delle generazioni future?
strutturale col diritto medesimo, cui dovrà essere richiesto “semplicemente” di farsi
carico delle nuove esigenze 36.
Ma se di questo si tratta, non si potrà che passare dalla via dell’attribuzione di
determinati doveri ai membri delle generazioni attuali e presenti, ai fini della
preservazione di determinati beni e valori da consegnare alle generazioni che
seguiranno.
4. DOVERI (E DIRITTI)
E qui entra in gioco la questione cruciale, quella che più di tutte conduce (o
dovrebbe condurre) a ripensare le nostre convinzioni teorico-giuridiche.
L’affermazione di Zagrebelsky, ripresa da Menga, in base alla quale occorre
rilanciare il discorso sui doveri in quanto non sono pensabili diritti delle generazioni
future, nasconde molti (e può essere causa di ulteriori) equivoci, di cui il primo è
relativo a quella affermazione di Bobbio in base alla quale, se avesse avuto tempo e
modo per farlo, egli avrebbe scritto un libro su “L’età dei doveri”, da affiancare a
quello su L’età dei diritti 37. Quella che era poco più di una battuta, fatta nel contesto
del dialogo con Maurizio Viroli sul repubblicanesimo, anziché essere indirizzata a
contrapporre un’etica dei doveri a un’etica dei diritti, aveva proprio l’intento di
sottolineare il nesso inscindibile tra i diritti e i doveri (e caso mai, come mi è capitato
di notare in altre occasioni 38, aveva il difetto di intendere i doveri in maniera
riduzionistica, riferendosi soprattutto ai doveri dello Stato nei confronti degli
Anche questo punto è ben colto, a mio parere, da Ciaramelli, là dove scrive che «poiché la
funzione del diritto (...) consiste nel dare persistenza alle possibilità di innovazione e cambiamento che
costituiscono la nostra identità di esseri storici, rendendo con ciò possibile l’istituzione del futuro,
spetta e compete allo stesso diritto, proprio nella sua funzione stabilizzatrice – finalizzata a garantire la
persistenza delle norme, in cui sono culminate le conquiste storico-sociali, e delle istituzioni che le
materializzano – farsi carico delle esigenze sociali, morali e culturali che pone la salvaguardia della
permanenza umana nel futuro» (Ciaramelli, Responsabilità per le generazioni future, cit., p. 34).
Cfr. Zagrebelsky, Senza adulti, Einaudi, Torino 2016, p. 89; Id., Diritti per forza , Einaudi, Torino
2017, p. 8, nel quale si parla addirittura di un presunto «voltafaccia di Bobbio». A Maurizio Viroli, il
quale gli faceva notare che «se prendi sul serio i diritti, devi prendere sul serio i doveri», Bobbio
rispondeva che «se [avesse avuto] ancora qualche anno di vita» avrebbe «tentato di scrivere L’età dei
doveri», ricordando di aver scritto un commento alla proposta di Carta Unesco dei doveri e delle
responsabilità degli Stati, nel quale aveva «sottolineato che non esistono diritti senza doveri
corrispondenti. Quindi — continuava il filosofo torinese — se la Dichiarazione dei diritti dell’uomo non
deve restare, come si è detto tante volte, un elenco di pii desideri, ci deve essere una corrispondente
dichiarazione dei doveri e delle responsabilità di chi deve far valere questi diritti» (N. Bobbio - M.
Viroli, Dialogo intorno alla Repubblica , Laterza, Roma-Bari 2001, p. 40).
Cfr. T. Greco, Dai diritti al dovere: tra Mazzini e Calogero, in Repubblicanesimo, Democrazia,
Socialismo delle libertà. “Incroci” per una rinnovata cultura politica , a cura di Th. Casadei, Franco
Angeli, Milano 2004, pp. 137-150 (in part. p. 138).
36
37
38
�258
T OMMA SO G RE CO
individui e non richiamando invece i doveri orizzontali che legano gli individui tra di
loro).
Ora, certamente è possibile fare un discorso sui doveri considerandoli in
alternativa ai diritti e al discorso mainstream che ne ha fatto il luogo esclusivo della
nostra dimensione etico-giuridica. Un discorso di questo tipo si colloca a mio parere
principalmente sul piano antropologico, là dove è possibile evidenziare — con
Giuseppe Mazzini — la portata associativa dei doveri, di contro alla portata
individualistica, atomistica e inevitabilmente conflittualistica dei diritti 39. È il
discorso che regge la nota tesi di Simone Weil sulla priorità dei doveri sui diritti 40,
citata anch’essa da Menga, e che è possibile rintracciare alla base dell’ultimo lavoro
di Zagrebelsky intitolato significativamente Diritti per forza 41.
Il discorso cambia, però, quando si passi dal piano antropologico a quello
giuridico. Qui la netta distinzione/contrapposizione tra diritti e doveri non può
essere invocata genericamente, e — come è ormai uso fare in una teoria dei diritti
talora ipertrofica e forse esageratamente portata a distingere le varie posizioni —,
occorre sempre procedere a distinzioni e stipulazioni al fine di precisare quale sia la
loro relazione. Si può essere convinti ad esempio che non ci siano diritti senza doveri
corrispondenti — un’affermazione che è al centro di ricorrenti ed intricate
polemiche 42, ma verso la quale convergono le tesi, pur diverse sotto molti profili, di
autori come Hohfeld, Kelsen e Ferrajoli — e tuttavia ritenere accettabile
un’affermazione, come quella di Zagrebelsky, secondo la quale «le generazioni
successive non hanno diritti da vantare nei confronti di quelle precedenti, ma queste
hanno dei doveri nei confronti di quelle» 43. Per la teoria della correlazione univoca,
infatti, è vero che «laddove vi sia un diritto soggettivo non può non esservi un dovere
correlato, ma non anche che ad ogni dovere corrisponde un diritto» 44.
Ho impiegato questa chiave di lettura, e discusso la relativa letteratura, nel mio articolo Prima il
dovere. Una critica della filosofia dei diritti, in S. Mattarelli, Il senso della repubblica. Doveri,
FrancoAngeli, Milano 2007, pp. 15-30.
Cfr. S. Weil, L’enracinement. Prélude à une déclaration des devoirs envers l’être humaine,
Librairie Gallimard, Paris 1949, tr. it. La prima radice. Preludio a una dichiarazione dei doveri verso
l’essere umano, a cura di F. Fortini, SE, Milano 1990. La tesi della Weil è richiamata da Menga sia in
Lo scandalo del futuro, cit., p. 32, sia in Cose dell’“altro mondo”, cit., p. 49-50.
Cit.
Polemiche e diatribe teoriche di cui è possibile ricostruire la trama piuttosto fitta grazie ai seguenti
lavori: B. Celano, I diritti nello stato costituzionale, Il Mulino, Bologna 2013, in part. cap. I. (“I diritti
nella jurisprudence anglosassone contemporanea. Da Hart a Raz”); L. Milazzo, La teoria dei diritti di
Francisco de Vitoria , Ets, Pisa 2012, cap. I (“Paradigmi interpretativi”); F. Poggi, Concetti teorici
fondamentali. Lezioni di teoria generale del diritto, Ets, Pisa 2013, cap. I (“Diritti soggettivi”).
G. Zagrebelsky, Senza adulti, cit., p. 87. Le considerazioni di Zagrebelsky sono riprese,
consentaneamente, da S. Ferlito, Il volto beffardo del diritto. Ragione economica e giustizia , Mimesis,
Milano 2017, p. 54 s.
Milazzo, La teoria dei diritti di Francisco de Vitoria, cit., p. 16.
39
40
41
42
43
44
�259
Da dove vengono i diritti delle generazioni future?
Ora, in generale, quando diciamo che in una determinata situazione non ci sono
diritti per determinati soggetti è perché non siamo in grado di (o peggio, non
vogliamo) individuare dei doveri da collocare in testa ad un qualche altro soggetto 45;
ma se invece siamo addirittura in grado di affermare che ci sono doveri (ad esempio
delle generazioni attuali), e magari siamo capaci anche di articolare e specificare
quali siano questi doveri, può benissimo conseguirne l’affermazione che esistono
anche i diritti corrispondenti, purché si sia disposti a riformulare la propria idea dei
diritti.
Le difficoltà a trarre una simile conclusione derivano infatti dalle condizioni
ritenute di volta in volta necessarie affinché esistano diritti. Il capitolo del lavoro di
Zagrebelsky intitolato emblematicamente “Diritti impotenti?”, rappresenta un’ottima
sintesi, non solo della visione dell’Autore, ma anche di una certa visione corrente e
diffusa sul tema dei diritti soggettivi. Due sono le condizioni, per Zagrebelsky,
affinché si possa parlare di diritti in senso giuridico: «a) che vi siano individuabili e
individuati “portatori” dell’interesse a far valere il diritto in questione; b) che vi sia
un’istanza di natura giudiziaria, cioè vincolata all’applicazione del diritto, alla quale
possa farsi ricorso e che questa istanza disponga degli strumenti necessari a eseguire
coercitivamente le proprie decisioni» 46.
Ora, tutto ciò dimostra non solo quanto sia vero che «parlare di ‘diritti’ delle
generazioni future dentro il modo tradizionale di concepire i diritti soggettivi [sia]
effettivamente un azzardo» 47; ma anche quanto pesi sulle conclusioni pratiche che si
vogliono raggiungere il paradigma teorico che, consapevolmente o meno, si assume
come riferimento. Se si pongono certe condizioni per l’esistenza dei diritti è perché ci
si mantiene ancorati a determinati postulati: nel caso in esame, ad esempio, da un
lato, si presuppone la necessità di individuare in maniera concreta chi possa essere
titolare dell’interesse che si vuole tutelare in maniera da attribuirgli un diritto
attivo 48; dall’altro lato, si pone nella garanzia secondaria (giurisdizionale) l’unico
Come giustamente nota Milazzo, riferendosi all’esempio del diritto dei bambini ad essere nutriti
di cui parla N. MacCormick, «una volta che si sia proclamato il diritto, escludere l’esistenza normativa
di un dovere morale ad esso correlato osservando che non è facile stabilire se faccia capo ai genitori,
all’autorità locale, al governo centrale o alla chiesa, esime dallo sforzo di stabilirlo e dalla responsabilità
che discenderebbe dalla conclusione plausibile che tale dovere grava solidalmente su tutti e su
ciascuno» (La teoria dei diritti di Francisco de Vitoria, cit., p. 31).
Zagrebelsky, Senza adulti, cit., p. 90-91. Anche queste condizioni sono condivise da Ferlito, Il volto
beffardo del diritto, cit., p. 64.
D’Aloia, Costituzione e protezione delle generazioni future, cit., p. 318.
Questo è anche il motivo che conduceva Hans Jonas ad escludere che si potesse far riferimento
alla teoria della reciprocità tra diritti e doveri: poiché assumeva che i diritti dovessero coincidere con la
pretesa, quello schema non poteva funzionare perché «pretese può avere soltanto ciò che avanza
pretese — ciò che è», mentre «il non esistente non solleva nessuna pretesa e perciò non può neppure
subire una violazione dei suoi diritti» (H. Jonas, Das Prinzip Verantwortung, Insel Verlag, Frankfurt
am Main 1979; tr. it. Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, a cura di P.P.
Portinaro, Einaudi, Torino 2009, p. 49).
45
46
47
48
�260
T OMMA SO G RE CO
elemento costitutivo del diritto stesso, dimenticando quindi il sistema degli obblighi
che costituisce invece la garanzia primaria. Ma entrambi i postulati si possono
criticare e rovesciare: si può sostenere, cioè, sulla base della teoria della correlatività,
che attribuire doveri a qualcuno vuol dire anche riconoscere diritti a qualcun altro,
anche a soggetti non ancora esistenti 49, prescindendo dunque da una qualche attività
o azione che essi debbano svolgere per essere riconosciuti come titolari dei diritti
medesimi; e si può sostenere altresì che la garanzia dei diritti non sta affatto
esclusivamente nella possibilità di percorrere la via giurisdizionale, bensì
innanzitutto nell’attribuzione di doveri a determinati soggetti, venendo la garanzia
secondaria a supplire all’eventuale mancanza dell’adempimento primario 50. Se tutto
ciò è sostenibile, allora non c’è alcuna illogicità nel sostenere che esistono diritti delle
generazioni future, se e nella misura in cui siamo in grado di individuare doveri delle
generazioni presenti che abbiano come scopo la tutela di beni fondamentali da cui
dipenda la sopravvivenza dei nostri discendenti 51.
In altre parole, invece di procedere partendo da una determinata (ma appunto
una) definizione dei diritti (che faccia di volta in volta perno sulla will theory, o sulla
activ rights theory, ad esempio) per concludere che non ci sono diritti delle
generazioni future, e quindi ipotizzare l’esistenza in capo alle generazioni presenti di
soli doveri morali, che portano le generazioni future «ad affidarsi, per la garanzia
delle loro aspirazione, all’adesione spontanea di chi potrebbe violarle» 52, si può
capovolgere il percorso e muovere dai doveri giuridici delle generazioni presenti, che
possono ben essere immaginati e resi efficaci mediante le norme dell’ordinamento.
Che poi questo significhi che si possa parlare di diritti delle generazioni future
dipende anche questa volta dalla definizione dei diritti che adottiamo e dalle
Si può qui richiamare per criticare la tesi di Zagrebelsky un argomento che egli usa con
l’intenzione di rafforzarla, là dove paragona la situazione delle generazioni future (senza diritti) a quella
del nascituro (Senza adulti, cit., p. 87): davvero possiamo dire che ai doveri che la madre ha nei
confronti del bambino che porta in grembo non corrispondano diritti di cui quel bambino (non ancora
nato) è titolare? E se non possiamo dirlo per il bambino, possiamo ancora dirlo per le generazioni
future? D’altra parte, come ricorda Attilio Pisanò, «il problema della soggettività delle generazioni
future è uno pseudoproblema», dato che il diritto costituzionale e quello internazionale «già
riconoscono una forma di soggettività alle generazioni future» (Diritti deumanizzati, cit., p. 165).
Su questo punto, cfr. da ultimo G. Pino, Il costituzionalismo dei diritti, Il Mulino, Bologna 2017, p.
102-103.
Un ragionamento di questo tipo presuppone ovviamente quella che viene individuata come
interest theory , là dove la choice theory renderebbe impossibile attribuire alcuna soggettività giuridica
alle generazioni future. Cfr. Pisanò, Diritti deumanizzati, cit., p. 168.
Zagrebelsky, Senza adulti, cit., p. 82.
49
50
51
52
�261
Da dove vengono i diritti delle generazioni future?
strategie retoriche che vogliamo mettere in atto 53. Ma il risultato appare diverso, anzi
opposto e decisamente più favorevole per la vita degli uomini futuri 54.
Se insisto su questo punto è perché sono convinto che la relazione tra diritti e
doveri si ponga non soltanto sul piano delle garanzie verticali ma innanzi tutto su
quello delle garanzie primarie ed orizzontali. Se si presuppone che i diritti consistano
esclusivamente nella possibilità di attivare le garanzie giurisdizionali, e quindi si
conclude nel nostro caso che non esistono diritti delle generazioni future, si rischia di
concepire anche i doveri — considerati «non semplicemente in quanto riflessi, in
quanto contropartite dei diritti, ma come posizioni giuridiche autonome che vivono
di vita propria, senza presupporre l’esistenza (attuale) delle corrispondenti situazioni
di vantaggio e dei relativi titolari» 55 — come qualcosa che ha anch’essa a che fare
prima di tutto con la dimensione verticale del potere e delle coercizione, facendo
perdere di vista il tema della relazione con coloro che dovranno beneficiare
dell’adempimento di questi doveri. “Poiché le generazioni future non possono né
esercitare, né rivendicare diritti, allora si impongano doveri (slegati da qualsiasi
diritto) alle generazioni presenti”: questo discorso rischia di reiterare proprio quella
visione negativa e autoritaria che tanto ha nuociuto all’uso del linguaggio dei doveri.
Occorre invece pensare ai nostri doveri attuali come un qualcosa che dobbiamo ad
altri, e ai quali dobbiamo adempiere dunque, non solo perché ce li impone il nostro
ordinamento politico-giuridico attuale, ma perché c’è una relazione che ci obbliga e
che nasce dall’appello che ci viene dal futuro. Questo peraltro mi sembra conseguire
dalle conclusioni del libro di Menga.
Non può costituire un ostacolo il fatto che i membri delle generazioni future non
siano presenti: allo stesso modo in cui è concepibile che si tutelino i diritti di un
soggetto assente o non ancora nato 56, anche i diritti dei futuri membri dell’umanità
possono essere fatti valere «ora attraverso persone o istituzioni che li rappresentino
hic et nunc» 57. E l’obiezione secondo cui «costoro solo apparentemente agirebbero in
nome altrui, poiché questo “altro” non esiste: agirebbero in nome e per conto
proprio, per far valere una propria visione del mondo, sia pure ispirata da qualche
Credo si possa concordare perciò con l’affermazione di Bifulco, secondo cui «diversi sono i
possibili modi di traduzione normativa degli interessi delle generazioni future in situazioni giuridiche
soggettive» (Diritto e generazioni future, cit., p. 79).
Infatti, «stabilire i diritti di una persona significa stabilire la loro rilevanza morale nella
determinazione di ciò che moralmente si deve fare in una qualsiasi situazione reale» (così T. Regan,
The Case for Animal Rights, University of California Press, Berkeley-Los Angeles 1983; tr. it. I diritti
animali, Garzanti, Milano 1990, p. 369.
Zagrebelsky, Senza adulti, cit., p. 87. Ancora più nettamente, Ferlito, nell’ambito di una
considerazione teorico-generale relativa alla distinzione tra ‘obbligo’ e ‘dovere’: «Il dovere costituisce
una figura deontica autonoma, dotata di validità giuridica propria e autosufficiente, estranea alla
relazione diritto/obbligo; è una figura autonoma perché, contrariamente all’obbligo, al dovere non
corrisponde alcun diritto» (Il volto beffardo del diritto, cit., p. 58).
Cfr. Bifulco, Diritto e generazioni future, cit., p. 78.
Così G. Pontara, Etica e generazioni future, Laterza, Roma-Bari 1995, p. 96.
53
54
55
56
57
�262
T OMMA SO G RE CO
intuizione di quello che potrebbe essere l’interesse di chi ancora non c’è e potrebbe
esserci un giorno» 58, è una obiezione che non toglie (e nemmeno aggiunge) nulla
all’unica strada che gli uomini — nella loro conformazione attuale, che li lega
esclusivamente al proprio tempo presente — possono (e devono, sulla base del
principio responsabilità 59) percorrere.
5. IL DOVERE DI EDUCARE
La conclusione del libro di Menga, nonché le considerazioni che a partire da esso
ho cercato di sviluppare, rendono abbastanza chiaro quale sia il problema che noi,
oggi, dobbiamo (e anche possiamo) affrontare. Si tratta di fare in modo che il tema di
cui qui si discute entri a far parte dell’agenda educativa e politica. Se è vero che ex
fabula ius oritur, come ha ricordato Pomarici seguendo François Ost 60, allora occorre
iniziare a costruire un sistema di ‘narrazioni’ che possa essere fonte del
riconoscimento, dell’assunzione e dell’attribuzione di doveri, nonché garanzia
primaria della loro efficacia. Dobbiamo cominciare ad essere uomini del futuro, e
non solo più del presente o del passato. Il che non significa soltanto avere uno
sguardo più ampio: l’uomo del futuro, infatti, come scrive Gerhart Husserl, «non
vede soltanto più in là; egli vede le cose anche diversamente, poiché il suo sguardo
riesce ad abbracciare un’altra dimensione temporale, quella del futuro. Questa
visione del tempo è un fattore determinante in rapporto al suo pensare e al suo
fare» 61.
Una simile impresa è possibile a patto che si superi innanzi tutto l’ideologia
dell’individuo irrelato e sovrano 62, e si prenda finalmente sul serio la tesi
dell’“animale sociale” rilanciata da studiosi autorevoli come Martha Nussbaum. Un
animale sociale che è collocato tocquevillianamente dentro una «catena delle
generazioni», e che sa che «come esseri umani, per quanto frammentati e
disseminati, non siamo funghi, né siamo in grado di autoprodurci» 63. Ebbene, di
questa trama di relazioni che ci costituisce fanno parte anche i nostri discendenti e i
membri futuri dell’umanità: e dunque il principio fraterno (con la benevolenza e la
fiducia che esso si porta dietro), opportunamente riscoperto come elemento
Zagrebelsky, Senza adulti, cit., p. 91.
«Agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la permanenza di
un’autentica vita umana sulla terra» (Jonas, Il principio responsabilità, cit., p. 16).
Pomarici, Verso nuove forme dell’identità?, cit., p. 93.
Husserl, Diritto e tempo, cit., p. 41.
Come per certi versi sta facendo anche una certa letteratura liberal, che sta recuperando il tema
della solidarietà: cfr. ad es. S. Rodotà, Solidarietà. Una utopia necessaria , Laterza, Roma-Bari 2014; N.
Urbinati, Liberi e uguali. Contro l’ideologia individualista , Laterza, Roma-Bari 2011.
Ciaramelli, Responsabilità per le generazioni future, cit., p. 21.
58
59
60
61
62
63
�263
Da dove vengono i diritti delle generazioni future?
fondamentale della nostra cultura giuridica 64, non può non rivolgersi anche ai
membri futuri dell’umanità 65. L’altro tabù da superare è quello che ha relegato i
doveri nel terreno angusto del discorso moralistico, retorico, o peggio ancora
autoritario. Se, come ci ha insegnato una gloriosa tradizione che ha Simone Weil tra i
rappresentanti più illustri, i doveri hanno a che fare innanzi tutto con le relazioni
‘orizzontali’ tra gli uomini 66, allora essi devono diventare un elemento cruciale della
nostra formazione civica, del nostro agire, del nostro modo di stare nel mondo e in
relazione con gli altri. Il “diritto di avere diritti” dovrà essere accompagnato dal
“dovere di avere doveri” 67.
Poiché non arriverà alcun James Cole 68 dal remoto futuro a cercare di sistemare le
cose nel presente onde evitare conseguenze disastrose per l’umanità a venire, non c’è
dunque altra strada che questa: assumerci noi le nostre responsabilità, facendoci
carico di ciò che questa comporta. Non si può non concordare con Zagrebelsky
quando afferma che se il costituzionalismo non ha avuto ancora modo (o necessità) di
occuparsi delle «prevaricazioni intergenerazionali», esso oggi ha molte ragioni per
farlo, «e drammatiche» 69.
Il fatto che il maggior produttore di miti contemporanei, vale a dire l’industria
cinematografica, recentemente collochi sempre più spesso i suoi miti nel futuro più
che nel passato, può forse essere considerato come una spia (luminosa e densa di
Cfr. ad es. F. Pizzolato, Il principio costituzionale di fraternità. Itinerario di ricerca a partire dalla
Costituzione italiana, Città Nuova, Roma 2012.
Cfr. A. Spadaro, L’amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fondamentali
fra ragionevolezza e globalizzazione, in R. Bifulco-A. D’Aloia (a cura di), Un diritto per il futuro. Teorie
e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale, Jovene, Napoli 2008, pp.
71-112; Pisanò, Diritti deumanizzati, cit., p. 168 ss.
Anche su questo punto, onde evitare di dilungarmi in questa sede, mi permetto di rinviare ad
alcuni miei scritti precedenti: Il ritorno dei doveri, in «Cultura e diritti. Per una formazione giuridica» Rivista della Scuola Superiore dell’Avvocatura, Pisa University Press, gen-mar 2012, pp. 91-98;
Relazioni giuridiche. Una difesa dell’orizzontalità nel diritto, «TCRS – Teoria e critica della
regolazione sociale», Mimesis, Milano, 2014, pp. 9-26.
Sono qui richiamati i titoli dei lavori di S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Laterza, Roma-Bari
2013, e di L. Violante, Il dovere di avere doveri, Einaudi, Torino 2014. Il discorso sui doveri sta
ricevendo in effetti una nuova attenzione — mi riferisco al panorama italiano, ma analoghi riferimenti
si potrebbero fare per altri paesi —, soprattutto grazie ai lavori di M. Viroli, di cui si veda almeno
L’Italia dei doveri, Rizzoli, Milano 2008, e di cui è autorevole esempio il lavoro già richiamato di G.
Zagrebelsky, Diritti per forza . Una testimonianza politica di rilievo è quella di E. Bonino, I doveri e la
libertà , intervista a cura di G. Casadio, Laterza, Roma-Bari 2011. Una ricostruzione recente del
dibattito teorico in ambito filosofico-giuridico è offerta da P. Helzel, Per una teoria generale del dovere,
Cedam, Padova 2017.
Si tratta del protagonista del film L’esercito delle 12 scimmie, diretto da Terry Gilliam nel 1995,
nel quale un ergastolano (James Cole, appunto, interpretato da Bruce Willis), viene inviato dal 2035 nel
passato per capire (e cercare di fermare) le cause di un’epidemia che ha distrutto quasi interamente
l’umanità e ridotto i pochi superstiti a vivere nel sottosuolo.
Zagrebelsky, Senza adulti, cit., p. 84.
64
65
66
67
68
69
�264
T OMMA SO G RE CO
speranze) di un mondo che comincia a cogliere questa urgente necessità del nostro
tempo.
�265
Etica & Politica / Ethics & Politics, XX, 2018, 1, pp. 265-272
ISSN 1825-5167
GARANZIA E CURA: L’INTERPELLO
DELLE GENERAZIONI FUTURE
A NGE LO A BI GNE NT E
Dipartimento di Giurisprudenza
Università di Napoli “Federico II”
angelo.abignente@unina.it
ABSTRACT
The demand arising from future generations has not only a moral but also a legal connotation. It
intimates a thorough reformulation of the classical conceptuality based on rights and obligations
linked to legal subjects understood as present subjects. In line with the need of such a
reformulation this paper, by mainly drawing on the motives of care and guarantee, seeks to discuss
some practical jurisdictional instantiations by means of which Ferdinando Menga’s book can be
viewed as a source of inspiration and critical appropriation.
KEYWORDS
Intertemporality, responsibility, justice, guarantee, care
1. Ferdinando Menga in una prospettiva etico-fenomenologica, all’esito di una
attenta lettura critica degli autori confidenti e scettici di fronte alla responsabilità per
le generazioni future, dei classici ma, soprattutto, di quelli che possiamo definire i
classici del nostro tempo tra i quali emerge Hans Jonas con il suo principio
responsabilità, pone in evidenza come la riflessione sulla intergenerazionalità nel
dibattito contemporaneo sia “avviluppata” su un presente auto-concluso. Può
cogliersi solo in John Rawls e nei suoi principi di giustizia un germe capace di
innovare il nostro modo di pensare alle generazioni future ed il “velo di ignoranza”,
non esente da una lettura critica, può cogliersi come la razionalità densa di idealità
che ci rende tutti contemporanei. Con il principio del “giusto risparmio” che travolge
la massimizzazione del profitto e la riduzione dei costi, le generazioni future si
manifestano come uno scacco alle nostre categorie tradizionali.
Le decisioni cruciali della nostra storia (emblematica e centrale la bomba atomica)
assumono un carattere di irreversibilità che stravolge il nostro individualismo
possessivo e ci fa cogliere nelle generazioni future una presenza che ci appartiene. La
soggettività incontra le generazioni future come alterità che la costituisce ed ho più
volte enunciato, ma ancora non soddisfatto, la mia curiosità di discutere con
�266
A NGE LO A BIGNE NTE
Ferdinando di un possibile recupero in questo senso della dialogicità comunicativa di
Habermas, per molti versi critico di Rawls a cui pure attribuisce un rilievo
predominante.
Ma seguiamo Ferdinando: il “primato etico dell’alterità” postula un “ripensamento
radicale” della morale radicata nella “semantica della presenza o della presenzialità
dei soggetti etici”. Nell’approccio fenomenologico, oltre Husserl, è la più significativa
novità del discorso di Ferdinando e la fecondità del suo scritto. Chiamando in causa i
suo autori, Levinas, Derrida, Ricoeur e Waldenfels, Ferdinando pone in evidenza
come il “soggetto” vada inteso “come connotato fin dall’inizio della sua insuperabile
condizione intersoggettiva, ossia, più precisamente, da una condizione tale per cui
esso è già sempre interpellato da e chiamato a rispondere alle istanze dell’alterità
ancor prima di poter pervenire pienamente a se stesso e reclamare, dunque, una
costituzione della relazione etica a partire da un presupposto autoriflessivo” .
Assumo questa considerazione di Ferdinando come chiave di lettura del suo libro
per sottolineare alcuni passaggi che a me appaiono significativi ed ineludibili anche
per una riflessione prettamente giuridica sul tema. Innanzitutto che la responsabilità
nasce da un “appello” che proviene dal futuro e che nella sua proprietà interpellante
è irriducibile al presente. Si tratta, seguendo le orme di Wandenfels, di un “futuro
anteriore” che, “essendoci già sopraggiunto dal futuro stesso in forma di ingiunzione,
ci ha già costretti a una risposta immediatamente responsabile verso di esso. Vale a
dire, a una risposta che, proprio perché connotata dalla semantica della
responsabilità, non può che parlare anche al futuro il linguaggio del passato” . Una
responsabilità, quindi, che si radica in ciò che si è contribuito a determinare nel
presente e che stravolge le teorie della responsabilità indiretta, dell’autoreferenzialità
in quanto proiezione di una soggettività costitutivamente intersoggettiva in grado di
porsi in dialogo con l’alterità per rispondere alle sue istanze. Il soggetto è vocato ad
un impegno nel presente, ad una decisione responsabile che assume il futuro non già
per esigenza di ulteriorità o per una generica intuizione morale ma per la necessità di
rispondere qui ed ora ad un’istanza già pervenuta nel suo orizzonte di conoscenza e
valutazione; un’istanza che si pone in termini di indisponibilità nel presente.
1
2
2. Tralasciando, nell’economia del mio intervento, riflessioni di carattere etico e
filosofico fortemente stimolate dallo scritto di Ferdinando e limitandomi ad
assumere l’angolo prospettico del teorico del diritto che mi è più congeniale, non
posso non considerare come questa impostazione del discorso sulle generazioni
future determini uno scandalo nelle nostre categorie giuridiche, tutte configurate
sulla presenza che impronta il codice binario di diritti-doveri: le generazioni future
F.G. Menga, Lo scandalo del futuro. Per una giustizia intergenerazionale, Edizioni di Storia e
Letteratura, Roma 2016, pag. 99.
Ivi, pag. 107.
1
2
�267
Garanzia e cura: l’interpello delle generazioni future
implicano la “rottura della contemporaneità”, con le parole che Ferdinando riprende
da Gustavo Zagrebelsky.
L’appello dell’alterità delle generazioni future non può considerarsi proveniente
da un soggetto che è titolare di diritti e la stessa espressione “diritti delle generazioni
future” è equivoca perché esse non hanno diritti: si tratta dell’ostacolo della non
esistenza, rilevato da Ferdinando, che nel diritto diventa particolarmente
problematico. Ciò rende difficile la traduzione nel linguaggio e nelle categorie del
diritto, improntato alla preminenza del diritto soggettivo ed ai codici binari dirittiobblighi o diritti-doveri. Il “binomio contraddittorio: ‘non ancora’ e ‘ora’” crea un
“paradosso”, come afferma Zagrebelsky, perché “il ‘non ancora’, per poter diventare
attuale, cioè per venire a esistere, dipende precisamente dall’‘ora’” .
È questo paradosso che a mio avviso si riverbera in alcune questioni giudiziarie,
ad esempio in tema di inizio vita dove ci si interroga sulla situazione giuridica del
nascituro e del concepito. Vi è sul tema un dibattito che non sembra sopirsi: può
riconoscersi al nascituro un diritto prima della nascita se il nostro ordinamento
afferma che la capacità giuridica si acquista solo con la nascita? Se il diritto
appartiene ai viventi e con esso la potenza e se “Coloro che non esistono non hanno
alcun titolo giuridico da opporre a coloro che esistono” la potenza dei secondi si
rivela “pre-potenza” , l’ostacolo dell’asimmetria di cui parla Ferdinando. Come uscire
da questa impasse?
Zagrelbesky, evocando Bobbio, propone di passare dall’età dei diritti all’età dei
doveri. È un riferimento implicito, per quanto mi sembra non testuale, al libro di
Luciano Violante, Il dovere di avere doveri, scritto in una chiave critica dello
speculare Diritto di avere diritti di Rodotà. Ma qui la prospettiva di Zagrelbesky si
allarga alle generazioni future intendendo il “dovere in assoluto”, scollegandolo dal
rapporto di reciprocità, rileggendolo come posizione giuridica autonoma che vive di
vita propria, “diritto oggettivo” collegato a “principi di giustizia oggettiva” . Sicché,
“una cosa è il dovere come soggezione a un potere; un’altra cosa è il dovere come
risposta a una chiamata in responsabilità nei confronti della condizione dei propri
contemporanei e nei confronti di coloro che dovranno venire dopo di noi. I doveri
verso i contemporanei sono doveri di giustizia; i doveri verso chi succederà a noi sono
doveri verso l’umanità” .
Assume così valore centrale la responsabilità, nell’etimologia propria del verbo
respondeo: “se una grande opportunità o un’immane tragedia [una decisione
irreversibile come quella sulla bomba atomica] dipende solo da te, e tu non hai la
sponda a cui aggrapparti che potrebbe essere una norma giuridica vincolante, la tua
3
4
5
6
3
4
5
6
G. Zagrebelsky, Diritti per forza , Einaudi, Torino 2017, pag. 120.
Ivi, pag. 121.
Ivi, pag. 96.
Ivi, pag. 94.
�268
A NGE LO A BIGNE NTE
responsabilità, connessa alla tua libertà, diventa somma responsabilità” . Per
Zagrebelsky si tratta di una responsabilità morale, non giuridica ma io credo – e il
libro di Ferdinando penso che possa dare alimento a questa mia riflessione – che qui
si celebra un incontro ineludibile tra diritto e morale. Il tema interroga perciò i
giuristi e se ne colgono nella letteratura più recente tracce significative.
Soprattutto i costituzionalisti leggono nella intertemporalità delle Costituzioni
moderne la humus in cui è possibile fondare una giustizia intergenerazionale che
superi il tradizionale lessico diritti/doveri. Nella sua lettura delle clausole
intergenerazionali presenti in numerose parti della nostra costituzione, guidato dalla
lente prospettica della ragionevolezza che reca in sé il senso del limite e
dell’autolimite ovvero “l’idea che nella valutazione di quello che posso fare oggi deve
avere un ruolo anche l’analisi degli effetti che scelte, comportamenti, decisioni
possono determinare per il futuro, quando questi effetti hanno un impatto
potenzialmente irreversibile e tale da compromettere la conservazione e la
trasmissione alle generazioni future di beni, risorse, condizioni di vita che noi stessi
riteniamo essenziali” , D’Aloia ritrova le radici di una solidarietà che “si pone in
antitesi tanto all’individualismo quanto al presentismo, entrambi estranei alla visione
e ai significati del personalismo costituzionale” . Da qui il passo è breve per
coniugare la “responsabilità verso la Costituzione” che pone un “vincolo rovesciato”
nella libertà della generazione presente intorno all’uso dei beni verso quelle future: è,
come sottolinea l’autore, il tema noto e dibattuto dell’“atteggiamento custodiale” che
ha animato il costituzionalismo americano con la tesi di Jefferson dell’usufrutto –
non della proprietà – della terra, per cui la terra viene usata dalla generazione
presente come usufruttaria non come proprietaria.
Penso che questa prospettiva sia importante, quasi speculare a quella di
Zagrebelsky intorno agli obblighi che D’Aloia sviluppa con attenzione intorno all’uso
delle risorse e dei beni, oggi al centro di un ampio dibattito sui beni comuni. Si
generano situazioni giuridiche che rivelano il ruolo del diritto di creazione di vincoli
e obblighi verso le generazioni future ma che al tempo stesso esigono una svolta
linguistica, specie sotto un profilo argomentativo, che si emancipi dall’“azzardo” di
“Parlare di ‘diritti’ delle generazioni future dentro il modo tradizionale di concepire i
diritti soggettivi”, perché “I diritti non sono solo risorse dei soggetti, ma ‘beni’,
interessi oggettivi, che riflettono principi di giustizia assunti dall’ordinamento come
propri criteri di riconoscimento; esprimono una identità dinamica, un modo di
essere di un ordinamento, indicano i suoi fini essenziali” .
7
8
9
10
Ivi, pag. 120.
A. D’Aloia, “Costituzione e protezione delle generazioni future”, in F. Ciaramelli, F.G. Menga (a
cura di), Responsabilità verso le generazioni future, Editoriale Scientifica, Napoli 2017, pag. 308.
Ivi, pag. 309.
Ivi, pagg. 318 s.
7
8
9
10
�269
Garanzia e cura: l’interpello delle generazioni future
In questa prospettiva, credo che l’interrogazione delle generazioni future al diritto
volta alla rivisitazione linguistica delle categorie e degli istituti tradizionali –
diritto/obbligo, soggetto/capacità – impegni in uno sforzo ulteriore che si concentri
sul nesso garanzia e cura. Qui ritengo che giochi un ruolo essenziale la questione
della tutela giudiziaria dei diritti e dell’ineludibile ruolo interpretativo ed
argomentativo dei giudici
Quando nel nostro ambiente si parla di garanzia e soprattutto di garantismo si
incontra un dibattito che vede contrapposto un garantismo fondato sui principi,
particolarmente quelli tradizionali, ed un garantismo costituzionale in senso stretto.
Questo in particolare fa capo alle note tesi di Ferrajoli che intravede nella
Costituzione la magna charta, la fonte di consacrazione delle funzioni di garanzia,
primaria e secondaria. Qui non voglio riprendere le sue teorie ed addentrarmi in una
giustificazione articolata di una possibile dissonanza che richiederebbe un discorso
articolato e complesso, forse ridondante. Mi limito ad osservare che a mio avviso si
può alzare lo sguardo più in lato: non si tratta solo delle garanzie, primarie e
secondarie, offerte dalla nostra costituzione, ma della nostra partecipazione al diritto
in termini di libertà. Con tutte le declinazioni possibili: dalla tutela della
partecipazione, l’istanza habermasiana della legittimazione data dalla controfattuale
accettazione da parte di tutti i potenziali partecipanti, alla conservazione della terra e
dell’ambiente per finire all’accesso alla giustizia.
Per un’articolazione in concreto della mia proposta, potrei riferirmi a quella
elaborazione dottrinale tedesca nota con il termine Schutzpflichten, assunta nel nostro
dibattito dottrinale e giurisprudenziale con il termine obblighi (doveri) di protezione
che, originariamente applicata alla teoria dei contratti (il comportamento esorbitante
dall’obbligo contrattuale che incide sui terzi o sulla stessa controparte, come previsto
dall’art. 2087 cc. o da varie norme ad es. in materia di protezione degli alunni
scolastici) è ora riletta nell’istituto della responsabilità da contatto (specie nell’ambito
della responsabilità medica ma anche dell’azione amministrativa). Non posso però
ritenerla esaustiva, per quanto suggestiva nell’allargamento delle categorie
dommatiche, perché essa implica sempre la presenza di un soggetto capace, titolare
di diritto, mentre nel nostro caso le generazioni future non hanno soggettività e
diritti riconosciuti dal nostro ordinamento.
11
3. Preferisco però prendere a modello del mutamento dei paradigmi verso la
garanzia e la cura un noto dibattito giurisprudenziale che ha coinvolto
particolarmente la III sez. civ. della Cassazione e le Sezioni Unite. Si tratta della
protezione da riconoscere al nato portatore di handicap ed al nascituro ed della
tutelabilità della sua posizione in termini risarcitori per la malformazione riportata:
L. Ferrajoli, Dei diritti e delle garanzie, Il Mulino, Bologna 2013; Id., Iura Paria. I fondamenti della
democrazia costituzionale, Editoriale scientifica, Napoli 2015; Id., Due modelli di costituzionalismo,
11
Editoriale Scientifica, Napoli 2016.
�270
A NGE LO A BIGNE NTE
la sua genesi può essere identificata con il famoso affaire Perruche, dal nome di un
caso giudiziario che vide nel 2000 la adunanza plenaria della Corte di Cassazione
francese riconoscere il risarcimento ad un bambino portatore di handicap,
sollecitando il legislatore che successivamente è intervenuto con disposizioni
limitative della responsabilità medica e del diritto al risarcimento sia dei genitori che
del bambino.
Ponendosi il problema della risarcibilità del danno subito da un nato portatore di
handicap per un errore diagnostico o terapeutico durante la gestazione o per
mancata informazione alla madre di un danno possibile, in una sentenza rilevante
la Cassazione si è posta il problema che nel nostro ordinamento l’art. 1, co 1, cc.
prevede che la capacità giuridica si acquista con la nascita, non potendosi far perno
sul secondo comma dello stesso articolo che in ipotesi particolari ed espressamente
previste nell’ordinamento giuridico riconosce diritto al concepito ma solo al
momento della nascita, in quanto appunto si tratta di diritti che devono essere
previsti.
Il giudice di legittimità aveva già affermato che, in base all’art. 32 Cost., “la tutela
della salute è garantita come fondamentale diritto dell’individuo, oltre che interesse
della collettività ritenendo che esso non è limitato alle attività che si esplicano dopo
la nascita od a questa condizionate, ma deve ritenersi esteso anche al dovere di
assicurare le condizioni favorevoli per l’integrità del nascituro nel periodo che la
precedono” e, pur riconoscendo che il concepito non aveva personalità giuridica,
aveva comunque ritenuto che poteva leggersi nel nostro ordinamento l’intento di
“tutelare l’individuo sin dal suo concepimento, garantendo se non un vero e proprio
diritto alla nascita, che sia fatto il possibile per favorire la nascita e la salute”.
Intervenendo sul tema nel 2009, la Corte ritiene che tale affermazione non è
condivisibile nella parte in cui attribuisce al concepito un interesse protetto senza
riconoscergli personalità giuridica. Essa, pertanto, elabora una distinzione tra
soggettività e personalità giuridica e riconosce al concepito, ancor prima della nascita
una soggettività, azionabile però soltanto all’avverarsi della conditio iuris della
nascita attributiva della personalità giuridica.
Si è parlato, a questo proposito, di un diritto adespota, cioè privo di un titolare: la
titolarità che lo renderebbe azionabile sarebbe subordinata alla nascita. Ma da qui il
passo è breve per una questione ulteriore: di quale diritto si tratta? Si potrebbe dire: il
diritto a nascere sano otterrebbe tutela, sotto il profilo del cd danno conseguenza, a
seguito della nascita. Ma allora, specularmente, si potrebbe dire che il concepito ha
un diritto a non nascere se non sano, il che contrasterebbe con i principi di tutela
della vita che sono impressi nella nostra Costituzione.
12
13
12
13
Cass. 10741/2009, relatore Spagna Musso.
spc. Cass. 11503/1993.
�271
Garanzia e cura: l’interpello delle generazioni future
Questi sono, emblematicamente, i dilemmi che sorgono quando ci sentiamo
costretti nelle categorie dommatiche tradizionali, del diritto, della capacità giuridica,
della soggettività.
Mi sembra che una possibile via di soluzione a questi dilemmi possa individuarsi
in una sentenza successiva della stessa sezione della Corte di Cassazione che, pur
destinata ad una rivisitazione da parte delle Sezioni Unite , conserva pregio
argomentativo nell’intento di superare la tradizionale dommatica del diritto
soggettivo, riconoscendo il concepito non come soggetto giuridico ma come oggetto
di tutela, dando così risonanza implicita a quei “principi di giustizia oggettiva” di cui
parla Zagrebelsky ed a quella coniugazione dei diritti come “beni” o “interessi
oggettivi” a cui ha fatto riferimento D’Aloia. È una sentenza molto complessa ma
non posso esimermi dal riportarne alcuni passaggi significativi, quando afferma che
“la protezione del nascituro non passi necessariamente attraverso la sua istituzione a
soggetto di diritto, ovvero attraverso la negazione di diritti del tutto immaginari,
come quello a ‘non nascere se non sano’, locuzione che semplicemente non
rappresenta un diritto”, per giungere ad affermare che “È tanto necessario quanto
sufficiente, di converso, considerare il nascituro oggetto di tutela, se la qualità di
soggetto di diritto (evidente astrazione rispetto all’essere vivente) è attribuzione
normativa funzionale all’imputazione di situazioni giuridiche e non tecnica di tutela
di entità protette”.
A giustificazione dell’assunto, la Corte riprende pronunce della Corte
Costituzionale in tema di diritti della madre e dell’embrione , della stessa Corte di
Cassazione e valuta le evoluzioni del nostro ordinamento dal 1942 ad oggi, alla luce
delle norme costituzionali e del ruolo sempre più incisivo delle fonti sovranazionali,
per giungere ad affermare che “La locuzione ‘centro di interessi suscettibile di tutela’
è peraltro espressione anfibologica, dalla quale è lecito dedurre tanto la conclusione
(non necessaria) della soggettività giuridica del nascituro, quanto quella, più
realisticamente aderente al dato normativo ed alla stessa concezione del soggetto in
termini di fattispecie […], in termini, cioè, di oggetto di tutela ‘progressiva’ da parte
dell’ordinamento, in tutte le sue espressioni normative e interpretative”; Ciò
comporta che il concepito è da intendersi “come oggetto di tutela e non anche come
soggetto di diritto. […] Chi nasce malato per via di un fatto lesivo ingiusto occorsogli
durante il concepimento non fa, pertanto, valere un diritto alla vita né un diritto a
nascere sano né tantomeno un diritto a non nascere. Fa valere la lesione della sua
salute, originatasi al momento del concepimento. Oggetto della pretesa e della tutela
risarcitoria è, pertanto, sul piano morfologico, la nascita malformata, su quello
14
15
16
17
14
15
16
17
Cass. 16754/2012, relatore Travaglino.
Cass. SU 25767/2015.
C. Cost. 27/1975.
Cass. 9700/2011.
�272
A NGE LO A BIGNE NTE
funzionale (quello, cioè, del dipanarsi della vita quotidiana) il perdurante e
irredimibile stato di infermità. Non la nascita non sana. O la non nascita”.
Al di là di questioni risarcitorie, anche sotto il profilo della individuazione del
nesso di causalità, esaminate nella sentenza con uguale attenzione ma che
richiederebbero una riflessione specifica,
credo che l’argomentazione della
Cassazione possa valere nel qui e nell’ora a fondare una nostra responsabilità che
assume tonalità non solo morali ma giuridiche nel garantire le condizioni che
consentiranno alle generazioni future di esercitare i loro diritti, sull’ambiente (è di
prima evidenza) ma anche ad esempio nelle condizioni di vita materiale e nel lavoro.
In particolare, di urgente emergenza, nella partecipazione, civile e politica, e
nell’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti perché è proprio nell’ambito del
giudizio che situazioni giuridiche astrattamente riconosciute trovano effettiva
consistenza.
Ho detto di “nostra responsabilità”, declinando al plurale la responsabilità di cui
parla Ferdinando in prima persona ma pur implicitamente proiettandola nella
dimensione plurale. Si tratta di una responsabilità che richiede attenzione, vigilanza
e cura nel presente, tessuta da quella immaginazione richiesta dall’ostacolo della
non determinatezza di Ferdinando.
Mi sembra che questa prospettiva che ho cercato di delineare, si rilevi sintonica
con la indicazione di Ferdinando dell’“articolazione temporale” del futuro anteriore
e mi consenta di concludere con lui: “l’appello a una responsabilità per il futuro si
origina non perché noi ci proiettiamo verso quest’ultimo a dal presente, ma perché è
l’appello stesso a sopraggiungerci dal futuro, da una lontananza che già sempre ci
ingiunge e si mostra irriducibile al dominio della presenza. È proprio in questa
articolazione diacronica e pratica dell’appello dal futuro che insorge
incontrovertibilmente un senso di giustizia dal carattere letteralmente intempestivo e
simultaneamente iperbolico” .
18
19
18
19
F.G. Menga, Lo scandalo del futuro, cit., pag. 114.
Ivi, pag. 117.
�273
Etica & Politica / Ethics & Politics, XX, 2018, 1, pp. 273-303
ISSN 1825-5167
PROBLEMI APERTI DI GIUSTIZIA
INTERGENERAZIONALE: RISPOSTE AI
MIEI CRITICI
FE RDI NA NDO G. ME NGA
Università della Campania “Luigi Vanvitelli”
Dipartimento di Giurisprudenza
ferdinandomenga@gmail.com
ABSTRACT
In this paper I seek to respond to some of the critiques and remarks raised by the authors invited
by the journal Etica & Politica / Ethics & Politics to discuss my book on intergenerational justice
Lo scandalo del futuro. Per una giustizia intergenerazionale (Roma, 2016). In engaging these
critical reviews coming from the perspective of different fields – especially, legal philosophy, ethics
and theoretical philosophy – I also attempt to readdress some pivotal points of the book which
need be better formulated, deepened and revised.
KEYWORDS
Intergenerational justice, futurity, responsibility, alterity, legal theories and practices
«Do not be tempted by the illusion that the world economy and its stock exchanges can
exist apart from the world’s natural environment. Our planet earth is a finite entity. You
have the data in front of you, you have the choice – the human project must be safely
and cleanly fuelled, or it fails, it sinks. You, the market, either rise to this, and get rich
along the way, or you sink with all the rest. We are on this rock together, you have
nowhere else to go …»
(I. McEwan, Solar)
Voglio innanzitutto ringraziare i direttori di Etica & Politica / Ethics & Politics,
Pier Marrone e Riccardo Fanciullacci, per il privilegio accordatomi nel dedicare la
sezione “Simposio” del presente numero della rivista alla discussione del mio libro
Lo scandalo del futuro. Per una giustizia intergenerazionale (Edizioni di Storia e
Letteratura, Roma 2016). Mi preme poi esprimere tutta la mia gratitudine
�274
F ERD IN ANDO G. M EN GA
all’indirizzo degli interlocutori intervenuti – Angelo Abignente (Università di Napoli
“Federico II”), Gabriella Baptist (Università di Cagliari), Tommaso Gazzolo
(Università di Sassari), Tommaso Greco (Università di Pisa), Michele Illiceto (Facoltà
Teologica di Bari) e Mario Vergani (Università di Milano “Bicocca”) – che con i loro
puntuali commenti, le importanti suggestioni, acute critiche e feconde proposte non
si sono limitati alla sola tematizzazione di snodi e punti critici relativi al volume, ma
hanno fatto qualcosa di più ampio e di molto più rilevante: hanno cioè prodotto dei
contributi che, a partire da diverse prospettive disciplinari e molteplici sensibilità
teoretiche, impreziosiscono il dibattito generale sul tema.
Il passaggio in rassegna dei vari approcci e percorsi che queste studiose e questi
studiosi hanno messo in campo nei loro testi dimostra, a mio avviso, un aspetto
essenziale della questione riguardante la responsabilità intergenerazionale: si tratta di
un tema che per ampiezza problematica ed estensione delle implicazioni non può che
imporre uno sforzo scientifico di carattere interdisciplinare e congiunto – aspetto,
questo, che ho già cercato di evidenziare nel libro stesso e ho continuato a rimarcare
in interventi ad esso successivi 1.
Pertanto, all’indubbio sentimento di gratitudine, che discende dal non comune
privilegio di poter replicare ad una serie di interventi espressamente dedicati al mio
libro, si aggiunge qui anche quello di soddisfazione per il fatto di propiziare –
attraverso il presente scambio – un’ulteriore occasione di discussione su un tema così
importante, urgente e pervasivo.
1. ONTOLOGIZZAZIONE DELLA RELAZIONE ETICA E PRECIPITATO NEL
CAMPO DELLA RESPONSABILITÀ INTERGENERAZIONALE
Nel replicare ai commenti, segnalazioni e critiche al mio libro formulate dai vari
interlocutori, scelgo di partire dall’intervento di Michele Illiceto, il quale mette in
campo una fondazione della responsabilità intergenerazionale, in qualche misura,
alternativa alla mia. Nonostante la definisca – molto generosamente nei miei
confronti – nei termini di un arricchimento concettuale rispetto al mio percorso, la
sua proposta mi pare costituire, invece, una vera e propria riflessione indipendente e
di carattere critico. È una presa di distanza che si rivela preziosa non solo perché mi
impone di rivisitare e meglio elucidare l’impianto strutturale del mio discorso, ma
anche e soprattutto perché fornisce al lettore una diversa esplicitazione di temi e
snodi teoretici di cui la mia indagine rappresenta soltanto uno dei possibili percorsi
di sviluppo.
Non v’è dubbio: Illiceto ha pienamente ragione nel sostenere l’unità di intenti fra i
nostri approcci nella loro comune presa di distanza dal presentismo etico tipico delle
1
L’intento di raccogliere una tale sfida di carattere multiprospettico ed interdisciplinare sta proprio
alla base del volume da me curato assieme a Fabio Ciaramelli: Responsabilità verso le generazioni
future. Una sfida al diritto, all’etica e alla politica, Editoriale Scientifica, Napoli 2017.
�275
Problemi aperti di giustizia intergenerazionale: risposte ai miei critici
teorie contrattualiste e utilitariste sulla responsabilità intergenerazionale. Sottoscrivo,
perciò, pienamente la sua riformulazione della mia critica secondo cui “utilitarismo e
contrattualismo estromettono il futuro dalle decisioni etiche relative al presente,
perché […] le categorie di utilità e di contratto abbracciano solo la sfera temporale del
puro presente, e pertanto risultano inadeguate a soddisfare l’esigenza di fare entrare
sulla scena etica i diritti di chi non ancora c’è”. Più problematica ritengo essere,
invece, la sua visione secondo cui a “support[o]” e “completa[mento]” del mio
“impianto” ben interverrebbe un’integrazione implicante la quadruplice dimensione
di un’ontologia della possibilità, della relazione, della generatività e dell’utopia.
Non potendomi addentrare in un’investigazione tale da rendere giustizia ai diversi
e assai articolati aspetti delle riflessioni elaborate da Illiceto in seno a ciascuna di
queste dimensioni, mi limito qui soltanto a rilevarne il tratto costitutivo comune –
tratto che, a mio avviso, resta difficilmente conciliabile con l’impalcatura strutturale
del mio discorso, nonostante alcune innegabili convergenze critiche e prospettiche. Si
tratta, in estrema sintesi, della tendenza ontologizzante che campeggia
nell’impostazione del discorso di Illiceto sulla responsabilità verso le generazioni
future. Mi spingerei a parlare di una sorta di primato ontologico nella riflessione di
quest’autore 2 che probabilmente trova la sua condensazione più marcata nella
seguente lapidaria affermazione, che riporto alla lettera: “È la relazione (ontologica)
che fonda la responsabilità (etica). In altri termini, la responsabilità traduce sul piano
etico la relazione che invece mi costituisce sul piano ontologico”.
Nella mia prospettiva, un tale movimento di riconduzione del piano etico a quello
dell’essere più che rafforzare un’etica di genuina caratura intergenerazionale e più
che liberare il futuro dalla tirannia del presente, finisce per riaffermare volens nolens
– e, oserei quasi dire, sotto mentite spoglie – la semantica presentistica stessa. In che
modo? Esattamente attraverso quella che Lévinas chiamerebbe la strategia di
neutralizzazione che ogni ontologia comporta nei confronti dell’etica 3. Nonostante
tutti gli ammorbidimenti di carattere relazionale, ogni impostazione ontologica porta
con sé il rischio endemico di liquidare l’incisività appellativa dell’alterità e
dell’alterità del futuro – sempre singolare, debordante, eccentrica – attraverso il gesto
di un suo addomesticamento strutturale e fondazionale. Ne consegue, pertanto, che
la realizzazione di un’etica per il futuro di carattere radicale, contrariamente a
quanto Illiceto tende a volere correggere di Lévinas, più che richiedere un
risospingimento fenomenologico della responsabilità entro un quadro ontologico,
impone un vero e proprio smarcarsi rispetto a quest’ultimo.
2
L’affermazione di questo primato mi pare essere, peraltro, uno dei temi di fondo del bel volume
dell’autore: M. Illiceto, La persona: dalla relazione alla responsabilità. Lineamenti di ontologia
relazionale, Città Aperta, Troina (EN) 2008.
3
Su questo si veda su tutti E. Lévinas, Totalità e infinito. Saggio sull’esteriorità, Jaca Book, Milano
1980.
�276
F ERD IN ANDO G. M EN GA
Da parte sua, Illiceto non lascia spiraglio alcuno di dubbio riguardo alla
gerarchizzazione fondazionale che intende propugnare e che, nel paragrafo che –
non a caso – porta il titolo di “La relazione come costitutivo ontologico e come
criterio normativo etico”, così formula:
Il primato dell’etica sull’ontologia, così tanto voluto da Lévinas, è rintracciabile solo a
livello fenomenologico ma non a livello fondativo. La fenomenologia, d’altronde, può
fondare solo rivelando ciò che ontologicamente si nasconde. Noi siamo responsabili di
ciò con cui siamo in relazione per il semplice fatto che ciò con cui siamo in relazione ci
costituisce proprio tramite la medesima relazione. E se è vero che ciò che ci istituisce ci
vincola, la relazione diventa il criterio normativo a cui deve sottostare ogni agire etico.
La relazione normativizza la responsabilità, fondandola.
Ecco dunque affiorare il nucleo fondamentale della riflessione di Illiceto, il quale
si riverbera poi in ognuna delle quattro dimensioni da lui messe in campo: il piano
ontologico, per quanto nascosto (o forse proprio perché nascosto), soggiace a e sta a
fondamento di ogni articolazione etica. Ma qui quantomeno qualche domanda
incalza: questo soggiacere dell’essere della relazione alla sua fenomenicità – al suo
accadere eticamente connotato – non si traduce esso stesso in una forma di stabilità,
di meta-temporalità, insomma, di continuum di presenza tale da cristallizzare e
sclerotizzare la relazione medesima, privandola così di ogni sua incisività
incondizionale 4 e del suo carattere genuinamente “iperbolico e intempestivo” 5? In tal
senso, rispetto al contesto di un’etica intergenerazionale, mi chiedo anche: una tale
prospettiva, al posto di liberare la futurità dalla tirannia del presentismo etico, non
finisce essa stessa per ricadere nelle maglie di un primato della presenza, però questa
volta non più nei termini di un’impostazione contrattualista o utilitarista, ma
piuttosto nella guisa di un’ontologia della relazione? In tale linea, non mi pare perciò
essere semplicemente una coincidenza il fatto che Illiceto, nella sua alleanza critica
con il mio lavoro, per quanto, da un lato, si dilunghi sulla condivisione rispetto alla
mia presa di distanza nei confronti delle prospettive contrattualiste e utilitariste,
dall’altro, nulla abbia da dire sull’altrettanto accesa critica che formulo all’indirizzo
delle prospettive ontologico-metafisiche e giusnaturaliste. Certamente, in più di un
passaggio della sua riflessione viene sottolineato che un’ontologia della relazione non
debba essere confusa con un’ontologia della sostanza. Ma ho il sospetto che questa
4
In effetti, mi pare essere esattamente il sottrarsi del fenomeno etico alla logica formale della
condizionalità (trascendente o trascendentale) il tratto più fecondo della proposta di Lévinas, tratto che
si rivela refrattario ad ogni tentativo di conciliazione con una dimensione ontologica. Sull’esplicitazione
di questo aspetto, risultano magistrali, a mio avviso, le pagine di M. Vergani, Levinas fenomenologo.
Umano senza condizioni, Morcelliana, Brescia 2011. Per una tematizzazione di questo plesso di senso
in chiave fenomenologico-giuridica si veda F. Ciaramelli, La legge prima della legge. Levinas e il
problema della giustizia, Castelvecchi, Roma 2017, in part. capp. 3 e 4.
5
Mi permetto di riprendere qui il titolo del mio studio: F.G. Menga, “Per una giustizia iperbolica e
intempestiva. Riflessioni sulla responsabilità intergenerazionale in prospettiva fenomenologica”, in
Diritto & Questioni Pubbliche 14, 2014, pp. 711-793.
�277
Problemi aperti di giustizia intergenerazionale: risposte ai miei critici
avvertenza non basti, fintantoché resta l’ontologia a dominare la relazione e non il
contrario. Cercherò, più avanti, di offrire un’esplicitazione per nulla speculativa circa
la posta in gioco che si consuma in questa alternativa, proprio discutendo uno dei
temi chiave del discorso di Illiceto: il peso che la generatività detiene in seno all’etica
intergenerazionale.
Ma prima di fare questo, mi si consenta una precisazione: il sospetto appena
sollevato non è nuovo e tantomeno mi arrogo una qualche originalità nell’averlo
portato ad evidenza. Al contrario, in tale contesto, più che mai mi preme richiamare,
per lo meno, il lavoro di Hannah Arendt e il suo sforzo di messa in discussione del
primato dell’ontologia sulla relazione nella sua riflessione sulla strutturazione plurale
dello spazio politico. Celebri, al riguardo, sono le sue parole in apertura di Vita activa
circa il fatto che noi non incontriamo in alcun modo prima qualcosa come l’essenza
dell’uomo per poi agire in base ad essa nell’ambito delle relazioni intersoggettive 6. Al
contrario, se c’è da indicare qualcosa come un momento “fondativo” della
condizione umana, allora questo, per la Arendt, è da rinvenirsi solo ed
esclusivamente nel fatto della pluralità, ossia nell’irriducibile singolarità e
molteplicità degli individui che si relazionano gli uni agli altri. Una radicalizzazione
del paradigma arendtiano della pluralità, nel senso di un’esplicita rottura con
un’ontologia della relazione, la ritroviamo poi, come è noto, tanto nel lavoro di JeanLuc Nancy 7 che in quello di Roberto Esposito 8, per i quali, più che di registrare la
dimensione dell’essere nella relazione, si tratta piuttosto di rinvenire la relazione al
fondo dell’essere. In modo analogo, infine, bisogna riferirsi anche alla posizione di
Giorgio Agamben, il quale, articolando a suo modo il tema della rottura ontologica
operata dalla singolarità, giunge alla conclusione secondo cui un’etica degna di tal
nome si palesa solo nella misura in cui si affranca da ogni tipo di irreggimentazione
sostanzialistica 9.
Ma, come richiamavo poc’anzi, se, in ambito intergenerazionale, vogliamo
davvero saggiare concretamente ciò che è in gioco fra, da un lato, l’opzione di
un’ontologia della relazione e, dall’altro, la prospettiva concorrente di una
fenomenologia della responsabilità di carattere immediatamente etico, dobbiamo
allora evidenziarne gli inconciliabili precipitati entro il discorso della generatività. È
proprio qui che la prospettiva di Illiceto, a mio avviso, scopre tutte le sue carte
ontologiche (sostanzialiste? giusnaturaliste?) con le diverse conseguenze che ciò
implica per un determinato modo di intendere gli obblighi intergenerazionali. Non
ritengo di esercitare troppa violenza ermeneutica nei confronti della progressione
argomentativa di Illiceto se pongo la cosa nei termini seguenti: il carattere di
generatività è essenziale perché generativa non è altro che la specificazione
6
7
8
9
Cfr. H. Arendt, Vita activa. La condizione umana , Bompiani, Milano, 2001, § 1.
J.-L. Nancy, Essere singolare plurale; Einaudi, Torino 2001.
R. Esposito, Communitas. Origine e destino della comunità , Einaudi, Torino 1998.
G. Agamben, La comunità che viene, Bollati Boringhieri, Torino 2001, in part. p. 39.
�278
F ERD IN ANDO G. M EN GA
ontologica stessa della relazione. Per cui, se – come abbiamo visto ad un primo livello
della riflessione –, per Illiceto, è vero che dal fatto di avere un essere relazionale
discende una responsabilità per la relazione stessa, tanto più vero – ad un secondo
livello di riflessione – è il fatto che dobbiamo essere responsabili per le future
generazioni, una volta che scopriamo che il carattere specifico d’essere della
relazione è proprio la generatività. Detto in termini semplici: dalla proprietà d’essere
di generare ne discende un obbligo di generatività e, di conseguenza, una
corrispettiva serie di diritti dei generati nei confronti dei generanti. Qui la parabola
discendente che dall’ontologia conduce dritta all’etica si rivela in tutta la sua
irriducibilità e pregnanza. Più che ulteriori commenti, è bene riportare le parole
stesse di Illiceto al riguardo:
[S]econdo il principio della generatività non si può non generare. Certo, si può anche
non farlo, ma ciò sarebbe un andare contro la nostra natura [corsivo aggiunto], la quale
ci chiede di perpetuare la nostra specie. La facoltà di generare ci obbliga a farlo [corsivi
aggiunti]. Tale obbligo ci mette davanti alla possibilità che le future generazioni –
generate dalle precedenti, cioè dalla nostra – abbiano il diritto ad essere generate. Si
evince quindi che il primo diritto delle future generazioni è quello di essere generate. È
quello di avere un presente. Se noi non fossimo capaci di farlo, non saremmo
responsabili del loro possibile non venire al mondo [corsivi aggiunti].
Come si evince chiaramente da questo passo, l’argomentazione di Illiceto mostra
qui tutta la sua chiara caratura metafisico-sostantivista: richiamando quasi un
giusnaturalismo di carattere forte, essa fa discendere il dover-essere dall’essere, o
meglio l’“obbligo” dalla “natura”. Ne consegue, in ambito intergenerazionale
un’approssimazione assai evidente a impostazioni di importanti studiosi quali
Jonas 10, Agius 11 e Visser ‘t Hooft 12.
Tuttavia, rispetto a tale approccio, non mi interessa, in questa sede, ripetere le
critiche da me già formulate nel libro – la più importante su tutte: il fatto che un’etica
di derivazione ontologica, più che liberare la futurità, alla fine, ne riassorbe tutta la
portata problematica entro l’alveo di una natura meta-storica.
Più importante è, qui, per me, sottolinearne invece l’inconciliabilità rispetto alla
mia impostazione nel solco di quanto andavo evocando all’inizio. C’è soprattutto un
punto che, in ambito di riflessione intergenerazionale, va evidenziato riguardo alla
distanza incolmabile fra un’impostazione ontologico-relazionale e una di stampo
etico basato su una fenomenologia dell’alterità: se, secondo la prospettiva ontologica,
è dalla condizione di generatività che deriva una determinata connotazione della
relazione intergenerazionale e degli obblighi che da questa ne discendono, secondo
10
Cfr. H. Jonas, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica , Einaudi, Torino 1990,
in part. cap. 4.
11
Cfr. E. Agius, The Rights of Future Generations. In Search of an Intergenerational Ethical
Theory , Catholic University of Leuven, Leuven 1986.
12
Cfr. H.P. Visser ‘t Hooft, Justice to Future Generations and the Environment, Kluwer, Dordrecht
1999.
�279
Problemi aperti di giustizia intergenerazionale: risposte ai miei critici
la prospettiva di un’etica dell’alterità è invece soltanto dall’appello dell’alterità futura
alla responsabilità che può derivare la possibilità stessa di una configurazione
generativa. Questa sorta d’inversione “fondativa” non è affatto soltanto speculativa,
ma detiene un precipitato straordinariamente concreto: infatti, così come, a livello
intragenerazionale, per una visione fenomenologica, non è la definizione dell’essererelazionale del soggetto a implicare responsabilità nella relazione, ma, al contrario, è
unicamente l’appello stesso alla responsabilità sempre a-topico, diacronico e
incondizionato dell’altro a costituire il soggetto medesimo e ad articolarne la
configurazione relazionale, allo stesso modo, anche a livello intergenerazionale,
sempre per una visione fenomenologica, non può essere la condizione ontologicogenerativa a definire la connotazione, il portato e l’estensione dell’obbligo morale,
ma è esclusivamente l’appellatività stessa dell’altro (dal) futuro a ingenerare, di volta
in volta, il modo in cui la configurazione generativa dei soggetti intertemporalmente
relati deve articolarsi. In altri termini, il carattere estremamente concreto di questa
differenza si condensa nel fatto che, mentre dal lato di una generatività
ontologicamente connotata e naturalmente preordinata, il massimo dell’obbligo e il
massimo della generosità intergenerazionali vengono a coincidere nel motto “la
facoltà di generare ci obbliga a farlo”, dal lato di una fenomenologia dell’alterità
futura interpellante, invece, è solo l’obbligo alla responsabilità proveniente dall’altro
futuro, che ci interpella, a fornirci la (dis-)misura stessa della nostra “capacità”
generativa, cosicché “chi”, “quanto” e “se in generale” generare si rivela questione
mai definita una volta per tutta. In linea con questa prospettiva, il massimo
dell’obbligo di generatività potrebbe addirittura venire a coincidere con il massimo
di una generosità contro-natura – per dirla restando nella semantica di Illiceto – che
si trattiene dal generare 13 e che decide contestualmente di concedere più spazio –
sempre secondo una relazione decisa dall’appellatività etica – ad alterità altre: come,
ad esempio, a quella di soggetti non-umani.
In fin dei conti, la grande risorsa che detiene un’etica intergenerazionale che non
si pensa a partire dall’ontologia, ma dall’appellatività, potrebbe essere proprio quella
di dare espressione a riconsiderazioni radicali circa i profili della relazionalità stessa.
Essa potrebbe aiutarci, insomma, non solo a ridefinire la relazione con gli altri del
futuro, ma anche a riconfigurare le tipologie d’alterità che la devono popolare. Per
dirla con un momento di chiara ispirazione lévinassiana, in termini
intergenerazionali, l’altrimenti che essere potrebbe non escludere una sua estensione
in un altrimenti che umano.
13
Per questi temi si vedano le belle pagine di M. Fritsch, “Between Intergenerational Presentism
and Reproductive Futurism: How to Be Concerned About the Future of Children Without Becoming
Repressively Heteronormative”, in F. Ciaramelli, F.G. Menga (a cura di), Responsabilità verso le
generazioni future, cit., pp. 65-87.
�280
F ERD IN ANDO G. M EN GA
2. LA DEFORMALIZZAZIONE ETICA DEL TEMPO COME SNODO
FONDAMENTALE PER UNA RICONFIGURAZIONE FENOMENOLOGICA
DELLA GIUSTIZIA INTERGENERAZIONALE
Sul ripensamento fenomenologico radicale del tema della generatività ruota anche
l’intervento di Mario Vergani, il quale, a partire dalla condivisione della mia critica
rispetto agli impianti presentistici e continuistici delle teorie mainstream sulla
responsabilità verso le generazioni future, va alla ricerca di un luogo esperienzialeconcreto in cui le generazioni mostrino la loro genuina struttura intergenerazionale.
È in questo luogo che Vergani, cercando di divincolarsi anch’egli da un’impostazione
di stampo logico-ontologico, cerca l’articolazione di una deformalizzazione della
temporalità futura tale per cui, citando Lévinas, viene ad emergere l’esigenza di “non
definire l’altro per mezzo dell’avvenire, ma l’avvenire per mezzo dell’altro” 14.
Come si nota, qui, alla stessa stregua di quanto ho cercato di evidenziare nelle
pagine precedenti, diventa decisiva una ridefinizione etica dell’articolazione
intergenerazionale della relazione. Solo che, per Vergani, una ridefinizione del
genere, proprio per sottrarsi all’abbaglio logico-ontologico di un mero relazionarsi
all’altro e per restare genuinamente fenomenologica, deve registrarsi nella carne viva
della generatività generazionale. Deve cioè rivelarsi come alterità vissuta che
rimanda intrinsecamente al carattere intergenerazionale. Vergani colloca un tale
vissuto proprio nel luogo in cui ogni generazione esperisce la rottura interna che fa
segno verso il suo essere in relazione con le altre generazioni: l’“inter”
dell’intergenerazionalità, che separando e unendo la generazione di volta in volta
presente al suo altro (passato e futuro) segna il locus o l’articolazione pulsante della
generatività – articolazione che segnala il fatto che ogni presenza generazionale è
aperta e dunque inter-relata perché incompiuta e costitutivamente chiamata dall’altro
nei termini di un appello alla giustizia. Mi pare sia questo il plesso di senso trasmesso
da Vergani nel momento in cui ci avverte di questo:
[N]on solo un’interpellazione che viene dal futuro, perché se futuro e passato
restassero ognuno al suo posto e separati dalla linea del tempo, se non si trattasse
che di pensare ad un appello che proviene dal futuro in analogia con quello che
riceviamo dal passato, allora forse questa descrizione non sarebbe sufficiente a
deformalizzare il tempo, se questo futuro non fosse anche anteriore a noi
(“Questo futuro secondario, che in fin dei conti è quello davvero primario, si
ubica contemporaneamente davanti a noi e dietro di noi” [citazione da: B.
Waldenfels, Ortsverschiebungen, Zeitverschiebungen. Modi leibhaftiger
Erfahrung, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2009, p. 198). In questo senso si può anche
accettare la tesi del primato dell’altro – che sopra abbiamo descritto come
ambigua e scivolosa –, alterità dell’altro esattamente da pensarsi come il fatto
14
Citato da Vergani: E. Lévinas, Il Tempo e l’Altro, il Melangolo, Genova 1987, p. 53.
�281
Problemi aperti di giustizia intergenerazionale: risposte ai miei critici
che sta davanti a noi, viene prima ed è al tempo stesso da-farsi, e questo a
condizione che il presente sia diviso e incompiuto, ovvero che in esso si esprima
un appello di giustizia.
La preoccupazione fenomenologica che, così, Vergani mette in campo ha una
portata radicale e, come una sorta di colpo di coda sulla mia presa di distanza
rispetto al discorso di Illiceto, pone nei confronti del mio stesso approccio una critica
assai simile sebbene spostata di segno. Egli avverte, infatti, che, una volta smarcatisi
dall’astrattezza logico-ontologica della relazione, bisogna stare bene attenti a non
ricadere vittime, sotto il profilo etico, di un’astrazione equiparabile che finisce per
professare un troppo generale primato dell’altro futuro. Diventa necessario, per
questo, secondo Vergani, intendersi bene su cosa significhi “primato dell’altro” e,
soprattutto, su come questo primato dell’altro futuro si declini. Di qui, il suo sospetto
nei confronti del mio discorso è che esso rischi di adagiarsi troppo rapidamente nella
comfort zone di una retorica dell’alterità di tipo prescrittivo che, però, difficilmente
trova riscontro nell’esperienza effettiva del vissuto generazionale. Di contro, la sua
prospettiva – come sopra già anticipato – esige che un tale primato, per rivelarsi in
modo fenomenologicamente genuino e radicale, debba registrarsi come appello
dentro il tessuto vivente del presente. Nello specifico, come presente che, “diviso e
incompiuto”, percepisce generativamente la sua incompiutezza come “un appello di
giustizia”. Ancora più concretamente, per Vergani, si tratta di tenere fermo un
primato dell’alterità futura sempre all’interno dell’inter- che articola di volta in volta
il rapporto intergenerativo, cosicché si lasci “spazio […] per un pensiero delle nascite,
delle morti, delle generazioni […] [p]er pensare il tra-noi del tempo infinito del
generare delle generazioni”.
Insomma, il richiamo fenomenologico di Vergani nei confronti del mio approccio,
volendolo tradurre nei termini di un luogo classico della teologia contemporanea –
per nulla estrinseco alla natura del problema qui affrontato –, quasi mi parrebbe
essere equiparabile a quanto una escatologia presentica potrebbe rimproverare ad
una escatologia futurica 15: il rapporto futurico incide già ora nel presente e qui si
articola senza doversi vivere proiettato nell’attesa di un di là da venire che svuota di
15
Non posso qui riprendere questo tema di matrice teologica per ovvie ragioni di economia
tematica e di spazio. Ritengo, tuttavia, che il discorso di una riformulazione e riconcettualizzazione
dell’esperienza futurica e, generalmente, temporale in termini etici molto avrebbe da apprendere da un
confronto, per lo meno, con le posizioni teologiche di Bonhoeffer (D. Bonhoeffer, “Le cose ultime e
penultime”, in Id., Etica , Queriniana, Brescia 1995, pp. 120-143), Bultmann (R. Bultmann, Storia ed
escatologia, Queriniana, Brescia 1989), Moltmann (J. Moltmann, Il futuro della creazione, Queriniana,
Brescia 1980), Rahner (K. Rahner, “Principi teologici dell’ermeneutica di asserzioni escatologiche”, in
Id., Saggi sui sacramenti e sulla escatologia , Edizioni San Paolo, Roma 1969, pp. 399-440) e Balthasar
(H.U. von Balthasar, Teodrammatica , V: “L’ultimo atto”, Jaca Book, Milano 1985). Per un magistrale
affresco su questi problemi, che ne mette in risalto anche la caratura filosofico-ermeneutica, si veda A.
Nitrola, Trattato di escatologia , 1: Spunti per un pensare escatologico, Edizioni San Paolo, Cinisello
Balsamo 2001.
�282
F ERD IN ANDO G. M EN GA
pregnanza il presente stesso (e che, notoriamente, in termini teologico-cristologici,
compone lo spinoso tema di un ritardo della parousia).
La preoccupazione fenomenologica di Vergani è assolutamente condivisibile e il
suo sospetto o richiamo alla cautela rispetto al mio discorso è pienamente
giustificato. Probabilmente, nella mia calibratura concettuale sul tema della futurità
etica, avrei dovuto stare più attento a non espormi troppo facilmente ad una sorta di
scivolamento messianico (per quanto mi renda conto qui che di messianismo ce n’è
ben più d’uno). Ma, pur intravedendo questo rischio e incassando perciò la critica di
Vergani con la promessa di revisioni future sul punto, mi preme nondimeno insistere
ulteriormente almeno su un paio di motivi che muovono al fondo del mio gesto
teorico.
In primo luogo, se, in ambito di dibattito sulla giustizia intergenerazionale, insisto
così tanto sulla dimensione dell’alterità futurica è perché ciò mi sembra inevitabile al
fine di ovviare all’errore che, a mio avviso, molte mainstream theories perpetrano,
ovvero ridurre la portata della futurità generazionale a un rapporto di mera
concatenazione relazionale con le generazioni più prossime. Ma, come ho cercato di
mostrare nel libro, sperando di esserci riuscito, la questione non può essere davvero
affrontata in modo adeguato attraverso lo stratagemma dell’overlapping fra le
generazioni, poiché il tenore problematico che ne deriva verrebbe impropriamente
ridotto a quello di una responsabilità vicaria comunque riconducibile alla semantica
del presente e alla preoccupazione concentrata soltanto sui futuri più vicini. La
risposta al problema di una responsabilità per i futuri, che deve invece indirizzarsi
anche ai futuri più remoti, ha perciò bisogno di svincolarsi in modo deciso dalla
“tirannia dei contemporanei”, per dirla con Stephen Gardiner 16. E, mi sembra, che
l’inclinazione di Vergani a concentrarsi in modo così preponderante sulla dinamica
del generare insito nel luogo dell’inter- del rapporto intergenerazionale, per lo meno,
corra il rischio di scivolare in una preoccupazione preponderante per le prossimità e
aderenze generative e generazionali, più che per la lunga gittata etica intrinseca alla
questione stessa. Di qui, la mia insistenza sulla dimensione, per così dire,
maggiormente futurica.
Ma c’è anche un secondo motivo alla base della mia insistenza futurica: se si resta
troppo concentrati su una connotazione del rapporto intergenerazionale in termini
strettamente inter-generazionali, si rischia, a mio modo di vedere, di fornire
indirettamente già uno spazio di determinazione dei rapporti, perdendo così la
grande vera opportunità di deformalizzazione etica della temporalità, che può
derivare soltanto nella misura in cui si accoglie il futuro a partire dalla sua mai
completa determinazione. La deformalizzazione etica deriva, infatti, solo dalla
risposta di volta in volta ingenerata dall’appello stesso dell’alterità futura alla
responsabilità mai precedentemente inscrivibile. Come a dire: è il cadere del futuro
16
S. Gardiner, A Perfect Moral Storm. The Ethical Tragedy of Climate Change, Oxford University
Press 2011, p. 36.
�283
Problemi aperti di giustizia intergenerazionale: risposte ai miei critici
nella risposta di volta in volta comandata a generare la misura e l’estensione del
rapporto generativo e inter-generazionale del fra-noi e non il contrario. Mentre, se
vincoliamo una tale misura all’esigenza del suo riscontro nell’alveo di una interrelazione in qualche modo presente – come quella richiesta dall’esigenza
fenomenologico-descrittiva di Vergani –, mi pare si corra proprio il rischio di
condizionarla e riformalizzarla. È per questo motivo che la mia prospettiva cerca
esattamente di liberare il futuro, in modo tale che sia il suo stesso incidere etico a
ingiungere risposte, generando così l’estensione stessa dell’inter- dei rapporti
intergenerazionali.
La ricaduta pratica di questo approccio è riscontrabile nel discorso assolutamente
filosofico-pratico di uno studioso come Stephen Gardiner, il quale intende
divincolarsi dalle strettoie definitorie di ciò che deve valere come “generazione”
proprio attraverso ciò che di volta in volta l’esigenza etica viene a dettare. Per cui,
secondo la sua visione, il rapporto d’obbligazione intergenerazionale non deve
partire da estensioni generazionali già prefissate, ma al contrario, è l’estensione stessa
di una generazione e il portato temporale dei suoi rapporti (inter-generativi) a doversi
definire in base alle ingiunzioni etiche a cui essa si trova a rispondere, componendosi
così in quanto tale 17. Come qui si intuisce, a differenza di quanto sostiene Vergani,
emerge proprio la necessità di una futurità di carattere prescrittivo che diviene
istanza centrale per il piano descrittivo.
Ciò che mi preme, infine, sottolineare dell’intervento di Vergani è la terza
importante domanda rivolta al mio discorso: come pensare una proiezione etica
verso il futuro che all’ingiunzione di questo risponde nei termini di un futuro
anteriore? Lo sviluppo di questa domanda da parte di Vergani mi sembra rilevante
poiché, nell’intravedere i rischi connessi ad una pratica etica proiettiva che finisce per
presentarsi il futuro imbrigliandolo, mette in campo una riflessione che, in fondo,
apre esattamente nella direzione sopra criticata dallo stesso autore, ovvero quella di
preservare il futuro nella sua futurica indeterminatezza. Così nelle sue parole:
La domanda che in questo caso è inevitabile porre verterà su un punto solo al
quale tutte le diverse formulazioni sopra riportate riconducono: quando
introduciamo questi termini (trasgressione estatica, estensione della fantasia
morale, proiezione immaginativa) non abbiamo già ricomposto il tempo, anziché
deformalizzarlo e non siamo già tornati ad una prospettiva proiettiva, riguardo al
17
Cfr. ivi, p. 147. Peraltro, sono convinto che precisamente da questo lato della questione, così come
si può rispondere alla domanda di definizione generazionale a partire dall’incidenza etica del futuro, si
possa rispondere anche all’importante domanda posta da Ulderico Pomarici: “può esistere e avere
senso per noi qualcosa come la dignità dell’umanità futura?” (U. Pomarici, “Verso nuove forme
dell’identità? Generazioni future e dignità umana”, in F. Ciaramelli, F.G. Menga (a cura di),
Responsabilità verso le generazioni future, cit., p. 92). La risposta risulta qui esattamente da
un’operazione di capovolgimento: non già è la dignità un’istanza ontologicamente determinata da
applicare anche in termini intertemporali, bensì essa si misura proprio attraverso l’incidenza
eticamente connotata della futurità.
�284
F ERD IN ANDO G. M EN GA
futuro, quando invece la questione è che il tempo ci proviene dall’altro e non è
quello che noi dobbiamo immaginare per l’altro a rischio di espropriarglielo?
Com’è evidente, il tema del “futuro anteriore” rinvia esattamente a questa idea
di assenza di un orizzonte di prevedibilità della futurizzazione radicale. […] In un
certo senso il futuro anteriore toglie il presente, perché esso non sta – e dunque
non è stato né sarà –, ma sarà stato, insieme qui e non ancora: già qui perché
sempre passato (passato irriducibile a un presente-passato, mai stato presente e
dunque mai sintetizzabile), ma non ancora perché sempre a venire,
incompatibile con ogni orizzonte che ne prefiguri l’attesa. Di fatto implica la
ripetizione – sarà stato – ma la singolarità di questa ripetizione è che è la
ripetizione di ciò che non ha mai avuto luogo, di un passato che si dà solo nel
futuro, che apre all’idea di una venuta senza che nulla lo preceda. E tuttavia è
anche ripetizione: come pensare la ripetizione senza che abbia mai avuto luogo
ciò che si ripete se non attraverso il paradosso irriducibile dell’iterazione
dell’irripetibile: l’esperienza dell’unicità dell’umano, ogni volta unica e tuttavia
plurale, generazioni di generazioni?
Rispetto a questa riflessione di Vergani non mi interessa tanto organizzare una
strategia di difesa – sottolineando, per esempio, come la proiezione immaginativa che
ho in mente non ha carattere impositivo, ma, in quanto responsiva, è già sempre
ingiunta eticamente dall’appellatività del futuro stesso –, quanto piuttosto mi preme
evidenziare come proprio una tale riflessione, per una sorta di movimento di autodecostruzione, metta in campo nel discorso stesso di questo autore un primato etico
del futuro refrattario ad ogni anticipazione (e inserimento nell’immediata
interconnessione generazionale). Per dirla con le sue parole, si tratta dell’“assenza di
un orizzonte di prevedibilità della futurizzazione radicale”; dell’“incompatibil[ità]
con ogni orizzonte che ne prefiguri l’attesa”.
Mi piace perciò pensare che con Vergani potremmo incontrarci almeno sul
seguente punto, ossia sul fatto che questo “orizzonte assente” non può che mettere in
scacco l’esercizio di una fenomenologia di carattere puramente descrittivo, aprendo
invece – lévinassianamente – a qualcosa di registrabile solo a-topicamente e che, per
ciò stesso, “sconvolge” eticamente l’approccio fenomenologico, addentrandolo nel
regno dell’“epifania” dell’altro 18.
D’altronde, nel suo raffinato intervento di commento al mio libro, Gabriella
Baptist si concentra proprio sulla connotazione a-topica dell’ingiunzione dell’altro
futuro, mettendone in evidenza l’irriducibile declinazione diacronica sottraentesi a
qualsivoglia riduzione fenomenologica. E qui il movimento di smarcamento che
l’autrice indica è esattamente quello di restare sì nella fenomenologia, ma
18
Cfr. E. Lévinas, “Enigma e fenomeno”, in Id., Scoprire l’esistenza con Husserl e Heidegger,
Cortina, Milano 1998, pp. 235-251.
�285
Problemi aperti di giustizia intergenerazionale: risposte ai miei critici
posizionandosi lungo il suo versante eccentrico, lontano sia dal trascendentalismo
husserliano che da quello ontologico-esistenziale di Heidegger 19.
Allo stesso tempo, però, focalizzando l’attenzione sull’importanza che il motivo
waldenfelsiano dell’Anderwann (“altroquando”) gioca per l’economia del mio
discorso, la Baptist si e mi interroga, in modo diretto e frontale, sulla portata teorica
radicale che ne può derivare per un’etica intergenerazionale. Introduce il suo
interrogativo, innanzitutto, attraverso una sorta di collocazione del mio approccio in
un’area di famiglia:
Ma che cos’è l’‘altroquando’ che Bernhard Waldenfels affianca all’‘altrove’ […]? Certo
non un tempo pianificabile da un soggetto onnipresente anche là dove non può più stare
o non può ancora essere, piuttosto un tempo caratterizzato dalla non sincronicità,
neanche quella dell’associazione immaginativa o della costruzione intuitiva, un tempo
controtempo, intempestivo e inattuale. Per variare il celebre titolo levinasiano:
Altrimenti che tempo? Come siamo, se siamo, in questo tempo che non fugge
semplicemente né incalza dietro le nostre spalle o ci rende ancora più vulnerabili
invecchiandoci, e che non è neanche solo messo intanto nella parentesi artistica e
letteraria del ‘come se’, dove ancora si rapporta all’intemporale, all’imperscrutabile e
all’immemoriale? Un tempo che mescola i tempi e i riferimenti come avviene nel futuro
anteriore cui rimanda spesso anche Jacques Derrida? Si tratta di un tempo che non si
conta come il tempo della physis, né si aspetta come il tempo della psyche, ma dal quale
si è invasi e addirittura sopraffatti nel patire l’urgenza di un ‘non c’è più altro tempo che
resta’.
Sono, questi, tutti luoghi che nel mio libro indago o, per lo meno, tocco. Ed è
proprio da qui che l’interrogare della Baptist, però, (mi) incalza:
Ci si potrà chiedere se la fondazione che Ferdinando Menga addita
nell’orientamento impossibile e non pianificabile a un futuro che non solo
incalza, ma che sorprende e spiazza, non si configuri come una sorta di nuovo
messianismo etico, senza profezia di salvezza e senza attesa di redenzione, senza
speranza di ricomposizione delle sconfitte, di emancipazione dalle condanne e
dalle catastrofi: nessun disvelamento, nessun approdo, ma un altro tempo alla
fine di ogni egocrazia autocentrata nella sua ‘topica’ e nella sua ‘cronica’, un
tempo inquieto dello scacco che fa impazzire ogni ordine incardinato nel qui e
ora, un tempo eccedente ancora da pensare nel risvolto etico del suo non essere
in alcun modo disponibile e afferrabile, un tempo che manca e che solo nel suo
sottrarsi resta, fondamento paradossale e necessariamente assente di un’etica
della responsabilità per quell’altro e quegli altri irrappresentabili che sono
l’avvenire e le generazioni future.
19
Con questo non voglio però dare ad intendere che Vergani, nel suo saggio, ometterebbe di
indicare nella medesima direzione. Anzi, lo fa esplicitamente. Ed è grazie a questo che la mia risposta
ad alcuni suoi passaggi ha la pretesa di inscriversi come momenti auto-decostruttivi e non di semplice
ed esteriore critica al suo impianto.
�286
F ERD IN ANDO G. M EN GA
Questo Mitdenken col – ovvero pensare assieme al – mio discorso, che la Baptist
così egregiamente espone e condensa nell’appena riportata parte finale del suo
intervento, mi consegna per lo meno un paio di motivi di riflessione. In primo luogo,
mi impone l’interrogazione sul rapporto che il mio approccio eventualmente intesse
con un messianismo di stampo etico. Qui, come peraltro l’autrice ben intuisce, di
legame si può – e, forse, si deve – senz’altro parlare, ma a condizione che lo si
interpreti nei termini di un messianismo “senza attesa di redenzione”. Connotazione,
questa, che, a mio avviso, si rivela fondamentale, poiché discende direttamente dal
fatto che l’appello dell’alterità futura, così come io lo penso, proprio perché
intrinsecamente a-topico e anacronistico, non può che sottrarsi ad ogni sua
collocazione o disponibilità lungo l’asse di una storia che raccoglie e dispone, magari
in termini dialettici. Già Benjamin indicava chiaramente in tale direzione,
allorquando inseriva il suo pensiero “messianico” nell’orizzonte di una “rottura” col
tempo “omogene[o]” e “continuità della storia” 20. Ma, per avvicinarmi maggiormente
ad un pensiero di marca prettamente fenomenologica, mi piace inserire un tale
messianismo etico di rottura e non di compimento ancor più segnatamente entro i
binari di un esercizio d’epoché, come se, appunto, l’appello dell’altro futuro che
rompe e proietta responsivamente-responsabilmente in termini intergenerazionali
altro non ingenerasse che una sorta di messa tra parentesi etico-critica rispetto alla
tirannia del presente. È per questo motivo che, lungo il solco di un illuminante
quanto criptico passaggio di Lévinas, per trasmettere il senso di un’interruzione e
sottrazione temporale di stampo etico, la figura messianica può essere accostata da
un’altra di matrice ebraica. Figura di sospensione temporale che Lévinas indica con
una quasi disarmante equivalenza: “Reduction = [ תבשshabbat]” 21. Ecco, dunque,
emergere una chiave di lettura fondamentale per il mio discorso: l’appello
intergenerazionale esercita una sospensione e riduzione del tempo, una rottura del
presente, non per essere poi reintegrato in esso, ma affinché quest’ultimo si scopra
sempre responsabilmente infiltrato dal futuro e si pensi genuinamente a partire da
questo.
E ciò mi porta direttamente nell’alveo della seconda riflessione: se l’appello
futurico alla responsabilità detiene un “risvolto etico” nel suo “non essere in alcun
modo disponibile e afferrabile”, nel suo essere “un tempo che manca e che solo nel
suo sottrarsi resta, fondamento paradossale e necessariamente assente di un’etica
della responsabilità per quell’altro e quegli altri irrappresentabili che sono l’avvenire
e le generazioni future”, ciò non deve suggerire una sospensione o riduzione totale
delle pratiche immaginative o proiettive, come se appunto alle pratiche del presente e
delle istituzioni presenti non restasse altro che prendersi un anno sabbatico totale,
20
W. Benjamin, Passagenwerk, in Id., Gesammelte Schriften, V.1, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1991,
pp. 587 [N 7, 7], 592 s. [N 9 a, 6] e 608 [N 18, 3].
21
E. Lévinas, Carnets de captivité et autres inédits, Grasset & Fasquelle, IMEC Editeur, Paris 2009,
<p. 30>.
�287
Problemi aperti di giustizia intergenerazionale: risposte ai miei critici
arrendendosi così di fronte all’incatturabilità e incontenibilità etica del futuro. Al
contrario, ciò implica esattamente lo sforzo opposto di una continua riconfigurazione
immaginativa. Solo che però, ora, questa cambia di segno: cioè non riduce più la
portata problematica intergenerazionale a quanto le categorie del presentismo
riescono a contenere di essa, ma invece giunge a farsi carico, se necessario, di una
vera e propria rivoluzione categoriale.
È in questo orizzonte che, accanto all’interrogazione etico-filosofica, la questione
intergenerazionale chiama in causa anche una profonda riflessione di matrice
filosofico-politica e filosofico-giuridica, nonché di carattere operazionale nei termini
dell’immaginazione di possibili nuovi scenari, pratiche e procedure istituzionali 22.
3. LA IM/POSSIBILE RESPONSABILITÀ GIURIDICA VERSO LE
GENERAZIONI FUTURE
Ma, prima di addentrarci nel dominio delle pratiche politiche e giuridiche, per
scandagliarne magari le possibili nuove traiettorie – sempre che di nuove traiettorie
si tratti –, che la questione intergenerazionale impone, è forse prudente restarne sulla
linea di confine per interrogarne la praticabilità fondamentale. Questo mi sembra
essere, in ultima analisi, l’approccio di fondo suggerito da Tommaso Gazzolo, il
quale, collocandosi ai margini del mio discorso, in qualche modo, seppure
indirettamente, lo erode decostruttivamente.
Pur correndo il rischio di qualche semplificazione di troppo nei confronti del ricco
e articolato saggio di Gazzolo, scelgo di confrontarmici raccogliendolo attorno ad
uno stile ermeneutico, che lo ispira, e a un doppio piano di considerazioni
fondamentali, che esso solleva in progressione argomentativa.
Lo stile – come peraltro poc’anzi segnalato – mi sembra essere quello di una
pratica decostruttiva di stampo derridiano, pratica che notoriamente si impegna a
delimitare il tenore e la misura di possibilità dei vari fenomeni che di volta in volta
scandaglia a partire da un margine – sempre sintomatico e mai artatamente
costituito – dell’illimite e di dismisura dell’impossibile. Per l’ambito di un possibile
discorso sulla responsabilità giuridica di carattere intergenerazionale, un tale
approccio, per Gazzolo, implica – in compagnia di Derrida, ma non solo, anche di
Anders – lanciargli al cuore una bomba. Più precisamente, prospettargli all’interno
l’im/possibile evento dello sgancio della bomba atomica tale da misurarne la
im/possibile tenuta concettuale relativa alla responsabilità che si tratta di pensare. È
attraverso questo gesto che Gazzolo intende raccogliere il senso di “scandalo” di una
responsabilità intergenerazionale ispezionato nel mio libro, impegnandosi a
22
In tale direzione non posso non segnalare lo sforzo recente di re-immaginazione istituzionale in
ambito intergenerazionale raccolto nel volume: I. González-Ricoy, A. Gosseries (eds.), Institutions for
Future Generations, Oxford University Press, Oxford 2016.
�288
F ERD IN ANDO G. M EN GA
rilanciarlo in modo iperbolico. Ma, diciamocelo pure, a decostruirlo alla radice. Ma
su questo dirò qualcosa più avanti.
In prima battuta, è bene richiamare la consistenza stessa dello scandalo che la
bomba atomica rappresenta per una pensabilità della responsabilità
intergenerazionale: lo sgancio della bomba sarebbe l’atto criminale nei confronti del
quale essere massimamente responsabili in termini intergenerazionali, in quanto ne
va del destino stesso del genere umano, ma il cui compimento – la cui attuazione –,
comportando esattamente la sparizione totale dell’umano, segnerebbe
paradossalmente l’obliterazione stessa di ogni crimine e responsabilità, giacché
implicherebbe l’impossibilità di ogni imputazione e testimonialità retrospettiva. Per
dirla con le efficaci parole di Gazzolo: “poiché dopo il suo compimento non ci
sarebbe alcuno a poterlo giudicare, a testimoniare per esso: non sarebbe, a rigore,
neppure un crimine, pertanto. Nel momento stesso in cui è divenuto possibile
compiere un simile atto, un atto che escluda a priori la possibilità di chiederne conto,
di risponderne, la stessa nozione di responsabilità rischia di perdere ogni significato”.
In tal modo, la bomba mostra il limite estremo e decostruttivo della
possibile/impossibile responsabilità verso il futuro e i futuri: da un lato, la bomba
disegna il perimetro massimo di una responsabilità intergenerazionale, derivazione
intrinseca del potere più compiuto della tecnica nell’epoca del suo più avanzato
sviluppo, ma dall’altro ne dissolve la pensabilità stessa, disinnescandone i più basilari
dispositivi morali e giuridici (di imputabilità).
Questo gesto estremo di cui si fa coraggiosamente carico la riflessione filosoficogiuridica di Gazzolo si articola – come prima anticipato – in un doppio ordine di
considerazioni intrecciate, che vale la pena ripercorrere nel suo spettro di importanti
conseguenze.
Il primo punto che l’autore mette in rilievo, in sintesi, è il seguente: l’eventualità
della bomba atomica, per quanto “ipotesi limite” in seno ad un discorso giuridico
sulla responsabilità intergenerazionale, non troppo velocemente deve essere dismessa
in quanto appunto estrema e, quindi, in fin dei conti, tale da non intaccare davvero i
dispositivi del diritto in regime di normalità. Gazzolo ci avverte, piuttosto, del
contrario: è proprio l’impossibile evento della bomba che deve essere trattenuto ed
approfondito, poiché da esso soltanto il diritto può trarre le conseguenze per il suo
esercizio in regime di normale gestione di obblighi intergenerazionali. Cosa ha,
dunque, da insegnare la bomba al diritto? Quanto segue: che quest’ultimo, a rigore,
non può prendersi carico di una determinata realizzazione di futuro, giacché davanti
alla realizzazione estrema di esso, di cui la bomba dà la cifra, si dissolve ogni
possibile responsabilità. Il compito di responsabilità, di cui il diritto può/deve farsi
carico – e che esso apprende sulla base dell’eventualità impossibile della bomba
atomica – è bensì quello di impegnarsi a rendere possibile il futuro per mantenere
aperta in esso la possibilità stessa della responsabilità. Con Gazzolo, si tratta, perciò,
di una “pratica giuridica […] [di] responsabilità che sia sempre possibile e che si
�289
Problemi aperti di giustizia intergenerazionale: risposte ai miei critici
mantenga come tale – e non una responsabilità che consista nel fare rispondere il
soggetto per ciò che avrà fatto. Non risponderai mai, ma devi sempre poter
rispondere – ed è di questo che rispondi”.
Questo slittamento da un’opzione di responsabilità di tipo materiale (agisci
responsabilmente affinché si realizzi un determinato futuro migliore o comunque
non peggiore del presente) ad una di tipo, per così dire, formale (agisci
responsabilmente in modo che sia mantenuta in piedi la possibilità stessa di futuro)
conduce immediatamente al secondo ordine di considerazioni sopra annunciato.
Piano, questo, per me di rilevanza fondamentale, non solo perché in esso si
dischiude, nel solco di quanto Gazzolo intende trasmettere, un necessario
riorientamento del diritto nei confronti della sua più consueta configurazione
moderna, ma anche perché è proprio in esso che si articola quel momento da me
sopra richiamato di apparente rafforzamento del mio discorso al prezzo, però, di una
sua effettiva e più profonda decostruzione.
Il riorientamento che Gazzolo esplicita si consuma nel fatto che un diritto
intergenerazionale che si impegna non più a determinare il futuro, ma solo sul
versante di rendere possibile l’a-venire delle generazioni, non può che essere “esposto
ad una trasformazione” radicale: quella di mettere in discussione la sua dimensione
di progettualità e di progresso. Si viene a connotare, con ciò, per utilizzare di nuovo
le parole di Gazzolo, “un diritto che non si f[a] più ‘in vista’ del futuro (guardando
cioè ad esso, rendendolo visibile e progettabile), bensì che p[uò] esporsi al
sopraggiungere di un avvenire il cui senso deve restare indeterminato e
imprevedibile”. Insomma, un diritto che non si pensa più “a partire dalla sua pretesa
di progresso (dal suo disporre-per l’avvenire)”, ma che “determin[andosi] a partire
dalle generazioni future – dalla responsabilità cui esse ci impegnano – […] si espon[e]
alla possibilità che le generazioni future giungano al di là da ogni anticipazione che
avremmo potuto averne, da ogni nostra ‘fondazione’”.
L’idea di responsabilità intergenerazionale che sulla base di questo riorientamento
subisce anch’essa una traslazione – come Gazzolo non manca di sottolineare – è
esattamente quella “retrospettiva”, ma anche “proiettiva”: se la pratica morale e
anche giuridica, in effetti, indietreggiano di fronte alla dinamica di determinazione
del futuro, impegnandosi soltanto a che questo av-venga, non si può che prendere
congedo allora dall’idea di “una responsabilità per ciò che è stato compiuto, per
qualcosa che è stato (di cui saremo chiamati a rispondere nei confronti delle
generazioni future). Di una responsabilità, cioè, di cui potremmo essere chiamati a
rispondere solo in futuro, ma per ciò che abbiamo compiuto nel passato”.
Mai orientamento pare poter essere più vicino alla mia impostazione di aperta
critica nei confronti della tendenza presentistica in ambito di giustizia
intergenerazionale che questo propugnato da Gazzolo! Quest’ultimo, peraltro, non
manca di sottolinearlo, nel momento in cui fa confluire la sua impostazione in una
pratica del
�290
F ERD IN ANDO G. M EN GA
diritto che, anziché progettarsi in vista del futuro (di quel determinato futuro che esso
assume, in ogni decisione giuridica, come migliore), si determin[a] proprio a partire
dall’idea che un futuro è tale solo se può non essere così come lo prevediamo. Il diritto
dovrebbe, da questo punto di vista, costituirsi come pratica orientata a rendere possibile
sempre più d’un futuro 23 .
È indubbio: su questo piano di critica ad ogni forma di presentismo etico e
giuridico, il discorso di Gazzolo tocca il punto di massima tangenza con il mio.
Nondimeno esso nasconde, però, al proprio interno un poderoso dispositivo teorico
che lo conduce a contrastare con alcune opzioni di fondo del mio approccio che, a
questo punto, è bene rimarcare.
In primo luogo, l’esperienza impossibile o limite sulla quale il discorso di Gazzolo
si impegna a squadernare le impostazioni consuete sulla responsabilità
intergenerazionale sembra obbedire ancora ad una logica lineare del tempo e dello
spazio, tale per cui la trascendenza impresentabile e non-colonizzabile del futuro, a
cui egli tende, si rivela, in fin dei conti, nei termini di u-topia e u-cronia. Dalla cui
cosa ne discende immediatamente, per Gazzolo, la necessità di riservare a questo
luogo altro e trascendente uno spazio di pura indeterminatezza non intaccato da
determinazioni presenti. Probabilmente è l’inserimento stesso dell’intera questione,
lungo il solco di Derrida, entro il binario del possibile/impossibile a costringere lo
svolgimento del tema entro una logica simile. Dalla mia prospettiva, invece, si tratta
di pensare la questione piuttosto nei termini di a-topia e a-cronia: vale a dire, di un
luogo altro e un tempo altro che segnano una trascendenza la quale si sottrae sì alla
presa del presente, ma nel mentre però si registra nella sua carne proprio attraverso
tale sottrazione 24.
Di qui due domande: quale può mai essere l’articolazione che permette un tale
registrarsi sottraentesi? Quale ne è, inoltre, il guadagno? L’articolazione in gioco è
proprio quella che non obbedisce alla dialettica lineare dell’impossibile che si nega al
possibile, così trascendendosi. È invece l’articolazione etica dell’appello dell’altro che,
come Lévinas insegna, è un registrarsi della trascendenza nel mondo nel mentre da
esso si sottrae e ciò al di là del possibile e dell’impossibile. Il guadagno di mettere in
gioco una tale articolazione consiste nel fatto di offrire alla dimensione della
responsabilità intergenerazionale immancabilmente percepita nello spazio della
23
In tale sua opzione teorica, Gazzolo mi sembra approssimarsi molto alla prospettiva di Brian
Barry di “rispettare la creatività delle persone del futuro”, il che comporta il fondamentale “requisito
[…] di fornire alle future generazioni le opportunità di vivere vite buone in base alla loro concezione di
ciò che costituisce una vita buona. Questo include certamente la possibilità che essi conducano una vita
buona secondo la nostra concezione; ma deve lasciare loro aperte anche altre opzioni” (B. Barry,
“Sustainability and Intergenerational Justice”, in A. Light, Holmes Rolston III (eds,), Environmental
Ethics. An Anthology , Blackwell, Malden MA 2003, p. 492).
24
Su questo aspetto mi intrattengo in modo più esplicito in: F.G. Menga, “Cose dell’‘altro mondo’.
L’atopia della giustizia intergenerazionale quale sfida all’etica, alla politica e al diritto”, in Sociologia
del diritto 3, 2017, pp. 29-57.
�291
Problemi aperti di giustizia intergenerazionale: risposte ai miei critici
presenza non la sola possibilità di preservare la possibilità di futuro attraverso un
movimento di rimbalzo verso una trascendenza a-venire da non intaccare. Piuttosto
si tratta di concederle spazio di trascendenza lasciandola però riverberare nel tessuto
dell’esperienza vissuta.
Ed è precisamente a questo spazio che, a mio avviso, il pensiero di Lévinas offre
adeguato riscontro, allorquando pensa ad un futuro etico che rompe la sincronia del
tempo presente, mostrando assieme ad un carattere di diacronia anche un tratto di
trascendenza ed eccentricità originarie. Infatti, l’appello che ci ingiunge dal futuro e
ci proietta al futuro esercita una pressione etica che, a ben vedere, proprio perché
non disponibile alla presa del presente, sfugge all’individuazione entro un posto nel
mondo. Questo futuro, anzi, in quanto appello che si annuncia sempre da un
“altrove” 25 che irrompe nel mondo, resiste all’essere reso elemento od oggetto
disponibile o configurabile dentro l’immanenza 26 di strategie contrattuali e
deliberative o anche entro codificazioni formalizzabili e iterabili. Non a caso Lévinas
conferisce a questa dinamica di interpellazione dell’altro – e dell’altro dal futuro – la
configurazione enigmatica di una resistenza etica 27, resistenza esercitata da una
trascendenza irriducibile a ogni immanenza. Prescindendo da una colorazione
religiosa ed escatologica, che un tale topos senz’altro esibisce 28, la cosa importante
che qui mi preme mantener ferma è che tale resistenza di cui parla Lévinas si traduce
in un appello che si fa sentire nel mondo, eppure resta fuori dal mondo – sì un
appello proprio come quello di un’ingiunzione alla responsabilità verso un futuro che
ancora non esiste, eppure, poiché comunque penetra nel mondo, ci inquieta e ci
sconvolge nella carne viva del presente 29 sotto forma di una fastidiosa e ineludibile
richiesta di agire concretamente.
Come ben si intuisce, una tale delineazione offre riscontro ad una vissuta
esperienza del richiamo alla responsabilità verso il futuro nel presente senza, da un
lato, pagare il prezzo di una unilaterale colonizzazione del futuro e, dall’altra, di una
sua mera collocazione nell’assolutamente trascendente e assolutamente possibile al
fine di preservarne la genuinità.
Questa resistenza da parte della trascendenza che, però, in quanto tale, nulla può
contro il potere del presente – tant’è che può al limite restare inascoltata 30 – è così
una sorta di epoché o sospensione etica del potere dei presenti e del presente al
mondo. Epoché che tanto inquieta il potere attraverso il comandamento etico, da un
25
B. Waldenfels, Antwortregister, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1994, p. 267.
Cfr. E. Lévinas, Scoprire l’esistenza con Husserl e Heidegger, cit.
27
Cfr. ivi.
28
Per approfondire questa traiettoria del discorso si vedano le assai istruttive pagine di W. Jenkins,
The Future of Ethics. Sustainability, Social Justice, and Religious Creativity , Georgetown University
Press, Washington DC 2013, cap. 7.
29
Cfr. E. Lévinas, Scoprire l’esistenza con Husserl e Heidegger, cit.
30
Cfr. ivi.
26
�292
F ERD IN ANDO G. M EN GA
lato, quanto neppure scalfisce questo potere, dall’altro, tant’è che quest’ultimo, se
vuole, può benissimo perpetuarsi nella pratica di una “tirannia dei contemporanei” 31,
come se nulla fosse avvenuto 32.
Di qui ne deriva un altro punto di distanza rispetto al percorso di Gazzolo. Infatti,
per una responsabilità intergenerazionale che riesce a ritagliarsi uno spazio di
genuina articolazione entro il presente, senza così tradire il futuro, non si tratta tanto
di evitare determinazioni etico-materiali o istituzionali del futuro al fine di
preservarne l’autentica possibilità, quanto piuttosto di pensare a modalità per
“sporcarsi le mani” eticamente con il futuro, adottando però prospettive che mettano
sempre in grado di ridiscutere e ridisegnare le traiettorie delle pratiche messe in
campo.
Qui, di nuovo, la chiave di volta, a mio avviso, non sta nell’evitare la logica di
imputazione proiettiva/retrospettiva di responsabilità verso il futuro – la mia visione
di un futuro anteriore di carattere etico si propone, anzi, esattamente una forma di
ripensamento dell’imputazione retrospettivamente proiettiva 33 –, quanto piuttosto
nel pensare a forme di inevitabile rappresentazione e sostituzione per il futuro di
carattere genuinamente responsivo. Insomma, se rappresentare il e sostituirsi al
futuro implica una inevitabile forma di paternalismo nei suoi confronti, ciò non vuol
dire che la sostituzione si riduca ad una forma esclusivamente paternalistica. Anzi,
come ci insegna ancora Lévinas, la sostituzione può essere vissuta come vera e
propria espropriazione del presente proprio nella misura in cui sostituirsi significa
lasciarsi imprigionare, prendere in “ostaggio”, dall’appello dell’altro che ci proietta
fuori di noi a suo favore 34.
È sulla base di questo che, in ultimo luogo, si profila, a mio modo di vedere,
l’autentica possibilità di impegnarsi in proiezioni immaginative di carattere giuridico
ed istituzionale che, più che rispondere alla semplice vocazione di preservare la sola
possibilità di essere responsabili in futuro, possono (forse debbono) continuare a
impegnarsi a trovare forme per essere responsabili per il futuro.
4. SFIDE DELLA RESPONSABILITÀ INTERGENERAZIONALE
ALL’IMMAGINARIO GIURIDICO CONTEMPORANEO: L’ETÀ DEI DOVERI,
DELLA CURA E DELLE TUTELE
È esattamente questa pressante esigenza che vedo muoversi al fondo
dell’intervento ricco ed articolato di Tommaso Greco. La sua riflessione, dopo una
31
S. Gardiner, A Perfect Moral Storm , cit., p. 36.
Cfr. E. Lévinas, Scoprire l’esistenza con Husserl e Heidegger, cit.
33
Cfr. F.G. Menga, Lo scandalo del futuro. Per una giustizia intergenerazionale, Edizioni di Storia e
Letteratura, pp. 107-111.
34
Cfr. E. Lévinas, Altrimenti che essere o al di là dell’essenza, Jaca Book, Milano 1983, pp. 142 ss.
32
�293
Problemi aperti di giustizia intergenerazionale: risposte ai miei critici
prima parte dedicata a un’attenta e precisa ricostruzione degli snodi teorici
fondamentali e categorie guida del mio percorso, confluisce – e fa confluire il
precipitato stesso del mio discorso – verso alcune considerazioni di decisiva portata
per una risistematizzazione del diritto nei confronti della questione
intergenerazionale.
Per molti versi, la riflessione di Greco può essere fatta giocare, peraltro, come
controprospettiva rispetto alla proposta elaborata da Gazzolo.
In primo luogo, Greco, riorienta in modo sostanziale l’interpretazione del diritto
nella sua dimensione progettuale, così da offrirne una visione molto diversa, rispetto
a quella di Gazzolo, circa la sua collocazione nei confronti del tema
intergenerazionale. Se si parte, infatti, dal presupposto – come Greco esplicitamente
fa – che il diritto è proprio il luogo in cui ogni “relazione […] carica di responsabilità
[…] che ci consegna dei doveri cui adempiere” trova spazio di articolazione, ne
consegue che esso non può che essere il luogo di strutturale accoglienza anche della
“relazione con altri che ci interpellano dal futuro”. Il meccanismo progettuale e
anticipatore del diritto che, così, immancabilmente ne deriva, nel suo stabilire
connessioni responsabili e responsive con l’avvenire, non può essere letto solo ed
esclusivamente nei termini di una mera imposizione determinatrice nei confronti del
futuro. Al contrario, deve essere inteso come pratica che, intrisa di responsabilità e
obbligazione, mostra una vera e propria “vocazione al futuro”. Questo è quanto
Greco sottolinea nel momento in cui scrive: “Non c’è diritto che non pretenda di
proiettarsi nel futuro, e anzi si potrebbe dire – lo ha sottolineato Fabio Ciaramelli –
che è proprio il diritto a farsi carico di quella essenziale propensione al divenire che è
tipica dei gruppi umani e nella quale ‘consiste la loro essenziale relazione all’alterità
del futuro’” 35.
Ne deriva così una visione del diritto nei confronti della sua portata
intergenerazionale che se, da un lato, non può sottrarlo al sospetto di decadere in una
pratica di predeterminazione del futuro, come a ragione Gazzolo fa notare, dall’altro,
a quest’ultima non può essere essenzialmente ridotto. Qui, è bene ribadirlo
nuovamente, il punto fondamentale sta proprio nel mantenere costantemente
operativa la dimensione della responsabilità e del dovere entro il tessuto del diritto.
Ma proprio in ragione della necessità di dare corretto riscontro alla centralità del
discorso sui doveri all’interno del diritto, risulta essenziale, per Greco, sgomberare il
campo da alcuni “equivoci” di fondo che confondono, più che aiutare, nel tentativo
di cogliere il genuino rapporto fra diritto e doveri di carattere intergenerazionale.
Per dare sviluppo a questo punto, Greco si intrattiene a lungo e criticamente con
la visione di uno degli autori che, in seno al mio percorso, più di altri mi consente di
introdurre la centralità della dimensione del dovere all’interno del discorso sui diritti
35
Il passo citato da Ciaramelli è tratto da: F. Ciaramelli, “Responsabilità per le generazioni future:
la funzione del diritto”, in F. Ciaramelli, F.G. Menga (a cura di), Responsabilità verso le generazioni
future, cit., p. 18.
�294
F ERD IN ANDO G. M EN GA
verso le generazioni future. Si tratta di Gustavo Zagrebelsky e della sua idea
sviluppata nei suoi ultimi scritti dedicati alla questione intergenerazionale, secondo
la quale, a fronte del fatto che le generazioni future non possono propriamente
reclamare diritti soggettivi in relazione ai quali possono essere identificati chiari
obblighi intergenerazionali per i soggetti presenti, la questione intergenerazionale
può essere svolta solo sul piano di doveri per i posteri a cui non corrispondono veri e
propri diritti 36.
La critica che Greco elabora nei confronti di questa visione di Zagrebelsky – e che
mi appresto a ripercorrere – può essere letta, in fondo, anche come un appunto
critico verso la mia stessa appropriazione di tale visione, forse colpevole di essere
stata quantomeno frutto di una lettura interrotta troppo in fretta. Concedo
pienamente a Greco il fatto che nel libro avrei potuto dedicare più attenzione e
spazio ad una lettura più attenta di questo snodo fondamentale proposto da
Zagrebelsky. Allo stesso tempo, vorrei però sottolineare in questa sede che
l’intenzione di limitare il mio confronto con il discorso di Zagrebelsky nei termini
riscontrabili nel libro ha dei motivi strutturali per l’economia del mio discorso –
motivi che espliciterò più avanti e che, a mio avviso, tornano di rimbalzo ed in modo
intrinseco anche in alcuni luoghi chiave del discorso stesso di Greco.
Ma vediamo prima la critica, assolutamente condivisibile, di Greco a Zagrebelsky.
In estrema sintesi, il maggiore rimprovero che Greco muove all’impostazione di
Zagrebelsky è quella di fondarsi su postulati di identificazione della sfera dei diritti
che, però, non soltanto non sono affatto gli unici possibili, ma, proprio nell’essere resi
tali, comportano anche delle conseguenze pratiche rilevanti sulla possibilità stessa di
collocare in modo corretto la dimensione dei doveri all’interno dell’ambito del
diritto. In relazione a tale critica di non esclusività, nessun commento può essere più
efficace delle parole stesse di Greco, che vale la pena qui riportare:
Se si pongono certe condizioni per l’esistenza dei diritti è perché ci si mantiene
ancorati a determinati postulati: nel caso in esame [l’opzione di Zagrebelsky,
aggiunta FGM], ad esempio, da un lato, si presuppone la necessità di individuare
in maniera concreta chi possa essere titolare dell’interesse che si vuole tutelare in
maniera da attribuirgli un diritto attivo; dall’altro lato, si pone nella garanzia
secondaria (giurisdizionale) l’unico elemento costitutivo del diritto stesso,
dimenticando quindi il sistema degli obblighi che costituisce invece la garanzia
primaria. Ma entrambi i postulati si possono criticare e rovesciare: si può
sostenere, cioè, sulla base della teoria della correlatività, che attribuire doveri a
qualcuno vuol dire anche riconoscere diritti a qualcun altro, anche a soggetti non
ancora esistenti, prescindendo dunque da una qualche attività o azione che essi
debbano svolgere per essere riconosciuti come titolari dei diritti medesimi; e si
36
Cfr. G. Zagrebelsky, Senza adulti, Einaudi, Torino 2016, pp. 86 ss. L’autore anche nel suo
ultimissimo libro (cfr. Id., Diritto allo specchio, Einaudi, Torino 2018) – nel quale, peraltro, tiene conto
del mio lavoro (cfr. ivi, p. 114) – ribadisce la medesima prospettiva (cfr. ivi, pp. 108 ss.).
�295
Problemi aperti di giustizia intergenerazionale: risposte ai miei critici
può sostenere altresì che la garanzia dei diritti non sta affatto esclusivamente
nella possibilità di percorrere la via giurisdizionale, bensì innanzitutto
nell’attribuzione di doveri a determinati soggetti, venendo la garanzia
secondaria a supplire all’eventuale mancanza dell’adempimento primario. Se
tutto ciò è sostenibile, allora non c’è alcuna illogicità nel sostenere che esistono
diritti delle generazioni future, se e nella misura in cui siamo in grado di
individuare doveri delle generazioni presenti che abbiano come scopo la tutela
di beni fondamentali da cui dipenda la sopravvivenza dei nostri discendenti.
Da qui, a cascata, discende subito il profilo delle conseguenze pratiche di tale
identificazione unilaterale dello statuto dei diritti che, per Greco, si riverbera in un
modo altrettanto limitante e unilaterale di intendere lo statuto stesso dei doveri: nella
misura in cui, infatti, si opta per una visione dei diritti che si compie e consuma
principalmente sul piano delle garanzie giurisdizionali si corre il rischio di
riscuoterne l’effetto nella prospettiva di una visione dei doveri anch’essa ristretta alla
“dimensione verticale del potere e della coercizione, facendo perdere di vista il tema
della relazione con coloro che dovranno beneficiare dell’adempimento di questi
doveri”.
In ultima analisi, dunque, la prospettiva di Zagrebelsky si rende colpevole,
secondo la prospettiva di Greco, non soltanto di non riconoscere alle generazioni
future un adeguato luogo giuridico entro l’ambito dei diritti, ma, alla fine, anche
entro l’ambito dei doveri, ovvero proprio dei doveri segnatamente orizzontali.
La seguente è, quindi, la posta in gioco che, per Greco, ne consegue da questo
stato di cose: riattivare in seno al dibattito sui diritti intergenerazionali le risorse
esistenti, sebbene non sempre indagate, di una impostazione che affonda le sue radici
esplicitamente sui doveri orizzontali. “Occorre”, dice l’autore, “pensare ai nostri
doveri attuali come un qualcosa che dobbiamo ad altri, e ai quali dobbiamo
adempiere dunque, non solo perché ce lo impone il nostro ordinamento politicogiuridico attuale, ma perché c’è una relazione che ci obbliga e che nasce dall’appello
che ci viene dal futuro”. E, qui, Greco chiude il cerchio, tornando, dopo il suo ricco
excursus critico, a ricongiungersi con il mio discorso.
Chiedo, tuttavia, a Greco, proprio a questa altezza, di fare un passo ulteriore e
domandarsi: da dove può mai provenire la forza motrice per impegnarsi
espressamente nel cambio di rotta richiesto? Sì, perché – penso Greco converrà qui
con me –, il fatto che esistano dei dispositivi giuridici adeguati ad un più consono
sviluppo della questione intergenerazionale, poco contribuisce a che si vada in tale
direzione. Anzi, mi pare che le teorie mainstream – ma anche le pratiche e
procedure 37 – ancora troppo poco frequentino le promettenti contrade da lui
indicate: molti dei discorsi dominanti in ambito si basano, invece, in modo ancora
preponderante sul paradigma contrattualista o variazioni di esso. Addirittura alcune
37
Su questo punto si veda l’intervento di Abignente.
�296
F ERD IN ANDO G. M EN GA
teorie assai raffinate di matrice comunitarista, notoriamente più inclini a mettere in
conto una più elevata dose di presupposti cultural-antropologici, sembrano
comunque non riuscire a scrollarsi di dosso completamente le acquisizioni di base di
una impostazione intergenerazionale fondata primariamente sulla contemperazione
degli interessi e sui diritti di matrice verticalista 38. Ed è a questo livello che, a mio
avviso, la chiave di volta sta esattamente nell’insistere sulla dimensione simbolicoculturale per attuare quella che Jaspers, ma anche Anders, all’indomani dei nefasti
eventi atomici di Nagasaki e Hiroshima, indicavano innanzitutto come una
necessaria rivoluzione etico-antropologica tale da fare emergere il primato etico dei
doveri 39. È solo nell’attivazione o riattivazione di un determinato immaginario
collettivo, che sta al fondo della costitutività dell’etico, del politico e del giuridico, che
una tale rivoluzione si rende possibile.
Ora, primariamente questo tipo di passaggio, a mio modo di vedere, viene
indicato nella riflessione di Zagrebelsky; ragion per cui quest’ultima riveste per
l’economia del mio lavoro un ruolo assai importante, a prescindere dalle giuste e
importanti indicazioni critiche sviluppate dall’intervento di Greco. Peraltro, mi
sembra che Greco stesso non solo abbia presente questo versante del discorso, non
mancando di segnalare espressamente la dimensione antropologica della questione,
ma anche con esso chiuda il suo intervento, cercando di mobilitare, in visione
prospettica, tutte quelle risorse simbolico-antropologiche e culturali – “narrazioni”,
“agenda educativa e politica”, “supera[mento] [del]l’ideologia dell’individuo irrelato e
sovrano” – che stanno al fondo e sullo sfondo di ogni pratica politico-giuridica.
Tocchiamo così la dimensione pratico-giuridica del discorso intergenerazionale,
tema specifico dell’intervento di Angelo Abignente. Nello specifico, Abignente
concentra la sua indagine nel mostrare alcune modalità e traiettorie attraverso le
quali l’appello alla responsabilità per il e dal futuro mette in discussione e – oserei
dire – talvolta in crisi alcune categorie teoriche ed operative fondamentali del diritto.
Non è affatto casuale la mia scelta di chiudere questo mio percorso di replica agli
interventi che compongono il presente simposio proprio con la riflessione elaborata
da Abignente. Per un verso, infatti, alcuni dei risvolti e delle suggestioni che questo
autore mette in campo mi consentono di ritornare su diversi punti chiave sopra
discussi con una dose di maggiore sostanziazione; per l’altro, mi impone nondimeno
di mettermi a confronto con una questione teorica fondamentale, rispetto alla quale
non posso non fornire qualche cenno di riflessione in chiusura.
38
Fra queste teorie di estrazione comunitarista forse la più raffinata è proprio quella di Janna
Thompson, la quale fonda la sua impostazione sull’esistenza comunitaria di “lifetime-transceding
interests” (J. Thompson, Intergenerational Justice. Rights and Responsibility in an Intergenerational
Polity , Routledge, New York/London 2009) - appunto, comunque, di “interessi”.
39
Cfr. K. Jaspers, La bomba atomica e il destino dell’uomo, Il Saggiatore, Milano 1960, 15 ss., 42
ss.; G. Anders, L’uomo è antiquato, vol. 1: Considerazioni sull’anima nell’epoca della seconda
rivoluzione industriale, Bollati Boringhieri, Torino 2003, pp. 255 ss.
�297
Problemi aperti di giustizia intergenerazionale: risposte ai miei critici
Rispetto al primo versante, con licenza di qualche semplificazione sui numerosi e
articolati motivi che questo autore fa emergere, vorrei concentrarmi soltanto su
alcuni aspetti.
In primo luogo, Abignente, calando la sua riflessione all’interno della concreta e
pulsante vita della pratica giuridica, mostra come l’appello intergenerazionale,
mettendo in crisi di quest’ultima la concettualità e addirittura la semantica, non può
essere accolto dal presente e dai presenti alla sola stregua di risposte formalprocedurali. Al contrario, esso costringe ad un doppio meccanismo di
determinazione concreto e materiale che agisce lungo l’asse di una responsività che si
articola secondo il “futuro anteriore” della responsabilità. Detto in termini più
esplicativi: ogniqualvolta colpisce il presente in modo rilevante ed effettuale, l’appello
del futuro innesca non soltanto un meccanismo di determinazione proiettiva e
appropriatrice rispetto all’avvenire, ma, anche e soprattutto, una dinamica
espropriante, tale per cui le pratiche del presente, trovandosi impreparate e sguarnite
rispetto ad esso, sono chiamate a rideterminarsi esse stesse per rispondere
efficacemente a ciò che “è pervenuto nel [loro] orizzonte di conoscenza e
valutazione”. Questo stato di cose trova pieno riscontro nell’ambito dell’operazione
ermeneutica che Abignente mobilita con la sua lettura delle due sentenze della
Cassazione (2009 e 2015) (sulla protezione da riconoscere al nato e al nascituro
portatore di handicap e sulla tutelabilità della sua posizione in termini risarcitori per
la malformazione riportata) in ordine alla sostanziale inadeguatezza della categoria
di “soggetto capace, titolare di diritti” e la conseguente necessità di riconfigurazioni
in direzione di categorie come quella di “oggetto di tutela” e “cura”.
Quello che quindi è importante sottolineare a questo livello del discorso è come la
riflessione di Abignente tenda proprio a mostrare quanto insufficiente sia una
prospettiva intergenerazionale tendente alla sola evidenziazione dell’aspetto tirannico
del presente e alla concomitante proposta di soluzione che si sostanzia nella sola
strategia di protezione formalistico-procedurale del futuro (da preservare nella sua
apertura). Nel presente che si carica giuridicamente di responsabilità avviene, invece,
il contrario: i presenti determinano il futuro, nella misura in cui ne sono però esposti
dall’appello. In altri termini, formano il futuro, (tras)formando loro stessi.
In tal senso, alla luce di questa prima riflessione, dal discorso di Abignente si
evince sia una risottolineatura della vocazione genuinamente progettuale del diritto
rispetto al futuro, così come l’abbiamo individuata nella riflessione di Greco, sia
anche, in contrapposizione, un freno rispetto alla lettura di un presentismo tirannico
del diritto, come l’abbiamo trovata nella riflessione di Gazzolo.
Allo stesso tempo, però, l’impostazione di Abignente, nel non mancare di
affondare il colpo sull’inadeguatezza che l’armamentario delle pratiche giuridiche
attuali mostra rispetto all’emergenza intergenerazionale, conduce anche ad una
ricalibratura del discorso di Greco teso a far emergere tutto il potenziale giuridico
della semantica dei doveri. Se, in effetti, riprendiamo la critica che Abignente muove
�298
F ERD IN ANDO G. M EN GA
alla non esaustività della categoria degli “obblighi dei doveri di protezione”
(colpevole di restare ancora entro l’alveo di una concettualità contrattualistica), non si
può non aprire nuovamente uno spiraglio di credito a tutta l’insoddisfazione che si
legge in filigrana nel discorso di Zagrebelsky rispetto all’operatività giuridica della
contrapposizione diritti/doveri in ambito intergenerazionale 40.
Ci sarebbero molti altri aspetti e stimoli da raccogliere e sviluppare dell’indagine
di Abignente. Mi limito, però, soltanto a quelli sopra richiamati, al fine di poter
dedicare l’ultimo tratto della mia riflessione ad una questione teorica a cui l’autore
mi richiama esplicitamente in termini critici. A ragione, egli rileva, infatti, all’inizio
del suo contributo – sebbene in modo assai generoso nei miei confronti (“la mia
curiosità di discutere con Ferdinando …”) – la pressoché assente presa in
considerazione da parte mia del paradigma deliberativo di stampo habermasiano e
della sua potenzialità (in termini di “dialogicità comunicativa”) nell’orizzonte di una
prospettiva di legittimazione della responsabilità intergenerazionale.
L’autore coglie qui un punto nevralgico rispetto a quella che oserei chiamare una
rinuncia preliminare da me operata nella redazione del testo: optare, infatti, per la
discussione della linea habermasiana e delle sue varie sempre più influenti
diramazioni in ambito intergenerazionale avrebbe implicato, per me, il tirarmi dietro
un’imponente serie di questioni politico-giuridiche che, alla fine, avrebbero
notevolmente trasfigurato l’economia strutturale del libro e che, d’altro canto,
sarebbero risultate oltremodo semplificate alla luce di un mero sguardo di sorvolo. In
ragione di ciò, ho scelto di sacrificare questo aspetto, ripromettendomi però di
tematizzarlo abbondantemente in studi successivi (spero imminenti).
Nondimeno, sollecitato dall’autore, non mi posso esimere qui dall’anticipare
alcune considerazioni al riguardo, premettendo tuttavia che esattamente la linea
habermasiana e, generalmente, deliberativa, agisce sulla mia impostazione in modo
contrastante: registro motivi di prossimità connessi a motivi di divergenza.
Per offrire un quadro generale della mia riflessione, vorrei fare ruotare la
discussione attorno ad una delle questioni più dibattute: la fecondità del notorio
paradigma deliberativo dell’all-affected principle – peraltro, chiamato in causa da
Abignente ad un certo punto della sua indagine – rispetto al tema della
responsabilità intergenerazionale.
Effettivamente, l’estrema fecondità di questo principio propugnato dai deliberative
democrats risiede nel fatto che una decisione si rivela tanto più legittima quanto più
essa include una procedura che promuove la libera partecipazione di tutti i potenziali
soggetti da essa interessati e in essa coinvolti quali destinatari degli effetti che essa
produce. Tutti i potenziali soggetti interessati avrebbero, perciò, in sede di pubblica
deliberazione, la possibilità di dare ragione dei loro interessi e delle loro opzioni,
cosicché la decisione finale raggiunta attraverso il vaglio di un confronto di
40
Non a caso, infatti, l’approccio di Abignente esibisce una lettura molto più conciliante nei
confronti della riflessione di Zagrebelsky sulla giustizia intergenerazionale.
�299
Problemi aperti di giustizia intergenerazionale: risposte ai miei critici
ragionevolezza fra posizioni diverse porterebbe certamente alla decisione più
legittima.
Esteso in ambito intergenerazionale, questo principio esibisce i notevoli vantaggi
che gli derivano dalla sua natura di deliberazione condivisa, strutturalmente fondata
sul principio di argomentabilità pubblica e, quindi, di apertura alla potenziale
partecipazione di ogni alterità capace di esibire ragionevoli interessi, incluse
ovviamente alterità future. Motivo per cui, sulla base di questo fondamento di
legittimità inclusiva, i potenziali interessi e prospettive di soggetti futuri, nella misura
in cui presi in considerazione, troverebbero terreno di pieno accoglimento all’interno
di decisioni prese dai presenti nei loro confronti 41.
Ulteriore vantaggio di questo principio è, inoltre, quello di rappresentare
indubbiamente un poderoso strumento per compiere, proprio attraverso la
procedura di pubblico discernimento argomentato, la scelta migliore e certamente
quella più democratica nel caso della determinazione di policies ambientali che
riguardano il futuro e che notoriamente si collocano nell’ambito di molteplici,
complesse e spesso contrastanti opzioni e experties chiamate in causa 42.
Per lo meno alla luce di questi due aspetti, non si può che dare allora ragione ad
Abignente circa l’elevata potenzialità dialogico-comunicativa che il modello
deliberativo detiene nei termini d’apertura e inclusività sostanziali verso soggetti e
interpellanze future. E, da parte mia, sulla base di questi elementi, non ho difficoltà
alcuna a riconoscere al modello deliberativo grande forza operativa in vista della
risoluzione di diversi problemi inerenti la legittimazione di una solida teoria di
responsabilità intergenerazionale.
Tuttavia, non posso non tenere presente, al contempo, anche alcuni suoi tratti
piuttosto problematici – tratti che, inseriti nel contesto intergenerazionale, fanno
propendere per una seria presa in considerazione di modelli alternativi e, in
particolar modo, per una determinata rilettura del modello di democrazia
rappresentativa nei cui confronti la teoria deliberativa, per il suo stesso carattere
partecipativo, non può che marcare la distanza.
Per apprezzare appieno questa traiettoria critica è importante, a mio avviso,
prendere sul serio e tenere fermo uno dei cardini a cui ogni teoria deliberativa di
carattere inclusivo non può rinunciare, ovvero il fatto che essa, proprio al fine di dare
vero riscontro all’all-affected principle, cioè alla possibilità di partecipazione effettiva
di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti in una decisione, deve considerarli non nei
41
Mi limito a segnalare qui, senza pretesa di esaustività, alcuni dei maggiori contributi di
provenienza deliberativa nel dibattito sulla giustizia intergenerazionale: J. Dryzek, Deliberative
Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations, Oxford University Press, Oxford 2000; R.
Goodin, Reflective Democracy , Oxford University Press, Oxford 2003 e Id., “Enfranchising All
Affected Interests, and Its Alternatives”, in Philosophy and Public Affairs 35, 1, 2007, pp. 40 ss.
42
Su questo aspetto si veda in particolar modo M. Hisschemöller, R. Hoppe, “Coping with
Intractable Controversies: The Case for Problem Structuring in Policy Design and Analysis”, in The
International Journal of Knowledge Transfer and Utilization 8, 4, 1995, pp. 42 ss.
�300
F ERD IN ANDO G. M EN GA
termini di componenti di una generale totalità, ma nella loro prospettiva particolare
e situata – dalla quale soltanto può derivare l’insorgenza dell’interesse individuale e
contestualmente la libera chance di difenderlo ragionevolmente nell’arena della
pubblica deliberazione 43.
Sennonché è esattamente questo principio d’individuazione e partecipazione,
essenziale a ogni teoria deliberativa, a comportare un precipitato problematico in
seno alla teoria della responsabilità intergenerazionale – problema dal quale, a mio
modo di vedere, si esce soltanto se si introduce nella scena deliberativa l’inevitabile
intervento della rappresentanza, con tutto il carico di asimmetrie e paternalismo
politico che questo comporta.
Per esplicitare meglio questo punto, voglio soffermarmi soltanto su quattro
considerazioni: le prime tre intendono offrire qualche elemento per dare avvio a un
ideale dialogo con Abignente sull’esaustività del modello deliberativo in ambito
intergenerazionale; la quarta, invece, si prefigge di segnalare, seppur cursoriamente,
almeno una problematica ripercussione di questo modello proprio all’interno
dell’impostazione che Abignente ha elaborato nel suo intervento.
In primo luogo, il problema generale che intravedo nella piena assunzione del
principio d’individuazione e d’inclusività partecipativa della teoria deliberativa è che
essa, non potendo bypassare la posizione del soggetto potenzialmente interessato e
intervenente nel discernimento deliberativo, si trova in sede intergenerazionale
davanti ai medesimi ostacoli delle teorie contrattualistiche: l’ostacolo della nonesistenza – il soggetto potenzialmente interessato futuro non esiste – e l’ostacolo
dell’asimmetria – il soggetto potenzialmente interessato futuro non può parlar per sé.
In ciascuno dei casi, è soltanto il ricorso al dispositivo di una rappresentanza
anticipante i potenziali soggetti e i potenziali interessi a risolvere il problema. Una
volta che però la procedura deliberativa cede necessariamente al meccanismo
rappresentativo 44, non può non fare i conti, a cascata, con i seguenti punti per essa
assai dolenti: nel determinare anticipatamente possibili soggetti e interessi, la
rappresentanza implica la definizione di principi sostantivi o materiali predeliberativi assolutamente stridenti con l’impianto della deliberazione, che prevede
invece un’apertura di principio alla dibattibilità stessa dei presupposti preliminari al
fondo di ogni deliberazione. La rappresentanza, con il suo meccanismo di
determinazione anticipata, produce immancabilmente inclusioni ed esclusioni in
43
Cfr. R. Eckersley, The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty , MIT Press,
Cambridge MA 2004, p. 104. È proprio sulla base di questo principio di partecipazione che una teoria
deliberativa non può conciliarsi né con l’aspetto di riduzione della pluralità tipico della democrazia
rappresentativa, né con l’estrema generalizzazione ideale imposta dalla situazione del “veil of
ignorance” di matrice rawlsiana (critica deliberativa a Rawls che, peraltro, Abignente non manca di
richiamare nelle sue pagine).
44
Questo è quanto, per esempio, Robert Goodin non può non concedere quale necessario
strumento: cfr. R. Goodin, “Enfranchising the Earth, and Its Alternatives”, in Political Studies 44,
1996, p. 846.
�301
Problemi aperti di giustizia intergenerazionale: risposte ai miei critici
ordine alla delineazione dei potenziali soggetti interessati, cosa che si scontra
evidentemente con il principio di generalizzata inclusività della teoria deliberativa.
Insomma, a questo livello, la deliberazione deve scendere a patti con l’introiezione di
una certa dose di “non-democratic[ità]” 45 al proprio interno, se vuole rispondere alle
esigenze intergenerazionali.
Questo meccanismo di determinazione anticipata, che si intrufola nell’impianto
della deliberazione non appena lo si cala nella problematica intergenerazionale, trova
particolare riscontro anche in quello che è stato definito “boundary problem” 46:
ovvero, il fatto che molte procedure di decisione, rispetto alle quali si prospetta una
inclusione democratica di tutti i possibili interessati per l’esame della stessa,
producono gli stessi soggetti coinvolti solo quale esito della decisione e non prima.
Motivo per cui l’inclusività generalizzata può essere raggiunta solo al prezzo di un
regresso infinito che allarga sempre più lo spettro delle varie possibilità a valle delle
decisioni per poter corrispettivamente raccogliere inclusivamente tutti i possibili
soggetti corrispondenti. Ma, come si può intuire, una tale strategia più che aiutare ad
azionare meccanismi di decisione deliberativa in ambito intergenerazionale finirebbe
per paralizzarli per eccessivo sovraccarico.
Ma queste prime considerazioni, che hanno sottolineato l’inevitabile intervento
dell’anticipazione determinatrice rispetto ai soggetti futuri in seno alle procedure
deliberative, ci conduce alla terza e più fondamentale considerazione in ambito di
legittimazione della responsabilità intergenerazionale: la teoria deliberativa, nella
misura in cui resta collegata al principio di individuazione dei soggetti esistenti
possibilmente coinvolti, nulla può contro il poderoso scoglio rappresentato dal NonIdentity Problem elaborato da Parfit, secondo il quale un soggetto, nella misura in
cui è determinato nella sua identità ed esistenza da decisioni passate, nulla può
rimproverare a queste ultime, giacché decisioni alternative, per quanto migliori,
avrebbero implicato la sua inesistenza 47. Questo tipo di argomento, come si può
cogliere, non viene scalfito in alcun modo dalla prospettiva deliberativa, dal
momento che ogni potenziale soggetto interessato che intervenisse nel criticare o
richiedere ragionevolmente modifiche all’impianto di decisioni precedenti, cadrebbe
nella contraddizione fondamentale di propugnare non condizioni migliori per sé, ma
semplicemente la causazione delle condizioni della sua stessa non-esistenza 48. Questo
conduce direttamente alla necessità di rinunciare, dunque, al principio stesso
45
C. Heyward, “Can the All-Affected Principle Include Future Persons? Green Deliberative
Democracy and the Non-Identity Problem”, in Environmental Politics 17, 4, 2008, pp. 625 s.
46
Cfr. F.G. Whelan, “Democratic Theory and the Boundary Problem”, in J.R. Pennock, J.W.
Chapman (eds.), Nomos XXV: Liberal Democracy , New York University Press, New York 1983, pp. 19
ss.
47
Cfr. D. Parfit, Ragioni e persone, Il Saggiatore, Milano 1969, cap. 16.
48
Cfr. C. Heyward, “Can the All-Affected Principle Include Future Persons?”, cit., p. 633.
�302
F ERD IN ANDO G. M EN GA
d’individuazione e d’inclusività partecipativa della teoria deliberativa se si vuole
legittimare adeguatamente una responsabilità di carattere intergenerazionale.
La domanda che segue recita: Abignente sarebbe disposto a tale rinuncia?
Ebbene, è proprio la risposta a questa domanda che, se analizzata in tutta la sua
portata, segnala, a mio avviso, un problema già tutto interno all’impianto del suo
discorso. A ben guardare, infatti, Abignente non ha bisogno affatto di giungere a tale
rinuncia, avendola già dall’inizio esplicitamente operata nel momento in cui la sua
riflessione teorica si rivela tutta tesa a risolvere molte delle impasse giuridiche
attraverso uno smarcarsi dalle posizioni soggetto-centriche, proiettandosi verso
categorie oggetto-orientate. Giusto per citare uno stralcio significativo della sua
discussione sullo statuto del concepito e del nascituro: “Mi sembra che una possibile
via di soluzione a questi dilemmi possa individuarsi […] super[ando] la tradizionale
dommatica del diritto soggettivo, riconoscendo il concepito non come soggetto
giuridico ma come oggetto di tutela”.
Lascio agli ulteriori sviluppi di un nostro confronto sul tema – che già da qualche
anno si protrae – la possibilità di poterci influenzare reciprocamente su possibilità
aperte e non ancora bene esplorate circa i fecondi contributi che la teoria deliberativa
può apportare.
Per il momento, la mia linea di riflessione – come peraltro sopra accennato – si
dirige in modo molto più preponderante verso una teoria che assume espressamente
ciò che la teoria deliberativa invece soltanto concede: cioè la necessità di una
rappresentanza del futuro e dei futuri. Sono ben consapevole che ogni meccanismo
rappresentativo porta con sé motivi di inevitabile asimmetria e paternalismo.
Tuttavia, un correttivo a questi elementi potrebbe passare proprio per l’esplicita
accettazione del carattere contingente e sempre rivedibile di ogni operazione
rappresentazionale, come anche dall’esplicita messa in rilievo dell’elemento
responsivo di essa 49: rappresentiamo il futuro e i futuri non perché noi presenti, a
bella posta, decidiamo per essi, ma perché esposti al loro appello, non possiamo fare
altro che, responsivamente e responsabilmente, sostituirvici 50. Il presente, in tal
modo, si rivela già sempre contaminato dal futuro: presente come un tempo “out of
joint”, per dirla con il celebre passo shakespeariano.
49
Questi aspetti, al centro della mia riflessione oramai da qualche anno, hanno trovato un loro
ulteriore approfondimento e sviluppo nel mio ultimo lavoro monografico: F.G. Menga, Ausdruck,
Mitwelt, Ordnung. Zur Urspünglichkeit einer Dimension des Politischen im Anschluss an die
Philosophie des frühen Heidegger, Fink, Paderborn 2018, in part. capp. 16 e 17.
50
Questo è un punto teorico chiave della mia impostazione che compare già nel libro e che traggo
esplicitamente dalla fenomenologia responsiva di B. Waldenfels, Antwortregister, cit. Recentemente
Waldenfels si è intrattenuto proprio sul tema intergenerazionale a partire da una tale prospettiva: cfr. B.
Waldenfels, “Antworten auf Ansprüche Nachkommender”, in Metodo. International Studies in
Phenomenology and Philosophy 5, 2, 2017 (Special Issue a cura di M. Fritsch e F.G. Menga su
“Responsibility and Justice for Future Generations in Dialogue with Phenomenology”), pp. 19-45.
�303
Problemi aperti di giustizia intergenerazionale: risposte ai miei critici
È precisamente la genuina e radicale vocazione intergenerazionale che qui si rivela
ad aver fatto da filo conduttore a tutti i contributi degli studiosi intervenuti in questo
simposio.
A tutti loro va nuovamente, in chiusura, il mio grazie.
�304
�305
Varia
�306
�307
Etica & Politica / Ethics & Politics, XX, 2018, 1, pp. 307-315
ISSN 1825-5167
GIANLUCA MORI SULL’ATEISMO
NELLA FILOSOFIA MODERNA
ST E FA NO BRA CA LE T T I
Università di Milano Bicocca
stefano.bracaletti@unimib.it
ABSTRACT
Gianluca Mori's book analyzes atheistic thought in the historical period between the second half of
the 1600s and the second half of the 1700s. Spinoza and D'Holbach are set respectively as the
initial and final point of this path articulating through the figures of Cudworth and Bayle, the
clandestine atheists (Meslier, Boulanvillier, Du Marsais and Fréret), Toland, Collins, Hume,
Voltaire and Diderot. A complex vision of the concept of atheism in modern age is sketched in the
text. In the Author’s perspective, the individuation of the path of modern atheism marks its
progressive emancipation from its intellectually and morally negative connotation and, more
generally, underlies the overcoming of a further stage in the uneven route towards the affirmation
of an open society.
KEYWORDS
Atheism, materialism, proofs of God’s existence, dogmatic theology, christianity
ST E FA NO BRA CA LE T T I
stefano.bracaletti@hotmail.it
Nell’Ateismo dei Moderni Gianluca Mori analizza il pensiero ateo avendo
riguardo specifico per il periodo storico tra la seconda metà del 1600 e la seconda
metà del 1700. Le figure di Spinoza e di D’Holbach sono poste rispettivamente quale
riferimento iniziale e terminale di tale parabola.
L’intera parabola dell’ateismo moderno sviluppa il suo tracciato in un contesto
storico-culturale a dir poco ostico, in cui la più o meno esplicita negazione
dell’esistenza Dio, o, pur anche un allontanamento, vero o presunto, dall’ortodossia
della Fede, impongono l’assunzione di rischi anche sul piano strettamente
esistenziale.
�308
S TE FA NO B RA C ALETTI
Ciò se, da un lato, spinge il “libero” pensatore a dissimulare, più o meno
artificiosamente, la propria reale linea di pensiero - rinverdendo una tradizione già
radicata nell’antichità classica - da altro lato, proprio per questo, costringe l’Esegeta
ad un lavoro supplementare di decodifica e di “interpretazione” delle autentiche tesi
degli Autori. Proprio su questo lavoro si concentra il Saggio in esame.
Prima di condurre il lettore entro il nucleo centrale della propria esposizione
analitica, l’Autore dedica il primo capitolo del volume ad inquadrare le questioni di
base nei loro termini generali e a chiarire, in chiave necessariamente problematica, il
quadro concettuale indispensabile per meglio comprendere lo sviluppo delle
successive analisi ed argomentazioni.
In particolare, viene tratteggiata una visione complessa del concetto di ateismo di
concezione moderna, non essendo affatto scontato quello che sia l’esatto perimetro
delimitante tale concetto e quali siano le differenziazioni sottese, specialmente nel
contesto di un’accezione più estensiva del medesimo.
Lo scenario si amplia e si complica in un passaggio logico ulteriore, fondato sulla
consapevolezza ineludibile che, anche su un piano strettamente nominalistico,
l’ateismo, nel suo porsi in termini negativo-privativi, rimanda al concetto “positivo”
di Dio e, nel rapporto dialettico con quest’ultimo, attinge la propria sostanza.
Invero, il perimetro del divino nelle varie concezioni elaborate nel corso dei secoli,
siano esse religiose o filosofiche, appare tutt’altro che stabile, così come non è stabile
nel pensiero dei Filosofi del periodo di riferimento, per quanto condizionato (e
limitato) nelle possibili espressioni dal difficile rapporto con il pensiero teologico
dogmatico culturalmente dominante.
Tornando al tema del libro, l’Autore ritiene di risolvere la questione appena
delineata reputando l’impostazione tratteggiata da Ralph Cudworth nel testo The
True Intellectual System of the Universe (R. Royston, London 1678) come la più
consona per delineare il confine tra teisti ed atei in relazione al periodo di
riferimento. Secondo Cudworth, poteva essere ritenuto ateo chi negasse l’esistenza di
un ente intelligente e consapevole in grado di produrre il mondo naturale e/o
conformarlo sulla base di un preciso disegno cosciente e volontario. Per contro
venivano scartate quelle definizioni di ateismo talmente estensive o restrittive nelle
condizioni poste da inficiare la funzionalità del concetto rendendo (in relazione
all’epoca in esame) quasi tutti credenti o quasi tutti atei.
Più in generale, dalla considerazione di quanto esposto, è logico desumere che la
variabilità dell’idea umana di Dio, ed il suo progressivo orientarsi e raffinarsi nella
speculazione filosofica e teologica, propaga i suoi effetti in relazione all’ampiezza ed
alla sostanza del concetto di ateismo e al movimento del suo argomentare
confutatorio.
Ulteriore complicazione sottolineata dall’Autore - forse di minore momento
assoluto ma, comunque, di non poco rilievo nella contingenza del periodo storico di
riferimento - è data dalla questione di quali filosofi possano essere detti atei ed in che
�309
Gianluca Mori sull’ateismo nella filosofia moderna
misura lo siano. Quelli dichiaratisi come tali? Anche quelli implicitamente
qualificabili in tal senso? Anche quelli – una pletora – accusati di esserlo in ossequio
ad una presunta ortodossia? persino quelli il cui pensiero si ravvisi essere suscettibile
di implicazioni ateistiche per cui possa pervenirsi a dissertare addirittura, in perfetto
stile inquisitorio, di un ateismo “preterintenzionale”?
A tal proposito, Mori individua e descrive le due impostazioni di studio che si
fronteggiano. Da un lato, gli “inclusivisti” e, cioè, coloro che ritengono di ascrivere
alla categoria degli autori atei tutti coloro che per scelta propria o designazione altrui
abbiano espresso posizioni non consonanti con l’ideologia e la teologia dominante. Si
osserva che tale impostazione, se idonea a rendere l’esatta misura di un travaglio
intellettuale che ha da sempre fatto da sommesso controcanto al pensiero
“ortodosso”, cade in difetto, tuttavia, nel momento in cui restituisce un quadro
troppo variegato e disorganico di posizioni anche reciprocamente inconciliabili.
Da altro lato gli “esclusivisti”, i quali, applicando un criterio di selezione
rigorosamente restrittivo, ascrivono alla categoria degli autori atei i soli pensatori
postisi dichiaratamente e rigorosamente su posizioni negazioniste del principio
divino della realtà. Tale posizione, secondo l’Autore, se presenta il vantaggio di
fornire un’immagine più lineare e meno controversa nella ricostruzione del pensiero
ateo, d’altro canto, palesa un limite sostanziale consistente nell’inadeguatezza a
rendere efficacemente il tormentato e diffuso processo critico che ha accompagnato e
profondamente infiltrato la cultura dell’Occidente cristiano, ponendo le basi per la
sua profonda trasformazione.
Proprio in tale chiave, nella prospettiva presentata dell’Autore, l’individuazione
del percorso dell’ateismo moderno segna la progressiva emancipazione dello stesso
dalla connotazione intellettualmente e moralmente negativa correlata all’assunzione
di posizioni negatorie dell’esistenza di Dio e, più in generale, sottende il superamento
di una tappa ulteriore nel cammino accidentato verso l’affermarsi di una società
aperta.
Nei successivi capitoli del saggio, l’Autore prende in considerazione una serie di
filosofi rappresentanti del filone dell’ateismo moderno, cercando di distillarne il
pensiero nel quadro degli strumenti concettuali già proposti nella parte generale
dell’esposizione.
La prima figura in esame è quella di Spinoza. Mori evidenzia come un consistente
filone ermeneutico, anche contemporaneo, abbia escluso tale filosofo dal novero dei
pensatori atei. Invero, la declinazione del concetto di ateismo, al variare del concetto
di Dio, può prestarsi all’inclusione o all’esclusione di un particolare sistema di
pensiero dal campo teistico. Ciò in particolar modo adottando un approccio adogmatico, per cui il concetto di “divinità” viene esteso tanto quanto lo consente
l’estensione delle disparate costruzioni religiose desumibili da una religiosità
naturale o positiva, piuttosto che dalle costruzioni filosofico-speculative. Tuttavia,
nella rigorosa prospettiva storica, ricostruita doviziosamente dall’Autore,
�310
S TE FA NO B RA C ALETTI
difficilmente può dubitarsi che le posizioni di Spinoza non entrino a pieno titolo nel
campo dell’ateismo. Infatti, una concezione religiosa come quella cristiana che
s’impernia sulla rivelazione di Dio nella Storia (e quindi pone la Storia - e la fede
nella storia - come presupposto di validità di tale rivelazione) e, ad un tempo,
umanizza la figura divina, una tale concezione non può non contrastare
radicalmente con chi universalizzi il divino riconoscendolo come principio
immanente insito nello stesso “continuum” naturale. E peraltro, una concezione
religiosa, quale quella di Spinoza che definisce il piano divino deantropomorfizzandolo (e, quindi, universalizzandolo) come principio ordinatore di
ciò che esiste in termini di leggi governanti inflessibilmente i rapporti causali, non è
compatibile con una visione della divinità così fortemente caratterizzata in chiave
“volontaristica” da attribuirle la capacità di interrompere – attraverso il miracolo –
l’operare delle leggi di natura.
Nel secondo capitolo dal titolo “Atei virtuali” l’autore analizza le figure di Ralph
Cudworth e Pierre Bayle.
In relazione a Cudworth, si evidenzia lo sforzo di definire in quali termini possa
classificarsi una forma organica di pensiero filosofico nell’ambito dell’ateismo. La
base di partenza condivisa da atei e teisti può senz’altro essere identificata nella
constatazione che dal nulla non possa emergere alcunché, per cui sia da postulare
qualche cosa di esistente da sempre da cui derivino tutti gli enti; ciò posto, i requisiti
necessari perché si riconosca ad una determinata visione del mondo il carattere ateo
è che, da un lato, la causa prima delle cose si collochi sul piano strettamente
materiale e che, da altro lato, tale causa prima materiale sia priva di consapevolezza,
ovvero dispieghi la sua azione efficiente in via automatica, non attingendo il livello
della coscienza e della direzione intenzionale che della coscienza è il portato. Quanto
specificamente al requisito della materialità, il concreto sostanziarsi di quest’ultimo
permetterà all’esegeta di procedere ad una classificazione dei sistemi filosofici atei
(tra loro non compatibili) distinguendo sotto questo profilo, in via generale, tra i
sistemi nei quali la materia viene considerata quale entità inerte (in cui sarà la
combinazione degli elementi a determinare l’emersione di proprietà complesse atomismo -, o in cui si manifesti una capacità di assumere determinate forme in senso
aristotelico - ilopatismo -) ed i sistemi in cui la materia viene riconosciuta come
portatrice di una intrinseca capacità evolutiva, per quanto inconsapevole (questa
capacità evolutiva potrà ravvisarsi o nella materia nel suo complesso che quindi viene
identificata come un unico super-organismo - ateismo cosmoplastico - o nelle sue
singole componenti - ilozoismo -). I sistemi del secondo tipo difetterebbero nel senso
che l’introduzione di un principio spirituale, per quanto immanente, presenterebbe
una pericolosa contiguità con la teologia ed in questo dominio finirebbero per
riconfluire. Le concezioni meccanicistiche manifesterebbero invece l’incapacità di
giustificare, a partire dalle semplici interazioni materiali, fenomeni complessi come la
�311
Gianluca Mori sull’ateismo nella filosofia moderna
generazione della vita per i quali si richiederebbe quel “saltum” che la semplice
combinazione degli elementi sembrerebbe incapace di garantire.
Sotto questo profilo il modello degli ilozoisti apparirebbe più resistente alla
confutazione, anche se Cudworth ritiene che un principio ordinatore distribuito
nell’estensione materiale non rappresenti ancora una soluzione soddisfacente nella
descrizione del reale e del suo divenire. Per questo motivo preferisce ad esso la
postulazione di un principio ordinatore sovra materiale diffuso (le “nature plastiche”)
che, entrando in rapporto diretto con la materia, ne informi l’organizzazione secondo
il disegno dell’intelligenza divina di cui sarebbe strumento “mediatore” rispetto al
piano meramente materiale.
Il lavoro di Bayle, sia pure mediante un procedere argomentativo artificioso, non
soltanto afferma il sostanziale riconoscimento all’ateismo della piena dignità
teoretica e morale, ma sottende altresì il primato della razionalità atea rispetto alla
fede istintiva delle posizioni teistiche.
Il filosofo prende le mosse dalla netta distinzione del dominio della ragione da
quello della fede: la ragione non conferma la fede e la fede non illumina la ragione,
ma il percorso dell’una e dell’altra divergono insanabilmente. Bayle, utilizzando
l’espediente retorico di un’adesione di facciata all’approccio fideistico, che rimarca
apparentemente gli effetti negativi di una ragione corrotta dalla sua stessa superbia,
si procura la libertà di attaccare alle fondamenta l’architettura dogmatica della
teologia cristiana e la stessa visione della divinità, ponendone in risalto le
contraddizioni razionali. In particolare l’azione demolitiva del filosofo si appunta
sulla questione del male e del dolore evidenziando, contro le argomentazioni
teologiche (anche mediante il recupero ed il potenziamento dell’armamentario
argomentativo della filosofia ellenistica), la profonda contraddizione tra gli attributi
morali di Dio (bontà, saggezza, giustizia) e la presenza omnipervasiva del male nella
creazione. Da tale azione demolitiva esce vincente il “male” che vede riconosciuta la
sua autosussistenza ontologica e sconfitto “Dio” che, così come teologicamente
definito, è dimostrato non esistere.
Il secondo movimento del pensiero dell’autore consta nella definizione della
natura di un mondo che è deprivato della sua origine divina. In tal proposito Bayle
oscilla tra i due termini filosoficamente accettabili, già enucleati da Cudworth, di un
evoluzionismo di matrice meccanicistica e di un finalismo immanente. Rispetto ad
un’iniziale propensione per l’impostazione evoluzionistica, Bayle finisce per
propendere per una concezione finalistica di matrice stratoniana, che ravvisa nella
natura un sistema dotato di propria organizzazione efficiente ed intrinseca finalità.
Dopo un capitolo dedicato agli atei clandestini (Meslier, Boulanvillier, Du Marsais
e Fréret) L’autore passa a esaminare le posizioni di John Toland ed Anthony Collins e
del filosofo scozzese David Hume.
Riguardo a Toland e Collins, l’Autore evidenzia come, contrariamente
all’inclusione formale nell’ambito del deismo, questi pensatori manifestino posizioni
�312
S TE FA NO B RA C ALETTI
non qualificabili in tal senso. Assunto che, nell’accezione di impiego comune nel
contesto filosofico seicentesco e settecentesco, tratto caratterizzante minimale del
deismo è la stabile attribuzione all’ente divino “di un’attività progettuale finalizzata”,
Toland, attraverso il suo percorso argomentativo, approda sostanzialmente ad un
modello di realtà basato su differenti presupposti. In primo luogo sull’asserzione che
non si possa distinguere tra Dio a la natura in quanto Dio non è altro che una forza
materiale insita nell’intero universo cosicché, se una distinzione è possibile, questa
può avvenire soltanto per mero discernimento razionale e non in virtù di una
separazione rilevabile osservativamente. Il passaggio complementare è che l’attività
del Dio-natura avvenga senza consapevolezza ed, ancora, senza un orientamento
finalistico, configurandosi così una sorta di eterno “universo statico”. Tutto ciò
caratterizza una posizione coerentemente atea e non deista.
Attraverso la ricostruzione del pensiero di Collins, sono toccati temi quali: la
questione dell’immaterialità dell’anima; la confutazione della prova relativa
all’esistenza di Dio; la dimostrazione dell’inesistenza di Dio; la visione del mondo
risultante dalla esclusione del fattore divino dal campo della realtà. In relazione al
primo punto, rispetto all’asserzione secondo cui a partire dalla materia non possa
giustificarsi l’esistenza del pensiero (nel senso che l’aggregazione di entità discrete
sarebbe incapace di produrre un fenomeno essenzialmente unitario come quello in
esame), Collins contrappone un modello del pensiero come proprietà della materia:
se e quando le parti materiali si organizzano secondo determinati schemi, il pensiero
si genera spontaneamente come prodotto di tale organizzazione. In relazione al
secondo punto, e, cioè l’asserzione dell’esistenza di un Dio dal cui impulso creativo
emerge il mondo materiale, Collins ne trasferisce l’onere probatorio a chi voglia
dimostrare l’esistenza di un Dio con siffatte caratteristiche. In assenza tale di prova
(che i teisti non sono in condizione di offrire) la materia deve ritenersi
autosussistente. Il principio organizzatore della materia per Collins è, quindi, la
materia stessa. In relazione al terzo punto e, cioè, l’asserita dimostrazione
dell’inesistenza di Dio (dimostrazione sulla quale Collins non lascia, peraltro, nulla di
scritto) il contenuto di questa è estrapolato da contributi non organici rispetto alla
soluzione del problema posto e per l’Autore consiste sostanzialmente nell’argomento
non inedito (e già visto in Bayle) secondo cui un Dio i cui attributi connaturali siano
saggezza, santità, bontà declinate con piena potenza, non può generare un mondo in
cui esista il male. Poiché l’esistenza del male è un dato osservativo irrefutabile, se ne
deduce l’inesistenza di Dio. Infine, con riferimento all’ultimo punto, al netto degli
espedienti diretti a dissimulare il proprio pensiero, Collins appare ben orientato a
sostenere una visione del mondo dominato da ferree leggi causali in cui la
deterministica concatenazione dei fenomeni escluda “in toto” qualsivoglia libertà di
arbitrio anche nel campo dell’agire umano.
Il sistema di pensiero di Hume, per il suo carattere empirico strettamente legato
all’indagine concreta del processo mentale, è, in teoria, lontano da temi
�313
Gianluca Mori sull’ateismo nella filosofia moderna
eminentemente metafisico-speculativi quali le problematiche teologiche. Tuttavia,
proprio per la loro stessa natura e per le loro implicazioni, le argomentazioni del
filosofo sono perfettamente idonee a minare nei loro fondamenti i capisaldi della
teologia razionale. Se argomento principe in ordine alla dimostrazione dell’esistenza
di Dio è l’individuazione, nel concetto di Dio, di quella causa prima che ha dato
impulso a tutti gli enti ed al loro divenire, allora il sistema di pensiero di Hume ne
mina alla radice la validità. È noto che per il filosofo scozzese la relazione causaeffetto non ha alcun fondamento oggettivo, universale e necessario, ma è il mero
portato dell’abitudine e della tendenza della psiche umana ad associare fenomeni (tra
i quali sussiste al limite una semplice relazione temporale di “prima” e “dopo”). Se è
così, allora viene a cadere il fondamento stesso del ragionamento per cui, mediante il
riconoscimento dei processi causali naturali e del loro divenire, si perviene,
muovendo a ritroso, a postulare una “causa prima” all’origine della serie causale
universale. Parimenti il pensiero di Hume intacca la validità della stessa “idea di
Dio”. Per Hume, infatti, le idee astratte come entità concettuali poste a priori
semplicemente “non esistono”. Tutte le idee, infatti, hanno natura derivata dalle
percezioni e da queste traggono la loro esistenza. Anche quelle che apparentemente
non trovano una corrispondenza nel campo della percezione, da questa discendono
per l’effetto dell’associazione di idee semplici oggetto della ricombinazione operata
dall’attività mentale. L’idea di Dio, pertanto, non sfugge a tale regolarità e,
mancando una percezione diretta di Dio, non può che concludersi che la relativa
idea sia determinata artificiosamente, unificando una serie di proprietà finite a cui
mentalmente viene attribuita una misura illimitata ed a cui, infine, viene associata
anche l’idea di “esistenza”.
Chiude il libro un capitolo su Voltaire, Diderot e D’Holbach che rappresentano la
conclusione della parabola dell’ateismo. Diderot, passando per un esordio prudente
caratterizzato dalle consuete cautele e dalla mistificazione dei propri reali
intendimenti (prudenza che, peraltro, non gli evitò alcuni mesi di detenzione) ed, in
seguito, con maggiore esplicita risolutezza, si colloca a pieno titolo nel filone
dell’ateismo filosofico. Il pensatore francese appoggia l’argomento forte del proprio
sostanziale ateismo riferendosi al contributo delle scoperte scientifiche, segnatamente
alle tematiche evoluzionistiche. La visione dell’universo e del suo procedere
governato da un disegno intelligente appare confutata dagli stessi tempi incalcolabili
il cui decorso risulta necessario per passare da uno stato iniziale meramente caotico
ad un universo localmente più ordinato, grazie al sorgere casuale di forme di
maggiore stabilità e capacità riproduttiva. Tale immane durata suggerisce
l’operatività di meri fattori stocastici piuttosto che di un disegno intelligente,
cosciente ed intenzionale. Sempre, in questo senso, su un piano più speculativoconcettuale, viene evidenziata in chiave dichiaratamente negatoria l’inadeguatezza
del concetto di Dio in rapporto all’essere ed al divenire del mondo. Diderot ritiene
infatti che il ricorso al piano divino per spiegare l’esistenza e la dinamica del piano
�314
S TE FA NO B RA C ALETTI
mondano, in luogo di fornire una spiegazione convincente dello stato delle cose,
introduca un fattore di ulteriore e peggiore complicazione, restituendo un concetto
della divinità insanabilmente aporetico: sia in termini statico-spaziali - essere
inesteso/essere che occupa estensione, essere che insiste interamente in ogni punto
dell’estensione occupata - sia in termini “dinamici” del rapporto con il mondo essere fuori dal mondo/ essere che agisce nel mondo senza muoversi e, quindi, causa
senza “essere causa”.
Il disvelamento dell’ateismo filosofico trova il suo punto di approdo nell’opera di
D’Holbach la cui precoce vena anticristiana trova compiuta manifestazione nel
Sistéme de la nature nel quale le tesi ateiste sono manifestate coerentemente e senza
alcun tentennamento. Nell’opera citata D’Hobach attinge ed integra il complesso
delle argomentazioni riferibili al filone del pensiero ateo del Sei-Settecento. Tale
sincretismo, se da un lato rende un compendio articolato del pensiero ateo, d’altro
canto, pregiudica spesso la coerenza intrinseca dell’impianto argomentativo
risultante. Tale peculiarità si manifesta ad esempio in relazione alle argomentazioni
sulla capacità della materia di auto organizzarsi e produrre entità anche senzienti. A
tal proposito Diderot, in prima battuta, appare aderire ad una concezione di matrice
meccanicistica in base alla quale le proprietà della materia emergono a partire dal
moto delle singole parti costitutive e dalle particolari configurazioni materiali che di
tale moto sono la risultante. Egli tuttavia introduce poi un problematico
“temperamento” sostenendo che già “ab origine” la materia sia caratterizzata da un
certo polimorfismo per cui ne esistono diversi tipi con qualità e caratteristiche
dinamiche differenti. In ogni caso, indipendentemente dalla perspicuità del proprio
impianto speculativo, viene ravvisata nell’opera del D’Holbach la capacità di
suggellare la tappa conclusiva nell’affermazione del pensiero ateo dei filosofi
moderni contestualmente al superamento della teologia razionale.
Mediante una minuziosa ricerca ed analisi testuale, testimoniata in maniera
significativa dal cospicuo apparato bibliografico proposto, Mori fornisce un vivido
quadro evolutivo del percorso filosofico dei pensatori moderni inserendolo
nell’appropriata prospettiva storica. Il piano delle analisi specifiche orientate alla
ricostruzione del pensiero autentico dei singoli filosofi, è reso solido ed organico dal
loro inserimento un quadro concettuale e definitorio idoneo a cogliere le
problematiche oggetto d’esame. A questo proposito l’autore riesce a delineare
categorie interpretative chiare e ben calibrate rendendo così agevoli, pur senza
ipersemplificazioni, l’esposizione e l’analisi di una materia proteiforme, intessuta di
punti di vista complessi non facilmente inquadrabili in maniera netta. La
ricostruzione storica, inoltre, si fonde lungo tutto il libro con il rigore argomentativo
nel seguire varie problematiche epistemologiche e logiche che la discussione sull’
esistenza o non esistenza di Dio necessariamente implica. Proprio a questo riguardo,
Mori riesce, senza sacrificare il rigore, a guidare in maniera fluida il lettore attraverso
snodi complessi, a volte tortuosi, dove l’argomentazione teologica e strettamente
�315
Gianluca Mori sull’ateismo nella filosofia moderna
logica si sovrappongono costantemente. In questo senso la lettura del libro di Mori
costituisce per il lettore interessato uno stimolante esercizio di pensiero e non solo un
acquisizione di informazioni. Dal punto di vista della storia culturale, il testo
restituisce un quadro netto vivido di quanto sia stato arduo, non scontato, rischioso,
Il cammino per arrivare alla visione del mondo contemporanea - che informa di sé
anche la vita quotidiana - in grado di scindere le problematiche religiose da quelle
scientifiche e morali. A questo proposito, il lavoro di Mori, pur preservando il rigore
scientifico e il necessario tecnicismo espositivo, è aperto alla agevole consultazione di
chiunque desideri ricercare un valido approfondimento di un passaggio
fondamentale del rapporto tra il momento della speculazione filosofica ed il pensiero
religioso nell’evoluzione culturale della civiltà occidentale.
�316
�317
Etica & Politica / Ethics & Politics, XX, 2018, 1, pp. 317-324
ISSN 1825-5167
IL FENOMENO “VIVENTE”
AGO ST I NO CE RA
ABSTRACT
This paper discusses Carmine Di Martino’s last work Viventi umani e non umani. Tecnica,
linguaggio e memoria (Edizioni Libreria Cortina, Milano 2017, pp. 204). The book deals with two
main questions, i.e. the anthropogenesis and the comparison between human and non-human
living beings (notably, anthropomorphic apes), with reference to three topics: technology, language
and memory. In particular, these pages highlight the phenomenological bon sens that the author
chooses to approach the vexed question regarding the relation between “the two cultures”. That is
to say, besides encouraging an authentic (i.e. radical and equal) dialogue between philosophy and
sciences, he vindicates the epistemological peculiarity and the consequent irreplaceable role of the
philosophical thought.
KEYWORDS
Humans-animals differences, phenomenology, Husserl, psychology, palaeoanthropology.
L’ultimo lavoro di Carmine Di Martino (Viventi umani e non umani. Tecnica,
linguaggio e memoria, Edizioni Libreria Cortina, Milano 2017, pp. 204) si pone in
rigorosa continuità con un percorso di ricerca consolidato negli anni, che si nutre di
una meritoria osmosi tra attività didattica e di ricerca. Tanto questo libro, infatti,
quanto il suo pendant (Segno, gesto, parola. Da Heidegger a Mead e Merleau-Ponty
ETS, Pisa 2005) 1 sono nati e cresciuti nell’alveo dei corsi tenuti presso l’Università
Statale di Milano, dove l’autore è docente di Filosofia Teoretica.
Il tema al centro del libro è quanto mai attuale: il confronto tra uomo e animale
rideclinato a partire da “l’irrompere della ‘vita’ e dei ‘viventi’ come problema
scientifico, filosofico, etico, giuridico e politico insieme” nel nostro tempo. In
concreto, ci si muove “sull’asse della duplice questione dell’antropogenesi e del
confronto tra viventi umani e non umani, con particolare riferimento ai primati non
umani” 2. Tanto maggiore, data l’attualità e l’interesse suscitato dal tema, il rischio di
ridondanza. Proprio l’abilità con cui il testo si sottrae a un tale rischio rappresenta la
Tr. fr., Signe, geste, parole: De Heidegger à Mead et Merleau-Ponty, Hermann, Paris 2015.
C. Di Martino, Viventi umani e non umani. Tecnica, linguaggio e memoria, Libreria Cortina,
Milano 2017, pp. 9-10.
1
2
�318
A GOSTINO C E RA
sua virtù principale. Circa il bon sens fenomenologico di cui esso si fa latore diremo
in conclusione, dopo averne illustrato per sommi capi: temi, finalità e metodo.
Dei cinque capitoli nei quali si struttura la ricerca, i primi due rappresentano una
sorta di premessa, rispettivamente tematica e metodologica: vi si definisce il già
menzionato tema generale (l’antropogenesi come prodotto di un approccio
analogizzante tra viventi umani e non umani), tracciando modalità e limiti
dell’incontro tra fronti epistemici – scientifico e filosofico – che l’autore riconosce
essere diversi ma non avversi. Seguono tre capitoli nei quali le regole d’ingaggio
appena guadagnate vengono testate al cospetto di altrettante parole chiave della
questione antropogenetica: tecnica, linguaggio e memoria. Ognuno dei capitoli
presenta un interlocutore privilegiato con le cui posizioni viene inscenato un serrato
confronto.
Il primo capitolo – Pensare animali che pensano – affronta la domanda “ma gli
animali pensano?” a partire dall’impostazione che ne ha proposto recentemente
Michael Tomasello nel suo A Natural History of Human Thinking (2014) 3, laddove si
cerca di ricostruire una “storia naturale del pensiero” ovvero di illustrare l’avvento
del “pensiero unicamente umano”. La posizione di Tomasello è piuttosto nota.
Muovendo dall’assunto che vi è pensiero quando vi è “intenzionalità individuale”,
ossia “quando un organismo cerca di risolvere un problema […] immaginando che
cosa accadrebbe se nella situazione data esso agisse in un certo modo o
intervenissero delle forze esterne” 4, si perviene alla conclusione che le grandi
scimmie antropomorfe dimostrerebbero una simile capacità. Sul tronco di questo
approccio continuista tra pensiero animale e umano si innesta l’interlocuzione
prettamente filosofica, che Di Martino, in ossequio alla sua formazione
fenomenologica, declina in chiave husserliana. Al netto degli indubbi meriti del
lavoro di Tomasello, alla filosofia spetta il compito di interrogare l’orizzonte
manifestativo dei suoi oggetti, scongiurando il rischio di una loro indebita
ontologizzazione, naturalizzazione. Con ciò il pensiero filosofico si fa carico di un
“antropocentrismo produttivo” 5, che assumendosi per intero la propria, peraltro
inaggirabile, parzialità dissacra lo idolum di una conoscenza priva di presupposti,
ponendo la questione di “chi” pensa le scimmie che pensano.
Il secondo capitolo (Per una fenomenologia dei viventi), il più lungo e il nucleo
epistemico-metodologico del testo, sostanzia questa integrazione filosofica ai
presupposti della scienza attraverso un confronto serrato con l’interpretazione
husserliana della differenza antropologica. Facendo uso soprattutto del materiale
raccolto nel volume XV della Husserliana (in particolare, dell’appendice X: Welt und
3
Tr. it., Unicamente umano. Storia naturale del pensiero, a cura di M. Ricucci, il Mulino, Bologna 2014.
4
Ivi, p. 21.
C. Di Martino, Viventi umani e non umani, cit., p. 27.
5
�319
Il fenomeno “vivente”
Wir. Menschliche und tierische Umwelt) 6, questa interpretazione viene ricostruita
puntualmente, anche nella sua evoluzione interna (suscitata dall’incontro di Husserl
con l’opera di Lucien Lévy-Bruhl), per essere a sua volta sottoposta ad analisi critica.
La tematizzazione fenomenologica della differenza antropologica si inscrive nella
“chiarificazione della concreta (inter)soggettività trascendentale che costituisce il
mondo umano” 7. La distinzione tra uomo e animale viene cioè posta sulla base di un
accesso intenzionale alla struttura dei viventi ovvero ricavata dalle rispettive IchStrukturen, le quali risultano i correlati di differenti strutture di esperienza del
mondo. Con ciò l’umanità dell’uomo coincide con il suo essere persona, una
dimensione che si compie nella combinazione dei requisiti di: culturalità, storicità e
temporalità. La prima consiste in una significazione che investe il rapporto con
l’intero mondo ambiente: i membri di un mondo si sanno membri di un mondo
condiviso e caratterizzato da un perenne mutamento. Quest’ultimo, del quale il
mondo animale (improntato alla ripetizione) risulterebbe sprovvisto, emerge come
tratto dirimente della storicità: quella coscienza del tempo che l’animale –
geschichtlos e zeitlos – non possiede. In forza di essa l’uomo perviene a quella visione
panoramica (Überschau) su se stesso che ne fa, in senso pieno, un “essere razionale”.
Pertanto, l’io personale è quello che sa essere oggetto di se stesso.
D’altra parte, impostando la differenza uomo-animale su un accesso intenzionale
alla struttura dei viventi, la fenomenologia si rivela poco sensibile al tema dell’origine
e a quello della continuità o discontinuità evolutiva. Questa potenziale carenza, che
potrebbe porla in imbarazzo al cospetto delle acquisizioni conseguite da discipline
come la psicologia sperimentale o la paleoantropologia, risulta compensata dalla sua
capacità di scoprire lo “apriori universale della correlazione”, di evidenziare, cioè, il
terreno di esperienza che implicitamente vige in ogni approccio scientifico. Alla
fenomenologia spetta così il compito di ricordarci che gli ‘oggetti’ delle scienze sono
rivelazioni interne a una esperienza (“all’esperienza che noi abbiamo di noi stessi e
del mondo”; un ‘noi’ “sempre qualificato da una determinata prospettiva” 8), il che ci
consente di apprezzarne le conquiste senza l’obbligo di sottoscrivere l’obiettivismo
con cui ci vengono presentate.
Forte di questo assunto epistemico, corrispondente alla consapevolezza che i
“fatti” della ricerca scientifica sono sempre fatti di determinati “modelli”, il terzo
capitolo – Tecnica e antropogenesi – propone un confronto più diretto con la
Cfr. E. Husserl, Husserliana Band XV, Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem
Nachlass. Dritter Teil: 1921-1928, hrsg. von I. Kern, Nijhoff, Den Haag 1973. Della citata appendice X esiste
una traduzione italiana, curata dallo stesso Di Martino, dal titolo: Il mondo e noi. Mondo-ambiente umano e
animale, in «Animal studies. Rivista italiana di antispecismo», n. 16/2017, pp. 10-22.
6
7
8
C. Di Martino, Viventi umani e non umani, cit., p. 29.
Ivi, p. 81.
�320
A GOSTINO C E RA
questione antropogenetica attraverso “l’abbozzo di una storia dell’ominazione di stile
filosofico”, che culmina nell’idea di una “tecnogenesi preterintenzionale
dell’umano” 9. Una posizione puntellata anzitutto dal confronto con l’opera di André
Leroi-Gourhan, che nei due volumi del suo capolavoro, Le geste et la parole 10,
decostruisce il paradigma cerebralista, sancendo nella locomozione “il fatto
determinante dell’evoluzione biologica”. L’assunzione della stazione eretta, lo
svolgersi di questa “podologia generale”, si accredita come “il nostro Rubicone” 11:
l’instantia crucis nel processo di ominazione.
Se la liberazione della mano e della bocca corrispondono ai due poli della
tecnicità (del gesto e della parola), l’utensile rappresenta in qualche modo una
“secrezione del corpo e del cervello degli antropiani” 12, al punto che pare lecito
applicare a tale ‘organo artificiale’ le stesse norme degli ‘organi naturali’. La stazione
eretta fa infatti emergere in primo luogo la protesi intrasomatica dell’uomo, quel
decisivo archeostrumento che è la mano. In forza di questo suo connaturato lusso
evolutivo, l’uomo inaugura il proprio destino tecnico, che lo porta a plasmare in
maniera sempre più invasiva il proprio ambiente, venendone a sua volta
irrimediabilmente modificato. Qui Di Martino mostra di maneggiare con notevole
perizia spunti ulteriori ed eterogenei con i quali arricchisce il discorso gourhaniano.
Il riferimento alle ormai classiche ricerche di Vygotskij e Lurija gli consente di
chiarire in modo più efficace il possibile discrimine tra l’agire strumentale
dell’animale e quello propriamente tecnico dell’uomo. A differenza del primo,
quest’ultimo è in grado di produrre opere, ovvero di conservare i propri mezzi,
nonché di innescarsi anche indipendentemente dall’immediata pressione ambientale.
È questa la chiave di volta affinché si possa parlare, di lavoro, cultura e infine di quel
mondo culturale-storico la cui presenza Husserl poneva al centro della differenza
antropologica.
A tale proposito, ci sia concessa una menzione – motivata dai nostri precipui
interessi di ricerca – all’impiego che l’autore fa della riflessione di quel geniale
antesignano dell’antropologia filosofica che fu Paul Alsberg, autore della teoria della
Körperausschaltung 13: l’idea che l’evoluzione tecnica dell’uomo si sposi a una
corrispondente “regressione corporea”. Ne segue che mentre “il principio evolutivo
Ivi, p. 105.
Tr. it., Il gesto e la parola, 2 voll. (vol I: Tecnica e linguaggio; II: La memoria e i ritmi), a cura di
F. Zannino, Einaudi, Torino 1977.
11 Cfr. C. Di Martino, Viventi umani e non umani, cit., pp. 86-90.
12 A. Leroi-Gourhan, Il gesto e la parola vol. I, cit., p. 109.
13 Cfr. P. Alsberg, Das Menschheitsrätsel (1922), ristampa: Der Ausbruch aus dem Gefängnis – zu
den Entstehungsbedingungen des Menschen, Focus-Verlag, Gießen 1975. Il riferimento ad Alsberg
suggerisce un’ulteriore suggestione: quella relativa alla stretta implicazione esistente tra la rinascita
dell’antropologia filosofica e la nascita di una consapevole filosofia della tecnica. Vale a dire: tra Paul
Alsberg ed Ernst Kapp (autore di Grundlinien einer Philosophie der Technik, 1877) ovvero tra
Körperausschaltung e Organprojection.
9
10
�321
Il fenomeno “vivente”
dell’animale è quello dell’‘adattamento corporeo’ (Körperanpassung), il principio
evolutivo dell’uomo è quello della ‘disattivazione corporea (Körperausschaltung)
mediante strumenti artificiali’” 14. Ciò spiega l’importanza decisiva dell’“effetto di
ritorno” della tecnica sull’uomo e la conseguente interazione, fino all’indistricabilità,
tra evoluzione biologica e culturale.
Giunti a questo punto, il terreno risulta approntato per l’inserimento del secondo
medium decisivo nel processo di tecnogenesi/ominazione: la parola, il linguaggio. La
capacità di significazione si accredita come la svolta per il successo evolutivo
dell’uomo, in particolare per la produzione del tipo dell’uomo razionale. Come
dimostrano, tra gli altri, gli studi di Eric Havelock, la scrittura alfabetica,
sublimazione della capacità significante, consente il primato dell’ocularità
(teoreticità),
l’emancipazione
dall’oralità
e
una
possibilità
di
registrazione/archiviazione in precedenza inimmaginabile. Detto in termini
gehleniani: essa aumenta esponenzialmente la capacità di esonero dell’uomo dai
vincoli somatici e, più in generale, naturali. Anche in questo caso, l’effetto reciproco
risulta determinante: lo sviluppo della memoria umana, ad esempio, apparirebbe
inspiegabile se non come retroazione della comparsa del linguaggio.
Avendo la paleantropologia attuale ribadito la centralità del linguaggio e posto con
forza rinnovata il tema della sua apparizione, il quarto capitolo – Il sapere della
parola – propone un confronto inziale con le posizioni espresse da Ian Tattersall in
Masters of the Planet: The Search for Our Human Origins (2012) 15, integrate da
quelle di Michael Corballis e, nuovamente, di Tomasello. Nella querelle tra innatisti
ed antinnatisti rispetto alla questione della nascita del linguaggio, Di Martino si
schiera dalla parte dei secondi, sancendo un primato della dimensione pragmatica
che si richiama a Wittgenstein e Mead. L’enigma del linguaggio ha a che fare con la
peculiarità del processo di sociogenesi umano, culminante nella strutturazione della
“intenzionalità del noi” (Searle) ovvero nel passaggio da una “intenzionalità
congiunta” a una “intenzionalità collettiva o condivisa” (Tomasello).
Nel suo essere strutturalmente pubblico e intersoggettivo, il segno si dimostra la
sede naturale per la nascita del significato, al quale risulta connaturata la dimensione
ideale, nel senso che “il diventare segno del suono e il diventare ideale del significato
(dello schema) sono le due facce di uno stesso evento”. Per sostenere questa genesi
pragmatico-evenemenziale del processo di significazione contro ogni riabilitazione di
un approccio platonizzante, l’autore si rifà alla via indiretta percorsa da Corballis in
From Hand to Mouth: The Origins of Language (2003) 16 e ripresa da Tomasello, la
P. Alsberg, Der Ausbruch aus dem Gefängnis, cit., p. 49.
Tr. it. I signori del pianeta. La ricerca delle origini dell’uomo, a cura di A. Panini, Codice, Torino
2013.
16 Tr. it. Dalla mano alla bocca. Le origini del linguaggio, a cura di S.Romano, Raffaello Cortina,
Milano 2008.
14
15
�322
A GOSTINO C E RA
quale pone il gesto come antesignano del segno nella sua funzione di correlato del
significato, distinguendo tra gesti deittici e mimici/iconici. Proprio il gesto sarebbe
alla base di quella svolta cooperativa che avrebbe decretato, circa due milioni di anni
fa, il successo evolutivo della nostra specie. Mentre il gesto deittico ritaglia e fa venire
in presenza la ‘cosa’, il gesto iconico risulta “il primo esercizio di ‘pittura’, di
reduplicazione del mondo” 17, realizzato nella sfera dei viventi. Esso dischiude
l’inedita possibilità di “costruire scenari finzionali con e per gli altri” e prepara la
strada all’avvento della parola, il cui potere coincide con il sapere che rende possibile.
Se da un lato con il linguaggio possiamo avere il mondo, dall’altro il sapere della
parola ha a che fare con l’autocoscienza. “Parlare è sempre parlarsi”. E, con ciò,
sapersi 18.
L’ultimo capitolo – Ricordare – completa il novero delle domande chiave
dell’antropogenesi, ponendosi la questione “gli animali ricordano?”, a integrazione
delle precedenti “gli animali pensano?” e “gli animali parlano?”. In concreto, viene
indagato il rapporto tra temporalità e rimemorazione umana e animale, partendo
anche in questa occasione dalla riflessione husserliana, integrata con le acquisizioni
della psicologia sperimentale.
Ponendo uno stretto legame tra percezione e ricordo, Husserl distingue tra
“ricordo primario” e “secondario” e, conseguentemente tra “presentazione” e
“presentificazione”. La prima si fonda sulla sintesi passiva di “impressione-ritenzioneprotenzione”: confondendosi di fatto con la percezione, essa non corrisponde a un
ricordo vero e proprio, laddove la presentificazione ri-presenta l’oggetto ora assente
ed è perciò un atto libero (prossimo alla fantasia), che Husserl definisce
rimemorazione (Wiedererinnerung). Impostato il tema in questi termini, la coscienza
potrebbe, in linea di principio, “rimemorare/ripresentarsi l’intero passato davanti a
sé”, in una pienezza intuitiva, dal momento che, “a rigore, la ritenzione è ‘infinita’ e
senza vuoti” 19. La difficoltà della posizione husserliana emerge al cospetto della
questione del perché i bambini molto piccoli, gli uomini primitivi o gli stessi animali
sembrino non avere dei veri ricordi.
Utilizzando acquisizioni recenti della psicologia sperimentale, Di Martino
contrappone Husserl a Husserl, obiettandogli le sue stesse considerazioni su mondo
ambiente animale e umano esposte nel secondo capitolo. A tale scopo si serve di un
saggio di Thomas Suddendorf e Michael Corballis 20, che sulla scia del lavoro dello
psicologo estone Endel Tulving indagano la questione del “foresight”, del “viaggiare
mentalmente nel tempo” (la facoltà che permette agli esseri umani di “proiettarsi
Cfr. C. Di Martino, Viventi umani e non umani, cit., p. 154.
Cfr. ivi, p. 161. Su questo tema si veda anche Id., Segno, gesto, parola, cit., pp. 133-195.
19 Id., Viventi umani e non umani, cit., p. 172.
17
18
Th. Suddendorf, M. Corballis, The Evolution of Foresight: What Is Mental Time Travel and Is It
Unique to Humans?, in «Behavioral and Brain Sciences», 30, 3, 2007, pp. 299-313.
20
�323
Il fenomeno “vivente”
mentalmente indietro nel tempo oppure in avanti” 21) in uomini e animali. La
psicologia sperimentale spiega la possibilità del viaggio mentale nel tempo/ricordo a
partire da una tassonomia standard della memoria, che culmina nel rapporto tra
“memoria episodica” e “memoria semantica” (le due parti della “memoria
dichiarativa”, a sua volta partizione della “memoria a lungo termine”) 22. La memoria
semantica contiene l’insieme degli schemi e dei significati caratterizzanti una
comunità umana, richiede la mediazione di un sistema di segni e si trova perciò in
un rapporto costitutivo con il linguaggio, mentre quella episodica consente l’accesso
immediato a eventi vissuti in prima persona. In questo modo si chiarisce il limite
dell’analisi husserliana, nella insufficiente attenzione che essa dedica al ruolo della
dimensione culturale e sociale del ricordo (ovvero della memoria semantica), messa
in luce invece dalla psicologia sperimentale.
L’ipotesi avanzata da Di Martino è che “per ricordare non basta la ritenzione di
sensi percettivi […] ma occorre la simbolizzazione linguistica dell’esperienza”.
Memoria episodica e linguaggio, ricordare e parlare sono essenzialmente intrecciati.
In altri termini: “se gli animali e gli infanti non hanno memoria episodica è perché
essi […] non hanno un linguaggio” 23. Non basta che qualcosa sia accaduto e sia stato
percepito perché noi lo ricordiamo, nel senso della memoria episodica. Per ricordare
eventi e particolari occorre che l’accadere sia “tradotto” in significati. Il rapporto tra
memoria episodica e memoria semantica “inscrive costitutivamente l’atto del ricordo
nella comunità umana ‘empatica e linguistica’, cioè nell’elemento del significato:
saputo, condiviso, e continuamente cercato” 24.
In tal modo, le tre variabili del processo antropogenetico (tecnica, linguaggio e
memoria) indagate nei tre capitoli conclusivi si mostrano accomunate da un
peculiare principio eziologico: “un’altra causalità – circolare, cibernetica, non lineare
–, al cui centro vi è la dimensione interattiva, relazionale, complessa” 25. Dette
variabili non si danno se non in forza dell’interazione di una serie di componenti,
caratterizzata da un costante effetto reciproco, in virtù del quale il conseguente
produce retroattivamente effetti sull’antecedente, trasformandolo in modo radicale e
alterando la stessa gerarchia eziologica di partenza.
A chiusura di questa “nota critica” vorremmo, come anticipato, spendere qualche
parola riguardo a quel bon sens fenomenologico, che ci è parso il principale, tra i non
pochi pregi, del lavoro di Di Martino. Il quale sceglie di prendere posizione senza
ambiguità rispetto alla tensione, mai sopita, tra le due culture. Senza ambiguità e al
Ivi, p. 299.
Cfr. E. Tulving, Episodic and semantic memory, in Id., W. Donaldson (Eds.), Organization of
Memory, Academic Press, New York 1972, pp. 381-402.
23 C. Di Martino, Viventi umani e non umani, cit., p. 196.
24 Ivi, p. 204.
25 Ivi, p. 155.
21
22
�324
A GOSTINO C E RA
contempo senza inutili enfasi militanti: una scelta di equanimità (di bon sens,
appunto), corroborata da una prosa che sa abbinare al rigore analitico il valore della
chiarezza e il pregio della leggibilità. Da un lato, l’autore non si rassegna all’idea che
qui e ora alla filosofia spetti al massimo il ruolo ancillare di confezionare le
acquisizioni della ricerca scientifica, la quale, per vocazione, sarebbe invece portata a
‘badare al sodo’. Più precisamente, non si assiste qui a un ulteriore tentativo di
‘legittimazione passiva’ della ricerca filosofica attraverso la coniazione dell’ennesimo
‘neuro-qualcosa’. Dall’altro lato, la rivendicazione di questa peculiarità (se non
differenza) epistemica della filosofia rispetto alle scienze non passa per la via più
facile, ma anche più deleteria: l’arroccamento snobistico dietro il proprio blasone,
anticamera certa di un destino antiquario. Al contrario, la strada battuta è quella ben
più ostica della ricerca e della richiesta di una piena interlocuzione con il fronte
epistemico opposto: di un dialogo autentico, che come tale ha per condizione
ineludibile il riconoscimento reciproco tra diversi. Un riconoscimento rivendicato
esponendo le ragioni per le quali la filosofia ha ancora (sempre) qualcosa da dire alle
scienze, ossia per le quali esse hanno ancora (sempre) qualcosa da lasciarsi dire dalla
filosofia. La ricerca filosofica possiede la virtù intrinseca di sabotare l’inerzia
naturalizzante, ontologizzante radicata nella pratica scientifica, facendo “entrare in
linea di conto la propria soglia osservativa” 26, ricordando che essa è sempre il
prodotto di rivelazioni interne a una esperienza.
Sta qui questo il senso del richiamo dell’autore a una attualità della fenomenologia
e del magistero husserliano, che più che di merito o di metodo è di atteggiamento. Di
ispirazione. Vale a dire che, a dispetto della celebre quanto infelice sentenza
heideggeriana, la scienza pensa eccome. Alla filosofia spetta il compito di non
lasciarla pensare da sola, senza interlocuzione. È dunque “nella sua fedeltà sempre
rinnovata alla manifestatività”, che consiste anche “la dimensione anti-idolatrica
della fenomenologia e il motivo della sua filosofica irrinunciabilità” 27.
26
27
Id., Segno, gesto, parola, cit., p. 10.
Id., Viventi umani e non umani, cit., p. 82.
�325
Etica & Politica / Ethics & Politics, XX, 2018, 1, pp. 325-339
ISSN 1825-5167
DIRITTO COSMOPOLITICO E
RAGIONE IN KANT 1
A NGE LO CI CAT E LLO
Università di Palermo
Dipartimento di Scienze Umanistiche
cicatello@gmail.com
ABSTRACT
From Kant’s cosmopolitan proposal, over and above its placing within the more specific space of
doctrine of right, important elements emerge in connection with the project of a “critique of
reason”, considered in all its architectural extension, and therefore, ultimately, in relation to what
Kant really means by “human reason”. And indeed – this is the hypothesis that guides the present
work – precisely starting from what the treatment of cosmopolitan law reveals about the
complexity of the concept of reason it becomes possible to understand in a theoretically informed
way the meaning of the political-legal proposal that pervades Kant’s late maturity. In order to
verify this hypothesis, the present paper aims, first of all, to highlight the elements of tension in
Kant’s text which, if they do not always justify, certainly encourage the proliferation of various,
often not reconcilable readings of cosmopolitan law and the theme of hospitality; secondly, it aims
to reconsider cosmopolitan law in a broader perspective, linked to the way in which Kant conceives
the relationship between humanity and rationality; and finally, in the light of this perspective, to
re-examine the antagonistic tension that, within the Kantian concept of hospitality, runs through
the relations between visitor and visited, host and guest.
KEYWORDS
Kant, cosmopolitan law, human reason, community, mutual action
1. Quale posto occupa nel pensiero di Kant il riferimento ad un diritto
cosmopolitico? Che ruolo gioca nel progetto di costruzione di una pace mondiale? E
1
Per le opere di Kant si fa riferimento al testo dell’Akademie-Ausgabe (Kants Gesammelte
Schriften, hrsg. von der Preußischen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1902 sgg.), indicato con la
sigla AA, cui segue immediatamente l’indicazione del numero del volume e del numero di pagina. Fa
eccezione la Kritik der reinen Vernunft (=KrV) che viene, invece, citata nelle pagine della prima e
seconda edizione originale (A e B). Per le lezioni di Kant sul diritto naturale (manoscritto Naturrecht
Feyerabend, relativo al semestre estivo del 1784) si fa riferimento a H. Delfosse – N. Hinske – G. Sadun
Bordoni, Kant-Index, Bd. 30, Frommann-Holzboog, Stuttgart 2010-2014.
�326
A NGE LO C IC A TELLO
ancora: in relazione a chi si rende necessario pensare un diritto che faccia da
complemento, come Kant esplicita, al diritto statuale e al diritto internazionale?
Il diritto cosmopolitico, in quanto facente riferimento ad un “universale Stato di
uomini” 2 o ad una cittadinanza della Terra che va al di là dell’appartenenza giuridica ad
una determinata realtà statuale, non assume in Kant una forma istituzionale precisa. E
ciò ha contribuito ad alimentare più di un sospetto sulla funzione che un diritto siffatto
può svolgere effettivamente nel contesto di un progetto politico di pace mondiale 3, al di
là del generico appello ad una non meglio identificabile comunità universale di uomini.
D’altro canto, ciò non significa che non si diano posizioni interpretative che, pur
evidenziando la resistenza kantiana ad ogni forma di applicazione transnazionale del
diritto cosmopolitico, non esitano, però, a riconoscere la consistenza e la validità del
progetto cosmopolitico di Kant anche sul piano stricto sensu giuridico 4.
Ritengo tuttavia che dalla proposta cosmopolitica di Kant, al di là della collocazione
che essa trova all’interno dello spazio più specifico della sua dottrina del diritto,
emergano elementi altrettanto rilevanti in connessione con il progetto di una “critica
della ragione”, considerato nella sua intera estensione architettonica, e dunque, in
definitiva, in relazione a quel che Kant intende propriamente per “ragione umana”. E
semmai – questa l’ipotesi che guida il presente lavoro – proprio a partire da quel che la
trattazione del diritto cosmopolitico rivela in merito alla complessità del concetto di
ragione si rende possibile comprendere in modo teoreticamente avvertito il significato
della proposta politico-giuridica che innerva gli scritti della tarda maturità kantiana.
Nell’intento di verificare questa ipotesi, il presente contributo si propone, anzitutto,
di evidenziare gli elementi di tensione del testo kantiano che, se non sempre
giustificano, certo però incoraggiano il proliferare di diverse letture, spesso tra loro non
conciliabili, del diritto cosmopolitico e del tema dell’ospitalità; in secondo luogo, di
riconsiderare il diritto cosmopolitico secondo una prospettiva più ampia, legata alla
modalità in cui Kant concepisce il rapporto tra umanità e razionalità; e, infine, di
ridiscutere in radice, alla luce di questa prospettiva, la tensione antagonistica che, in
2
I. Kant, Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf (=ZeF), AA 08: 349. Anm .; tr. it. Per la
pace perpetua . Un progetto filosofico, in I. Kant, Scritti di storia, politica e diritto, di F. Gonnelli, p.
169, nota.
3
Mori sostiene, ad es., che il Terzo articolo definitivo per la pace perpetua «svolge [...] una funzione
marginale nell’economia dell’opera e [che] la critica ha spesso sopravvalutato il significato che esso
riveste nel quadro del pacifismo e, a volte, dell’intera filosofia giuridica di Kant» (M. Mori, La pace e la
ragione. Kant e le relazioni internazionali: diritto, politica, storia , il Mulino, Bologna 2004, p. 147). Si
tratta di una valutazione che insiste sulla riluttanza di Kant a far rientrare le prerogative messe in gioco
dal diritto cosmopolitico in un sistema giuridico sovranazionale il cui potere cogente vada al di là del
potere di autodeterminazione dei singoli stati sovrani. Tale riluttanza renderebbe, di fatto, “lettera
morta”, perché priva di qualsiasi cogenza giuridica esterna, l’idea di una cittadinanza cosmopolitica in
forza della quale gli individui possano essere considerati come sottoposti ad un’autorità diversa rispetto
a quella dello Stato in cui vivono (Cfr. Ibidem ).
4
Cfr. ad es. l’analisi circostanziata di P. Kleingeld, Kant’s Cosmopolitan Law: World Citizenship for
a Global Order, in «Kantian Review», 2/1998, pp. 72-90, in part. pp. 81-84, 86-87.
�327
Diritto cosmopolitico e ragione in Kant
seno al concetto kantiano di ospitalità, attraversa i rapporti tra visitatore e visitato,
ospite e ospitato.
I “cittadini della Terra” 5 di cui Kant ragiona in relazione al progetto di una società
cosmopolitica si presentano, in prima istanza, come coloro i quali possono muoversi
liberamente lungo l’intero pianeta senza essere trattati come nemici al loro primo
ingresso in terra d’altri. E possono far ciò in ragione di un “diritto di visita
(Besuchrecht)” che spetta ad ogni uomo in base al “diritto al possesso comune della
superficie della Terra”6. Il diritto al possesso comune del suolo coincide con un diritto
di superficie che non è ancora diritto di proprietà. Esso esprime, infatti, quella
caratteristica del suolo terrestre per cui esso è accessibile in linea di principio ad ogni
uomo, in quanto costituisce un intero che, perché tale, non è concepibile in termini di
parcellizzazione proprietaria. Della proprietà il possesso comune del suolo costituisce,
piuttosto, la condizione in quanto rappresenta la premessa di quell’atto arbitrario
mediante il quale viene stabilito il primo possesso su un territorio.
Da un lato, dunque, l’idea di una comunità originaria del suolo è ciò a partire da cui
soltanto può prendere legittimamente avvio il processo mediante il quale si acquisisce
la proprietà di un territorio:
Impadronirsi di un terreno isolato costituisce un atto di arbitrio privato, senza tuttavia
essere autoritario. Chi se ne impossessa si basa sul possesso comune innato della terra
[auf dem angebornen Gemeinbesitze des Erdbodens] e sulla corrispondente volontà
generale a priori riguardo a un lecito possesso privato di essa (perché altrimenti le cose
disponibili dovrebbero essere trasformate da sé e in base a una legge di cose senza
padrone) e acquista mediante la prima presa di possesso originaria un terreno
determinato, opponendosi con diritto (iure) a chiunque volesse impedirgliene l’uso
privato [...]7.
5
I. Kant, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (=Anth), AA 07: 333; tr. it. Antropologia dal
punto di vista pragmatico, di G. Garelli, Einaudi, Torino 2010, p. 352.
6
ZeF, AA 08: 358; tr. it. p. 177. Nella Metafisica dei costumi si parla in questo senso del «diritto di
tutti gli abitanti della terra di ricercare (versuchen) una comunità universale e di visitare (besuchen) a
questo scopo tutte le regioni della terra» (I. Kant, Metaphysik der Sitten (=MS), AA 06: 353; tr. it.
Metafisica dei costumi, di G. Landolfi Petrone, Bompiani, Milano 2006, p. 317).
7
MS, AA 06: 250; tr. it. pp. 101-103. Nel manoscritto del Naturrecht Feyerabend si legge: «La
proprietà inizia con l’occupazione delle cose. Da ciò sorgono obligationes negativae, che altri devono
astenersi da tutto ciò che qualcuno ha occupato. Che cosa è necessario a tal fine? Attestare che si è
preso possesso della cosa. Poiché si deve presumere che egli abbia anche voluto appropriarsi di essa. Se
io vedo che qualcosa è nel potere di un altro, non posso sottrargliela, perché non so se gli reco un torto.
La mera volontà dell’altro non può limitarmi rispetto alle cose in suo possesso, bensì solo la cosa, che è
un prodotto della libertà, in quanto io allora agisco contro la libertà dell’altro (Kant-Index, Bd. 30, cit.,
Teilband II: Abhandlung des Naturrecht Feyerabend: Text und Hauptindex, 2014, pp. 1343-1344; tr. it.
in I. Kant, Lezioni sul diritto naturale, a cura di N. Hinske e G. Sadun Bordoni, Bompiani, Milano
2016, pp. 121-123). Sul nesso intrinseco che, nella prospettiva kantiana, lega proprietà e relazioni
interpersonali cfr. T. Patrone, Kant’s Rechtlehre and Idea of Reason, in S. Baiasu – S. Pihlström – H.
Williams (eds.), Politics and Metaphysics in Kant, University of Wales Press, Cardiff 2011, pp. 115-133;
�328
A NGE LO C IC A TELLO
In ragione di ciò Kant afferma: “La prima presa di possesso ha [...] un fondamento
giuridico per sé (titulus possessionis), che è il possesso comune originario”8.
D’altro canto, proprio perché originario, il possesso comune del suolo ricorda a chi
ha stabilito la proprietà su una parte di esso che quella parte non cessa per questo di
essere parte di un tutto e, in quanto tale, non può di principio costituire un luogo
inaccessibile ad altri:
[... ] il possesso del suolo sul quale possono vivere gli abitanti della terra può essere
pensato sempre soltanto come possesso di una parte di un tutto determinato, quindi
come quello sul quale ognuno ha un diritto originario .
9
Come spiega bene Muthu, “L’argomento di Kant è che non possiamo presumere dal
semplice fatto di possedere legittimamente un territorio che questo ci dia l’autorità e il
diritto di escludere del tutto altri da esso” 10.
In Per la pace perpetua Kant afferma, non a caso, che in forza del diritto al possesso
comune della superficie terrestre, “[...] originariamente nessuno ha più diritto che un
altro a stare in luogo di essa”11. Il diritto cosmopolitico dello straniero di non essere
trattato in modo ostile al suo arrivo in terra d’altri, in quanto è fondato sul possesso
comune originario del suolo, sta, allora, a ricordare che ogni acquisizione rimanda ad
un atto che, per quanto ricompreso nello spazio di legittimità del diritto, si presenta nel
suo gesto iniziale arbitrario. E in considerazione di tale arbitrarietà anche il possessore
legittimo di un territorio conserva comunque un obbligo nei riguardi dello straniero in
visita, l’obbligo di non trattarlo in modo ostile e di non respingerlo, quando il
respingerlo comportasse un pericolo per la sua vita.
Il diritto cosmopolitico di visita definisce, dunque, i tratti etici di una idea di
comunità che si estende agli abitanti della Terra, nel senso che, in forza del possesso
comune originario del suolo, tutti hanno almeno il “diritto di proporsi come membri
della società (zur Gesellschaft anzubieten)” 12 o di “tentare un commercio con gli
antichi abitatori (einen Verkehr mit den alten Einwohnern zu versuchen)”13. Si badi, il
pp. 125-128; cfr. al riguardo anche i rilievi di Thorpe che ricostruisce la questione della proprietà, in
modo originale, sullo sfondo della peculiare lettura che Kant, sul piano dell’indagine metafisica, offre
del rapporto sostanza-accidente (L. Thorpe, Kant on the Transferal of Property: The Relationship
between Kant’s Metaphysics and His Philosophy of Right, in V. Rohden – R. R. Terra – G. A. De
Almeida – M. Ruffing (hrsg. von), Recht und Frieden in der Philosophie Kants: Akten des X.
Internationalen Kant Kongresses, de Gruyter, Berlin/New York 2008, Bd. 4, pp. 735-744.
8
MS, AA 06: 251; tr. it. p. 105.
9
MS, AA 06: 352; tr. it. p. 352.
10
S. Muthu, Justice and Foreigners: Kant’s Cosmopolitan Right, in «Constellations. An
International Journal of Critical and Democratic Theory», 7, 1/2000, pp. 23-45, p. 35.
ZeF, AA 08: 358; tr. it. p. 177.
11
12
13
Ibidem
Ibidem
�329
Diritto cosmopolitico e ragione in Kant
diritto di proporsi per una società, o di tentare un commercio con gli antichi abitatori,
non equivale al diritto di entrare in società o di istaurare relazioni commerciali. Perché
questo avvenga, si richiede il consenso dell’altra parte. Anzi, nella Metafisica dei
costumi Kant condanna come deprorevole ogni tentativo di entrare forzatamente o con
l’inganno in relazione con popoli che vivono in isolamento. Questo tentativo non può,
neppure, venire subdolamente legittimato dalla presunta buona intenzione di convertire
allo stato di diritto uomini che conducono una vita selvaggia, e di civilizzare così i
“popoli rozzi” 14 . Il postulato kantiano del diritto pubblico, secondo il quale “nella
situazione di inevitabile coesistenza con tutti gli altri uomini, si deve uscire dallo stato
di natura per entrare in uno stato giuridico” 15 , il Proximity Principle, come lo ha
ribattezzato Waldron16, non può tradursi, in nessun caso, nella legittimazione di una
condotta di dominio, di insediamento sul suolo altrui, anche qualora venga perpetrata
all’insegna di una missione di civilizzazione. Infatti, ciò equivarrebbe alla pretesa di
requisire un principio universale per metterlo al servizio di una volontà particolare,
quella che oggi definiremmo la pretesa di “esportare” modelli istituzionali
preconfezionati. L’idea di una edificazione universale e duratura della pace da
perseguire con i mezzi di una costituzione civile che leghi gli uomini che vivono fianco
a fianco implica infatti, come Kant afferma nelle pagine conclusive della sezione sul
diritto pubblico, che la regola di tale costituzione civile “non deve venire derivata
dall’esperienza di coloro che finora l’hanno potuta apprezzare così tanto da farne una
norma per altri, bensì deve essere in generale derivata a priori mediante la ragione
dall’ideale di un’unione giuridica degli uomini sotto leggi pubbliche” 17 . L’ideale
cosmopolitico di un’unione giuridica degli uomini sotto leggi pubbliche non riguarda,
cioè, uno standard normativo che alcuni possano rivendicare come loro possesso e che
possano, perciò, pretendere di imporre ad altri, ma concerne il senso di un’accessibilità
alle norme dell’agire razionale che nessuno può negare ad altri senza con ciò perdere,
14
Cfr. MS, AA 06: 353; tr. it. p. 317.
MS, AA 06: 307; tr. it. p. 225.
16
Cfr. J. Waldron, Redressing Historic Injustice, in L. Meyer (ed.), Justice in Time: Responding to
Historical Injustice, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2004, pp. 55-77, p. 57.
17
MS, AA 06: 355; tr. it. p. 321. Ciò vale, senz’altro, come tratto costitutivo del cosmopolitismo
maturo di Kant, nel quale si fa strada con chiarezza il motivo di una critica decisa contro il
colonialismo europeo. Il che non toglie che nell’intero arco dell’opera kantiana non si incontrino
indicazioni che vanno, invece, nella direzione di una civilizzazione forzata dei popoli che non si sono
dati una costituzione civile. Cfr. ad es. R 8065, AA 19: 599, databile nel periodo compreso tra il 1780 e
il 1789. Più in generale, sull’evoluzione del pensiero kantiano riguardo al colonialismo, cfr. la
ricostruzione di Kleingeld, la quale ritiene che una critica senza riserve del colonialismo si dà in Kant
solo a partire dalla metà degli anni ‘90 (P. Kleingeld, Kant’s Second Thoughts on Colonialism , in K.
Flikschuh – L. Ypi (eds.), Kant and Colonialism: Historical and Critical Perspectives, Oxford University
Press, Oxford 2014, pp. 43-67, in part. pp. 52-66). Sull’argomento cfr. anche i rilievi di Lauden, il quale
però non concorda con l’idea di collegare, come fa Kleingeld, l’anticolonialismo esplicito della
produzione tarda di Kant allo sviluppo di una posizione più libera da stereotipi a sfondo razziale (Cfr.
R. B. Lauden, Kant’s Human Being. Essays on his Theory of Human Nature, Oxford, University Press,
Oxford 2011, p. 134).
15
�330
A NGE LO C IC A TELLO
egli per primo, l’accesso alla ragione in quanto tale. È questo il senso in cui Kant fa
riferimento alla pace universale come allo “scopo finale della dottrina del diritto
all’interno dei limiti della semplice ragione”18.
2. Risulta allora evidente come il progetto di pace universale non possa legarsi
semplicemente alla promozione e all’intensificazione dei rapporti di interazione e di
comunicazione tra gli uomini, di cui il diritto cosmopolitico, fondato sul possesso
comune originario del suolo terrestre, si farebbe garante. Altrettanto decisivo è, per
Kant, il motivo che insiste sui rischi legati all’abuso di questo diritto. Da qui viene la
necessità di delimitare con precisione lo spazio del suo effettivo esercizio. Non stupisce
perciò che il Terzo articolo definitivo per la pace perpetua presenti il diritto
cosmopolitico anzitutto all’insegna di una sua necessaria limitazione:
Il diritto cosmopolitico deve essere limitato alle condizioni della ospitalità universale .
19
La limitazione consiste nel fatto che il diritto di visita non autorizza lo straniero a
risiedere nel paese che lo ospita. Non è, letteralmente, un diritto di essere ospitato
(Gastrecht). Per questo si richiede uno speciale contratto con il sovrano, che renda il
visitatore un coabitante.
Dietro la distinzione tra Besuchrecht e Gastrecht, dietro l’attenzione di Kant a
marcare i confini e lo spazio di esercizio del diritto cosmopolitico, che di primo acchito
può sembrare esaurirsi nella forma striminzita di un’ospitalità a gettoni, si manifesta, in
realtà, un intento progettuale concreto. Quello che individua storicamente le condizioni
universali di pace mondiale nella necessità di delegittimare la condotta di conquista
economica e territoriale protratta dai cosiddetti popoli civilizzati ai danni dei nativi.
Anzi, il motivo che oggi si direbbe anticolonialista ispira dal profondo la trattazione
kantiana del diritto cosmopolitico. La distinzione tra Besuchrecht e Gastrecht trova da
questo punto di vista più di un semplice incentivo nell’esigenza di delegittimare la
condotta di certi “visitatori” che fanno presto a trasformare, con la violenza o con
l’inganno, la visita in occupazione. Così Kant, nel denunciare quel che ostacola la
possibilità che i popoli entrino tra loro in rapporti pacifici:
Si confronti con ciò la condotta inospitale degli Stati civilizzati del nostro
continente, soprattutto di quelli commerciali, e si vedrà che l’ingiustizia che essi
dimostrano nella visita a territori e popoli stranieri (che per loro è un tutt’uno
con la loro conquista) giunge sino all’orrore. L’America, le terre dei negri, le
Isole delle Spezie, il Capo di Buona Speranza, ecc. quando furono scoperti erano
per essi terre che non appartenevano a nessuno; infatti gli abitanti per loro non
18
19
MS, AA 06: 355; tr. it. p. 321.
ZeF, AA 08: 357; tr. it. p. 177.
�331
Diritto cosmopolitico e ragione in Kant
contavano nulla. Nelle Indie orientali (Hindustan), con il pretesto di filiali
commerciali soltanto progettate, introdussero truppe straniere, e con queste
l’oppressione degli indigeni, l’istigazione dei diversi Stati della regione a guerre
sempre più estese, e così carestie, insurrezioni, tradimenti e tutto il resto che può
venir aggiunto alla litania dei mali che opprimono il genere umano .
20
Nel difendere le ragioni dei nativi dalle aggressioni dei paesi commerciali, Kant si fa
portavoce di un diritto cosmopolitico che in nessun caso può diventare appannaggio
culturale esclusivo dei popoli europei, quasi che “cosmopolitismo” possa significare
l’estensione e l’esportazione su scala globale di un modello pre-determinato di
“umanità” o di “razionalità”. La volontà di garantire la diversità delle forme di vita, di
esistenza, di cultura e di scelta dell’assetto politico più idoneo per la convivenza
sembra in effetti un tratto caratteristico del cosmopolitismo maturo di Kant. Il diritto
cosmopolitico, proprio nel suo carattere limitativo, unisce, per usare una felice formula
di Höffe, “un diritto alla cooperazione universale con il diritto alla differenza)”21.
L’attenzione al motivo anticolonialista consente, così, di smarcare Kant dalle facili
obiezioni che tendono a considerare la distinzione tra Besuchrecht e Gastrecht come il
prodotto di una volontà ideologica tendente ad escludere lo straniero dalla
partecipazione a pieno titolo alla vita della comunità civile che lo ospita. D’altra parte,
l’accento sul motivo, diremmo, anticolonialista contribuisce anche a sedare ogni facile
entusiasmo in merito ad un Kant teorizzatore di un diritto esteso all’ospitalità
universale, in forza del quale si proporrebbe come una sorta di difensore ante litteram
della causa dei richiedenti asilo e degli immigrati. Come si legge in Per la pace
perpetua, “[...] questo diritto di ospitalità, vale a dire la facoltà dei visitatori stranieri,
non si estende oltre le condizioni di possibilità di tentare un commercio con gli antichi
abitatori”22. È questo lo spazio nel quale deve essere limitato il diritto di ospitalità.
Dunque, non è in gioco un diritto cosmopolitico all’ospitalità universale, ma, come
recita il Terzo articolo definitivo, si tratta di determinare a quali “condizioni” il diritto
del visitatore si rende compatibile con un ordine universale di pace. Così, l’accento non
cade su un diritto all’ospitalità che andrebbe esteso universalmente ad ogni uomo. Cade
piuttosto sul fatto che in nessun modo tale diritto, per quanto universalmente
riconosciuto, può legittimare forme di condotta che ledano sistematicamente l’esercizio
dell’arbitrio altrui, ledano, nella fattispecie, il diritto dei primi possessori, ovvero dei
nativi.
A questo proposito si può, anzi, rintracciare in Kant un modo specifico di fare
appello al diritto fondato sul possesso comune originario del suolo: l’attenzione questa
volta si rivolge, non alle prerogative del visitatore, ma all’esigenza di proteggere il
visitato da visitatori troppo invadenti. Così, nella dottrina del diritto privato della
20
ZeF, AA 08: 358-359; tr. it. p. 178.
O. Höffe, Kants universaler Kosmopolitismus, in Recht und Frieden in der Philosophie Kants, cit.,
Bd. 1, pp.139-155, p. 153.
ZeF, AA 08: 358; tr. it. p. 177.
21
22
�332
A NGE LO C IC A TELLO
Metafisica dei costumi il possesso comune originario del suolo non viene chiamato in
causa a sostegno della prerogativa degli uomini di muoversi liberamente sulla
superficie della Terra, ma viene identificato con il diritto che essi hanno “di essere lì
dove la natura o il caso (senza la loro volontà) li ha messi”23. Qui Kant, più che dello
straniero in visita in terra d’altri, parla di chi in questi luoghi abita da sempre ed ha
potuto così su di essi stabilire il primo possesso. Le popolazioni native sono quelle che
per definizione si trovano ad abitare un luogo che non hanno scelto, ma che la natura o
il caso ha scelto per loro. Come dire, quello stesso possesso originario del suolo
terrestre che obbliga il visitato a non trattare come un nemico lo straniero in visita,
obbliga, però, anche il visitatore a non violare i diritti dei popoli nativi 24. Essi hanno
infatti il diritto di essere lì dove la natura o il caso li ha messi.
3. Si registra, così, già solo a partire dal modo articolato in cui Kant si richiama al
possesso comune originario del suolo terrestre, una tensione interna alla sua proposta
cosmopolitica. Essa vede da un lato il motivo che insiste sul contenuto positivo del
diritto di visita in quanto diritto teso a garantire la libera circolazione degli uomini sulla
Terra e la loro interazione. Il visitatore straniero, sia esso il commerciante o il
viaggiatore curioso, è, secondo questa prospettiva, titolare di un diritto che gli spetta in
quanto portatore sano di potenziali relazioni atte a preparare il terreno per un futuro di
pacifica interazione tra i popoli della Terra. In quanto volto a garantire la condizione
dello straniero in visita, il diritto cosmopolitico è chiamato ad assicurare le condizioni
minime di pensabilità di un ordine mondiale di pace da costruire nel tempo mediante il
ricorso a forme istituzionali di convivenza politica via via più complesse che
interessino zone sempre più ampie del globo terrestre. In questa direzione vanno, ad.
es., le osservazioni dello scritto Per la pace perpetua sul fatto che “la cultura crescente
e il graduale avvicinamento degli uomini ad un più ampio accordo sui principi”
riequlibri la “tendenza all’odio reciproco” dovuta alla “diversità delle lingue e delle
religioni”25. Così pure, è rilevante il ruolo delle relazioni commerciali e dei rapporti
finanziari che costringono gli stati, non foss’altro che per ragioni di reciproca
convenienza economica, a favorire la pace, là dove il diritto delle genti, e dunque
23
MS, AA 06: 262; tr. it. p. 129. È significativo che, sempre nella Metafisica dei costumi, Kant
caratterizzi specularmente il colonizzatore come colui che per sua volontà, e non per volere della natura
o del caso, entra in contatto con altri popoli e, nella fattispecie, con popoli la cui forma di convivenza
sociale non possiede ancora un assetto giuridico (Cfr. MS, AA 06: 266; tr. it. p. 135).
24
«La costruzione giuridica di un ipotetico possesso comune della Terra, che ha un lontano e
onorevole antecedente nell’antica giurisprudenza europea, funziona in questo contesto come una lama
a doppio taglio. Da una parte, Kant vuole evitare l’impiego di tale costrutto per giustificare e
legittimare l’espansione coloniale occidentale; dall’altra, egli vuole fondare il diritto degli esseri umani
ad associarsi sul fatto che, poiché la superficie della Terra è limitata, prima o poi dovremo imparare a
condividere le risorse che essa offre» (S. Benhabib, I diritti degli altri. Stranieri, residenti, cittadini, tr.
it. di S. De Petris, Raffaello Cortina, Milano 2006, p. 25).
25
Cfr. ZeF, AA 08: 367; tr. it. p. 186. L’equilibrio dinamico tra spinta antagonistica e avvicinamento
reciproco fornisce del resto, vale la pena ricordarlo, la ricetta di una intesa di pace tra i popoli che non
deve tradursi, per Kant, nella dispotica soppressione delle differenze.
�333
Diritto cosmopolitico e ragione in Kant
l’assetto politico internazionale, non sarebbe invece in grado di garantirli dal pericolo
della reciproca aggressione e della guerra26.
Dall’altro lato incalza però in Kant con uguale forza il motivo critico che pone
l’accento sulla necessità di limitare ogni forma di ospitalità che rischiasse di tradursi in
una minaccia per i popoli ospitanti. L’accento cade qui, come si visto, sul fatto che il
diritto di visita non può e non deve legittimare politiche aggressive di insediamento
coloniale. Più che a difendere le ragioni culturali o commerciali del viaggiatore, Kant si
mostra da questo punto vista interessato a difendere le ragioni delle popolazioni native
o anche più in generale, a giustificare l’atteggiamento di quei governi che adottano un
politica accorta nei confronti del visitatore straniero 27.
Si badi, non si tratta di due istanze che debbano necessariamente entrare in
contraddizione: concepire un diritto di visita in forza del quale lo straniero non può
essere aggredito senza ragione al suo primo ingresso in terra d’altri non è di per sé
incompatibile con il fatto che il visitato debba essere protetto da possibili aggressioni
del visitatore mediante una limitazione del diritto all’ospitalità. Ciò che invece genera
conflitto è il porre esclusivamente in rilievo uno di questi due aspetti, esagerandone la
portata a detrimento dell’altro.
Sul primo aspetto, che si lega ai contenuti di socialità e interazione tra gli uomini del
diritto cosmopolitico di visita, hanno insistito diversi autori che, sebbene a partire da
prospettive diverse, hanno focalizzato l’attenzione sul contenuto positivo del diritto di
visita inteso come diritto degli individui alla libera circolazione e al libero scambio, si
tratti di merci o di idee28. L’enfasi cade, in questo caso, sul carattere inalienabile di un
diritto che garantisce l’azione del visitare, del muoversi liberamente verso il proprio
vicino per stringere relazioni con lui.
L’insistenza sull’elemento di socievolezza del diritto di visita e sul suo ruolo di
promotore di una prima forma di “amicizia” tra i popoli che prepari, o anche sostituisca
26
Sul ruolo che le relazioni commerciali e gli interessi economici svolgono nel progetto
cosmopolitico di Kant cfr. G. Cavallar, Kant’s Embedded Cosmopolitanism. History, Philosophy,
Education for World Citizens, De Gruyter, Berlin/Boston 2015, pp. 64-73.
27
In Per la pace perpetua si fa l’esempio della Cina e del Giappone (Cfr. ZeF, AA 08:359; tr. it. pp.
178-179).
28
H. Arendt riporta il diritto cosmopolitico di visita ad una formulazione in chiave giuridica
dell’interesse kantiano per la socievolezza degli uomini e per la costituzione di quella mentalità ampia
che, in Kant, passerebbe dalla possibilità, la più estesa possibile, di visitare il punto di vista degli altri
(cfr. H. Arendt, Lectures on Kant’s Political Philosophy , Edited and with an interpretive Essay by R.
Beiner, The University of Chicago Press, Chicago 1982, pp. 74-75, 114-115). Sulla scia del paradigma
comunicativo di Arendt si colloca, per certi versi, anche la lettura di D. Howard che, in riferimento al
diritto di visita, parla di obbligazione a perseguire la comunicazione pubblica (Cfr. D. Howard, The
Politics of Critique, Macmillan, London 1989, pp. 101-103). Altri autori, come ad. es. H.G. Schmitz,
insistono piuttosto sul ruolo sistematico che il diritto di visita, in quanto diritto che favorisce
l’interazione e l’avvicinamento tra i popoli, svolgerebbe all’interno di un progetto politico di pace (H.G.
Schmitz, Moral oder Klugheit. Überlegungen zur Gestalt der Autonomie des Politischen im Denken
Kants, in «Kant-Studien», 81, 4/1990, pp. 413-434, p. 423). Cfr. anche E. Garzón, La paz republicana, in
«Enrahonar», 17, 1994, pp. 21-23; M. Bösch, Globale Vernunft. Zum Kosmopolitismus der Kantischen
Vernunftkritik, in «Kant-Studien», 98, 4/2007, pp. 473-486, pp. 475-476, 483.
�334
A NGE LO C IC A TELLO
provvisoriamente, il costituirsi di un ordine politico mondiale, non esaurisce però
l’intero spettro della proposta cosmopolitica di Kant. Come si è visto, altrettanto
significativi sono i rilievi sul tratto di insocievolezza e sulla condotta inospitale di certi
visitatori nei riguardi di popoli per i quali l’arrivo dello straniero può far presto a
trasformarsi in vera e propria invasione. Nel porre l’attenzione su questo aspetto della
riflessione kantiana, alcuni autori hanno, così, individuato nella limitazione del diritto
d’ospitalità e nel divieto del colonialismo la condizione cosmopolitica di giustizia per
poter cominciare a costruire un ordine mondiale di pace 29. Si comprende bene come il
diritto di visita qui non venga tanto preso in considerazione come norma universale che
incentiva e protegge la libera circolazione degli uomini sulla Terra. Esso figura,
piuttosto, come forma di ospitalità ristretta, le cui prerogative non possono estendersi al
di là di quel limite oltre il quale non verrebbero garantite le condizioni minime di
sicurezza e di reciproco scambio pacifico tra visitatore e visitato. Solo alle condizioni
di un diritto di ospitalità limitato, per richiamare le parole di Kant, “[...] continenti
lontani possono entrare pacificamente in rapporti reciproci che in seguito divengono
regolati da leggi, e così possono infine condurre il genere umano sempre più vicino ad
una costituzione cosmopolitica” 30 . Torna, qui, con forza il motivo kantiano della
necessità dell’uomo di uscire dallo stato di natura per entrare in uno stato civile.
29
Rilievi sull’importanza della critica del colonialismo nell’ambito del diritto cosmopolitico di Kant
si trovano, in forma sistematica o anche episodica, in buona parte della Kant-Forschung. Su questo
tema ha posto l’attenzione, tra i primi, G. Cavallar, Pax Kantiana: Systematisch-historische
Untersuchung des Entwurfs "Zum ewigen Frieden" (1795) von Immanuel Kant (Schriftenreihe der
oesterreichischen Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts), Böhlau, Wien 1992, pp. 225-234,
in part. 225-227. Sul ruolo decisivo che svolge la posizione anticolonialista di Kant cfr. più
specificamente R. Malter, Nachwort zu: Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden, Reclam, Stuttgart 1984,
pp. 69-85, in part. p. 75; K. Väyrynen, Weltbürgerrecht und Kolonialismuskritik bei Kant, in V.
Gerhardt – R.P. Horstmann – R. Schumacher (hrsg. von), Kant und die Berliner Aufklärung. Akten des
IX. Internationalen Kant-Kongresses, Berlin 2000, de Gruyter, Berlin/New York 2001, Bd. 4, pp. 302309, pp. 303-306. Secondo M. Caimi, che si colloca in modo ancor più radicale su questa scia
interpretativa, non sarebbe il mero diritto individuale di visitare terre straniere, ma l’eliminazione di
ogni giustificazione del colonialismo e dunque di qualsiasi abuso del diritto di ospitalità, la condizione
per realizzare un ordine cosmopolitico di pace (Cfr. M. Caimi, Acerca de la Interpretación del Tercer
Artículo Definitivo del Ensayo de Kant Zum ewigen Frieden, in V. Rohden, (ed.), Kant e a instituição
da paz, Ed. da Universidade/UFRGS, Goethe-Institut/ICBA, Porto Alegre 1997, pp. 191-200, in part. pp.
196-197). La tensione interpretativa tra le posizioni che considerano il diritto di visita come garanzia di
libertà di circolazione e di comunicazione e le posizioni che invece leggono nel Terzo articolo definitivo
l’intenzione di limitare gli abusi del colonialismo è evidenziata anche da R. Terra, La actualidad del
piensamento politico de Kant, in «Episteme», 28, 2/2008, pp. 93-119, pp. 115-117. Il motivo della
tensione tra diritto all’ospitalità e critica del colonialismo sta anche sullo sfondo della lettura di J.
Thumfart, il quale individua, però, nel diritto cosmopolitico di Kant, al di là della semplice censura del
colonialismo, i termini di una riformulazione dello ius communicationis (cfr. J. Thumfart,
Kolonialismus oder Kommunikation. Zur Kants Auseinandersetzung mit Francisco de Vitorias ius
communicationis, in S. Bacin – A. Ferrarin – C. La Rocca – M. Ruffing (hrsg. von), Kant und die
Philosophie in weltbürgerlicher Absicht. Akten des XI. Internationalen Kant-Kongresses, Pisa 2010, De
Gruyter, Berlin/Boston 2013, Bd. 3, pp. 929-939, in part. 932-934).
30
ZeF, AA 08: 358; tr. it. pp.177-178.
�335
Diritto cosmopolitico e ragione in Kant
L’ingresso nello stato civile, dal punto di vista cosmoplitico, richiede, cioè, innanzitutto
la limitazione del diritto naturale all’ospitalità affinché esso si renda compatibile con il
principio stesso del diritto. Detto diversamente: l’arbitrio di ciascuno, e così anche la
libertà individuale di visitare terre straniere, deve potersi accordare con l’arbitrio di chi
può legittimamente rifiutare di entrare in società con un visitatore che abbia tutto
l’aspetto dell’invasore. Solo a questa condizione, dunque, potrebbe parlarsi, in senso
proprio, di un diritto d’ospitalità, ovvero di un titolo che ciascun uomo può avanzare
legittimamente nei confronti di altri uomini. Da questo punto di vista, la traiettoria che
descrive il progresso verso un ordine cosmopolitico di pace mondiale non si identifica
con la semplice idea di una crescente interazione sociale e politica per la quale si
richieda una normazione giuridica sovranazionale. L’urgenza è invece quella di
arginare i rischi che una crescente interazione sociale e politica può produrre, quando
non sia concepita all’insegna di regole che ne limitino il potenziale autodistruttivo. Il
porre l’accento sull’elemento di socievolezza del diritto cosmopolitico, o, viceversa,
sul potenziale di insocievolezza che può essere innescato dall’estendersi su scala
globale degli antagonismi, sta dunque alla base di due modi diversi di leggere l’idea
kantiana di progresso. Da un lato si pone al centro la valorizzazione di un diritto
universale, fondato su principi a priori della ragione, che garantisca e incentivi il
contatto e la comunicazione tra i popoli. Dall’altro, appare invece decisiva la necessità
di arginare l’elemento di violenza e prevaricazione implicato nell’esercizio di un diritto
d’ospitalità non ristretto alle condizioni della convivenza pacifica.
Il darsi di paradigmi di lettura così diversi del diritto cosmopolitico, e più in generale
del discorso kantiano sull’ospitalità, non è però solo da imputare alla socievole
insocievolezza degli interpreti, ma dipende, come si è visto, anche dal fatto che nello
stesso Kant le due prospettive sembrano stare in un equilibrio talvolta precario 31 .
Perciò, se non è ermeneuticamente auspicabile spezzare la tensione che attraversa la
trattazione kantiana del diritto cosmopolitico a favore di uno o dell’altro versante
interpretativo 32, neppure è possibile coltivare il sogno coerentista di un Kant che riesca
31
Ponendo forse troppa enfasi sugli elementi di frizione presenti nel cosmopolitismo kantiano,
Derrida legge il diritto cosmopolitico all’insegna di un conflitto antinomico tra l’istanza imperativa di
una ospitalità incondizionata e la necessità di tradurre l’ospitalità nella forma giuridica di norme che
ne regolino l’applicazione concreta (cfr. J. Derrida, Cosmopolites de tous les pays, encore un effort!,
Galilée, Paris 1997, pp. 65-67; 73). Una critica puntuale di questa interpretazione è contenuta in G. W.
Brown, The Laws of Hospitality, Asylum Seekers and Cosmopolitan Right. A Kantian Response to
Jacques Derrida , in «European Journal of Political Theory», 9, 3/2010, pp. 308-327; al riguardo mi
permetto di rinviare anche a A. Cicatello, Il diritto di visita entro i limiti della semplice ragione. Note a
margine del cosmopolitismo di Kant, in «Estudos Kantianos», 3, 2/2015, pp. 73-90. Al di là delle pur
evidenti forzature interpretative, la lettura di Derrida ha comunque contribuito non poco a far affiorare
nel dibattito contemporaneo l’enorme potenziale ermeneutico contenuto nel diritto cosmopolitico di
Kant, mostrandone la rilevanza in relazione alle questioni dell’immigrazione e dell’asilo politico.
32
Waligore (Cosmopolitan Right, Indigenous Peoples, and the Risks of Cultural Interaction, in
«Public Reason» 1, 1/2009, pp. 27-56, pp. 29-31) denuncia, ad es., il vizio di parzialità di letture che,
come quella di Waldron (Kant’s heading ‘Cosmopolitan Right. Manuscript. Cambridge University,
Cambridge, p. 230) esagerano il significato del diritto di visita in quanto norma che promuove e
�336
A NGE LO C IC A TELLO
a comprimere in una formula unica tutte le dinamiche che attraversano il complesso
rapporto tra i diritti del visitatore e quelli del visitato. E ciò perché in entrambi i casi
rischia, comunque, di andare perduta la ricchezza della proposta cosmopolitica
kantiana.
4. Spirito commerciale, comunicazione, promessa di interazione e di scambio
reciproco da un lato, politiche aggressive di espansione economica, abuso della
proprietà altrui e fenomeni di civilizzazione forzata dall’altro, popolano allo stesso
titolo il suolo terrestre sul quale Kant intende cominciare a costruire il suo progetto
cosmopolitico di pace.
Non è un caso che il diritto al possesso comune del suolo venga chiamato in causa,
nella Metafisica dei costumi, non solo per affermare le prerogative del visitatore che si
reca volontariamente in terra d’altri, ma anche, come si è visto, per proteggere la
condizione di chi in quella parte di terra è stato posto dalla natura e dal caso, di chi
insomma c’è nato. Entrambi sono cittadini del mondo a pari titolo. Sono loro i
“cittadini della Terra” in vista di cui deve essere affermato e, ad un tempo, limitato un
diritto cosmopolitico. E ciò perché, come Kant stesso dice con formula problematica, il
possesso comune del suolo non fonda una comunità del possesso. Non si riferisce, cioè,
all’uso comune del territorio e nemmeno a una sorta di proprietà comune primitiva.
Descrive solo il trovarsi degli uomini in una “situazione di possibile scambio fisico (in
einer [...] physischer möglische Wechselwirkung [commercium]) 33. Il ricorso al latino
“commercium” esibisce una precisa valenza semantica in relazione al modello di
comunità che Kant concepisce sotto il segno del diritto cosmopolitico. La comunità del
suolo terrestre non risponde alla “comunità giuridica del possesso (communio) e perciò
dell’uso o della proprietà del suolo stesso”34. Piuttosto, il diritto al comune possesso
originario procede dal fatto che gli uomini, in virtù della forma sferica della Terra35, si
trovano già sempre nella condizione di poter venire a contatto l’uno con l’altro e con
ciò “in un rapporto continuo di un popolo con tutti gli altri che si offrono allo scambio
reciproco [sich zum Verkehr untereinander anzubieten]” 36 ; dove è decisivo
comprendere a quali condizioni l’azione di proporsi per formare una società possa
incentiva il contatto e la comunicazione tra popoli, a discapito dell’attenzione rivolta da Kant agli
ostacoli decisivi che forme di interazione e di società non consensuale possono opporre lungo il
cammino verso la realizzazione di un ordine cosmopolitico di pace. Non meno viziate di parzialità
possono, però, risultare letture che puntano esclusivamente sul motivo anti-colonialista, sminuendo
invece il significato del diritto di visita in quanto diritto individuale alla libera circolazione e alla
comunicazione. Cfr. a questo riguardo le obiezioni mosse a M. Caimi (op. cit.) da C Belfort (Estudo da
natureza do homem em Kant a partir do caso do estrangeiro e o conceito de hospitalidade, in «Kant EPrints», 2, 2/2007, pp. 127-142, p. 137).
33
MS, AA 06: 352; tr. it. p. 315.
34
35
Ibidem
«La natura ha circoscritto tutti i popoli entro determinati confini [Grenzen] (grazie alla forma
sferica del loro soggiorno, il globus terraqueus) – MS, AA 06: 352; tr. it. 315. Cfr. anche ZeF, AA 08:
358; tr. it. p. 177).
36
MS, AA 06: 352; tr. it. p. 315.
�337
Diritto cosmopolitico e ragione in Kant
favorire, e non invece impedire, il progressivo costituirsi di una pace duratura. Non si
tratta, dunque, di un possesso statico, come se si potesse condividere come patrimonio
comune qualcosa di già dato. In gioco è, invece, la possibilità di una interazione
dinamica a partire dalla quale si costituisce, per Kant, il senso specifico della comunità
cosmopolitica. In altri termini, a definire il senso della comunità del suolo terrestre non
è la condivisione di qualcosa di dato, sia esso, uno spazio chiuso entro confini fissati, o
un sistema di valori culturali, o persino la rivendicazione del possesso della facoltà
razionale intesa come dotazione fisiologica dell’uomo. La comunità degli esseri
razionali terrestri si definisce sempre e solo nella forma dinamica del commercium,
dell’azione reciproca (Wechselwirkung).
E del resto, nella Critica della ragion pura il termine “commercium” e la
distinzione dal termine “communio” occorrono, nel contesto della discussione della
Terza analogia dell’esperienza, per indicare un significato di comunità fondato
sull’azione reciproca: “Nella nostra lingua il termine comunanza (Gemeinschaft) ha
due significati: può voler dire, cioè, sia communio sia commercium. Qui ci serviamo
del termine nel secondo significato, come una comunanza dinamica, senza la quale
neanche la comunanza locale (communio spatii) potrebbe mai essere conosciuta
empiricamente” 37 . Il fatto che Kant parli nella Metafisica dei costumi di
“commercium” in relazione alla comunità del suolo, corrisponde, in definitiva,
all’insistenza sul carattere dinamico-relazionale della sua idea di società
cosmopolitica, là dove decisivo non è il costituirsi di una società sulla base di ciò che
è comune, ma il formarsi di una comunità sulla base dello scambio di ciò che è
differente 38.
Quando parla di un diritto connesso al possesso comune del suolo, Kant fa
riferimento, in definitiva, non a un suolo comune. A rigore, anzi, un suolo comune non
si dà, se non in termini di possibili relazioni di scambio, se non come un’idea della
ragione, l’idea di un “tutto determinato” 39 , a partire dal quale, soltanto, sono
concepibili le parti. In gioco è qui, allora, il senso metafisico di un intero, il cui
contenuto, in quanto pensabile solo a partire dalla pura ragione, non può consistere
nella semplice somma empirica delle parti, ma deve implicare la possibilità che la
parzialità delle parti venga superata. Nella Metafisica dei costumi Kant parla, non a
caso, del possesso comune originario come di un “concetto pratico della ragione, che
contiene a priori il principio secondo il quale soltanto gli uomini possono utilizzare il
posto che occupano sulla Terra in base a leggi di diritto”40.
37
I. Kant, Kritik der reinen Vernunft (=KrV), A 213/B 260; tr. it. Critica della ragion pura , di C.
Esposito, Bompiani, Milano 2004, p. 409.
38
Al proposito cfr. i rilievi di S. Anderson-Gold, Cosmopolitan Right: State and System in Kant’s
Political Theory , in Politics and Metaphysics in Kant, cit., pp. 235-249; pp. 239-240.
39
MS, AA 06: 352; tr. it. p. 352.
40
MS, AA 06: 262; tr. it. p. 129. Sempre nella Metafisica dei costumi Kant parla della «comunione
originaria del suolo (urprüngliche Gemeinschaft des Bodens)» come di una «idea che ha realtà
oggettiva (giuridica e pratica) [objective (rechtlich praktische) Realität]» (MS, AA 06: 251; tr. it. p. 103).
�338
A NGE LO C IC A TELLO
La possibilità di usare o di stabilire la legittima proprietà su una parte del suolo si
fonda sul presupposto che gli uomini possano pensarsi come esseri che abitano la parte
di un tutto determinato, ovvero della superficie terrestre intesa come globo. Senza aver
sviluppato questa disposizione razionale, potremo al massimo concepire un’idea del
mondo che abitiamo secondo l’estensione dei confini di quella parte sulla quale
abbiamo posto la nostra sede. Ed è esattamente a disinnescare il potenziale di violenza
contenuto in questa idea insieme sedentaria ed espansionistica di cosmopolitismo che è
rivolta la distinzione kantiana tra diritto di visita e diritto di residenza. Così, se il
semplice proporsi all’altro per formare una società non può, di principio, giustificare
nell’altro una reazione aggressiva, d’altra parte tale società non può essere
subdolamente propinata o imposta con la forza, magari con la giustificazione che
l’altro non abbia ancora raggiunto quel livello civile di razionalità che solo potrebbe
sottrarlo allo stato selvaggio.
Prima che della possibilità di una istituzione giuridica mondiale che preservi in
modo permanente la pace, con il diritto cosmopolitico ne và, insomma, del diritto
stesso alla ragione; quella ragione che per i suoi connotati terrestri, umani, non può,
come la superficie della Terra, venire semplicemente parcellizzata a vantaggio di chi
pretenda appropriarsene sottraendola ad altri. A partire da questa prospettiva, il diritto
di visita può, allora, acquisire un significato diverso da quello di una semplice forma
restrittiva di ospitalità. Esso si fa espressione di una ragione che non è semplicemente,
naturalmente, data a tutti gli uomini in guisa di una comune dotazione antropologica,
ma richiede di essere istituita sul terreno cosmopolitico dello scambio reciproco tra
forme di vita differenti. Sulla ragione, come sulla superficie della Terra, ciascun
individuo può legittimamente rivendicare il possesso, solo a patto di non escludere
nessun altro dalla possibilità di accedervi. In gioco è qui, si potrebbe dire, la possibilità
di una deduzione nel senso kantiano del termine: dalla ragione come quaestio facti, alla
ragione come quaestio iuris dell’umanità. Mediante questa deduzione, dell’idea di
ragione viene delimitato l’orizzonte terrestre, umano, così che la ragione possa rendersi
atta a istituire relazioni politiche, dando forma a costumi e istituzioni 41. Il richiamo
geografico di Kant alla forma sferica della Terra come superficie circoscritta sulla quale
gli uomini non possono disperdersi all’infinito ma sono destinati ad incontrarsi, rivela
allora un legame più che metaforico con l’idea, espressa nella Critica della ragion
Come dice bene Cavallar, «la comunità originaria è, analogamente al contratto originario, non un fatto
storico ma un’idea razionale» (G. Cavallar, The Rights of Strangers. Theories of International
Hospitality, The Global Community, and Political Justice since Vitoria, Ashgate, Burlington 2002, p.
363); cfr. anche A. Pinheiro Walla, Private Property and the Possibility of Consent: Kant and Social
Contract Theory , in L. Krasnoff – N. Sánchez Madrid – Paula Satne (eds.), Kant’s Doctrine of Right in
the Twenty-First Century, University of Wales Press, Cardiff 2018, pp. 29-45; pp. 33-34.
41
Leggerei in questa prospettiva il suggerimento di P. J. Rossi di riguardare il cosmopolitismo
kantiano come «forma di resistenza alle dinamiche egemoniche che tentano l’essere umano ad
oltrepassare i limiti che la critica richiede a noi di istituire seguendo la ragione» (P. J. Rossi,
Cosmopolitanism and the Interests of Reason: Hope as Social Framework for Human Action in
History , in Recht und Frieden, cit., Bd 4, pp. 65-75, p. 69).
�339
Diritto cosmopolitico e ragione in Kant
pura, di una ragione che deve essere riguardata come una “sfera” e non come un
“piano esteso” sul quale stabilire “confini (Schranken)”42, mobili certo, ma in definitiva
invalicabili. La comunità degli esseri razionali terrestri, sotto il cui segno Kant
concepisce il suo progetto cosmopolitico di pace, risponde all’idea di un intero, di un
tutto in sé determinato, il cui significato e il cui possesso si rendono accessibili solo a
chi non pretenda di ridurli a semplice estensione della parte su cui ha fissato la propria
sede 43.
Da questo punto di visita, dal punto di vista della ragione intesa come bene
comune originario che ci diviene proprio solo nella misura in cui ci rendiamo capaci
di riconoscere agli altri il medesimo diritto di accedervi, potremmo dire che per Kant
siamo tutti ad un tempo ospititi e ospitati, visitatori e visitati. In altri termini,
l’insistenza sulla distinzione tra visita e residenza caratterizza il senso in cui ciascun
uomo, per Kant, può legittimamente riferire a se stesso il possesso della ragione,
ovvero di quel territorio sul quale non possiamo fissare la nostra sede escludendone
l’ingresso ad altri, senza con ciò perdere noi stessi il diritto di abitarvi. Mi pare che
possa essere, in ultima analisi, identificato qui il contributo kantiano fondamentale per
poter oggi ripensare il tema dell’ospitalità, senza cadere facili prede del conflitto tra gli
assertori dell’identità culturale e della sovranità nazionale e i teorici di un’ospitalità
incondizionata che nella parola “identità” additano l’origine di tutti i mali. Se è
senz’altro vero, come afferma Habermas, che “l’idea kantiana di cosmopolitismo
[deve] essere riformulata per non perdere il contatto con una situazione mondiale
radicalmente mutata” 44, è altrettanto vero, anche se forse meno ovvio, che il modo
peculiare in cui Kant concepisce il diritto cosmopolitico, e soprattutto il concetto di
“ragione umana” che ne risulta, può fornire un valido antidoto contro ogni facile
semplificazione che su temi come ospitalità, immigrazione, accoglienza, rischia solo di
acuire antagonismi latenti, innescandone il potenziale di violenza.
42
Cfr. KrV, A 762/B 790; tr. it. p. 1079. Cfr. anche KrV, A 759/B 787; tr. it. p. 1075, dove si fa anche
esplicito riferimento alla forma sferica della Terra.
Il cittadino della ragione non ha a che fare semplicemente con Schranken, ma con Grenzen, ossia
con l’idea di un tutto determinato, di un intero, il mondo, il cui significato non si riduce alla semplice
somma delle sue parti. Il critico della ragione, volto a determinare i Grenzen della ragione (KrV, A
761/B 789) trova, in questo senso, nel cittadino cosmopolitico la sua figura storico-progettuale.
44
J. Habermas, L’idea kantiana della pace perpetua, due secoli dopo, in Id., L’inclusione dell’altro.
Studi di teoria politica , tr. it. di L. Ceppa, Feltrinelli, Milano 2008, pp. 177-352, pp. 189-190.
43
�340
�341
Etica & Politica / Ethics & Politics, XX, 2018, 1, pp. 341-361
ISSN 1825-5167
LA VIRTÙ DELLA SELF-RELIANCE
NELLE FILOSOFIE DI EMERSON E
NIETZSCHE
CA RO LA I S A I A
Università degli studi di Genova
Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia
isaia.carola@gmail.com
ABSTRACT
The aim of this preliminary work is to trace an affinity between Emerson’s and Nietzsche’s
philosophies in relation to one of Emerson's recurrent themes, self-reliance, whose several forms
will be analyzed: inconsistency, nonconformism and nomadic thought. Despite the lack of a
systematic discussion of self-reliance, Nietzsche shows in many passages of his production a clear
consonance with the Emersonian instances which encourage this virtue of independence.
KEYWORDS
Emerson, Nietzsche, self-reliance, nomadic thought, nonconformism.
Non è certo una novità sottolineare la profonda consonanza di pensiero tra
Nietzsche ed Emerson, 1 e indubbiamente si può sostenere che la filosofia
nietzschiana abbia realmente risentito del pensiero emersoniano, anche nei suoi
contenuti più strutturali e caratteristici.
È un giovanissimo Nietzsche quello che, negli anni di Pforta, si imbatté nella
traduzione tedesca della raccolta di saggi Conduct of Life; 2 l’impatto fu tanto decisivo
1
Specialmente negli ultimi decenni la letteratura su questo tema ha registrato un’espansione; ad es.
G. J. Stack, Nietzsche and Emerson: An Elective Affinity , Ohio University Press, Athens 1992; I.
Makarushka, Religious Imagination and Language in Emerson and Nietzsche, Palgrave Macmillan
1994; M. Lopez (a cura di), Emerson / Nietzsche, Pullman, Washington 1998; D. Mikics, The romance
of individualism in Emerson and Nietzsche, Ohio University Press 2003; B. Zavatta, La sfida del
carattere. Nietzsche lettore di Emerson, Editori Riuniti, Roma 2006.
2
Come rileva lo studio filologico della Zavatta: «[…] Nietzsche nel 1862 acquistò in una libreria di
Lipsia, fresca di stampa, la traduzione tedesca della raccolta The Conduct Of Life, la lettura della quale
si rivelò poi tanto entusiasmante da spingerlo ben presto ad acquistare anche gli Essays: first and
second series, pubblicati in traduzione tedesca alcuni anni prima. […] A partire dal 1876 si possono
rintracciare riferimenti anche a due saggi su Goethe e Shakespeare appartenenti alla raccolta
�342
C A ROLA I SA IA
che Emerson rimase sempre un luogo di conforto e di ispirazione per la produzione
filosofica di Nietzsche, un «maestro di prosa» 3 e di vita che, probabilmente, lo
accompagnò anche nel periodo di maturazione di quel pensiero abissale che diverrà
la bandiera nietzschiana dell’affermazione della vita e dell’amor fati: l’eterno ritorno.
A far pensare a una assidua lettura di Emerson è un brevissimo pensiero, risalente al
periodo di Aurora e de La Gaia Scienza, che il pensatore tedesco dedica a Emerson,
confessando di non essersi «mai sentito così a casa in un libro», e che proprio in virtù
di questa incredibile vicinanza il tesserne le lodi equivarrebbe a elogiare se stesso. 4
A fondamento della profonda stima e del vivificante entusiasmo che sorge in
Nietzsche dalle sue letture emersoniane bisogna ricordare che Emerson, pensatore
eclettico e atipico entro l’atmosfera culturale dell’America dell’Ottocento, 5 fu per
Nietzsche un raro e costante esempio di energia vitale e di salute di spirito, un vero e
proprio maestro dell’anti-conformismo, tanto leale ai princìpi del libero pensiero da
sapersi distaccare, senza rancore o rimpianto, dai dogmi religiosi, culturali e
accademici che si respiravano all’epoca, e anzi sottolineando la stringente necessità
della liberazione da questi gioghi in vista della propria autentica fioritura umana. La
condivisione da parte di Nietzsche di queste istanze emersoniane, con le dovute
differenze – specialmente a livello metafisico –, fa sì che la loro prosa si faccia
portatrice di un messaggio messianico di salvezza di sé, secondo la legge di una
nuova provvidenza personale e attraverso l’esercizio della virtù vivificante della selfreliance (fiducia in se stessi), posta come contraltare della virtù eteronoma predicata
dalla società moralista, divenuta ormai una mortificazione dell’espressione
individuale di sé. Per corroborare l’idea che le letture emersoniane di Nietzsche
abbiano operato sulla sua filosofia un’influenza “vivificante”, è bene notare che non è
raro riscontrare, entro la letteratura dedicata, posizioni sostenitrici del fatto che il
“savio di Concord” sia stata la fonte di quel vitalismo del pensiero nietzschiano che
permise l’abbandono della visione pessimistica adottata a partire dalle letture di
Schopenhauer. Benchè solitamente, nel considerare i maestri di Nietzsche, sia stata
6
Representative Men, la quale diverrà accessibile a Nietzsche nella sua interezza solo dopo il 1883,
grazie alla traduzione di Ida Overbeck. Al quarto libro di Emerson facente parte della sua biblioteca
personale, Letters and social aims, acquistato nella traduzione tedesca Neue Essays il 24 aprile 1876,
compaiono invece scarsi rimandi espliciti» in B. Zavatta, La sfida del carattere. Nietzsche lettore di
Emerson, Editori Riuniti, Roma 2006, pp. 41-42.
3
F. Nietzsche, aforisma 92, libro II, La Gaia Scienza , in Idilli di Messina - La gaia scienza Frammenti postumi (1881-1882), a cura di M. Montinari e F. Masini, Adelphi, Milano 1965, pp. 100101.
4
F. Nietzsche, frammento 12 [172] autunno 1881, ivi, p. 415.
5
È noto il contributo di Emerson, insieme a letterati del calibro di Whitman, Thoreau e Melville,
nell’affermazione di quel movimento di nascita della cultura autonoma americana, rinominata da
Francis Otto Matthiessen Rinascimento americano nel suo American Renaissance: Art and Expression
in the Age of Emerson and Whitman, Oxford University Press 1968.
6
vd. ad es. Postfazione, in R. W. Emerson, Condotta di vita , a cura di B. Soressi, Rubbettino,
Soveria Mannelli 2008, pp. 286-287.
�343
La virtù della sel f -reliance nelle filosofie di Emerson e Nietzsche
concessa una decisiva priorità a Schopenhauer, Emerson resta una figura
fondamentale, tanto che, ignorando l’influenza che ebbe nella genesi e nel successivo
cammino del pensiero di Nietzsche, si trascurerebbe un anello determinante del suo
sviluppo intellettuale.
Questo preliminare lavoro vuole approfondire un nodo teorico centrale nella
produzione filosofica di entrambi, che concerne la virtù della fiducia in se stessi,
ovvero nella propria natura e nel genio individuale di ognuno; si tratta di una
tematica che richiama proprio quel vitalismo emersoniano, mutuato da Nietzsche,
che enfatizza la vita e l’esperienza come “vissuto” contro una conoscenza puramente
sterile, e che alla morale eteronoma oppone una vita morale istintiva e naturale. Per
quanto sia vero che nell’opera nietzschiana non è presente una tematizzazione
ordinata della self-reliance, Nietzsche, tuttavia, dimostra in molti luoghi della sua
produzione un’evidente concordanza con le istanze emersoniane che promuovono
questa virtù. Egli accoglie la necessità di quel ritorno a se stessi e della fiducia nella
propria iniziativa individuale, che è esattamente il cuore della self-reliance
emersoniana. Il presente lavoro avrà dunque l’obiettivo di rintracciare alcune di
queste consonanze di pensiero al fine di renderle manifeste, mostrando che in
Nietzsche è in parte presente una trattazione indiretta di questa tematica.
Si cercherà primariamente di fornire una panoramica della self-reliance, tentando
l’impresa di definirne i contorni e le caratteristiche. Innanzitutto ne verranno
mostrati gli elementi propedeutici, quali da un lato una “sana incoerenza” nei
confronti del proprio sé passato, necessaria ai fini della fiducia in quella sorgente
creativa che darà vita al proprio sé futuro, con particolare attenzione al processo di
costruzione del carattere personale (sezione 1), e dall’altro l’atteggiamento nonconformista, inteso come liberazione dall’etero-direzione che domina ogni aspetto del
nostro vivere quotidiano, tanto nell’ambiente accademico-intellettuale quanto
nell’agire pratico (sezione 2). La liberazione dai vincoli della “coerenza a tutti i costi”
e del conformismo si accompagna al rifiuto dei canoni morali di “buono” e “giusto”,
e insieme rileva uno sconfortante fallibilismo epistemologico; il rimedio davanti
all’inevitabile abbandono di ogni metro e misura, di ogni coerenza e regola sociale,
di ogni canone morale e intellettuale, è una ferrea fiducia in se stessi e nella propria
natura quale unica legge, e il conseguente abbandono al mondo della vita e
dell’esperienza come “vissuto”, dove il mezzo per la conoscenza e l’agire sta nella
sperimentazione individuale. Ci troviamo dunque ad avere a che fare con un
innocente scetticismo, che non è da intendersi come livellamento di tutti i punti di
vista, bensì come pluri-prospettivismo, ovvero un atteggiamento capace di saggiare
tutto, senza mai operare una fossilizzazione del pensiero e del sé, quell’atteggiamento
che garantisce a colui che se ne appropria di essere a casa dovunque (sezione 3).
Solo allora, dopo aver esplorato premesse, sostanza e conseguenze della fiducia in
se stessi, ci troveremo dinnanzi a un’immagine più nitida dell’autentico self-reliant
man, un individuo che ha accettato la sfida del proprio destino costruendo e
�344
C A ROLA I SA IA
perfezionando il proprio carattere con strenua dedizione e disciplina, ormai lontano
dall’eteronomia che governava il suo quotidiano, colui che erge a legge solo la
propria natura, e così facendo si riscopre come divino.
1. LA FIDUCIA IN SE STESSI: UNA PANORAMICA 7
Emerson promuove la self-reliance come un ideale, una forza, una virtù, e
precisamente quella virtù vivificante tipica dello spirito libero, che contrasta in
molteplici modi l’essere dipendenti intellettualmente e moralmente dalle opinioni e
dai sistemi di credenza vigenti; una virtù che quindi si declina sia come un principio
dell’intelletto, sia come un modo di condurre la propria vita.
Sebbene Nietzsche non elabori esplicitamente l’idea di una “fiducia in se stessi”,
in molti luoghi della sua opera è possibile rintracciare una condivisione delle istanze
che richiamano alla necessità di edificare l’emersoniano self-reliant man, che è
descritto da Emerson come colui che
ha abbandonato i motivi comuni dell’umanità e si è avventurato a confidare in se stesso come unico
maestro. In alto sia il suo cuore, ricolma di fede la sua volontà, limpido il suo sguardo, affinchè nel modo più
serio possa essere per se stesso dottrina, società e legge, e affinchè un semplice proposito possa per lui essere
così forte come la ferrea necessità lo è per gli altri. 8
La visione emersoniana della self-reliance si esprime sostanzialmente nella fiducia
che si ripone nella propria iniziativa individuale; questa nuova virtù è posta come
rimedio alla decadenza della civiltà umana, causata dalla mancata espressione di sé,
dalla totale etero-direzione a cui l’individuo si sottomette per comodità o pigrizia in
tutti gli ambiti del quotidiano. La correzione di questa tendenza è operata attraverso
l’assunzione di un sano atteggiamento scettico e, insieme, il ripudio non solo del
conformismo, ma, prima ancora, della coerenza come metro di affidabilità e fedeltà a
se stessi. La fiducia in sé non sta infatti nel fossilizzarsi su ciò che eravamo ieri (ciò
che ci ha nutrito, ciò che ci ha appassionato, ciò che abbiamo amato, condiviso ed
esperito), ma in ciò che saremo domani. Tributare fede e fedeltà assoluta alla propria
natura significa innanzitutto essere sempre pronti all’incoerenza, dal momento che,
come sottolinea Soressi nel suo R. W. Emerson. Il pensiero e la solitudine: «Solo chi
si è allontanato da sé (dal sé passato) può confidare in sé (nel prossimo sé). Confidare
nel sé passato […] significa diffidare del prossimo, possibile, sé: significa negarlo». 9 E
Quello della self-reliance, è certamente uno dei temi più trattati dalla critica in relazione al
pensiero emersoniano. Tra le molte produzioni sull’argomento possiamo citare: G. Kateb, Emerson
and Self-Reliance, Sage, Thousand Oaks 1995; G. Van Cromphout, Emerson’s Ethics, University of
Missouri of the Essays, Cambridge UP, Cambridge 1999; K. S. Sacks, Understanding Emerson: "The
American Scholar" and His Struggle for Self-Reliance, Princeton University Press, 2003.
8
R. W. Emerson, Fiducia in se stessi, in Diventa chi sei. Fiducia in se stessi, Compensazione, Leggi
Spirituali, a cura di S. Paolucci, Donzelli Editore, Roma 2005, p. 30.
9
B. Soressi, Ralph Waldo Emerson. Il pensiero e la solitudine, Armando editore, Roma 2004, p. 53.
7
�345
La virtù della sel f -reliance nelle filosofie di Emerson e Nietzsche
dunque – si chiede Emerson – perché mai portarsi dietro questo «cadavere dei tuoi
ricordi», per la stolta paura di contraddirsi pubblicamente? Perché costringerci al
principio della “coerenza ad ogni costo”? 10
La self-reliance non è dunque un punto di arrivo, un traguardo, caratterizzato
dalla staticità una volta raggiunto; ricorda invece la natura di un processo, che non si
estingue con il raggiungimento di una meta esterna, perché l’arrivo, la meta, è il
processo stesso, che è dinamico per definizione. Il “sé” in cui avere fiducia è il sé
sempre rinnovato nel processo di auto-creazione in cui ognuno di noi è
costantemente implicato, 11 quello stesso processo per cui «si diviene ciò che si è»,
come recita il sottotitolo di una delle più fedeli autobiografie di Nietzsche, Ecce
Homo, che voleva essere propriamente il manifesto che sancisse la liberazione dello
spirito dai condizionamenti e modelli del proprio io passato, come nel caso di
Nietzsche lo erano stati Schopenhauer e Wagner, e affermasse con strenuo vigore la
sua predilezione per la cultura mediterranea e una nuova salute spirituale.
La fonte che alimenta la scelta di adottare il principio della “coerenza a tutti i
costi” è individuata da entrambi gli autori nella paura di incontrare il biasimo altrui
nel momento in cui ci mostriamo incostanti nel nostro stile di vita, nelle nostre
opinioni e abitudini, tutte qualità che vengono solitamente interpretate come segni
distintivi dell’identità personale dell’individuo, specialmente agli occhi degli altri;
essi infatti, nota Emerson, «non hanno altri elementi, per calcolare la nostra orbita,
se non le nostre passate azioni». 12 Il timore per il biasimo altrui non è soltanto la
ragione che ci spinge ad adottare il metro della coerenza, ma è esattamente quel
«timore che ci allontana dalla fiducia in noi stessi», una forte limitazione
dell’espressione autentica di sé e della possibilità di accrescere il proprio spirito
trasformandosi continuamente; «un’anima grande non ha semplicemente nulla a che
fare con la coerenza ad ogni costo». 13
Questa convinzione è propria anche di Nietzsche, che in Aurora ci invita a
guardare allo spirito libero:
come poco spregevole, in se stesso, appare a quest’ultimo il mutare le proprie
opinioni! Come onora egli invece nella capacità di cambiare d’opinione un raro
ed elevato segno di distinzione, specialmente se essa arriva fin nel cuore della
vecchiaia! 14
Nella visione complessiva di Nietzsche, una «salda reputazione» è semplicemente
il riflesso di una presunta sicurezza e fermezza da voler esporre davanti agli altri, così
10
R. W. Emerson, Fiducia in se stessi, op.cit., p. 14.
Leggiamo nel saggio emersoniano Compensazione: «La vita dell’uomo è un progresso, e non una
stazione» ivi, p. 71.
12
R. W. Emerson, Fiducia in se stessi, ivi, p. 14.
13
ivi, p. 15.
14
F. Nietzsche, aforisma 56, libro I, Aurora , in Aurora e Frammenti postumi (1879-1881), a cura di
F. Masini e M. Montinari, Adelphi, Milano 1964, pp. 44.
11
�346
C A ROLA I SA IA
da poter essere stimato come qualcuno su cui si possa davvero contare, in quanto si
«rimane uguale a se stessi». Ma anche per Nietzsche siamo in realtà davanti
all’atteggiamento «di gran lunga più dannoso» non solo per la self-reliance, ma per la
stessa conoscenza. 15
La grandezza e la salute dello spirito si constatano allora proprio dalla capacità di
mutare le proprie convinzioni come il serpente muta di mese in mese la sua pelle, di
essere dediti a un rinnovamento costante della propria individualità, sempre pronti a
mettere in discussione le proprie scelte e abitudini, anche e soprattutto a costo di
essere fraintesi – dirà Emerson –, esattamente come «Pitagora fu frainteso, e così
Socrate, Gesù, Lutero, Copernico, Galileo, Newton» furono fraintesi; «essere grandi
vuol dire essere fraintesi». 16
Sembrerebbe naturale a questo punto domandarsi se questa continua metamorfosi
di sè non rischi effettivamente di frantumare la propria integrità individuale; eppure
cambiare abitudini e rivalutare vecchie decisioni è proprio inteso da Emerson come
il più efficace antidoto contro la “perdita di sé”, che accade invece nel momento in
cui si rimane fedeli a ciò che si è stati, mantenendosi inflessibilmente fermi sulle
medesime opinioni e posizioni di sempre. Rinunciare al mutamento di sé significa
rinunciare a crescere spiritualmente come essere umano, lasciando nascoste o
silenziate tutte le potenzialità inscrutabili che la vita riserva a ciascuno.
L’atteggiamento proposta da Nietzsche come contraltare a questa potenziale rinuncia
di sé è il saper vivere nello «stato d’animo del viandante», consci che la vita è
processo, e non staticità e fissazione, ed è un processo misterioso, che non ci consente
di prevedere più aldilà dell’indomani. In un appunto del 1878 Nietzsche, citando un
passo emersoniano, elaborerà esattamente l’idea della metamorfosi personale
nell’imprevedibilità della vita:
Emerson dice: “il valore della vita risiede nelle sue insondabili capacità: nel
fatto che io non so mai, se sto diventando un individuo nuovo, che cosa mi può
capitare”. Questo è lo stato d’animo del viandante. 17
Vivere secondo lo stato d’animo del viandante comporta l’acconsentire a quel
dinamismo vitale che sta alla base dell’accrescimento dello spirito, e che procede,
tanto nella natura quanto nell’uomo, secondo la legge del divenire e della crescita.
Emerson osserverà come è proprio in virtù di questa «intrinseca necessità» che ogni
anima
15
F. Nietzsche, aforisma 296, libro IV, La Gaia Scienza , op.cit., pp. 172-173.
R. W. Emerson, Fiducia in se stessi, op.cit., p. 15; parte passo emersoniano lo ritroviamo copiato
tra gli appunti di Nietzsche, vd. F. Nietzsche, frammento 30 [104] estate 1878, in Umano, troppo
umano II e Frammenti Postumi (1878-1879), a cura di M. Montinari e S. Giametta, Adelphi, Milano
1967, p. 313.
17
F. Nietzsche, frammento 32 [13] autunno 1878, ivi, p. 330.
16
�347
La virtù della sel f -reliance nelle filosofie di Emerson e Nietzsche
abbandona il suo intero sistema di cose, i suoi amici, la sua casa, le leggi, la
fede, al pari di come il mollusco striscia fuori dalla sua bella ma pietrosa
custodia perché questa non permette più la sua crescita, e pian piano si
costruisce una nuova dimora. 18
Finora si è delineata un’immagine del self-reliant man in negativo, mostrando cioè
quali limitazioni egli deve lasciarsi alle spalle per intraprendere un cammino
all’insegna della fiducia in sé. Tuttavia l’individuo che è riuscito a slegarsi dalla
tendenza conformista e che professa una sana incoerenza non è, di per sé, sufficiente
a fondare un’autentica fiducia in se stesso. A questo scopo è infatti necessario anche
un lungo lavoro preparatorio sul proprio carattere, sul proprio temperamento e
indole, utile al contempo a conoscersi intimamente, tastando ed esperendo limiti e
potenzialità della propria natura. La self-reliance richiede dunque, quali premesse
propedeutiche, la conoscenza di sé (self-acquaintance) e il possesso di sé (selfpossession), premesse indiscutibilmente legate e imprescindibili l’una all’altra.
Conoscere se stessi è prima di tutto diventare consci dei nostri limiti, interni ed
esterni; tra questi sono facilmente individuabili gli impulsi naturali. Il dominio di sé
si realizza in prima istanza attraverso un corretto governo di quell’impulso dionisiaco
e caotico della nostra naturale corporeità. È risaputa la stima che Nietzsche nutriva
nei confronti della grecità, descritta come quella civiltà che mai rinnegò «l’impulso
naturale che si esprime nelle cattive qualità», ma che è anzi stata capace di
inquadrarlo escogitando «sufficienti misure precauzionali per poter dare a quelle
acque impetuose il deflusso più innocuo possibile». 19 Entrambi gli autori sono consci
del potenziale distruttivo delle passioni e degli istinti non controllati; Emerson li
delineerà come «quegli elementi dalla forza più sottile» che, specialmente quando si
manifestano in sovrabbondanza, rischiano di diventare essi stessi «padroni»
dell’uomo; ma il rimedio corretto sta nell’accrescere la propria personale abilità di
dominarli e incanalare queste forze negli spazi giusti al momento giusto, non nel
mortificarli e sopprimerli: «si dovrà dunque rinunciare al vapore, al fuoco,
all’elettricità, o si dovrà imparare a gestirli? La regola per tutta questa classe di agenti
è: tutto il sovrappiù è buono, basta soltanto metterlo al posto giusto». 20
Al fine di una più profonda conoscenza di sé non è sufficiente il dominio
dell’impulso e dell’istinto; infatti viene individuato un altro limite del quale dover
prendere coscienza: si tratta del subdolo potere del fato che agisce su tutti noi quale
dura legge e della natura e dell’individuo umano; “fato” è un termine con cui
Emerson, e il giovane Nietzsche dopo di lui, 21 identificano tutta quella serie di
18
R. W. Emerson, Compensazione, op. cit., p. 73-74.
F. Nietzsche, aforisma 220, Opinioni e sentenze diverse, in Umano, troppo umano II e Frammenti
Postumi, op. cit., pp. 83-84.
20
R. W. Emerson, Potenza , in Condotta di vita , op. cit., p. 82.
21
Cfr. con gli scritti giovanili di Nietzsche Fato e storia e Libertà della volontà e fato in F.
Nietzsche, Scritti giovanili 1856-1864, a cura di G. Campioni e M. Carpitella, Adelphi, Milano 1998,
19
�348
C A ROLA I SA IA
condizionamenti costantemente operanti entro la nostra indole che derivano dai
caratteri ereditari delle generazioni che ci hanno preceduto, dal sesso di
appartenenza, dal clima in cui siamo nati e cresciuti, dai precetti educativi che hanno
informato la nostra giovinezza. Emerson sosterrà che tutti questi elementi sono
accomunati dalla loro capacità di «imprigionare la potenza vitale in certe direzioni» 22
piuttosto che in altre. Tuttavia, il fatto che tutte queste predisposizioni operino su di
noi silenziosamente e inconsciamente, suggerisce, secondo l’americano, che solo
divenendo consapevoli che «la potenza di un uomo è accerchiata dalla necessità» 23
avremo compiuto il primo passo verso l’autentico possesso di sé, e potremo aprire le
porte a una nuova potenza, perché «benchè il Fato sia immenso, anche la potenza,
che è l’altro fatto nel mondo duale, è immensa. Se il Fato segue e limita la potenza, la
potenza attende al varco il Fato e ne diventa l’antagonista» 24 e insieme la compagna,
dato che non si tratta di rinnegarlo – dal momento che è appurato – ma soltanto di
tributagli fede.
Il germe iniziale dell’amor fati nietzschiano si ritrova precisamente nella lieta
accettazione del nostro essere necessitati, senza manifestazione di rassegnazione, ma
anzi consapevoli al contempo che in ognuno di noi «creatura e creatore sono
congiunti»; 25 perciò è concessa una certa plasticità alla nostra potenza creatrice, la
quale – immensa tanto quanto è immensa la necessità che il Fato esercita su di noi –
aspetta soltanto di essere stimolata, nutrita e accresciuta. In questo modo essa viene a
definirsi sempre più come lo strumento che ci permette di edificare e perfezionare il
nostro carattere, di favorire certe attitudini piuttosto che altre, e volgere a nostro
vantaggio quelle che ora viviamo come ostacoli.
La conoscenza di sé intesa come conoscenza delle proprie limitazioni è dunque il
primo passo per il dominio di sé, e conseguentemente per la costruzione artistica del
proprio carattere. Si potrebbe concludere che, in fondo, la fiducia in se stessi sia
essenzialmente una questione di carattere. Come dirà Nietzsche, l’uomo che riesce ad
essere «contento di se stesso» è colui che sa «conferire stile al proprio carattere», colui
che «abbraccia con lo sguardo tutta la panoplia di forze e debolezze che la sua natura
offre e le inquadra poi in un piano artistico» finchè anche la più infelice debolezza
riesca ad «incantare l’occhio». Siamo dinnanzi a quel processo di costruzione di
un’anima grande e bella allo stesso tempo, raggiunta attraverso continue operazioni
pp. 203-213; si tratta di due dei primi tentativi filosofici di Nietzsche, che si possono considerare, sotto
molti aspetti, come una riflessione e insieme una parafrasi di tematiche esplicitamente emersoniane; lo
scrittore americano è d’altronde citato direttamente in almeno due luoghi importanti, che rimandano
ad argomenti contenuti nei saggi Fato e Circoli. Per approfondimenti vd. B. Zavatta, La sfida del
carattere. Nietzsche lettore di Emerson, Editori Riuniti, Roma 2006, in particolare pp. 47-72.
22
R. W. Emerson, Fato, in Condotta di vita , op. cit., pp. 33-36.
23
Ivi, p. 45.
24
Ivi, p. 47.
25
F. Nietzsche, aforisma 225, in Al di là del bene e del male, a cura di F. Masini, Adelphi, Roma
1977, pp. 133-134.
�349
La virtù della sel f -reliance nelle filosofie di Emerson e Nietzsche
di correzione e perfezionamento, di trasfigurazione del brutto in sublime, che consta
in un «lungo esercizio e una quotidiana fatica». Le nature forti sono tali proprio in
virtù della ferrea disciplina e costrizione che impongono a se stesse, e solo «entro tale
disciplina e compiutezza godranno sotto la propria legge la loro gioia più bella»,
proprio perché saranno divenute autenticamente padrone di se stesse. 26
2. SELF-RELIANCE COME NON-CONFORMISMO
L’essere autenticamente padroni di sé si accompagna anche all’istanza nonconformista. La società – che comprende il sistema di valori morali, di usi e costumi,
di opinioni della comunità accademica, della religione e della tradizione – trama
costantemente contro l’individualità e la sua potenza. Emerson la descriverà come
quel luogo «dove la virtù più gettonata è il conformismo, e la fiducia in se stessi è ciò
che vi si oppone». 27 Lo stesso processo di cosiddetta “maturazione” verso l’età adulta,
a cui tutti andiamo incontro, è in realtà un processo di “conformazione” ai canoni
che fanno da pilastro del vivere comune. C’è un’assidua tendenza a sforzarsi di
compiacere, di essere accettati, che ci spinge a conformarci ai dettami imposti dalla
società. L’uomo è diventato principe della mortificazione di sé; egli – ammonisce
Emerson – «non osa dire “Io penso”, “Io sono”, ma preferisce citare qualche santo o
saggio». 28 Raramente, infatti, ci fermiamo a riflettere su quanto delle nostre opinioni
e credenze provenga dall’opinione comune e vigente e non dal nostro intimo
pensiero. Anche l’occhio acuto di Nietzsche aveva rilevato come «la prima opinione
che ci viene in mente, quando siamo improvvisamente interrogati su una cosa, di
solito non è la nostra propria, ma solo quella usuale, appartenente alla nostra casta,
posizione, origine; le opinioni proprie fluttuano raramente alla superficie». 29
Se Emerson in Fiducia in se stessi dichiara senza esitare che: «chi vuole essere un
uomo, deve essere un non-conformista», 30 Nietzsche, nell’Inattuale dedicata a
Schopenhauer, dimostra di collocarsi molto vicino al pensiero dell’americano:
l’intenzione è quella di mostrarci come lo stile di vita conformista è sicuramente
vissuto come comodo e accomodante, ma al prezzo di una totale perdita di
espressione di sé e manifestazione della nostra unicità, un sostanziale spreco
dell’unica vita che ci è concessa. La causa che Nietzsche scopre a fondamento del
vivere conformista è la pigrizia, che è insieme adattabilità e ignavia, interpretata
come “paura per la scomodità”, che trova piena attuazione nell’atto di fuggire il
26
F. Nietzsche, aforisma 290, libro IV, La Gaia Scienza , op. cit., p. 167-168.
R. W. Emerson, Fiducia in se stessi, op. cit., p. 7.
28
Ivi, p. 23.
29
F. Nietzsche, aforisma 571, L’uomo con se stesso, in Umano, troppo umano I e Frammenti
Postumi (1876-1878), a cura di S. Giametta e M. Montinari, Adelphi, Milano 1965, p. 281.
30
R. W. Emerson, Fiducia in se stessi, op. cit., p. 7.
27
�350
C A ROLA I SA IA
proprio genio. 31 Sotto la pigrizia si cela un immenso timore per tutti quei fastidi che
«una onestà e nudità incondizionata imporrebbe loro», come vuole la virtù della selfreliance, che è anche coraggio di essere onesti con se stessi prima di esserlo con gli
altri. Questo, come dirà Emerson, implica il non nascondere la verità che sta
nell’unicità di ognuno di noi, significa avere il coraggio di esporre pubblicamente il
proprio nudo pensiero; è mostrarsi per ciò che si è e «dire la cruda verità in tutti i
modi», perché «la verità è inestimabilmente più bella di ogni affetto». 32 Invece –
come sembra aggiungere Nietzsche – la tendenza comune sta nel «dire la verità solo
a certe condizioni: cioè a condizione di essere capiti in modo benevolo». 33
A legare Emerson e Nietzsche sul fronte del non-conformismo è dunque la volontà
di liberare l’uomo dall’etero-direzione che domina ogni aspetto del nostro vivere
quotidiano. Le fondamentali dimensioni dell’umano in cui questa istanza di
liberazione si fa sentire più forte che mai sono la Cultura e la Morale, ambiti in cui
regna indisturbata la tendenza a sostituire alla saggezza interiore una fonte di
saggezza totalmente esterna. C’è necessità di individui Fiduciosi, perché il
conformismo ha consentito il radicamento di una prospettiva eteronoma che viene
applicata in ogni dove; il merito e le stesse opere grandiose non trovano mai la loro
sorgente nell’Io individuale, ma sempre in qualcosa d’altro, di esterno. Invece –
suggerirà Emerson – «chi sa che la forza è innata, chi sa che la debolezza gli deriva
dall’aver cercato il bene al di fuori di sé e altrove, e, avendo intuito ciò, si affida senza
esitare al proprio pensiero, immediatamente si raddrizza, guadagna una postura
eretta, comanda le sue membra, compie miracoli» 34: ecco il self-reliant man.
La cultura e il sapere accademico che si fanno oggetto di critica e di superamento
in Emerson e Nietzsche sono costituiti dalla vecchia e stantia cultura europea, i cui
valori Nietzsche tanto ambiva a trasvalutare nell’intento di difendere la singola
genialità individuale minacciata dalle opinioni accademiche. Allo stesso modo
Emerson, nella sua famosa conferenza The American Scholar esortava i giovani
studenti americani a liberarsi della dipendenza culturale europea, dichiarando per
contro la necessità di coltivare la fiducia in se stessi:
Forse è giunto ormai il momento in cui il pigro intelletto di questo continente
alzerà le sue palpebre di ferro, e risponderà alla prolungata aspettativa del
mondo con qualcosa di meglio che con l'esercizio di abilità meccaniche. Il nostro
giorno di dipendenza, il nostro lungo apprendistato per rapporto al sapere di
altre terre, volge verso il termine. I milioni di persone che intorno a noi
irrompono nella vita non potranno essere sempre nutriti con i residui stantii di
31
F. Nietzsche, Schopenhauer come educatore, a cura di M. Montinari, Adelphi, Milano 1985, pp.
3-4.
32
R. W. Emerson, Fiducia in se stessi, op- cit., pp. 8-9.
F. Nietzsche, frammento 7 [6] fine 1886 – primavera 1887 in Frammenti Postumi 1885-1887, a
cura di S. Giametta, Adelphi, Milano 1975, p. 260.
34
R. W. Emerson, Fiducia in se stessi, op. cit., p. 44.
33
�351
La virtù della sel f -reliance nelle filosofie di Emerson e Nietzsche
raccolti stranieri. Sorgono eventi, azioni che devono essere cantati, che
canteranno sé stessi.
35
L’esortazione a questa liberazione, tenute presenti le dovute differenze dei climi
culturali, è molto simile al nucleo motivazionale che sta alla base delle Inattuali
nietzschiane, opere che sanciscono la definitiva rottura di Nietzsche con
l’establishment accademico, nelle quali il suo dissenso nei confronti della cultura
contemporanea è espresso in termini di antirazionalismo e antistoricismo. Contro le
menti mediocri che permettono la perpetrazione di una cultura erosa dalla
decadenza, Nietzsche esalta la figura del filosofo quale utilissima medicina capace di
curare questa malattia culturale degenerativa. La filosofia accademica cade in un
pericoloso baratro quando «si impegna a presentarsi in primo luogo e principalmente
come erudizione. Soprattutto come conoscenza della storia della filosofia»: qui non
c’è allora spazio per il genio filosofico, per quell’anima bella che è fermamente fedele
alla credenza che «frugare in innumerevoli opinioni estranee e assurde è quanto di
più ripugnante e fastidioso si possa immaginare». 36
Il peso dell’erudizione, quando quest’ultima è presa come principale criterio per
determinare gli uomini di cultura, è tanto ingente da non permettere più al pensiero
d’oggi di librarsi in un’aria nuova, in intuizioni che non sono ancora state trasposte
su carta, e ci costringe a ripercorrere tutti i pensatori del passato per essere
accreditati quali pensatori del presente. Questo è anche il motivo di critica che apre il
saggio emersoniano Natura, dove «i sepolcri dei padri» che fanno da metro e misura
richiamano la cultura europea, dalle cui dipendenze l’America doveva redimersi: «Le
generazioni passate guardarono Dio e la Natura faccia a faccia, noi attraverso i loro
occhi. Perché non dovremmo intrattenere anche noi un rapporto originale con
l’universo?» si chiede Emerson; infatti «il sole risplende anche oggi», «nuove terre,
nuovi uomini e nuovi pensieri» aspettano di essere scoperti, e nuove e grandiose
opere devono essere rivendicate. 37
Non è un caso, quindi, che sia ancora una volta Emerson il maestro a cui
Nietzsche si richiama per delineare le caratteristiche di quel genio filosofico, di quel
grande pensatore che troverà il suo motivo nel ribaltamento della filosofia da quella
ridicola «erudita saggezza» in qualcosa di assolutamente «temibile», come
effettivamente dovrebbe essere:
“State attenti” dice Emerson “quando il gran Dio fa venire sul nostro pianeta
un pensatore. Allora tutto è in pericolo è come se in una grande città sia
scoppiato un incendio, e nessuno sa sicuramente che cosa sia e come andrà a
finire. Allora niente vi è nella scienza che domani non possa essere capovolto […]
35
R. W. Emerson, The American Scholar, in The American Scholar, Self-Reliance, Compensation,
a cura di O. H. Smith, American Book Company 1911, pp. 21-22.
36
F. Nietzsche, Schopenhauer come educatore, op. cit., p. 90.
37
R. W. Emerson, Natura (1836), a cura di I. Tattoni, Donzelli, Roma 2010, p. 19.
�352
C A ROLA I SA IA
Un nuovo grado di cultura sottoporrebbe istantaneamente a un rovesciamento
l’intero sistema delle aspirazioni umane. 38
D’altronde i più grandi pensatori della storia, dirà Emerson, da «Mosè a Platone e
a Milton», sono stati emarginati per le loro idee originali, ma è proprio qui che sta il
loro merito, ovvero nel non aver tenuto «in alcun conto libri e tradizioni», e di aver
invece espresso «ciò che essi stessi pensavano». 39
«Credere nel proprio pensiero, credere che quel che si ritiene vero nel profondo
del cuore sia vero per tutti gli uomini: questo è il genio» 40 descritto da Emerson:
l’erudito che invece fa completo affidamento sulla tradizione di pensiero e sui testi
che la costruiscono come tale, prendendoli come modello di rifermento comparativo
per ogni idea e intuizione personale, esemplifica un atteggiamento altamente
limitante per la self-reliance: la potenza creativa del soggetto è impedita, come è
impedito lo sviluppo di nuove idee, proprio in quanto la loro portata è
“rivoluzionaria” rispetto ai canoni della tradizione. Può quindi succedere che,
silenziando questi pensieri sul nascere, arrivi il momento in cui questa idea viene
diffusa da un'altra mente più coraggiosa, con la probabilità che trovi largo consenso
in molti ambiti, e il soggetto si ritrovi così ad acconsentire alla sua stessa opinione, e
a dirsi: se solo avessi avuto il coraggio di dire “io penso”! 41
L’etero-direzione rilevata nell’ambito culturale e accademico è in realtà riflessa
anche nelle virtù morali sfoggiate in società. Nella quotidianità e nel vivere sociale
agiamo sempre preoccupati delle potenziali reazioni esterne; l’individuo subisce
ancora quel medesimo timore del biasimo altrui, e corre al riparo, stando attento ad
avere pronta ogni sorta di giustificazione a difesa del suo agire.
Avere fiducia in se stessi, nel pensiero emersoniano, vuol dire anche correre il
rischio di essere tacciati di egoismo o follia, ma gli individui veramente divini sono
proprio quelli che tributano fedeltà assoluta al loro sentire piuttosto che conformarsi
alla virtù eteronoma di una società moralista, acconsentendo a «chi crede di sapere
meglio di te quale sia il tuo dovere». 42 Emerson consiglia così di vivere veramente e
genuinamente secondo i canoni validi per me: «la mia vita vale per se stessa e non
per fare spettacolo»; l’unica cosa importante è essere consci che «quello che devo fare
è tutto ciò che mi riguarda e compete, e non ciò che la gente pensa». 43 Questa è la
norma per discernere tra «grandezza e mediocrità» d’animo, in quanto è una cosa
tanto semplice e accomodante nei confronti di se stessi vivere in società secondo
«l’opinione del mondo», come è altrettanto facile nella solitudine della propria anima
38
F. Nietzsche, Schopenhauer come educatore, op. cit., pp. 100-101; R. W. Emerson, Circles, Essays:
first series, in The complete essays and other writings of R. W. Emerson, a cura di B. Atkinson, Modern
Library, NY 1950, p. 283.
39
R. W. Emerson, Fiducia in se stessi, op. cit., p. 4.
Ivi, pp. 3-4
41
Ibidem .
42
Ivi, p. 11.
43
Ibidem .
40
�353
La virtù della sel f -reliance nelle filosofie di Emerson e Nietzsche
vivere secondo le proprie leggi e misure; ma la grandezza di un uomo si misura dal
coraggio di mantenere questa dolce «indipendenza della solitudine» anche nel
mondo e nella società. 44 Questa lodata solitudine non vuole però essere l’incipit di
una forma degenerativa di individualismo, dal momento che l’allontanamento dal
mondo che Emerson promuove è di natura diversa: «il vostro isolamento non deve
essere meccanico, bensì spirituale, ovvero deve essere un’elevazione». 45
La virtù della società moralista è interpretata – e ciò è noto – anche da Nietzsche
come l’atto di conformarsi a dettami esterni e spesso non sentiti con la necessaria
consonanza di spirito, un uniformarsi ai canoni dell’agire imposti da una società che
predica valori che richiedono una trasvalutazione, laddove vogliano consentire un
agire che sia finalmente indipendente e libero dai dogmi di comportamento. La
nuova virtù può nascere soltanto dall’autentica fiducia in se stessi, nel sapere di poter
essere comandati e dominati esclusivamente dalla propria natura, a cui si è tributata
fede assoluta. L’uomo portatore di un grande spirito aborre le «virtù del gregge», e
invece di preferire l’obbedienza a «una legge che già esiste» si fa creatore di una
nuova legge, che è la propria. 46
Contro la tentazione di definire le prospettive emersoniana e nietzschiana come
fautrici di un antinomianismo, seppur autorevole, Emerson risponde che «per quanto
la grande massa considera il vostro rifiuto delle regole popolari come rifiuto di tutte
le regole», lo fa perché non è a conoscenza della strenua inflessibilità a cui la legge
autoimposta richiama l’individuo self-reliant; costui non agisce in balia di
sentimentalismi e capricci, ma agisce secondo i dettami della propria legge, che è
dipinta come il giudice più severo, il quale esige un rigore irremovibile: «la legge
della coscienza resta ben salda. […] Se qualcuno pensa che questa legge sia
permissiva, provi per un giorno a tenere fede ai suoi comandamenti». 47
3. SELF-RELIANCE COME SANO SCETTICISMO
È convinzione di entrambi gli autori che all’etero-direzione presente in ogni
ambito del vivere umano dovrebbe sostituirsi un agire indipendente e vitale, dove le
doti della creatività e della spontaneità – tipiche dello sperimentatore quale emblema
dello “spirito libero” nietzschiano ed emersoniano – si accompagnano a un pluriprospettivismo scettico. Uno scetticismo così inteso non è da confondere con
44
Ibidem ; alcuni passaggi si ritrovano copiati negli appunti di Nietzsche: vd. F. Nietzsche,
frammento 17 [27] Principio del 1882, in Idilli di Messina - La gaia scienza - Frammenti postumi (18811882), op. cit., p. 464.
45
R. W. Emerson, Fiducia in se stessi, op. cit., p. 27.
46
F. Nietzsche, frammento 7 [6] fine 1886 – primavera 1887 in Frammenti Postumi 1885-1887, a
cura di S. Giametta, Adelphi, Milano 1975, pp. 260-262.
47
R. W. Emerson, Fiducia in se stessi, op. cit., pp. 29-30.
�354
C A ROLA I SA IA
un’attitudine che opera il livellamento di tutte le diverse prospettive, bensì come ciò
che richiama la necessità di esplorare ognuna di esse per scegliere, in ogni momento,
quella più rispondente alla propria natura. È un atteggiamento lodato come
fortemente positivo in quanto permette al pensiero di non fossilizzarsi. Non si tratta
dunque di quella «paralisi e malattia della volontà» – come scriverà Nietzsche nel
1886 – che è lo scetticismo di colui che è portatore di una «costituzione malaticcia»,
che non ha il coraggio di essere libero nel suo volere e sicuro nell’indipendenza delle
proprie decisioni: questi uomini, anzi «dubitano della “libertà del volere” sinanche
nei loro sogni». 48 Questo atteggiamento avvilente, che viene a costituirsi come una
maschera per una sostanziale indolenza o viltà, si traduce in un difetto di selfreliance. Un sano scetticismo, invece, è piuttosto da interpretarsi come nomadismo di
pensiero che, sancita l’inaffidabilità dei canoni morali di “buono” e di “giusto”
insieme a uno sconfortante fallibilismo epistemologico, si volge alla sperimentazione
individuale di ogni possibilità. Proprio in questo stanno la sua forza, la sua potenza e
la sua sorgente di conoscenza, accresciute dall’assimilazione di ogni nuova
esperienza, punto di vista o abitudine.
La prima premessa che motiva questo pluri-prospettivismo scettico è costituita,
come accennato, dal rifiuto dei canoni morali di “buono” e “giusto” come
universalmente validi e vincolanti. Tanto la prospettiva emersoniana quanto quella
nietzschiana accolgono la necessità di scardinare questi criteri morali dalla loro
valenza universale e in certo modo oggettiva, sicuramente con profonde differenze
nei rispettivi intenti, ma approdando poi al medesimo risultato: l’unica legge e
l’unico canone è la «legge della mia natura».
Al fine di comprendere correttamente la posizione emersoniana bisogna tenere
presente che il pensatore americano, poco dopo aver assunto l’ufficio di Ministro
della Chiesa Unitaria, abbandonò questa dottrina per riscoprire il divino come oversoul, un’anima universale che si presenta al contempo come trascendente e
immanente. Dio è nella Natura e in ognuno di noi, perché ogni cosa partecipa di Lui;
si tratta solo di ri-scoprirlo nel nostro intimo. Il flusso divino perpetuo che alimenta
la nostra realtà, allora, si pone come garante di un divenire benevolo verso il
meglio. 49 La legge divina che muove il mondo è la Legge di Compensazione, che fa sì
che quest’ultimo sia moralmente bilanciato, e che il male non venga mai lasciato
impunito: «il bene resta, il male scompare» 50 perché, come dirà Emerson,
48
F. Nietzsche, aforisma 208, in Al di là del bene e del male, op. cit., pp. 113-114.
Sta proprio qui, forse, il motivo per cui Emerson fu spesso additato come pensatore
eccessivamente ottimista, incapace di riconoscere il male e il tragico della vita. Interpretazione che poi
verrà corretta attraverso il crescente interesse della ricerca sulla riflessione filosofica complessiva
dell’autore.
50
Lo scriverà un giovane Nietzsche, sull’onda delle letture emersoniane, negli appunti del 1863 per
la composizione della sua Canzone per l’estate. Come rileva B. Zavatta: «Nietzsche fa propria l’idea
emersoniana di compensazione o polarità, secondo la quale ogni fenomeno in natura è
immediatamente seguito e completato dal suo opposto. Emerson nega infatti che vi sia soluzione di
49
�355
La virtù della sel f -reliance nelle filosofie di Emerson e Nietzsche
tutto il nostro sapere è un sistema di compensazioni. Ogni difetto in un senso è
risolto nell’altro. Ogni sofferenza viene ricompensata, ogni sacrificio è premiato,
ogni debito viene pagato. Tutte queste cose, e importantissime serie di fatti,
stanno alla base della nostra fede nell’esistenza di Dio e nella sua Provvidenza. 51
In virtù di questa legge «nessun uomo può arricchirsi (di spirito, nda) compiendo
cattive azioni o impoverirsi compiendone di buone». 52
Se dunque la realtà è interpretata come flusso della Super-anima universale, che
ne costituisce la fonte, allora le nozioni di “giusto” e “sbagliato” risultano essere non
solo obsolete, ma anche potenzialmente dannose per il self-reliant man: l’agire
morale diventa concretizzazione del sentimento morale proveniente dalla nostra
natura, di cui dobbiamo avere fiducia perché a sua volta deriva dall’infinito
potenziale della coscienza individuale, che è di natura divina.
Ebbene, è su queste premesse che Emerson, in Fiducia in se stessi, denuncerà i
vecchi canoni morali di “buono/cattivo” e “giusto/sbagliato” come predicati relativi,
in quanto «molto facilmente attribuibili a questa o a quella cosa»; il giusto, nella
visione emersoniana, può essere soltanto ciò che ha una rispondenza con la mia
natura, e sbagliato è solo «ciò che va contro di essa». 53
Alla potenziale obiezione che vivere secondo la propria natura comporti un vivere
secondo pulsioni e istinti distruttivi e irrazionali, che «potrebbero sorgere dal basso, e
non dall’alto», Emerson risponde che, nonostante non sembrino affatto tali, se
proprio sarò «figlio del Diavolo, vorrà dire che trarrò la mia vita dal Diavolo». Se
d’altronde l’unica norma è tributare fede e fedeltà alla propria natura, anche laddove
questa mi si rivelasse come malvagia sarebbe sempre meglio esserle fedele piuttosto
che seguire degli antichi dettami morali eteronomi. «Nessuna legge può essere per
me sacra se non quella della mia natura». 54
Nietzsche, come è facilmente prevedibile, non condividerà la credenza metafisica
in una over-soul, specialmente qualora venga posta come garante della sostanziale
bontà del divenire e del mondo. 55 Certamente, fin dalla sua giovinezza, egli
riconoscerà l’incontrovertibile legge di polarità che muove l’universo, ma senza
interpretarla come principio regolatore e ordinatore, bensì come legge intima
dell’innocente divenire. La fondamentale differenza che intercorre tra le visioni
continuità tra materia e spirito, tra bene e male o tra necessità e libertà, ipotizzando piuttosto un
processo di progressivo raffinamento ed evoluzione tale per cui alla fine “il bene resta, il male
scompare” […]» in B. Zavatta, op. cit., p. 55.
51
R. W. Emerson, Journal XVII, in Journals of Ralph Waldo Emerson 1820-1872, vol. II, Houghton
Mifflin, Boston and NY 1909, p. 72.
52
Riportato in R. L. Rusk, The Life of Ralph Waldo Emerson, Scribner, New York 1949, p. 123; cfr.
Postfazione di S. Paolucci in R. W. Emerson, Diventa chi sei, op. cit., pp. 113-114.
53
R. W. Emerson, Fiducia in se stessi, op. cit., p. 8.
54
Ibidem .
55
Nietzsche, nella sua copia personale dei Saggi emersoniani, appunterà accanto all’idea dell’oversoul esposta nel saggio Storia la glossa: «No! Ma è un ideale!», vd. in B. Zavatta, op. cit., p. 122.
�356
C A ROLA I SA IA
emersoniana e nietzschiana sta dunque nel fatto che Emerson pone un’ulteriore
garanzia alla self-reliance che in Nietzsche è assente: la partecipazione al flusso
dell’over-soul, guidata dalla Compensazione divina. Per Emerson la fiducia che si
tributa a se stessi è il riflesso della fiducia riposta nella natura divina del mondo; per
Nietzsche l’unico oggetto di fiducia e fedeltà è invece la propria natura, altrettanto
divina, ma non in termini di trascendenza.
Stabilite le dovute differenze di prospettive, Nietzsche pure rileva i concetti di
“buono” e “giusto” come erronei, laddove posti come giudizi prescrittivi
universalmente e oggettivamente validi. L’indagine morale di Nietzsche è
sostanzialmente un’indagine genealogica e demistificatoria, che, come osserva
Domenico Venturelli, vuole mostrare «l’impossibilità di pervenire alla certezza
intellettuale nell’ambito del giudicare morale», e questo sarà il motivo alla base della
sua critica al tentativo kantiano di costruire un imperativo categorico quale norma
morale. 56 È tuttavia da specificare che l’intento di Nietzsche non è immorale, bensì
ultra-morale: il suo prospettivismo, che sancisce l’impossibilità di valutazioni
oggettive e riconosce che ogni punto di vista è smisuratamente personale e unico,
non vuole essere a capo di un agire che prescinde dalla considerazione morale, bensì
vuole essere stimolo per un’ulteriore ricerca morale. «Nietzsche – osserva ancora
Venturelli – soffre non per difetto ma per eccesso di sensibilità morale e perciò
avanza, rispetto alla moralità, richieste di giustificazione intellettuale esorbitanti». 57
La fede troppo umana nella possibilità di un giudizio universalmente valido che
fissi la certezza morale in senso intellettuale è sostituita, nella proposta nietzschiana,
da un’altra fede incondizionata che sta alla base della certezza morale: si tratta
proprio di quella granitica fiducia in se stessi che caratterizza come tale l’anima
dell’uomo superiore. Una nuova morale verrà da esso edificata sulla spinta di una
divina volontà e potenza creatrice, la quale ordinerà una nuova tavola di valori. È una
creatività che ha trovato il suo apice di grandezza e di maestosità laddove è propria
dell’uomo che ha fede in se stesso. L’unica legge a cui egli è pronto a sottomettersi è
la propria legge, l’unica sua misura sta nella certezza di essere individuo sovrano, e
quindi riposa nella fiducia che esso ha in se stesso, che fa da base per la
giustificazione dello stesso valore del suo criterio soggettivo.
Abbandonando l’ambito morale, la seconda premessa che sta a fondamento
dell’adozione di un sano scetticismo è costituita dal rilevamento di uno sconfortante
fallibilismo epistemologico.
Il prospettivismo nietzschiano vuole insegnarci che «esiste soltanto un vedere
prospettico, soltanto un conoscere prospettico»: 58 esistono plurali prospettive
56
D. Venturelli, Nobiltà e sofferenza. Musica, religione, filosofia in F. Nietzsche, Il Melangolo,
Genova 2006, pp. 181-185 e 192.
57
Ivi, p. 184.
58
F. Nietzsche, aforisma 12, Che significano gli ideali ascetici?, in Genealogia della morale. Uno
scritto polemico, a cura di F. Masini, Adelphi, Milano 1984, p.113.
�357
La virtù della sel f -reliance nelle filosofie di Emerson e Nietzsche
mediante cui intendere la verità, le quali sono incondizionatamente personali e
soggettive. Su queste basi viene affermata l’impossibilità di valutazioni propriamente
oggettive e universali capaci di prescindere dall’individualità che le ha pensate o
scovate. L’intenzione di Nietzsche è di ricordarci che quelle che siamo soliti chiamare
“verità” in realtà «sono illusioni di cui si è dimenticata la natura illusoria», un
artifizio del tutto inventato. 59
L’unica possibile verità, per Nietzsche, proviene dall’assimilazione di molteplici
punti di vista sulla medesima cosa; non si tratta di una verità assoluta, ma è ciò che
più vi si avvicina: adottare una sola prospettiva equivale a guardare un fenomeno da
un’unica angolazione, la quale esclude al contempo tutte le altre. Nietzsche vuole
invece guardare alle cose con una molteplicità di occhi e prospettive differenti, di
modo da poter cogliere tutte le sfaccettature che ogni cosa offre di sé, dal momento
che «quanti più affetti lasciamo parlare sopra una determinata cosa, quanti più occhi,
differenti occhi sappiamo impegnare in noi per questa cosa, tanto più completo sarà
il nostro “concetto” di essa, la nostra “obiettività”». 60 Se una verità definitiva è
un’illusione, ciò che ci rimane è la possibilità di rinnovare costantemente il nostro
sguardo sulle cose, imparare a guardarle da ogni lato e ogni visuale. Le istanze che
leggiamo nel prospettivismo di Nietzsche si traducono quindi in una fuga dalla fissità
di pensiero e dalla staticità intellettuale, caratteristiche che nulla hanno a che vedere
con il vero «uomo di conoscenza»: in lui c’è un Sé «bramoso di tutto, che vorrebbe
vedere attraverso molti individui come attraverso i suoi stessi occhi e mercè loro
vorrebbe afferrare, come per mezzo delle sue stesse mani», un Sé che ha tanta avidità
«che niente vuole perdere di quel che potrebbe appartenergli», la cui anima sospira:
«Oh! Se potessi rinascere in cento esseri!». 61
Laddove Nietzsche sancisce la verità come mera illusione, Emerson, nel saggio
Esperienza, ne proclama con dolore l’inconoscibilità nel senso tradizionale del
termine. Si tratta di uno scritto che esprime nel suo incipit la condizione di lutto per
la perdita del figlio che, secondo l’interpretazione cavelliana, 62 funge da metafora per
descrivere la sostanziale impossibilità di pervenire a una conoscenza comprensiva,
sintetica e unitaria della realtà, la quale, quando ne diveniamo coscienti, ci
abbandona in uno sconforto senza pari. Dirà infatti Emerson in Experience: «Io
considero questa evanescenza e lubricità di tutti gli oggetti, che li fa scivolare
59
F. Nietzsche, Su verità e menzogna in senso extramorale, a cura di G. Colli, Adelphi, Milano
2015, p. 20.
60
F. Nietzsche, aforisma 12, Che significano gli ideali ascetici?, in Genealogia della morale, op. cit.,
p.113.
61
F. Nietzsche, aforisma 249, libro III, La Gaia Scienza , op. cit., pp. 155-156.
62
S. Cavell, Finding as Founding. Taking Steps in Emerson’s “Experience”, in Emerson’s
Trascendental Etudes, Stanford University Press, Stanford 2003, pp. 110-140 (già pubblicato in Id.,
This New Yet Unapproachable America. Lectures after Emerson after Wittgenstein, University of
Chicago Press, Chicago 1989).
�358
C A ROLA I SA IA
attraverso le nostre dita proprio quando noi li afferriamo più saldamente, come la
parte più spiacevole della nostra condizione». 63
La frustrazione che deriva dall’impotenza del pensiero di mantenere una presa
ferma sul mondo che ci circonda pone il problema di come recuperare una vicinanza
con la realtà: se non la conoscenza intellettuale, cosa? La modalità più consona per la
conoscenza del mondo viene così rilevata nella ricettività, e non nella conoscenza nel
senso dell’attività di un pensiero che vuole plasmare la realtà. Proprio qui si instaura
quel sano scetticismo emersoniano che enfatizza il ruolo del «sé recettore» che, come
ricorda Soressi, solo in questa modalità riesce ad aprirsi all’over-soul: il divino, infatti,
è un flusso che scorre in ogni sé individuale, il quale diviene una «fonte» del divino
stesso, esperito mediante le proprie «correnti vitali, istinti, emozioni, intuizioni»,
tutte modalità opposte al calcolo e all’esercizio puramente razionale del pensiero. 64
Non siamo più, dunque, davanti al problema di come conoscere razionalmente a
partire dall’esperienza, ma all’istanza di apprendere un modo diverso di coniugare il
conoscere, declinato in un’attività non più strettamente razionale, bensì emotiva e
intuitiva, che prescrive un abbandono all’esperienza e al vissuto personale,
sacrificando la tendenza tutta umana al dominio conoscitivo.
È esattamente sulla scia di queste considerazioni che Cavell va definendo
l’emersoniana «epistemologia degli stati d’animo» (epistemology of moods), intesa
come una particolare riformulazione correttiva delle tradizionali categorie kantiane,
le quali, in questa nuova configurazione della conoscenza come vissuto personale,
risultano insufficienti. Egli suggerisce invece «che ci sono più modi o strati» mediante
cui conoscere la realtà. 65 È come se il mondo rispondesse ai nostri umori,
dipingendosi della medesima tonalità che contraddistingue gli stati d’animo
mediante cui noi lo guardiamo:
la vita è un susseguirsi di stati d’animo, come un filo di perle, e quando noi passiamo attraverso di essi, si
dimostrano essere delle lenti colorate che dipingono il mondo con le loro tinte, e ciascuno di essi ci mostra solo
quello che è contenuto nel suo raggio focale. 66
Cavell ha sostanzialmente ripreso «l’affermazione di Kant di aver compiuto una
rivoluzione copernicana nella metafisica: cioè, capire le configurazioni del mondo in
funzione delle configurazioni della nostra stessa natura»; tuttavia ha anche trasposto
il discorso al di là delle circoscrizioni kantiane, ammettendo che gli stati d’animo
devono essere considerati come aventi un ruolo «almeno altrettanto valido nel
presentarci la realtà di come lo ha l’esperienza sensoriale». Dipingere il mondo come
63
R. W. Emerson, Experience, Essays: second series, in The complete essays and other writings of
R. W. Emerson, op. cit., pp. 344-345.
64
B. Soressi, op. cit., p. 24.
65
S. Cavell, Thinking of Emerson, in Id., The Senses of Walden, North Point Press, San Francisco
1991, pp. 125-126.
66
R. W. Emerson, Experience, Essays: second series, in The complete essays and other writings of
R. W. Emerson, op. cit., p. 345.
�359
La virtù della sel f -reliance nelle filosofie di Emerson e Nietzsche
«magnanimo», quindi, non sarà meno obiettivo che dipingere una mela
«attribuendole i colori rosso o verde». 67
Sicuramente innovativa, l’epistemology of moods proposta da Cavell
consentirebbe di cogliere al meglio la complessità del reale, enfatizzando la
dimensione dell’ordinario e del vissuto personale quale autentica sorgente di
conoscenza, la quale non è più intesa nel senso epistemologico tradizionale.
Se la nostra percezione del mondo, dalla quale ne deriva conoscenza, è
sostanzialmente instabile in quanto si costituisce come flusso di umori, ognuno di
questi stati d’animo equivarrà a una diversa prospettiva tramite cui guardare alla
realtà e alle cose che la compongono. Ciò richiama intimamente l’istanza sostenuta
da Nietzsche tramite la proposta di un pluri-prospettivismo scettico. E se la
conoscenza è accumulazione di diverse prospettive sulla medesima cosa, essa
risulterà tanto più piena e completa laddove questo flusso sarà più ricco di
prospettive diverse.
Questo concetto potrebbe essere riassunto nella considerazione che Nietzsche
aveva della vita, letta come un «esperimento volto alla conoscenza», 68 che trae
nutrimento dal variare di ogni fattore, prospettiva, stile di vita, dieta, abitudine,
amicizia. Lo stesso concetto di conoscenza viene a risentirne, stabilendosi non più
come «un giaciglio di riposo o la via ad un giaciglio di riposo, oppure uno svago o un
ozio», ma come un’attività estremamente pericolosa e temibile, «un mondo di
pericoli e di vittorie, in cui anche i sentimenti eroici hanno le loro arene per la danza
e per la lotta». 69
Questo apre le porte a un ripensamento dello stesso concetto di esperienza in
termini di sperimentazione personale, ovvero della necessità di saggiare su di sé ogni
potenziale punto di vista, stando sempre pronti a rimodulare le “categorie” con cui
esperiamo il mondo e mediante cui esso si mostra a noi.
La sperimentazione individuale si configura come un nuovo metodo di
conoscenza, imprescindibile per permettere l’attuazione della stessa self-reliance: si
tratta infatti della declinazione della fiducia in se stessi nel senso di un “metodo
intellettuale” totalmente contrapposto alla tendenza di chinarsi a presunte verità di
pensiero consolidate nella tradizione e all’assodato metodo razionale di conoscenza.
Emerson confesserà in Circoli:
Io sono solo uno sperimentatore. […] Nessun fatto è sacro per me, nessuno è
profano; soltanto sperimento, ricercatore instancabile, senza passato alle mie
spalle. […] Nulla è sicuro se non la vita dell’attimo, la transizione e lo spirito
creativo. Nessun amore può essere fissato da giuramenti e patti in modo da non
67
68
69
S. Cavell, Thinking of Emerson, op. cit., p. 125.
F. Nietzsche, aforisma 324, libro IV, La Gaia Scienza , op. cit., p. 186.
Ibidem .
�360
C A ROLA I SA IA
poter raggiungere un grado ancora più alto. Nessuna verità è così sublime da
non poter apparire banale domani, alla luce di una nuova. 70
La condizione che permette di sperimentare ogni circostanza è data dal
«nomadismo intellettuale», espressione di cui Nietzsche si serve per
contraddistinguere gli spiriti liberi, che è in realtà presa a prestito dal saggio
emersoniano Storia; 71 Nietzsche appunterà nel 1882: «Il nomadismo intellettuale è il
dono dell’oggettività, oppure il dono di trovare dappertutto uno spettacolo
dilettevole. Ogni uomo, ogni cosa è una mia scoperta, è mia proprietà: l’amore che lo
anima per tutto, gli appiana la fronte». 72 Questa è l’imprescindibile caratteristica dello
«spirito libero e non radicato» 73 che è capace di schiudersi alla incredibile varietà del
mondo, spinto ad assaggiare tutto senza mai rimanervi abbastanza da permettere il
verificarsi del radicamento in quella abitudine o modo di vedere le cose. È
nell’esemplificativo aforisma della Gaia Scienza dedicato alle «abitudini brevi» che
Nietzsche ci racconta di come esse siano un «inestimabile mezzo per imparare a
conoscere molte cose e situazioni e per calare giù fino in fondo alle loro dolcezze e
amarezze»; ma un giorno ecco che essa avrà fatto il suo tempo, e «sazia di me, come
io sono sazio di lei» ci si porgerà la mano come per congedarsi, perché «il nuovo
aspetta alla porta». Ugualmente Nietzsche procede con «cibi, pensieri, uomini, città,
poesie, musiche, dottrine, ordini del giorno, maniere di vita», dichiarando odio
contro le tiranniche «abitudini durature» le quali fanno sì che «l’aria vitale si
addensi», spegnendo ogni energia e curiosità per il nuovo. 74
Solamente ora, consci delle premesse, delle caratteristiche e degli esiti della selfreliance, abbiamo tra le mani abbastanza elementi per comprendere come anche
soltanto il desiderio di essere uomini realmente Fiduciosi sia un cammino terribile e
maestoso allo stesso tempo. Questo percorso richiede la virtù del coraggio di essere
indipendenti da ogni canone assodato nella tradizione di pensiero o nei costumi
morali; ci chiede di abbandonare ogni affetto laddove si configuri come ostacolo
all’espressione del nostro genio individuale.
Il self-reliant man viene così a costituirsi come quell’individuo che ha felicemente
accettato il suo essere necessitato e senza rassegnazione ha riscoperto nel suo intimo
quella forza e quella potenza creatrice impiegate poi nel perfezionamento continuo
del proprio sé, sottoponendosi, con dedizione ma non senza sofferenza, a una ferrea
auto-disciplina.
70
R. W. Emerson, Circles, Essays: first series, in The complete essays and other writings of R. W.
Emerson, op. cit., pp. 288-289.
71
R. W. Emerson, History , ivi., p. 134.
72
F. Nietzsche, frammento 17 [13] Principio del 1882, in La Gaia Scienza , in Idilli di Messina - La
gaia scienza - Frammenti postumi (1881-1882), op. cit., p. 462.
73
F. Nietzsche, aforisma 211, Opinioni e sentenze diverse, in Umano, troppo umano II e Frammenti
Postumi, op. cit., p. 80.
74
F. Nietzsche, aforisma 295, libro IV, La Gaia Scienza , op. cit., pp. 171-172.
�361
La virtù della sel f -reliance nelle filosofie di Emerson e Nietzsche
La spinta alla conquista di noi stessi avviene attraverso un procedere composto da
numerose tappe, ognuna delle quali si mostra a noi come virtualmente racchiudente
gli elementi del nostro potenziale, che dobbiamo essere sempre pronti a imparare a
volgere a nostro vantaggio, anche attraverso la loro trasvalutazione.
Questo cammino di accrescimento dello spirito non avrà mai un compimento
definitivo, ma sarà sempre affamato di novità e di diversità, perché è la diversità la
sorgente di ogni autentica conoscenza. Passione, esercizio, dolore, vita piena
accompagnano il self-reliant man verso la riscoperta della sua natura intimamente
divina, l’unica ad aver esperito, oltre che conosciuto, la vera libertà.
�362
�363
Etica & Politica / Ethics & Politics, XX, 2018, 1, pp. 363-381
ISSN 1825-5167
THE INTERNAL-RAWLSIAN
UNSUSTAINABILITY OF RAWLS’S
DUTY OF ASSISTANCE
ME NNO R. K A MMI NGA
University of Groningen
Department of International Relations and International Organization
m.r.kamminga@rug.nl
ABSTRACT
Philosophers interested in John Rawls’s international political theorizing have paid
considerable attention to the duty of assistance as a key notion of his Law of Peoples.
However, in focusing on contentious-theoretical and practical implications of this duty, they
have not thoroughly examined the more immediate question of whether this duty is
sustainable from the perspective of Rawls’s Law of Peoples itself. The thesis of the present
article is that Rawls’s duty of assistance is internally unsustainable, as it cannot be
adequately justified from within his Law of Peoples. A threefold argument is developed.
First, Rawls’s own explanation of the duty of assistance within the Law of Peoples is unclear
and confusing. Second, others’ ‘Rawlsian’ ideal-theoretical and non-ideal-theoretical attempts
to justify the duty of assistance probably inevitably fail. Third, Rawls’s Law of Peoples leads
to skepticism about the duty of assistance’s applicability to the non-ideal world. The article
concludes that at most a principle of corrective justice in ideal theory combined with a right
of assistance and an ad hoc duty of corrective justice in non-ideal theory is maintainable
within the Law of Peoples.
KEYWORDS
Duty of assistance, global justice, John Rawls, law of peoples.
1. INTRODUCTION
Contemporary international political theory has surely confirmed John
Rawls’s diagnosis that the eighth principle of his Law of Peoples ‘is especially
controversial’ (Rawls 1999: 37 n. 43). This principle, which Rawls (1999: 84-85)
valued highly (cf. Reidy 2007: 199-201), states that ‘[p]eoples have a duty to assist
other peoples living under unfavorable conditions that prevent their having a
just or decent political and social regime’ (Rawls 1999: 37). Whereas his earliest
set of international principles matched international law’s core elements (Rawls
�364
M E NNO R. K A MMINGA
[1971] 1999: 331-335), ‘[t]he duty of assistance is Rawls’s greatest divergence
from…today’s international law’ (Wenar 2017). This ‘progressive’ duty seems to
require rich countries to address global poverty much more actively and
financially support poor states far more generously than they have done so far
(Beitz 2000: 672, 694; Neufeld 2011: 29; Wenar 2017).
The controversy about Rawls’s duty has mostly involved various ‘nonimmediate’ issues: more indirect issues that affect the moral-theoretical
framework underlying the duty and more outward ones that concern the duty’s
practical value. The key indirect issue has concerned Rawls’s choice for a
second, international original position of peoples separate from his first,
domestic original position of individual persons, with an international duty of
assistance as a result (Rawls 1999, [1971] 1999). ‘Cosmopolitans’ have insisted
on a single persons-populated global original position and, consequently, a
global, not just domestic, egalitarian principle of distributive justice as more
Rawlsian-liberal in a politically-economically globalized world (Beitz [1979]
1999; Pogge 1989, cf. 2004: 261; Moellendorf 2002). Rawls (1999: 82-83, 115120), however, has resolutely opposed this alteration of his theory, regarding a
single global original position as basically intolerant towards non-liberal
political collectivities - which, like liberal peoples, could (and, in case of ‘decent’
societies, do) have independent moral value - and the consequent, more radical
principle of global (re)distribution as unjustly egalitarian. Moreover, other
philosophers have defended the Rawlsian-ness of Rawls’s choice for a two-level
original position structure and subsequent rejection of a global principle of
distributive justice against the cosmopolitans by also pointing to the continued
absence of a global cooperative society or global liberal-democratic people
(Reidy 2004, 2007; Kamminga 2006; Martin 2015; cf. Opeskin 1996). Indeed, a
so controversial, if not discredited, cosmopolitan original position would take us
outside the Law of Peoples as a ‘realistically utopian’ Rawlsian theory (cf.
Williams 2014). It offers insufficient reason for believing that Rawls’s duty of
assistance may not be tenable.
The more outward issues surrounding Rawls’s duty of assistance - with
cosmopolitans and various others as Rawls-critics - have involved the sufficiency
or demandingness as well as the feasibility and effectiveness of the duty in
tackling global inequality, poverty, and climate change, the extent of societies’
self-responsibility, the fulfilment of human rights within societies, and the
appropriateness of striving for societies’ political-cultural and institutional
democratization (cf. Beitz 2000: 689-694; Armstrong 2009; Kenehan 2015;
Brown 2015: 184-204; Maffettone 2017). Such debates make real sense only if it
may be assumed that Rawls’s duty of assistance is somehow justifiable within
his Law of Peoples itself. However, while Rawls, who made a decades-long
�365
The Internal-Rawlsian Unsustainability of Rawls’s Duty of Assistance
journey towards the duty of assistance, acknowledges that the duty’s nature is
controversial and concedes that the basis for it is less firm than the other seven
principles of his international theory (Neufeld 2011: 27), remarkably little
scholarly attention has been given to this more immediate issue of the duty of
assistance’s tenability within his Law of Peoples (though see Beitz 2000: 688689; Pogge 2004: 260-261; Williams 2011: 71-74, 81-89, 2014: 336-337). The
cosmopolitan original position argument being dubious does not settle the
matter, because that offers merely indirect support: it cannot say whether
subsequent, more direct arguments for the duty of assistance are plausible.
Thus, a fuller analysis of the internal-Rawlsian basis of the duty of assistance,
more so than has been provided so far (as should become clearer below), is
called for.
In this article, my thesis is that Rawls’s duty of assistance principle is
internally unsustainable, since it cannot be adequately justified from within his
Law of Peoples. Indeed, I suggest that the very addition of a duty of assistance
has been a hasty, intuitive expression of Rawls’s desire to rescue the Law of
Peoples as international translation of his domestic theory of justice by trying to
pacify his early cosmopolitan critics who were surely right to identify the moral
relevance of the enormous scale of global poverty (Beitz [1979] 1999; Pogge
1994).
I will develop a threefold argument for my thesis. First, Rawls’s own
explanation of the duty of assistance within the Law of Peoples is unclear and
confusing overall. Eager to show that his own theory thus does include a
suitable response to global misery, Rawls’s prime concern seems to have been
merely to safeguard his two-level political theory against cosmopolitan criticism.
Second, the ‘Rawlsian’ ideal-theoretical and non-ideal-theoretical attempts of
other philosophers to justify the duty of assistance have not been, and probably
could not have been, successful. Third, Rawls’s Law of Peoples results into
skepticism about the duty of assistance’s applicability to the non-ideal world.
The article concludes that, instead of a duty of assistance, at most a principle of
corrective justice in ideal theory combined with a right of assistance and an ad
hoc duty of corrective justice in non-ideal theory is justifiable within the Law of
Peoples. If my argument will be correct, those who share the intuition that some
1
If successful, my argument would hold even more strongly against more egalitarian
principles of justice defended on internal-Rawlsian grounds (cf. Pogge 1994; Moellendorf 2002:
13) and applied globally. But such distributive principles seem implausible anyway: while the
persons of Rawls’s domestic original position need economic cooperation to safeguard their basic
interests, the (self-sufficient) peoples of his international original position do not (cf. Reidy 2007:
211-212).
1
�366
M E NNO R. K A MMINGA
duty of foreign assistance exists in our world of massive poverty will have to
seek elsewhere for a rational-theoretical underpinning.
2. RAWLS’S OWN DEFECTIVE EXPLANATION OF THE DUTY OF
ASSISTANCE
My first argument is that Rawls’s own explicit explanation of the duty of
assistance within the Law of Peoples is unclear and confusing overall. My
reconstruction of the duty of assistance will suggest that protecting his two-level
liberal theory against cosmopolitanism has mattered more to Rawls than
showing the duty to be a natural implication of his Law of Peoples.
In his 1993 article on the Law of Peoples, Rawls (1993: 46) does not include
the duty of assistance as a principle of ideal theory, thus limiting his set of
principles that should guide conduct among peoples to seven. Now the notion
of ‘duties of assistance’ is already there (Rawls 1993: 47; cf. Rawls 1999: 38), and
so is the claim that the representatives of decent (tolerable) peoples ‘care about
the benefits of trade and assistance between peoples in time of need’ (1993: 5354; cf. 1999: 69). Yet Rawls (1993: 62-64) presents the duty of assistance only as
part of non-ideal theory, stating that ‘the goal specified by non-ideal theory for
the case of unfavorable conditions [is that] eventually each society now
burdened by unfavorable conditions is to be raised to, or assisted towards,
conditions that make a well-ordered society possible’ (Rawls 1993: 62). Against
cosmopolitan critics, he defends peoples’ duty to assist:
Even though no liberal principle of distributive justice would be adopted
for dealing with unfavorable conditions, that certainly does not mean that
the well-ordered and wealthier societies have no duties and obligations to
societies burdened by such conditions. For the ideal conception of the
society of peoples that well-ordered societies affirm directs that all societies
are in due course to reach, or to be assisted to, the conditions that make a
well-ordered society possible (Rawls 1993: 63, cf. 64 n. 51).
However, while it is clear that, for Rawls, ‘the basis of the duty of assistance is
not some liberal principle of distributive justice’, what remains less clear is why
‘the ideal conception of the society of peoples itself as consisting of well-ordered
societies’ (1993: 63) requires nothing less than a duty. Thus, in the 1993 version,
the duty of assistance, apart from not being elevated to a Law of Peoples
principle, is not given a satisfactory, direct explanation.
In his 1999, final version of the Law of Peoples, Rawls continues to treat
the duty of assistance as the kind of non-ideal theory that tackles unfavorable
conditions, stating early on:
�367
The Internal-Rawlsian Unsustainability of Rawls’s Duty of Assistance
[W]e must ask how far liberal or decent peoples owe a duty of assistance to
[burdened] societies so that the latter may establish their own reasonably just or
decent institutions. The aim of the Law of Peoples would be fully achieved when
all societies have been able to establish either a liberal or a decent regime (Rawls
1999: 5).
Rawls now also introduces the duty of assistance as ideal theory’s eighth
principle. To requote: ‘Peoples have a duty to assist other peoples living under
unfavorable conditions that prevent their having a just or decent political and
social regime’ (Rawls 1999: 37).
However, Rawls’s new, remarkable principle is confusing, if not worse,
because it suggests that ‘peoples’ can be burdened (although the word
‘burdened’ is not included) and should then be assisted (cf. 1999: 85), whereas
his overall international theory holds peoples to have just or decent regimes and
be non-burdened. In fact, Rawls (1999: 37 n. 43, 43, 105-120) again chooses to
discuss the duty of assistance mostly in the part on non-ideal theory, as he
emphasizes that ‘the “duty of assistance” applies only to the duty that liberal
and decent peoples have to assist burdened societies’ (Rawls 1999: 43 n. 53,
emphasis in original). Now in mentioning ‘peoples’ rather than ‘societies’ in his
eighth principle Rawls probably means what he writes, even if confusingly so,
because he is discussing ideal theory. Yet, while it is natural to think that
Rawlsian peoples should assist one another in need (Pogge 2004: 260) and will
accept provisions for this (Rawls 1999: 38), it remains odd to phrase this in
terms of a duty of assistance, when that duty is primarily meant towards
burdened societies.
Rawls reintroduces the duty of assistance in his ideal-theoretical
treatment of ‘cooperative organizations’. First he explains these organizations,
which include only (liberal or decent) peoples (Rawls 1999: 25), by stating that
the peoples-representing ‘parties will formulate [additional] guidelines for
setting up cooperative organizations and agree to standards of fairness for trade
as well as certain provisions for mutual assistance’ (Rawls 1999: 42, cf. 115).
Next he postulates three such organizations: one directed at fair trade, another
occupied with cooperative banking, and a third to safeguard global peace and
security (Rawls 1999: 42). Then Rawls defends the ‘corrective’ role of the duty
of assistance for these ideal organizations, notably fair trade ones: ‘Should these
organizations have unjustified distributive effects between peoples, these would
have to be corrected, and taken into account by the duty of assistance’ (1999: 43,
cf. 115 and 19, 36, 38, 41, 46, 84, 86, cf. 70, 112-113).
2
To speak of Rawlsian ‘burdened peoples’ as some theorists do (e.g., Wenar 2017), is to
employ a misnomer never used by Rawls himself yet one for which he is somewhat to blame.
2
�368
M E NNO R. K A MMINGA
However, Rawls’s use of the duty of assistance as a principle for
cooperative organizations of peoples is confusing besides presumably
intentional again. It seems intentional, for if he felt that the duty applied to
burdened societies only, he would not explicitly rely on it for the purpose of
compensating disadvantaged peoples in case of ‘unjustified distributive effects’
from cooperation (Rawls 1999: 43, 115). Apparently, what Rawls (1999: 43) holds
is that ‘all well-ordered peoples must refrain from acting, whether individually
or through their voluntary associations, in ways certainly or likely to disable any
people from…remaining well-ordered’ (Reidy 2004: 314). Nevertheless, for two
reasons at least, it remains puzzling why Rawls (1999: 43) invokes the duty of
assistance in this context.
First, it is unclear why, as Rawls suggests, ‘correction’ should occur only
when cooperation results in peoples facing the threat of relapsing into
burdened-ness. Apparently, only such effects could count as ‘unjustified’, since
invoking the duty of assistance would make no sense if this is not what Rawls
means. Yet it is not obvious why less undesirable effects of cooperation would
need no correction. Indeed, Rawls fails to clarify the baseline for indicating
‘unjustified distributive effects’ (Beitz 2005: 21 n. 21; Pogge 2004: 282).
Second, more seriously still, Rawls here mixes up the duty of assistance
with a duty of corrective justice. Not only are these two very different principles,
but also is the latter more appropriate here, and within ideal theory more
generally, than the former, which could probably better have been saved (if at
all) for non-ideal theory only (like in the 1993 account). Thus, Rawls overloads
his duty of assistance by including ‘correction’ besides ‘assistance’. Whereas the
duty of assistance seems a ‘positive’ duty (helping others because of their being
in independent need) and is clearly understood this way by Rawls (1993, 1999)
elsewhere in the Law of Peoples, corrective justice is ‘negative’ duty-generated
for assuming a relationship in need of rectification for harm done (cf. Opeskin
1996; Pogge 2004). While Rawls conflates the two as applied here, he nowhere
defends the duty of assistance in terms of rectification. Obviously, he does not
wish to restrict the scope of the duty of assistance to the Society of Peoples with
its organizations, since then it could have no relevance for conduct towards
‘outside’ societies.
In the part on non-ideal theory, Rawls fleshes out his duty of assistance,
but treating it, as earlier, as a duty owed to burdened societies only:
Burdened societies…lack the political and cultural traditions, the human capital
and know-how, and, often, the material and technological resources needed to be
well-ordered. The long-term goal of (relatively) well-ordered societies should be to
bring burdened societies, like outlaw states, into the Society of well-ordered
�369
The Internal-Rawlsian Unsustainability of Rawls’s Duty of Assistance
Peoples. Well-ordered peoples have a duty to assist burdened societies…Only
burdened societies need help (Rawls 1999: 106, emphasis in original).
The duty of assistance, Rawls holds, has three guidelines. First, since a wellordered society need not be wealthy (Rawls 1999: 106), analogous to the
domestic ‘duty of just savings’,
the aim is to realize and preserve just (or decent) institutions, and not
simply to increase, much less to maximize indefinitely, the average level of
wealth, or the wealth of any society or any particular class in society. In
these respects the duty of assistance and the duty of just savings express
the same underlying idea (Rawls 1999: 107)
Second, whereas well-orderedness depends on political culture rather than
natural factors, ‘there is no recipe, certainly no easy recipe, for well-ordered
peoples to help a burdened society to change its political and social culture’
(Rawls 1999: 108). The difference is made by virtues such as probity,
industriousness, innovativeness, cooperative talents, and also by controlled
population policy, attentiveness to human rights, and creation of gender
equality (Rawls 1999: 108-111). 3 Thus, ‘throwing funds’ will not work (Rawls
1999: 110).
Third, ‘its aim [being] to help burdened societies to be able to manage
their own affairs reasonably and rationally and eventually to become members
of the Society of well-ordered Peoples’ (Rawls 1999: 111, cf. 111-115), as a
principle of ‘transition’ like the just savings duty the duty of assistance has a
‘target’ and a ‘cutoff point’ - much more obviously so than cosmopolitan
principles of egalitarian distributive justice (Rawls 1999: 106, 117-120):
The…duty of assistance…is a principle of transition, [like] the principle of
real saving over time in domestic society…[R]eal saving is meant to lay the
foundation for a just basic structure of society, at which point it may cease.
In the society of the Law of Peoples the duty of assistance holds until all
societies have achieved just liberal or decent basic institutions. Both the
duty of real saving and the duty of assistance are defined by a target
beyond which they no longer hold…[The latter] has also...a cutoff point,
since for each burdened society the principle ceases to apply once the
target is reached (Rawls 1999: 118-119, emphases in original).
However, Rawls again fails to offer an adequately immediate explanation for
his duty of assistance. Certainly, his three guidelines, which indicate the
While Rawls’s duty of assistance’s second guideline defends the promotion of human rights
(Rawls 1999: 108-111, cf. 48 n. 59), Martin (2015: 745-746) seems wrong to think that a separate
Rawlsian duty to fulfill the right to subsistence in burdened societies exists.
3
�370
M E NNO R. K A MMINGA
analogy with the duty of just savings and specify the aim of assistance, the
importance of political culture, and the focus and limits of assistance, do much
to demarcate it. Yet, not only do these guidelines not clearly explain the duty of
assistance as a duty, but also do they seem to function primarily to make the
duty of assistance more realistic and acceptable than cosmopolitan egalitarian
justice. Thus, Rawls explains the duty of assistance in a ‘relative’, thus nondirect, sense at best.
Still, Rawls’s only explanation of the duty of assistance that could count as an
attempt at justification - and perhaps added in 1999 for that reason - is the duty
of just savings analogy (Rawls 1999: 106-107): as we saw, the two duties
supposedly share ‘the same underlying idea’. However, the analogy between
‘intergenerational’ just savings and ‘international’ assistance is strained on
Rawls’s own terms, because in domestic society - which is the object of a ‘proper
patriotism’ (Rawls 1999: 44, 62, 111-112) - the duty operates within a people
including their own descendants (their children, with whom the present
generation is directly connected), whereas internationally it would apply
between groups of ‘strangers’ who each are self-responsible in principle (against
Williams 2011: 84-85, cf. 86-88). Rather, this more intuitive justification, while
not strong enough to sustain an international duty as such, is merely sufficient
for the duty of assistance to have a cutoff point, like the duty of just savings.
Overall, Rawls’s presentation of the duty of assistance betrays insecurity
about the duty’s adequacy. Rather than providing an ‘argument for the duty of
assistance analogous to the argument for a distributive principle in domestic
society’ (Beitz 2000: 689), 4 Rawls tries to protect his originally domestic theory
against cosmopolitan reformulations by explaining the sensibleness of his
peoples’ duty against cosmopolitan justice.
3. THE FAILURE OF OTHERS’ ‘RAWLSIAN’ ATTEMPTS TO JUSTIFY
THE DUTY OF ASSISTANCE
Having argued that Rawls’s eventual choice to include the duty of assistance
in his list of international principles is troubling, I now turn to the ‘Rawlsian’
ideal-theoretical and non-ideal-theoretical efforts of other philosophers to justify
this duty. However, second, I argue that these attempts fail, and probably
inevitably so. I start with non-ideal theory.
As Beitz adds, ‘there is no suggestion, for example, that the international distribution of
natural resources is unfair or that the circumstances of an individual’s birth…are in any ethically
significant sense arbitrary’ (2000: 689).
4
�371
The Internal-Rawlsian Unsustainability of Rawls’s Duty of Assistance
Rawls-adherents David Reidy (2004: 314 n. 10, 2007: 195 n. 3, 231) and Rex
Martin (2015: 748-749) have argued that Rawls’s non-ideal theory needs a
principle of corrective, or rectificatory, justice for addressing historical injustices
such as (the legacy of) colonialism or imperialism. In his attempt to defend
Rawls, Reidy (2007: 198-199) has even suggested that the duty of assistance
could be justified as a duty of corrective justice in the real world of today. Note
that, by itself, Rawls’s own belief that wealth and poverty are mainly
determined by internal-cultural factors (Rawls 1999: 108, 117) offers insufficient
ground for averting Reidy’s and Martin’s claims. This non-ideal theory
underlying, empirical dispute - the effects of colonialism or imperialism as
opposed to the role of political culture - cannot be settled by simply siding with
Rawls, who nowhere mentions any need for corrective justice between peoples
and burdened societies as rectification of past wrongs.
Yet the above line of reasoning cannot save Rawls’s duty of assistance due to
conceptual and empirical problems. Obviously, this attempt would not solve the
problem identified earlier regarding ideal-theoretical cooperative organizations
among peoples, but one could also not plausibly defend the duty of assistance
as based on a principle of rectificatory justice in non-ideal theory. First, the
mixing up of negative and positive duties as noted in the previous section would
then simply be extended beyond ideal theory to non-ideal theory. Second,
corrective justice is a particular, case-by-case principle that is extremely hard to
apply and does not fit the Law of Peoples’s universal aim (Rawls 1999: 85-86,
121-122). As Brian Opeskin (1996: 22, 26-28) points out, corrective justice is
merely applicable in defined circumstances and therefore no general solution
for poor countries, since plausible claims for corrective justice require the wrong
to be recent and the injury to be reliably quantifiable. Various difficulties exist,
such as the reliance on a - highly speculative and hardly objective - counterhistorical assessment of colonized societies’ non-colonial developmental paths
in order to establish the harm done, the absence of a clear causal relationship
between being colonized and being (relatively) poor, and the uncomfortable
finding that colonization often also conferred educational, economic,
technological, legal, and infrastructural benefits on the local population
(Opeskin 1996: 34-35). And third, since corrective justice merely requires
rectifying past wrongs, peoples responsible for colonialism or imperialism could
compensate the - adequately quantified - harm done by making a single full
payment, or perhaps a few partial payments, to the burdened societies affected,
irrespective of whether or not this helps to establish these societies’ wellorderedness. Thus, Reidy and Martin seem right only to the extent that a
colonialism- or imperialism-based duty of corrective justice may be of
supplementary value. Since the duty of assistance must be kept apart from
�372
M E NNO R. K A MMINGA
corrective justice, conceptually and probably also empirically (cf. Martin 2015:
749; against Williams 2011: 78, 139-140, 154), a separate justification for it
remains necessary. The above sympathetic critique cannot support Rawls’s own
duty and is of casual non-ideal-theoretical value at best.
Ideal-theoretically, the basic problem is whether peoples could have duties to
societies not represented in the international original position. Now, as Pietro
Maffettone notes, the recent literature about what could justify the duty of
assistance regards it as ‘the result of an assurance problem based on the
possibility that a well-ordered people might become a burdened society through
no fault of its own’ (2017: 355 n. 3; cf. Reidy 2007; Williams 2011; Kenehan 2013:
316-317). This way, the duty of assistance principle would protect peoples from
relapsing into burdened societies. Thus, Reidy defends the duty of assistance as
ideal theory-based and non-ideal theory-extended:
It would be rational for agents [representing well-ordered peoples in an
international original position] to agree to a mutual insurance policy
guaranteeing coverage to any burdened society so long as there is no clear
and compelling historical evidence of its political responsibility for selfinflicted wounds. If this is right, then Rawls’s duty of assistance…has a
sound justification within ideal theory and is naturally extended to the
conditions of nonideal theory with just the implications Rawls suggests:
well-ordered peoples today owe aid and assistance to most, if not all,
presently burdened societies (Reidy 2007: 198-199, emphasis added).
Huw Lloyd Williams offers a justification comparable to, yet more basic
than, Reidy’s:
[B]urdened societies are regarded as exempt from the international
original position given their reduced capability, but their interests are
nevertheless served by representatives of other peoples who know they
might befall the same fate, and are concerned to include provisions for
mutual assistance. The fact that burdened societies are not party to the
original agreement does not seem to me to be good grounds on which to
deny that a duty of justice applies to them (Williams 2011: 88, emphasis
added).
However, the ‘assurance problem’ solution fails due to various reasons. First,
Rawls himself does not claim his duty of assistance to be something like an
‘assurance problem’, which is expectable actually since the duty of assistance is
a duty to help already burdened societies and the ideal-theoretical eighth
principle a later addition (1999) to an earlier, essentially non-ideal-theoretical
account (1993). Second, as Williams acknowledges, ‘there seems to be a
qualitative difference between…a duty of mutual assurance between well-
�373
The Internal-Rawlsian Unsustainability of Rawls’s Duty of Assistance
ordered peoples, and a duty of assistance’ to (historically) burdened societies
that could not have demanded equal respect or developed a full moral identity
(2011: 73, cf. 83). Third, Reidy’s condition of a burdened society having ‘no
clear and compelling historical evidence of its political responsibility for selfinflicted wounds’ violates Rawls’s own view that the duty of assistance applies
just as well to self-caused burdened societies (Armstrong 2009: 469) and
suggests a corrective justice justification already rejected above. And fourth,
Williams’s argument may work as an empathy-based plea for assistance to
burdened societies but not as a defense of a duty to do so - let alone one of
justice. After all, that ‘peoples…might befall the same fate’ as burdened societies
(say, ‘as the result of a natural catastrophe’; Maffettone 2017: 355 n. 2) is
extremely unlikely or hardly possible within the context of Rawls’s ideal theory,
also because peoples can typically rely on each other for provisions and support
(cf. Rawls 1999: 37-38). Moreover, this argument suggests, rather perversely, that
the higher peoples’ chances of falling into burdened-ness are, the stronger their
duty of assistance becomes. 5 Thus, we are dealing with flawed attempts to
support Rawls’s duty.
Now Williams (2014: 336-337) also argues that, on Rawls’s view, burdened
societies are to be seen as future members of the Society of Peoples, so that their
interests are still represented equally and these societies treated in the spirit of
equality, and that, therefore, the duty of assistance is a duty - again even a
strong one of justice rather than a weak, humanitarian one. However, this
argument of Williams’s is at worst question-begging for presuming a duty of
assistance - so that equal representation is guaranteed - and at best in line with
Rawls’s emphasis on the ‘aim’ of assistance, of which it is questionable, as
suggested in the previous section, whether this as such is sufficient for
establishing a straightforward duty, let alone one of justice. In fact, Rawls
reformulates the ‘aim’, which is ‘to help burdened societies to be able to manage
their own affairs reasonably and rationally and eventually to become members
of the Society of well-ordered Peoples’ as defining the ‘target’ of assistance
(1999: 111, cf. 106-107); the ‘aim’, then, is not the ‘duty’s’ basic justification but
merely its ‘third guideline’, defining its ‘target’. Overall, Williams (2011: 81-89)
overstretches Rawls’s view by arguing that the duty of assistance is a duty of
justice (grounded in a global cross-original position ‘hidden’ equal treatment)
Williams draws a flawed analogy: ‘Individuals with temporary health problems are regarded
as exempt from the original position given their reduced capability, but their interests are
nevertheless represented there by rational choosers, who know they might befall the same fate
and so are concerned to include the provision of health care in the social minimum’ (2011: 88).
In this case, it seems more plausible to believe that healthy ‘rational choosers’ will care for
provisions and are rather equal in this respect: sooner or later, they all may well, even suddenly,
‘befall the same fate’ as the unhealthy.
5
�374
M E NNO R. K A MMINGA
without firstly demonstrating that there is a Rawlsian duty at all for peoples to
help societies outside the international original position.
Why, then, do such ideal theory defense attempts seem bound to fail? Within
Rawls’s framework, peoples should be reasonable towards other peoples as
fellow partners in the international position. However, it is just not obvious why
they should also be reasonable, let alone equally so, to burdened societies as
non-peoples. Thus, early Rawls-critic Thomas Pogge explains the idealtheoretical problem for justifying the duty of assistance by a plain, Rawlsian
reciprocity-emphasizing argument - remarkably, one virtually ignored by
Rawls’s defenders:
It is doubtful that the [newly added duty] would be adopted in Rawls’
international original position, which represents liberal and decent peoples
only. Each such representative is rational and seeking an international
order that enables his or her own people to be stably organized according
to its own conception of justice or decency. Such representatives may well
agree to assist one another in times of need. But why is it rational for them
to commit to assisting poor peoples that never had a liberal or decent
institutional order?...[P]eoples neither liberal nor decent are not
represented in the international original position, and the interests of their
members are thereby discounted completely (Pogge 2004: 260-261).
6
Darrell Moellendorf puts the point as follows: ‘The selection of the duty of
assistance in this original position is beset with interpretive difficulties. If the
parties assume strict compliance, it is unclear why they would select a duty of
assistance’ (2014: 227). The Pogge-Moellendorf critique is as strong as it is
simple, even if we consider that peoples with their shared goals are reasonable
as well as rational (cf. Rawls 1999: 35, and that Pogge and Moellendorf actually
want Rawls to accept the cosmopolitan original position already disputed in the
introduction).
Noting that Rawls himself does not understand the duty of assistance as
grounded in either beneficence or distributive justice (Beitz 2005: 21; cf. Brown
215: 196), Charles Beitz, another early critic, suggests that this duty could have a
more prudential justification at best:
The force of the duty of assistance seems to arise…from the importance
for liberal societies of enlarging the Society of Peoples to include,
eventually, all the societies of the world. For example, [within the
constraints imposed by Rawls’s theory] it might be argued that the chances
Pogge adds that this is also problematic for ‘forceful intervention’ in outlaw states (2004:
280-281), since outlaw states, like burdened societies, are not parties in Rawls’s international
original position.
6
�375
The Internal-Rawlsian Unsustainability of Rawls’s Duty of Assistance
of peace would be greater in a world in which all societies had been lifted
out of burdening conditions (Beitz 2000: 688-689).
But, as Beitz (2000: 689) adds, since any security threat coming from
burdened societies will not be that serious, defending the duty of assistance this
way would not be very convincing. 7 Therefore, it is conceivable to see
‘assistance’ as a Rawlsian obligation of charity at best, as Allen Buchanan (2000:
710), yet another early Rawls-critic, suggests. As Buchanan explains: ‘There is
no indication that this duty of aid is to be understood as the collective
responsibility of the society of peoples and no mention of a right on the part of
‘‘burdened societies’’ to receive it’ (2000: 710, cf. 715) - societies that, for Rawls,
remain responsible for their own predicaments (cf. Armstrong 2009: 466-470).
Indeed, since the mere aim of globalizing the Society of well-ordered Peoples
cannot turn ‘assistance’ into a moral ‘duty’, and a defense of the duty of
assistance in terms of prudence is dubious empirically - but also weak morally assistance seems best understood as a measure of charity, or supererogatory act
(praiseworthy but not mandatory). If so, peoples retain the right to provide
assistance.
In short, the discussed attempts to justify the duty of assistance are, and most
likely cannot be but, unduly strained. Like Rawls himself, the Rawlsians
involved fail to somehow defend the duty of assistance parallel to Rawls’s
defense of domestic distributive justice. Perhaps a satisfactory defense does
appear possible one day, but surely the prospect looks dim. But there is still a
third issue to consider.
4. RAWLSIAN SKEPTICISM ABOUT THE DUTY OF ASSISTANCE IN
THE NON-IDEAL WORLD
Third, I argue that Rawls’s Law of Peoples leads to skepticism about the duty
of assistance’s applicability to the non-ideal world. Pivotal to this - presumably
surprising - argument is Rawls’s introduction of non-ideal theory:
On the assumption that there exist in the world some relatively wellordered peoples, we ask in nonideal theory how these peoples should act
toward non-well-ordered peoples. We take as a basic characteristic of wellRawls (1999: 112-113) himself suggests that well-ordered peoples seek a world in which all
societies have well-ordered - thus not dangerous but peaceful and cooperative - regimes, and so
support a duty of assistance, at least initially, out of self-interest; over time, affinity, mutual
concern, and cooperativeness among peoples may become stronger and moral considerationsbased. But, apart from lacking in empirical convincingness, this motivational argument does not
make the ‘duty’ of assistance itself any more moral.
7
�376
M E NNO R. K A MMINGA
ordered peoples that they wish to live in a world in which all peoples accept
and follow the…Law of Peoples (Rawls 1999: 89).
Rawls makes two claims here. First, peoples naturally want other state-level
collectivities to come to behave as well-ordered peoples. Second, insofar as
necessary, it is up to existing ‘relatively well-ordered peoples’ to make this
happen. As I will explain, both claims, particularly the second, are troubling,
especially in case of the duty of assistance, which, recall, is explicated thus: ‘The
long-term goal of (relatively) well-ordered societies should be to bring burdened
societies…into the Society of well-ordered Peoples. Well-ordered peoples have a
duty to assist burdened societies’ (Rawls 1999: 106, emphasis in original).
There is, I argue, a double flaw in the bridge between ideal and nonideal theory that applies to non-ideal theory in general but to the present kind
in particular. First, Rawls’s ‘relatively well-ordered peoples’ notion is shaky.
Rawls never clarifies ‘relatively’, in terms of content, stage, and sufficiency
(without completeness being required) for assuming duties towards others. He
never explains when actual ‘peoples’ qualify as ‘relatively well-ordered’, so that
they may be expected to conduct a moral foreign policy, including a duty of
assistance. And he never defends the duty of assistance’s immediate and full,
rather than gradual, force from the tipping-points of ‘relativeness’ and ‘peopleness’. Actually, it is hard to see how a wholly satisfactory defense could have
been provided in this respect.
Second, Rawls’s duty of assistance is unstable, if not worse, for being
dependent on ‘people-ness’ as such. Rawls (1999: 17, 23-30, 34-35, cf. 46-48)
bases his theory on ‘peoples’ with their reasonable-moral motives (peace,
mutual equal respect, human rights), because he sees ‘states’ as merely
rationally pursuing power and self-interest. However, Rawls’s international law
characteristically cannot be relevant to state actors external to the Society of
Peoples, since he assumes that, as long as state-level collectivities have not
become peoples, they cannot have acquired moral foreign policy duties. But
how could we ascertain that peoples exist, or will always exist (even if merely
‘relatively’), in our non-ideal world? What if (many) so-called liberal collectivities
should be considered outlaw states for having violated the human rights of
outsiders? Indeed, ‘the idealized counterfactual features attributed to
hypothetical liberal peoples…may not reflect the characteristics of actual liberal
peoples’ (Kang 2016: 46-48, quotation 47), and the same goes for ‘decent
peoples’. Could the wish to avoid foreign duties not be a (internally conceivable)
8
In referring to ‘non-well-ordered peoples’ Rawls is inaccurate again, since in his theory
peoples are well-ordered by definition. Yet here we should assume that he has all human statelevel collectivities other than ‘peoples’ in mind, notably ‘benevolent absolutisms’, ‘outlaw states’,
and ‘burdened societies’.
8
�377
The Internal-Rawlsian Unsustainability of Rawls’s Duty of Assistance
reason for rationally self-interested collectivities to not become peoples? Is
‘relativeness’ not actually an ad hoc concession to make things easier in this
regard? Thus, with only well-ordered peoples having a duty of assistance, the
duty is jeopardized in a world of amoral, if not immoral, states.
Rawls’s theory, then, betrays a realist tendency towards international
skepticism (against Beitz 2000: 696): it must accept that the non-ideal world may
have states as its major actors, and allow for the serious possibility that even
‘relatively well-ordered peoples’ do not, or hardly, exist. If a limited number of
such peoples do exist, these may not be wealthy enough (together) to provide
meaningful assistance to an indefinite number of burdened societies. Insofar as,
now or in the future, global politics is dominated by states that do not or no
longer qualify as Rawlsian peoples, it would include no real Rawlsian
international duties and thus no duty of assistance (Kamminga 2015). In the
non-ideal world, peoples could lose their well-orderedness by being unable to
prevent falling back into burdened societies themselves and thus to assist other
such societies. Or they could become outlaw states, thus could choose to lose
their well-orderedness and their duties of assistance, possibly even while
remaining rich.
Now Rawls (1999: 101, 43 n. 53) does suggest that the countries of North
America and Europe qualify as liberal-democratic peoples. Yet, as Beitz notes,
it is questionable ‘whether the requisite common sympathies and moral nature
can be found in culturally diverse societies like those of the United States or
Belgium, to say nothing of India or the Philippines’ (2000: 680). In fact, it
appears difficult for ‘liberal’ collectivities to meet, and certainly to uphold, the
three Rawlsian criteria for peoplehood (even if only ‘relatively’): ‘a reasonably
just constitutional democratic government that serves their fundamental
interests; citizens united by…“common sympathies”; and…a moral nature [in
being both reasonable and rational]’ (Rawls 1999: 23, cf. 23-25). One typical
danger, as Rawls himself notes, is that the democracy or moral character of
American and European peoples becomes undermined by capitalism and
consumerism. Also, the United States may have lost much of its democratic
9
10
Perhaps Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, the United Arab Emirates, Bhutan, Singapore,
Samoa, and Brunei could qualify as decent peoples. But these countries together have very little
global impact (Brown 2015: 74).
Rawls once wrote about the European Union in relation to the United States: ‘Isn’t there a
conflict between a large free and open market comprising all of Europe and the individual
nation-states, each with its separate political and social institutions, historical memories, and
forms and traditions of social policy[?] Surely these are great value to the citizens of these
countries and give meaning to their life. The large open market including all of Europe is aim of
the large banks and the capitalist business class whose main goal is simply larger profit. The idea
of economic growth,…with no specific end in sight, fits this class perfectly. If they speak about
9
10
�378
M E NNO R. K A MMINGA
character for violating Rawls’s criterion of democracy of being ‘not directed by
the interests of large concentrations of private economic and corporate power
veiled from public knowledge and almost entirely free from accountability’
(Rawls 1999: 24). And Rawls’s remark that a people could decide to go to war
for economic profit or expansion or power and influence (Rawls 1999: 91)
brings the American 2003 Iraq war to mind. Or, as Pogge (2004: 282; 2006:
223, cf. 221) argues, it is highly questionable to what extent rich Western
countries may qualify as (liberal) peoples rather than being outlaw states for
having violated the global poor’s human rights. Even if we reject Pogge’s stress
on the West-imposed world order as a systematic cause of world poverty, we
should still allow for the possibility - and this is sufficient here - that this order is
occasionally involved in global poverty. Surely this is a relevant empirical issue
that Rawls as a political philosopher cannot evade.
To recapitulate, the problem of Rawls’s (unintended) eventual
international skepticism with the resulting shakiness of the duty of assistance is
twofold. First, Rawls problematically assumes collectivities to have moral duties
only if and once they have become relatively well-ordered; these duties, then,
lack independent moral status. Second, the more it has to be stressed, in line
with Rawls’s overall perspective, that the ideal ought not to be confused with
the real world, the greater the gap between ideal theory and non-ideal theory
becomes. From some point, ideal theory cannot be plausibly used as a
benchmark anymore: applying peoplehood to the non-ideal world will then start
to have absurd implications. As Chris Brown notes, under non-ideal conditions,
‘we are really interested in the rights of states since states actually exist whether
they are [peoples] or not…and so find ourselves trying to translate “peoples” into
states’, but at some point the ‘translation’ breaks down (2015: 73). And if we
must conclude that no sufficiently well-ordered peoples exist, we must
acknowledge that there are no duties of assistance either. Since this is possible,
and also that there may be rationally self-interested collectivities that refuse to
11
12
13
distribution, it is [al]most always in terms of trickle down. The long-term result of this - which we
already have in the United States - is a civil society awash in a meaningless consumerism of some
kind’ (Rawls and Van Parijs 2003).
As Rawls asks: ‘When politicians are beholden to their constituents for essential campaign
funds, and a very unequal distribution of wealth obtains in the background culture, with the
great wealth being in the control of corporate economic power, is it any wonder that
congressional legislation is, in effect, written by lobbyists, and Congress becomes a bargaining
chamber in which laws are bought and sold?’ (1999: 24 n. 19).
Rawls admits that ‘so-called liberal societies…may act wrongly’ (1999: 91 n. 3).
Arguably, liberal collectivities will always qualify as well-ordered peoples for meeting the
requirements for decent peoples (cf. Rawls 1999: 63). Yet as a solution for the present problem,
its absurd implication would be that Rawls needs the non-liberal category of decent peoples to
save his liberal international theory.
11
12
13
�379
The Internal-Rawlsian Unsustainability of Rawls’s Duty of Assistance
become peoples and then take on moral duties to outsiders, the duty of
assistance, and thus the fate of burdened societies unable to become wellordered on their own, will be blocked by an ‘unlucky’ real world situation.
Certainly, for Rawls, collectivities should become and remain liberal or decent,
but if they are not or do not wish to, they effectively, and troublingly, have no
duty to assist burdened societies.
In short, a serious line of skepticism regarding the non-ideal world
applicability and stability of the duty of assistance exists within Rawls’s Law of
Peoples itself. While the other kind of non-ideal theory - just war doctrine - is
also affected by the above analysis, the critique is less worrying in that case.
While Rawls defends a ‘duty of assistance’, he justifies merely a ‘right to war’,
that is, a right for peoples to defend themselves or to intervene in outlaw states
to protect human rights (Rawls 1999: 89-94). Indeed, Rawls plausibly suggests
that Michael Walzer’s philosophically less abstracting Just and Unjust Wars
[1977], as an ‘impressive work’ from which he does not ‘depart…in any
significant respect’ (1999: 95, cf. 98), could have done that latter job at least as
well. Not surprisingly, the Law of Peoples’ list of principles (Rawls 1999: 37)
does not even include a right, let alone a duty, to intervention.
5. CONCLUSION
Altogether, Rawls’s duty of assistance is a non-starter. His Law of Peoples, its
prominent status in the debate on global justice notwithstanding, cannot
successfully uphold its duty to assist deprived countries, undeveloped and
unstable as that is. Considering Rawls’s confused treatment of ‘correction’
among cooperating peoples as falling within the scope of the duty of assistance,
the most ideal theory could support is a principle of corrective justice among
well-ordered peoples. In non-ideal theory, Rawls may well uphold a mere ‘right
of assistance’ besides a modest, casual corrective justice duty. From his
perspective, it seems reasonable to hold that peoples, even if hard to identify in
the non-ideal world, may well try to universalize the Law of Peoples and so to
provide assistance to burdened societies, if assistance is not carried out
‘paternalistically’ (Rawls 1999: 111). This way, burdened societies remain
intended future members of the Society of Peoples. As with the ‘right to
intervention’, the Society of Peoples’s aim justifies only this. Adopting these
moral notions would not offset but still soften an abandonment of the duty of
assistance as Rawls’s key addition to contemporary international law.
�380
M E NNO R. K A MMINGA
BIBLIOGRAPHY
Armstrong, C. (2009) ‘Defending the duty of assistance?’, Social Theory and
Practice 35(3): 461-482.
Beitz, C.R. ([1979] 1999) Political Theory and International Relations. Princeton,
N.J.: Princeton University Press.
Beitz, C.R. (2000) ‘Rawls’s Law of Peoples’, Ethics 110(4): 669-696.
Beitz, C.R. (2005) ‘Cosmopolitanism and global justice’, The Journal of Ethics
9(1): 11-27.
Brown, C. (2015) International Society, Global Polity: An Introduction to
International Political Theory. London: SAGE.
Buchanan, A. (2000) ‘Rawls’s Law of Peoples: rules for a vanished Westphalian
world’, Ethics 110(4): 697-721.
Kamminga, M.R. (2006) ‘Why global distributive justice cannot work’, Acta
Politica 41(1): 21-40.
Kamminga, M.R. (2015) ‘Against the Beitzian consensus: why international
political theory is not beyond realist skepticism’, Philica.com, article number 538.
Kang, H.-R. (2016) ‘Can Rawls’s nonideal theory save his ideal theory?’, Social
Theory and Practice 42(1): 32-56.
Kenehan, S. (2015) ‘In defence of the duty to assist: a response to critics on the
viability of a Rawlsian approach to climate change’, Critical Review of Social and
Political Philosophy 18(3): 308-327.
Maffettone, P. (2017) ‘Rawls’s duty of assistance: a defence and re-elaboration’,
Etica & Politica / Ethics & Politics, 19 (1): 353-376.
Martin, R. (2015) ‘Rawls on international economic justice in The Law of
Peoples’, Journal of Business Ethics 127(4): 743-759.
Moellendorf, D. (2002) Cosmopolitan Justice. Boulder, Colo.: Westview Press.
Moellendorf, D. (2014) ‘Duty of Assistance’, in J. Mandle and D.A. Reidy (eds.)
The Cambridge Rawls Lexicon. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 226228.
Neufeld, B. (2011) ‘Aid to Burdened Societies’, in D.K. Chatterjee (ed.)
Encyclopedia of Global Justice, Dordrecht: Springer, 26-29.
Opeskin, B.R. (1996) ‘The moral foundations of foreign aid’, World Development
24(1): 21-44.
Pogge, T.W. (1989) Realizing Rawls. Ithaca: Cornell University Press.
Pogge, T.W. (1994) ‘An egalitarian law of peoples’, Philosophy & Public Affairs
23(3): 195-224.
�381
The Internal-Rawlsian Unsustainability of Rawls’s Duty of Assistance
Pogge, T.W. (2004) ‘“Assisting” the Global Poor’, in D.K. Chatterjee (ed.) The
Ethics of Assistance: Morality and the Distant Needy, Cambridge: Cambridge
University Press, 260-288.
Pogge, T.W. (2006) ‘Do Rawls’s Two Theories of Justice Fit Together?’, in R.
Martin and D.A. Reidy (eds.) Rawls’s Law of Peoples: A Realistic Utopia? Malden,
MA: Blackwell Publishing, 220-239.
Rawls, J. ([1971] 1999) A Theory of Justice. Cambridge, Mass.: Belknap Press of
Harvard University Press.
Rawls, J. (1993) ‘The law of peoples’, Critical Inquiry 20(1): 36-68.
Rawls, J. (1999) The Law of Peoples. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Rawls, J. and Van Parijs, P. (2003) Three letters on The Law of Peoples and the
European Union. Revue de Philosophie Économique 7(1): 7-20.
Reidy, D.A. (2004) ‘Rawls on international justice: a defense’, Political Theory
32(3): 291-319.
Reidy, D.A. (2007) ‘A just global economy: in defense of Rawls’, Journal of Ethics
11(2): 193-236.
Walzer, M. (1977) Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical
Illustrations. New York: Basic Books.
Wenar, L. (2017) ‘John Rawls’, in E.N. Zalta et al. (eds.) Stanford Encyclopedia of
Philosophy,
Stanford:
Stanford
University
Press,
https://plato.stanford.edu/entries/rawls/, accessed August 30, 2017.
Williams, H.L. (2011) On Rawls, Development and Global Justice: The Freedom
of Peoples. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Williams, H.L. (2014) ‘The Law of Peoples’, in J. Mandle and D.A. Reidy (eds.) A
Companion to Rawls. Malden, MA: Wiley, 327-345.
�382
�383
Etica & Politica / Ethics & Politics, XX, 2018, 1, pp. 383-395
ISSN 1825-5167
THE MORAL DECISION: FROM
PHRONESIS TO ETHICAL
COMPETENCE
FRA NCO MA NT I
Università of Genova
Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia
franco.manti@unige.it
ABSTRACT
The Aristotelian idea of φρόνησις (phronesis) is an invaluable resource to help amending the limits
of deontological and consequentialist theories. It permits to free the moral decision from rules and
standard principles and to give contextual motivations.The ethical competence, as a process of
construction of moral judgment aimed to give reason for our choices, is a contemporary
development of this intuition.
KEYWORDS
Ethics monism, phronesis, heterogeneity of morality, moral judgment, ethical competence.
LIMITS OF ETHICS MONISM
The two most influential theories in moral philosophy from the end of the XVIII
century are the Kantianism and the utilitarianism.
They have been usually considered as rival theories, but actually they converge on
some aspects and they point out common limits 1. These two theories give different
answers to the attempt to developing a standard decision procedure to resolve moral
dilemmas, however both believe that what is considered as ethically decisive in a
lifespan field should enjoy the same consideration in other fields.
Therefore, the kantianism and the utilitarianism share the idea that there is a
unique moral principle able to orient and justify our choices. According to the
kantianists, the moral decision is deontological, while according the utilitarianists it
1 See F. Manti, Biós e pólis. Etica, politica, responsabilità per la vita, Genova University Press,
Genova 2012, pp. 15 – 18.
�384
F RA NC O M A NTI
is consequentialist; according to the former all moral obligations are categorical
(binding a priori), according to the latter they are not. Both the decision models are
characterized by their ethics monism.
This led to neglect the moral judgement as the ability to correlate principles or
general rules to specific contexts, and has led - for example - to consider
controversial ideals of the person founded on the autonomy (Kant) or the
sperimentalism towards different forms of life (J. S. Mill), as the basis of the liberal
neutrality 2, and it has elided the moral conflict as the typical dimension of the
morality.
Even the contemporary reports, as the reports by Rawls and Harsanyi, are not so
persuasive when trying to overcome the aforementioned limits. It is not possible here
to discuss analytically the question 3.
Extremely and partially summarized:
Rawls’ contractarianism and the utilitarianism follow different decision rules, but
both the maximin rule and the principle of the medium social utility with related
axioms and social welfare, reduce ethics to a branch of the Rational Choice Theory.
The divergence concerns the “moral algebra” that has to be used. Harsanyi does
not challenge the original position as an analytical tool to be used in order to define
the justice criteria and other aspects of morality, but he opposes the Bayesian
calculus (with the principle of equiprobability) to the maximin rule.
In my opinion, both the aforementioned theories are subjected to at least three
criticisms able to question their own structure:
1. Any calculus procedure of the Game Theory can take into account that
morality has to manage a plurality of factors coming from specific contexts and
with contextual and biographical dimensions.
2. The requirements imposed by the rationality of the calculus make marginal the
psychological and the emotional dimensions which have – on the contrary – a
relevant impact on orientations and conducts.
3. The Rational Choice Theory is based on basic conditions of internal
consistency (axiom of contraction and axiom of expansion) which limit the
decision to this consistency. This limit is excessive and inadequate when
applied to moral and social decisions 4.
2 I do not discuss here the questions related to the relationship between ethics and politics. I only
want to underline how monistic moral theories have insisted on giving an ethical justification and not
only a political justification of the principle of neutrality. For an in-depth analysis, see F. Manti, La
neutralità politica come principio deontologico, in “Etica & Politica/Ethics & Politics”, vol. 17, n. 3,
2015, pp. 247-261.
3 For an in-depth analysis see F. Manti, Bios e polis, op. cit. pp.18 – 41.
4 See A. Sen, Rationality and Freedom , The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge
Massachusetts, pp.121-157; F. Manti, Scelte di mercato. Una teoria della decisione ragionevole, in
AA.VV., Etica ed economia il binomio possibile, Sentieri Meridiani, Foggia 2010, pp. 29 - 35. In
particular, the internal consistency required by these axioms is not able to take into account real
�385
The Moral Decision: from Phronesis to Ethical Competence
Even the revision of the theory of justice proposed by Rawls in Political Liberalism
arrives at a theory of decision based on the overlapping consensus that does not
respond convincingly to the need to relate general principles and rules to specific
contexts in order to obtain indications to face and – if possible – resolve moral
dilemmas. As a matter of fact, the object of this consensus is restricted to the basic
structure of a well-ordered society 5.
AN INTUITION OF ARISTOTLE
As defined by C. Larmore, an invaluable resource to help amending the limits of
deontological and consequentialist theories, is given by the Aristotelian idea of
φρόνησις (phronesis) 6, which is fundamental to understand what is the moral
judgement, since it permits to free the moral decision from rules and standard
principles and to give contextual motivations.
Before defining the idea of φρόνησις, Aristotle gives a methodological indication
related to the arguments concerning human behaviours and, precisely, referring to
their precision. Though φρόνησις is a dianoetic virtue, they are not epistemic, since
they do not affirm an incontrovertible truth, but “[…] ἐπὶ τὸ πολὺ […]” 7, that is
“mostly”. Their grade of truth is approximate also because if we start from
preconditions carrying these traits, the conclusions have to be of the same type.
Therefore, the precision of our expressions in this field is as high as permitted by the
nature of the object.
The following example is illuminating:”παραπλήσιον γάρ φαίνεται μαθηματκοῦ τε
πιθανολογοῦντος ἀποδέχεσθαι καὶ ῥητορικὸν αποδείξεις ἀπαιτεῖν.” 8. That is:
expecting precision from “mostly” preconditions “would be, more or less, admitting
that a mathematician counts on persuasion and a rhetorician on rigorous
demonstrations.”.
context conditions characterized by their dynamism or variations (always possible) in the information
we have (see A. Sen, Internal Consistency of Choice, “Econometrica”, Vol. 61, N..3, pp. 495 - 521).
Outside the assumption of situations with a high level of abstraction, as the original position, the
calculus that follows the internal consistency axioms of the Rational Choice Decision shows all its
limits. This is true also for a probabilistic calculus as the one of the function of the average utility (or
function of social utility) since it is influenced by the attribution of values of utility to the different
individual utilities. Harsanyi, though, does not have difficulties to accept the original position as a sort
of heuristic assumption able to clarify several aspects of morality.
5See J Rawls, Political Liberalism. Expanded Edition, Columbia University Press, New York, 2005,
pp. 133 – 172. For a discussion on the consent by intersection, see F. Manti, Bios e polis, op. cit., pp.
74 – 80.
6 See C. Larmore, Patterns of Moral Complexity , Cambridge University Press, p. xii.
7Aristotle, Nicomachean Ethics, I, 1094 b 21.
8Ivi, I, 1094 b 25 – 27.
�386
F RA NC O M A NTI
Therefore, judgement is not elaborated thanks to general rules but taking into
account the context in which we act: “ […] τὰ πρὸς τὸν καιρὸν σκοπεῖν […] “ 9.
This also means that moral judgment does not have to deal with formal rules, but
with life activities where examples, experiences, education have a fundamental role.
The φρόνησις allows us to choose the best behavior in every context. Aristotle
specifies how it is a customary state of mind, accompanied by reason and addressed
to action, which pertains to what is good or evil for man 10. The good action,
therefore, is, in itself, an aim (ἔστι γὰρ αὐτὴ ἡ εὐπρασξία τέλος) 11. It follows that,
according to Aristotle, there is a connection between truth and good. In summary,
φρόνησις, like all the dianoetic virtues, allows us to reason correctly and approximate
the truth: the logos recognizes what is true and so desire accords to it. The ὀρθός
λόγος (orthόs lόgos), that is the right reason, is therefore to deliberate what we have
the most reason to do as appropriate to the context in which we are and to the
promotion of good life 12.
The dissertation on φρόνησις, proposed by Aristotle in the VI Book of
Nicomachean Ethics 13, on a hand further specifies his vision of this virtue, on the
other hand it underlines some difficulties.
By the way, I consider very interesting that – in spite of what happens with σοφία
(sophia) – Aristotle does not give a real definition of φρόνησις but – in order to
understand it – he refers to people considered as wise. Aristotle textually affirms:
“Πεπὶ δὲ φπονήσεως οὕτως ἂν λάβομεν τοὺς φρονίμους” 14. Wise is he who has the
ability to decide what is good or is appropriate 15 to him, not in a specific field, but in
general, for a good life. His characteristic is the ability to decide “ […] εἴη φρόνιμος ὁ
βουλευτικός “ 16, since he does not demonstrate. The demonstration regards what
cannot be different from what actually is, while the demonstration requires to
evaluate and discuss the principles that can be different from what they actually are.
When we refer to our behaviours, we talk about things that “[…] ἐνδεχέται καὶ ἄλλως
9 Ivi, II, 1104 a 9.
10 J. Annas proposed to translate φρόνησις with intelligence. It concerns good life in general. See J.
Annas, The Moral of Happiness, Oxford University Press, New York - Oxford 1993, pp. 73-74.
11Aristotle, Nicomachean Ethics, VI, 1140 b 7.
12 See ivi, VI, 1140 to 27- 28. For a closer look at the subject, see M. Mangini, Etica democratica.
Una riflessione sui valori etici nella società liberale, Giappichelli, Torino 2013, pp. 61 - 64 e pp. 69 – 72.
For a different interpretation, from the one I propose, of the ὀρθός λόγος, understood as reasoning
capable of correctly deriving from the first and universal principles of being coherent conclusions of a
logical and ontological order, see L. Clavell, La presenza di Aristotele nell’enciclica Fides et ratio, in S.
L. Brock (ed), L’attualità di Aristotele, Armando, Roma 2000, p. 162.
13 See ivi, VI, 1140 a 24 – 1140 b 30.
14 See ivi, VI, 1140 a 24.
15Aristotle uses the words τὰ συμφέποντα which can be also translated as what is useful,
convenient, beneficial.
16 Aristotle, Nicomachean Ethics, VI, 1140 a 26 – 27. The use of the word βουλευτικός is relevant
because it indicates also the use of the ability of political decision. (See Aristotle, Politica , 1260 a 12)
�387
The Moral Decision: from Phronesis to Ethical Competence
ἔχειν” 17, can be different. Therefore, wise are people who can judge (θεωρεῖν) upon
what is good for themselves and for other men.
It is evident that with this statement Aristotle wants to specify that wisdom regards
the decision related to other people too, underlining – with the example referred to
Pericles – the political dimension in addition to the ethical dimension 18.
Once defined the conditions where the moral judgment is acquired and its
function, we have to answer to the question related to the modalities through which
we build it or to the way we exercise this faculty. Aristotle gives us two clues: the
theory of mediety and the practical syllogism.
With regard to the further, we have to underline this passage “Ἔστιν ἄρα ἡ ἀπετὴ
ἕξις προαιρετική, ἐν μεσότητι οὖσα τῇ πρὸς ἡμᾶς, ὡρισμένῃ λόγῳ καὶ ᾧ ἂν ὁ
φπόνιμος ὁρίσειεν” 19.
Without considering refined philological debates, in my opinion ὡρισμένῃ is
referred to mediety toward ourselves and is made possible by the ὀρθός λόγος . In
other words, virtue consists in the ability to appropriately face the requirements
which emerge from a determined situation, avoiding excesses of any kind.
Aristotle underlines also that it is difficult to practice ethical virtues as mediety. It
is difficult to look for and find the middle path as it is difficult to find the centre of
the circle: it is not for all, but only for he who has a full knowledge (εἰδότως) of the
subject.
He also underlines some rules of behaviour able to define what really is the
mediety towards ourselves 20, but as Larmore argues: “[…]only judgement can shape
their vagueness and transform them in significant provisions.” 21.
In the III Book of Nicomachean Ethics, when analysing the deliberation 22 (βουλή
and βούλευσις) 23 and giving causes for reflection on the practical reasoning, Aristotle
does not give indications on its form and if and to which extent is it oriented by
considerations concerning virtue. The moral decision, as said, regards cases that
“mostly” happen, whose result is uncertain, and where there is indefiniteness.
In this context of ideas, Aristotle identifies the syllogistic type of the structure of
the moral decision (which we do not have to forget has a contextual character and
does not concern the aims but the means which conduct to the aims). This structure
is as follows:
Major premise: what is considered as what has to be done
17Ivi, VI, 1140 a 35.
18 See ivi, 1140 b 7-11
19 Ivi, II, 1106 b 36 – 1107 a 1-2 «Virtue, so, is a disposition that orients decision following a
mediety towards ourselves, defined by reason and as defined by he who is wise»
20 See ivi, II, 1109 b 2 – 26.
21 C. Larmore, Patterns of Moral Complexity , op. cit., p. 18.
22 Aristotle, Nicomachean Ethics, III, 1112 a 18 – 1113 a 14.
23 The two words cannot be considered as synonyms.
�388
F RA NC O M A NTI
Minor premise: means through which I do what I affirmed in the major premise
(given the context)
_____________________________
Conclusion: the accomplished aim
It is evident that the premises imply the moral judgment and that it precedes and
permits to formulate the premises from which the conclusion is inferred. In the light
of these considerations, I think that Larmore is right when he affirms that the
practical syllogism cannot be considered as a model able to explain how the moral
judgment works 24.
THE HETEROGENEITY OF MORALITY
The modern alternatives to the Aristotelian intuition regarding the moral
judgement do not seem convincing. The third formulation of the Kantian categorical
imperative and the idea of a moral algebra able to calculate which is the decision that
produces more social wellness, respond to the same requirement: determining the
moral obligation in the light of a unique and universally valid impartial principle as
rationally justifiable, the deontological principle or the consequentialist principle of
utility. The critics that Rawls moves to the utilitarianism and the critics by Harsanyi
to the deontological neocontractualism of the further underline (both and mutually)
the limits of the ethical monism, whichever its declination is. I think, therefore, as
sharable what said by Larmore:
The correct point of view, in my opinion, is that there is the deontological reasoning,
the consequentialist reasoning, and both are valid ways of morally reasoning. The
mistake made by both the utilitarianists and Kantianians consists in claiming that only
one of these principles can be licit. And I think that it can exist more than a moral
reasoning and that we have to admit the multiplicity of these ways 25 .
The existence of a multiplicity of ways of reasoning on the right action to do in
order to pursue other people’s good, implies the acknowledgement of the heterogeneity
of the moral as a matter of fact of our experience. Depending on the contexts, we
decide and choose moral actions giving deontological or consequentialist reasons.
This experience also shows that not always the moral decision requires impartiality.
There are some peculiar categories of people, groups or individuals with whom we
have special relationship that can be related to ways of life like interests: toward these
24 See C. Larmore, Patterns of Moral Complexity , op. cit., p. 8.
25 C. Larmore, Dare ragioni, Rosemberg & Sellier, Torino 2008, p. 34 (The text has been published
only in Italian since it is the report of a lesson, authorized by the Author).
�389
The Moral Decision: from Phronesis to Ethical Competence
people we can act in a preferential way in determined circumstances and conditions,
justifying these preferential actions.
Therefore, we should place side by side to the deontological and consequentialist
principles the principle of partiality “[...] following which we have to respect the
specific and particular relationships we have towards the others and we have to act for
their good in the light of these special bonds we have with them.”26.
In addition, always in the light of our moral experience, it is possible to note that, in
our social relationships, we are asked to justify some decisions determined not only by
considerations on principles, but also by the convergence of contextual factors
(included education and tradition), intersubjective and negotiation relationships,
motivations generated from our moral loyalties, our “moral feelings” and emotions.
Our moral experience shows that we have to face daily obligations like keeping
promises, be honest, return others what we owe them, whose rules do not require in
many occasions a particular processing on the moral side.
Other obligations like - for example - being benevolent, generous or fair, require a
reflection on when do we have to follow them, how can we realize them, which
consequences will have our actions on the others: in other words, they require the
processing of the moral judgement. There are also circumstances where the moral
judgement is solicited or induced by passions, or, as we say nowadays, by emotions.
The emotional impact of situations like suffering, inequality, etc. can contribute to
generate a moral reflection on how should we act to avoid them or, at least, to limit
their impacts. Aristotle had foreseen a relation between good and passions to the point
that he thought that sometimes they could even coincide 27. Friendship with ourselves is
considered in itself as a mutual agreement among reason and passions 28. The vast
majority of modern ethics has elided passions from the moral dimension. Thanks to the
philosophers of the moral sense like Shaftesbuty, Hutchenson, Hume, A. Smith, the
emotional dimension of the moral has been underlined, to the point that Hume could
consider passions (at that time passion meant emotion) as the ground where morality
grows.
Among these philosophers, he who underlined more than others the importance of
the moral judgement was A. Smith. Apart from underlining that justice rules are the
only rules of morality to be precise, while the rules regarding virtues are unprecise,
vague and undetermined he also underlined that virtues are connected with a general
rule or with a way of acting, and, at the same time, integrated with the moral feeling
proper of each of them.
This feeling is exposed to several changes depending on the contexts. A. Smith has
defined sympathy as the ability of putting yourself in someone else’s shoes and to care
for his/her wellbeing, that is the moral sentiment par excellence 29.
26 Ivi, p. 37.
27 See Aristotle, Eudemian Ethics, VII, 12, 1245 b 1-2.
28 See Aristotle, Magna Moralia , II, 11, 1211 a 33 - 37.
29 See A. Smith, Theory of Moral Sentiments, Cambridge University Press, Cambridge 2002, pp.
11- 18.
�390
F RA NC O M A NTI
Referring explicitly to Hume and A. Smith, Hoffman has proposed an interesting
theory of the relationship among empathy and moral development. His thesis is that
even if the empathetic moral can explain many aspects of pro-social behaviour, a moral
theory needs to be referred to some moral principles. The relationship between
empathetic affections and moral principles is orthogonal 30 .
For example, empathy implies the ability of putting yourself in someone else’s
shoes, so it is orthogonal with the respect of individuals’ rights, though producing a
deep motivation to justice. An observer can be motivated by empathy to help a person
an, at the same time, consider take care of others as a duty.
With regard to the three fundamental principles of morality, empathy is orthogonal
with the deontological principle, since we feel that helping a person in trouble is our
moral duty (putting ourselves in his shoes); empathy is orthogonal with the
consequentialist principle because we take the responsibility of our actions thinking
about the consequences of our actions and about how we could feel in the same
situation; and it is orthogonal with the partiality principle, when we take into account
the particular “familiarity” and sharing we have with other people.
To sum up: if the majority of moral dilemmas raises empathy because they imply
visible and invisible victims, present or future, orthogonality among empathy and
moral principles allows to weaken the bias to which the further is subjected, to activate
the moral imagination and to elaborate the judgement.
Even if the moral judgement is not completely determined by rules, it “[ ...] is not
arbitrary. […] We do not judge blindly, but reacting to the particular given situation, on
the basis of some reasons.” 31.
So we should pay serious attention not only to the different elements of the moral
judgement, but also to the process through which we formulate it. It is also because we
are aware of this process that we can give reasons to ourselves and to others for our
decisions.
THE ETHICAL COMPETENCE
The elaboration of the moral judgement and the concrete practice of the
decisional process implied by a particular judgement can be defined as ethical
competence. There are many and problematic definitions of competence . I think
that the definition by Cepollaro is very interesting: according to him “competences
are not things” . Nor they are knowledges or skills, even if they imply both of them.
To understand their nature, it is possible to define them as emergent properties,
32
33
30 M.L Hoffman, Empathy and Moral Development, Cambridge University Press, Cambridge
2000, p. 221.
31 C. Larmore, Patterns of Moral Complexity , op. cit., p. 22.
32 See P.G. Bresciani, Capire la competenza , Franco Angeli, Milano 2012.
33 G. Cepollaro, Le competenze non sono cose, Guerini e Associati, Milano 2008.
�391
The Moral Decision: from Phronesis to Ethical Competence
relational, connected to uses and contexts. This means that these competences emerge
from real intersubjective
practises 34.
Being related to fluxes of communication, competences are dynamic and cannot be
reduced to the conditions of their emergence. This implicates their retroactivity with
regard to the initial conditions and the transformation of these conditions.
Therefore, competences are not “things” or “sets” that can be learnt and applied to a
system, since their fundamental characteristic is that they are related to a context,
locals, situated, evolving in the contexts where they emerge. They contribute to the
evolution of the contexts by generating new ones. So interpreted, competences can be
seen as a bricolage of knowledge and ability to act in determined contexts, where they
represent knowledge in action and the ability to use given resources.
With regard to the ethical competence, this is a basic competence, since it is
transverse and influential on more specific competences. Since the moral dilemmas
regard intersubjective relationships in determined contexts, the ethical competence
emerges as an answer - as taking the responsibility of these dilemmas.
More in details, it consists in the definition of which ethics fundamental principles
have to be endorsed in a specific context, taking also into account the orthogonality
with the emotions and, first of all, with empathy.
In addition, acting in a way ethically driven, when there are dilemmas or moral
conflicts, can contribute to determine a moral co-evolution of the interested subjects or,
at least, if there is not a possible solution, to formulate and/or recognize rules and ways
of conflict management and cohabitation.
The ethical competence is, therefore, an expression of the dynamic-cultural and
operative balance people can find among themselves and the context and it is done by
subjects who can diagnose the environment where they operate and produce complex
performances, actions, relations adequate to the context itself on the basis of the
decisions they have to justify.
Inside complex organizations, the ethical competence requires to take into account
stakeholders’ needs, to choose, after reflecting, priorities, having in mind a generative
vision of ethics that should be implemented and supported by all, but especially, by he
who has directive functions and responsibilities.
A deep moral sense endorses the development of clear and positive relationships
among all the stakeholders. As said by Damon, morality is not a constraining power
that forces people to be honest and to avoid problems, but, on the contrary, it realizes a
fecund source of motivation, inspiration and innovation 35. Therefore, choices and
behaviours founded on moral decisions strengthen negotiation and cooperation and
generate influential relationships able to determine the well-being for all stakeholders
in a structured system.
34 See ivi, p. 30.
35 See, W. Damon, The Moral Advantage,
in “Optimise” 2002, http://www.optimizemag.com/issue/003/ethics.htm.
�392
F RA NC O M A NTI
MORAL DECISION AND LIMITS OF ETHICAL COMPETENCE
Since now I have underlined the different “elements” of the moral judgment, the
complexity of the process of its construction that results in the ethical competence. I
was not able to propose a definition. Due to the fact that it does not imply the mere
compliance to rules, a standard definition looks like impossible. As said, the moral
judgement is not arbitrary, since we answer to emergences in particular situations on
the basis of some reasons. The moral decision implicates a judgement that merges
rationality requests with moral sentiments, the biographical dimension and the
experiences of each of us, and the context where it has to be made. This means that,
when formulating the moral judgement, it is not requested a theoretical rationality
nor a generic reference to empathy (or to other moral sentiments), but a practical
sensibleness able to merge rationality and empathy. In addition, it is also thanks to
the awareness of the process through which we elaborate a moral judgement that we
give reasons, to ourselves and to others, of the decisions we make.
The deontological, consequentialist and partiality principles can be identified as
the fundamental principles of the moral. Above them, we have to face other moral
principles like the principle of promptness, beneficiality, justice, responsibility,
respect for autonomy etc. Let me define the first principles, which are fundamental,
as first order principles, while the others can be grouped in a second order.
In fact, we use the latter on the basis of deontological, consequentialist or
partiality considerations.
Our moral experience is complex since, in the light of the heterogeneity of the
moral, it merges a plurality of factors. The judgment is expressed on the basis of the
definition of a hierarchy among the fundamental principles of the moral
(deontological, consequentialist, partiality), which is elaborated, from time to time,
taking into account the context where we have to act. This choice guides the use of
some principles which I define as second order principles (freedom, beneficiality,
justice, etc.) and it contributes to give reasons for our actions. For example, I can
believe to act for the right because I am pursuing an obligation or because I am
evaluating the consequences of what I am going to do.
The reference to this or that principle, pertaining to the first order or to the
second order, can be guided by factors like empathy, biographic experiences, cultural
tradition, negotiating needs, relational needs or even by a mix of these factors. Since
– as I tried until now to demonstrate – we do not decide on ethically relevant issues
following formal criteria of internal consistency following our preferences, but we
decide to take into account a plurality of factors like information and evaluations
related to the context where we have to decide, when we have to give reasons for our
�393
The Moral Decision: from Phronesis to Ethical Competence
actions (to ourselves and to others) we need to refer to a contextual principle of
justification that could be formulated as follows:
We are requested to give reasons for decisions, choices and actions in the light of
the ways through which we arrive to recognize the priority to one of the principles of
the first order and we connect them to the principles of the second order, taking into
account the specific context where we are situated when deciding.
The moral judgment, in itself, is not able to overcome the moral conflict nor it is
always expressible. It has to face the rational conflict that can be considered as the
effect of the limits of our reason. Even if we try hard to give reasons, a profound
moral dilemma can be irresolvable and so it represents a conflict. For example, the
urgency reasons that can be invoked to sustain priority in the consequentialist
principle could not necessarily be of the same intensity for everybody.
Larmore affirms that when consequentialist reasons are in conflict with
deontological reasons of the strictest type, we should suspend the judgment on which
of the two principles represents an obligation for us (but we have to decide which of
the two principles we want to follow) 36. So he proposes a sort of epochè (suspension
of judgement) when we think that we could have more information that could modify
our view of the situation. The problem is that we cannot always have access to more
information related to a conflict. Sometimes we have to admit that there are some
irresolvable conflicts. This can happen in the relationship with others, but even with
the relationship with ourselves. This is the case when we feel obliged to act in the
light both of the deontological principle and of the consequentialist principle, since
both of them require actions we think as acceptable, but, indeed, obligatory. In these
cases – as said by Larmore – we do not have a deficit in our knowledge, but, on the
contrary, we know too much, that is, we know that we are obliged to do the action
that we consider the best one from both the deontological and the consequentialist
points of view 37.
Are we facing a defeat? Does admitting the heterogeneity of the moral implicate
the impossibility to decide? Should we come back to foundationalist morals? Let us
start with this last question.
Firstly, I would say that rationally recognizing that we do not infer the
fundamental principles of the moral but actually we find them, and that these
represent the undeniable connections enabling us to look at ourselves as moral
agents – whichever our vision of good life is – does not implicate any metaphysic of
the moral subject, nor the need to look for foundations outside the moral itself.
36 C. Larmore, op. cit., p. 149
37 Ivi, p. 150.
�394
F RA NC O M A NTI
In this regard, the principle of contextual justification recalls the fact that
whichever the justification we give to our actions is, it has to be referred to a specific
context. This means that, even if the moral principles justify actions, they do not
have justifications since they represent assumptions of our rationality. I agree on
Larmore’s idea following which the fundamental principles, having the
aforementioned characteristics, establish the limits of the moral intelligibility 38.
In this regard, I think that we have to add another reflection: when facing an
irresolvable moral conflict and the necessity to decide, we have to acknowledge that
there are some obligations we cannot respect, so that moral decisions where
fundamental principles are in conflict are always difficult. Among the contexts as
they are and as they ought to be, there is our ability to do things, but we have to be
aware that “Our possibilities in the world are then too narrow for what we know we
ought to do” 39.
I do not think this represents a defeat: on the contrary this represents the realistic
acknowledgement of our limits, of the necessity to know them and to face them
constantly.
This is the conclusion of the journey that has taken us from φρόνησις to ethical
competence, thanks to which we have seen how is it possible to build the moral
judgement and which are its limits.
Aristotle had a great intuition when putting the judgment at the core of the moral
reflection and even if he has nothing to say to us with regard to the heterogeneity of the
moral, and the φρόνιμος does not correspond to he who is ethically competent 40, it
contributes, still today, to remind us that this centrality does not involve the eclipse of
the role of the reason. The idea of practical reasonableness, that is involved in the
practise of the ethical competence, is connected with Aristotle’s intuition and represents
an alternative to the ethical monism and to the Rational Choice Theory in a social and
relational ethics perspective.
38 Ibidem.
39 Ibidem.
40 Φρόνιμος is he who can decide on the good life in general, while the ethics competence is
situated, contextual and does not imply nor a vision of the good life in itself, nor a perfectionistic idea
of human nature. As J. Annas points out, « [...] Plato and Aristotle, insist that working for a living was
incompatible with developing the virtues; Thus virtue and skill, would not naturally be considered as
forming aspects of the same life.». (J. Annas, op.cit., P.72). Ethical competence, on the contrary, allows
to deal with moral dilemmas emerging from professional practices
�395
Etica & Politica / Ethics & Politics, XX, 2018, 1, pp. 395-403
ISSN 1825-5167
MARGALIT SUL TRADIMENTO
PI E RPAO LO MA RRO NE
Università di Trieste
Dipartimento di Studi Umanistici
marrone@units.it
ABSTRACT
Margalit believes that betrayal and its complex phenomenology offer a strong case for reshaping
the difference between ethics and morals. Ethics would concern strong relationships and moral
those weak. Betrayal would be the breaking of the strong bonds present in ethics. My criticism is
that strong bonds is neither objective nor interpersonal, but is perceived as such only by those who
feel betrayed. The only exception is represented by emotional and sexual betrayal.
KEYWORDS
Betrayal, Avishai Margalit, trust.
Guardo alla parete la riproduzione di un dipinto di Jack Vettriano, l’artista
scozzese di origini italiane, l’artista che ha introdotto il genere noir nella propria
immaginazione pittorica e anche nella nostra attraverso una inquietudine erotica
trattenuta, che sembra il preludio di una tragedia o di un losco affare. Il titolo di
questo dipinto è Contemplation of a Betrayal.
Questo artista è stato talvolta accusato di dipingere delle cartoline che sollecitano
l’immaginario soprattutto maschile per le numerose scene cariche di presagi di
erotismo. Non sono un critico d’arte e non ho le competenze per addentrarmi in una
analisi pittorica della sua produzione. Però questo dipinto è tutt’altro che scontato e
mostra una coerenza di intenti molto precisa. Vi sono raffigurati un uomo e una
donna. L’uomo è alla nostra destra e la donna alla nostra sinistra (e quindi alla sua
destra). Entrambi sono vestiti elegantemente. La donna ha in mano un calice di vino.
Si intravede una vetrata sullo sfondo. Si immagina che siano a una festa e siano
circondati da altre persone. L’uomo è chino verso di lei e le dice qualcosa
all’orecchio. Lei ha il viso leggermente inclinato alla propria destra. La parte del volto
che entrambi mostrano è quella sinistra. Quella destra è completamente invisibile per
l’uomo e per la donna è celata dai capelli che le cadono in avanti. Si tratta forse di un
indizio importante.
È noto, oramai al di là della cerchia degli specialisti, che il nostro cervello è
asimmetrico. La parte sinistra è deputata ad alcuni compito e quella destra ad altri,
�396
P IE RPA OLO M A RRONE
sebbene la plasticità cerebrale possa supplire efficacemente a carenze in uno dei due
emisferi cerebrali. Questa asimmetria ha delle ricadute notevoli anche per le
modalità attraverso le quali noi interpretiamo gli indici corporei dei nostri
interlocutori per scoprirne le emozioni. Esistono esperimenti nei quali vengono
presentate a dei soggetti le due metà di due volti accostate l’una all’altra, uno con
un’espressione triste e una con un’espressione sorridente. Sono volti che sono nel
medesimo tempo tristi (sinistra) e felici (destra) oppure felici (sinistra) e tristi (destra).
Per la maggior parte degli osservatori le emozioni dominanti sono quelle espresse
dalla parte sinistra del volto, perché il loro riconoscimento è governato dalla parte
destra del cervello che presiede all’interpretazione delle emozioni e al
riconoscimento dei volti. Una maggioranza dei ritratti presenti nei musei occidentali
presenta un orientamento dei volti verso sinistra e in generale il lato sinistro è
considerato quello maggiormente espressivo. Nelle scene della crocifissione del
Cristo il suo volto è sbilanciato verso sinistra circa il 90% delle volte. Se la scelta fosse
casuale, lo sarebbe circa il 30% delle rappresentazioni. Anche le eccezioni sono però
rivelatrici. I ritratti degli scienziati che sono esposti nella sede londinese della Royal
Society hanno quasi tutti il volto esposto a destra, forse per rispondere
inconsciamente allo stereotipo che vuole lo scienziato non dominato dalle emozioni.
In questo dipinto di Vettriano non a caso, io credo, la parte destra dei due volti
non è rappresentata ed è occultata. I due soggetti stanno pianificando un tradimento,
forse a danno dei propri partner – questa è la prima cosa che ci verrebbe in mente,
penso – ma forse il loro tradimento è di altro genere. Forse sono delle spie e stanno
trasmettendosi innominabili segreti tradendo il loro paese. Forse stanno pianificando
uno spionaggio industriale oppure si stanno trasmettendo dei segreti militari. La loro
razionalità deve essere occultata e per raggiungere i loro obiettivi non essere
manifestata a chi certamente è là attorno. Ciò che li rende liberi non è la
manifestazione pubblica della verità, ma la condivisione tra pochi di una verità che
non può essere pronunciata. Noi viviamo in un mondo completamente secolarizzato.
Alle nostre orecchie le parole del Cristo (“Se rimanete nella mia parola, siete
realmente miei discepoli, e conoscerete la verità, e la verità vi renderà liberi”,
Giovanni 8:31, 32) non hanno molto significato a meno che non abbiamo fede. In
questo caso, l’apostasia potrebbe essere considerata affine al tradimento, ma nessuno
o quasi solleverebbe questa accusa pubblicamente oramai, perché la verità della fede,
anche per chi la ritiene tale, ha una dimensione privata e non più pubblica.
Si potrebbe sostenere che proprio nel nostro mondo secolarizzato la stessa
distinzione che è fatta propria dalla quasi totalità dei filosofi politici, ossia quella tra
società civile e Stato, ha la funzione di rendere pubblica la ricerca della verità,
attraverso il confronto delle diverse opinioni espresse dalle libere forme associative
dei cittadini, che lo Stato deve proteggere e promuovere. Questa pubblicità della
verità è qualcosa di affine alla virtù, almeno nella presunzione della sua
proclamazione da parte della quasi totalità dei politici. Nella retorica politica, la
�397
Margalit sul tradimento
verità deve essere detta e non essere occultata. Anche Antonio Gramsci pensava,
apparentemente, che la verità dovesse essere detta. “Dire la verità, arrivare insieme
alla verità, è compiere azione comunista e rivoluzionaria.” Nelle sue parole risuona
un’incompletezza, quella del rivoluzionario di professione che sa benissimo che
operare nella menzogna può essere una necessità persistente per raggiungere il
potere. Questo è quanto io credo sia celato nell’idea che si arriva assieme alla verità,
che per lui era nient’altro che la verità della storia che si compie nella vittoria
rivoluzionaria del proletariato. Questa vittoria, liberando il proletariato, avrebbe
liberato assieme anche l’essere umano e manifestato la parzialità di ogni verità
contenuta nelle epoche antecedenti. Perché è chiaro che per Gramsci la verità non è
tanto una proprietà degli enunciati, ma qualcosa che si compie nella storia della lotta
di classe. Questo noi fatichiamo ad accettarlo oramai, perché quella prospettiva
filosofica e politica (che certamente non a caso aveva tanto a cuore Machiavelli) ci
appare molto distante e figlia di un’altra epoca.
Fatichiamo però anche ad accettare oramai che la verità possa manifestarsi nel
confronto pubblico. Al contrario, la menzogna ci appare come molto più
comprensiva e diffusa sia rispetto a una presunta verità rivoluzionaria che si svelerà
alla fine dei tempi e alla quale quasi nessuno crede più sia anche rispetto all’idea che
la verità emerge dal confronto di posizioni contrastanti liberamente espresse. La
menzogna è tanto più comprensiva e diffusa quanto più appare chiaro che noi
viviamo nell’epoca del cinismo di massa. In questa epoca del disincanto diffuso
nessuno si attende che venga detta la verità nell’arena della competizione politica,
che è il luogo di esercizio di ambizioni di potere. Nelle relazioni affettive, poi, il
minimo che si possa dire è che le occasioni per esercitare la menzogna sono state
esponenzialmente moltiplicate dalle occasioni offerte dalla diffusione dei social. La
stessa competizione sociale, alla quale ci viene detto non esserci alternativa, la
impone all’ordine del giorno.
C’è un legame analitico tra menzogna e tradimento, nel senso che non pare essere
possibile tradire senza una qualche manifestazione menzognera che non rende
manifesto quanto abbiamo intenzione di fare. Tuttavia, al tradimento non è stata
dedicata dai filosofi una attenzione specifica e particolare, almeno sinora. Avishai
Margalit, Sul tradimento (d’ora in poi citato come ST) cerca di fornire alcuni
strumenti di concettualizzazione con un’opera dotta e piena di numerosi spunti di
discussioni e di excursus storici, come altrimenti non potrebbe essere per indagare
un tema così presente nelle nostre vite. Avevo detto che nel dipinto di Vettriano è
rappresentato l’occultamento della razionalità di chi mente, dal momento che la
menzogna medesima è occultamento. Tuttavia, non bisogna nascondersi che
desiderare avere accesso a tutta la verità disponibile per circostanze per noi rilevanti
potrebbe non essere razionale. Noi siamo vittime del pregiudizio che una maggiore
quantità di verità sia meglio di una quantità minore. “Ma è necessario chiedersi:
l’assunto razionale è giusto? Volete sapere, per esempio, se avete ereditato una
�398
P IE RPA OLO M A RRONE
mutazione genetica che vi espone maggiormente al rischio di sviluppare una brutta
malattia incurabile, senza possibilità di remissione temporanea né di un
rallentamento del decorso? Non mi pare ci sia nulla di irrazionale nel non voler
conoscere questa informazione terribile che non offre via di scampo.”( ST, p. 113). E
per quanto riguarda il tradimento sentimentale, che è la prima fattispecie che forse a
ciascuno di noi viene in mente, quando pensiamo alla rottura del vincolo fiduciario,
non è forse vero che spesso riconosciamo dei segnali che nella loro ambiguità
trasmettono la possibilità del tradimento, ma scegliamo di non tenerne conto?
Preferisci pensarlo come una malattia stagionale e non come una malattia terminale.
Potresti avere ragione.
Il tradimento potrebbe contribuire a farci ridisegnare le nostre consuete categorie
di interpretazione dell’azione pur essendo un comportamento con il quale abbiamo
familiarità? Il tradimento ferisce che cosa innanzitutto? È la rottura di un legame,
certamente, o almeno la possibilità che questo legame si rompa. Ma i legami che noi
stabiliamo, i legami di cui noi siamo fatti sono di diverso genere. Si pensi al motto
della rivoluzione francese, che Robespierre pensava dovesse essere cucito sulla
bandiera “liberté, égalité, fraternité”. La fraternité è il lato debole di questo triangolo
per noi che viviamo nelle società liberal-democratiche. Pensiamo che sia sufficiente il
nostro accordo sulle regole della convivenza civile che tutela il maggior sistema totale
di libertà compatibilmente con il godimento di un eguale sistema per ciascun altro
cittadino. Pensiamo che questo accordo basti a garantirci la tranquillità e la pace e a
tutelare la nostra individualità. Questa individualità potrebbe essere parte dell’idea
stessa di eguaglianza in un certo senso, poiché se la libertà tutela la nostra
individualità, allora saremo egualmente liberi. L’eguaglianza è, cioè, da noi concepita
come un eguale accesso ad opportunità grosso modo simili.
Ma bastano queste virtù politiche fredde per consolidare la nostra convivenza
nelle società liberal-democratiche? Sono sufficienti gli accordi sulle procedure da
rispettare per mantenere la coesione in una situazione dove la liquidità – ossia
l’instabilità – dei legami sociali pare essere la nostra cifra attuale? Margalit è convinto
di no. In questa convinzione è solidale con le critiche che da parecchi decenni
vengono mosse al modello liberal-democratico dalle filosofie comunitarie, ad
esempio da MacIntyre e Charles Taylor. Ci sarebbe qualcuno disposto a morire per
la negoziazione procedurale descritta da Rawls nel suo esperimento di pensiero? Per
questo Margalit propone di introdurre il terzo termine che mai è stato cucito sulla
bandiera francese come un termine di paragone per comprendere la portata teorica
del tradimento. Senza la fratellanza la motivazione necessaria per costruire libertà e
eguaglianza sarebbe estremamente scarsa. Le nostre battaglie politiche, quelle poche
che ancora in questo momento ha forse un senso combattere, sono esperienze di
condivisione. Questa condivisione non si esaurisce nel risultato, ma continua come
un processo che ha una precisa funzione di coesione. “Solo una società dotata di un
solido spirito di fratellanza ha le potenzialità per instaurare la giustizia. In questa mia
�399
Margalit sul tradimento
ultima affermazione non vi è nulla di scontato. Io qui la pronuncio con i tratti del
dogma perché il mio libro non si occupa direttamente di fratellanza, ma di
tradimento. L’idea non è quella di affrontare la fratellanza in modo diretto, bensì di
giungere a essa tramite la sua patologia, che è il tradimento.” (ST, p. 4)
Quest’ultima idea ha una sua attrattività, perché ci fa immaginare una situazione
sociale dove i rapporti di giustizia siano anche rapporti solidaristici, ma l’equivoco è
in agguato, a mio parere. Questo equivoco è ritenere che le situazioni di giustizia
siano una situazione di tutto o niente al modo dei rapporti modellati sulla
fratellanza. La fratellanza è infatti un rapporto di tutto o niente. Con il fratello e con
l’amico, che può essere una sorta di fratello, puoi litigare, ma sin tanto che non si
giunge a una definitiva rottura (che può essere tanto dolorosa quanto la rottura di
coinvolgenti rapporti di altro genere) il fratello rimane sempre tale. Non è un caso
che le amicizie più coinvolgenti vengono da noi spesso descritte come amicizie
fraterne, a voler sottolineare un legame profondo che si avvicina ai rapporti di
sangue. La giustizia non è una questione di tutto o niente, a meno che non implichi
un coinvolgimento nella comunanza di valori che descrivono un significato condiviso
attribuito all’esistenza umana. Questa prospettiva è però quasi sempre legata alla
religione e alle utopie rivoluzionarie e millenaristiche, e quindi, non può essere
accettabile per società laiche, che presuppongono invece un pluralismo dei significati
attribuibili all’esistenza da ciascuno dei suoi cittadini. La giustizia riguarda più gli
atti giusti che una prospettiva completa. Alcuni atti possono essere solo parzialmente
giusti, ad esempio le azioni compensative. Se ti viene proposto un risarcimento per
quello che un tribunale ritiene un ingiusto licenziamento, il compenso realmente
sana i danni che hai subito, ad esempio lo stress di trovarti senza lavoro, la perdita
della tua professionalità, la fatica di cercare di rientrare nel mercato del lavoro?
Potrebbe essere che tu non riesca a vedere le cose in questo modo, perché il tempo
che è stato sottratto al tuo benessere non è recuperabile dal passato. Ma la situazione
sarebbe identica se non ti fosse stato riconosciuto un risarcimento? Naturalmente no,
ma questo risarcimento si avvicina realmente a un atto di fratellanza? Io ne dubito.
Ciò che è stato colpito dal tuo ingiusto licenziamento ha recato un danno, magari
grave e profondo, alle tue prospettive esistenziali, ma non rappresenta di solito una
rottura di vincoli di fratellanza.
Allora dove collocare la giustizia? Qui il discorso di Margalit si complica, perché il
tradimento aiuta a ridisegnare ambiti diversi del comportamento cooperativo dotato
di uno spessore etico. Margalit infatti distingue tra etica e morale. Si tratta di una
distinzione che ha già avuto corso nella storia del pensiero e di solito viene spiegata
dicendo che la morale riguarda i comportamenti privati e l’etica ha a che fare invece
con i comportamenti pubblici. È una prima approssimazione, perché è realmente
difficile esemplificare degli atti che non abbiano potenzialmente una dimensione
pubblica. Margalit ridisegna questa distinzione nei termini dell’”idea secondo cui il
tradimento rientra prevalentemente nell’etica, e solo in seconda battuta nella morale.
�400
P IE RPA OLO M A RRONE
La distinzione fra etica e morale si basa sulla distinzione fra rapporti umani forti e
deboli. Tradimento significa tradimento di rapporti forti.” (ST, p. 41). Quali sono
questi rapporti forti? Le esemplificazioni sono numerose. I rapporti che si
intrattengono con i propri familiari, con la cerchia più stretta dei propri amici, con il
proprio paese, con la propria fede politica ne sono degli esempi.
33In alcune situazioni, poiché le relazioni forti possono essere molteplici, questi
insiemi di rapporti forti possono entrare in conflitto tra di loro. Si prenda il film del
1984 Another country, che drammatizza e si ispira alla vicenda di Guy Burgess, uno
dei Cinque di Cambridge, il gruppo di spie doppiogiochiste britanniche che tradì a
favore dell’Unione Sovietica. Nel film ad un certo punto viene chiesto al protagonista,
impersonato da Rupert Everett, oramai rifugiatosi in Unione Sovietica, se quanto ha
fatto sia stato giusto. La risposta è “giusto o sbagliato: che importa?”. Ci sono almeno
due interpretazioni possibili di questa risposta. La prima la vede come la cinica
risposta di un uomo anziano oramai posseduto dal disincanto sul finire della propria
vita. La seconda, secondo me più interessante, è una risposta giustificativa della
propria attività spionistica e di quanto agli altri è sembrato un tradimento, ma non lo
è stato per lui. Il giusto e lo sbagliato devono essere interpretati all’interno di un
sistema di vincoli deboli, ossia dentro a quanto Margalit chiama morale. Questi
vincoli per il protagonista riguardano anche le relazioni con la propria nazione, che
sono meno forti delle relazioni con la classe progressiva, rappresentata per il
protagonista dall’Unione Sovietica. Non si può non pensare che se le parole del
protagonista rispecchiano convinzioni profonde, allora il suo non può essere
considerato un tradimento, dal suo punto di vista e relativamente ai legami forti, che
rientrano per Margalit nell’etica.
Il tradimento deve essere sempre considerato come qualcosa che può essere
qualificato come tale da parte di colui che lo compie? La questione è complessa e ci
sono casi nei quali il tradimento mi pare emergere con dei connotati di oggettività,
per così dire. Un esempio è ricordato dallo stesso Margalit. Si tratta del massacro
compiuto da polacchi su istigazione dei nazisti a Jedwabne un piccolo paese di 2500
abitanti. Metà della popolazione maschile polacca partecipò al rastrellamento e alla
cattura degli ebrei che vivevano nel paese. Riuniti in un fienile, vennero arsi vivi nel
luglio del 1941. La vicenda è narrata in un volume di Jan Gross che ha un titolo
significativo sia in polacco (Sąsiedzi “i vicini di casa”) sia in italiano (I carnefici della
porta accanto). Che cosa è stato tradito in questa orribile vicenda? I polacchi
avrebbero potuto dire che hanno solo che liberato il loro paese dall’infezione
giudaica, mentre introiettavano la propaganda nazista, secondo la quale loro stessi
erano dei subumani. Ma questa spiegazione non ha nessuna forza presso di noi, che
continuiamo a ritenere il crimine dei polacchi orrendo anche per il tradimento dei
propri vicini di casa. Il vincolo che è stato spezzato a Jedwabne è quello della
prossimità spaziale.
�401
Margalit sul tradimento
I vicini di Giobbe lo raggiungono da lontano per condividere la sua sofferenza e
consolarlo nella prossimità. Quando si vuole sottolineare una condivisione emotiva
con un amico o un’amica si dice che li si sente vicini. Il vicino è il prossimo. Per
questo in certe circostanze appare perfettamente sensato il precetto di amare il
prossimo come se stessi. Ma chi è il nostro prossimo? Come è noto la parabola del
buon samaritano offre una risposta. Un uomo è derubato e picchiato e viene soccorso
da un estraneo. Il “il samaritano e l’ebreo derubato e percosso non si conoscevano
ma, una volta incontratisi, la prossimità diretta sancì una rivendicazione morale
diretta. Il samaritano non era un vicino, ma era prossimo, molto prossimo, in virtù di
un mero incontro casuale.” (ST, p. 52) La prossimità può essere tanto beata, come
nella parabola del buon samaritano, quando minacciosa, quando lo sciovinismo si
amplifica e si moltiplica, con la sua enorme forza regressiva, dall’odio per le altre
nazioni al fastidio per chi abita un’altra regione del proprio paese o a chi viene
percepito come diverso nel nostro piccolo borgo. La prossimità può cominciare e
finire a casa. La casa e la patria (homeland) sono “simboli sostitutivi dei nostri
rapporti forti con gli abitanti di casa nostra o della nostra patria, oppure se casa e
patria siano associati all’abitare stesso. Se agiscono da simboli sostitutivi, allora
tradire la propria casa e la propria patria (per esempio disertando) non è altro che un
modo indiretto per tradire la propria famiglia, il proprio popolo.” (ST, p. 53). Manca
all’espressione inglese “homeland”, quel connotato irriducibile, almeno finora, alle
espressioni burocratiche (espressioni come ‘homeland security’, sicurezza interna),
che si trova in altri termini come ‘Heimat’ e ‘patria’, i quali hanno connotazioni
semantiche fortemente emotive legate alla prossimità e alla familiarità. L’heimlich è,
infatti, il familiare e l’unheimlich, quello che Freud analizza come ‘perturbante’ è
quanto familiare non è.
Si tradisce, allora, solo quello che è prossimo e familiare nel vincolo fiduciario? Da
un certo punto di vista è così, a vedere le cose dalla prospettiva di colui o di coloro
che si sentono traditi, ed effettivamente si piò sostenere che chi con le sue azioni
scioglie il vincolo forte della fiducia e della prossimità (che non sono certo la stessa
cosa) tradisce. Tuttavia, a vedere le cose dalla prospettiva di chi non ritiene più
questo vincolo fondante una parte della sua dimensione etica si deve concludere in
maniera diversa. La nostra comprensione intuitiva del tradimento si complica e si
rivela inadeguata quando guardiamo le questioni in maniera più dettagliata e non è
detto che chi si sente tradito provi l’esperienza di una semplice sottrazione di
fiducia33, poiché potrebbe sperimentare piuttosto un mancato riconoscimento che
riteneva invece naturale. Questo accade nel cosiddetto tradimento di classe. Margalit
ne distingue due generi, quello dall’alto e quello dal basso. Nel primo caso, “il
tradimento dall’alto compromette la legittimità della pretesa delle classi alte di
governare. Le classi alte si considerano i regnanti naturali, nati per governare, scevri
dalla natura capricciosa tipica delle masse. Difendono la continuità (il ‘retaggio’), la
stabilità, l’esperienza inveterata: in sostanza difendono la tradizione, l’assodata
�402
P IE RPA OLO M A RRONE
saggezza delle generazioni passate.” (ST, p. 217). Nel tradimento dal basso, per
Margalit si tradisce l’idea stessa di giustizia e l’idea di una società retta da principi
solidaristici di mutuo riconoscimento. Per questo tradire la giustizia significa tradire
la totalità delle relazioni umane. A illustrazione di queste due modalità, Margalit cita
due aneddoti su Zhou Enlai. “Uno narra che il rozzo Nikita Chruščëv, invidioso del
fatto che Zhou fosse un uomo di mondo, cercò di provocarlo dicendo: ‘È interessante,
no? Io sono di origine operaia, mentre tu sei nato in una famiglia di proprietari
terrieri’. Al che Zhou rispose a tono: ‘È vero, ed entrambi abbiamo tradito la nostra
classe’. L’altro aneddoto racconta di quando chiesero a Zhou se la Rivoluzione
francese fosse una buona cosa, e lui rispose con una frase rimasta storica: ‘È troppo
presto per dirlo’”. (ST, p. 218)
Questi due aneddoti non parlano però di giustizia, come crede Margalit, bensì
piuttosto di potere. Ci dicono che la prospettiva della giustizia è uno sguardo lontano
dalla lotta, che questa lotta è fatta di compromessi e errori che possono anche
apparire fatali nel presente, ma che riveleranno la loro natura quando coloro che
commisero quelle azioni che magari ora ci appaiono ingiuste e censurabili non ci
saranno più. È questa una prospettiva assolutoria? In fondo, dire che tutto deve
essere osservato in prospettiva, non equivale a dire che tutto deve essere giustificato
in una prospettiva più ampia? “Tout comprendre c’est tout pardonner.” secondo la
sentenza attribuita a Madame de Staël. Ma dobbiamo attendere così a lungo come
ironicamente indicava Zhou? Di fatto lui non aveva atteso, perché si era dotato della
filosofia della storia marxista-leninista e già sapeva che nella rivoluzione francese e in
quello che ad altri era apparso come il suo tradimento di classe semplicemente si
palesava la razionalità della storia nel primo caso e il suo collocarsi accanto alla
classe progressiva, come Marx chiamava il proletariato, nel secondo. Insomma il suo
tradimento per lui non era affatto tale, come non lo era per i Cinque di Cambridge,
come non lo è per chi chiamiamo apostata, ma che semplicemente si vede come un
credente migliore di noi.
Il tentativo di Margalit di ridisegnare il confine tra etica e morale sulla base di una
fenomenologia rappresentativa di casi esemplari, allora deve ritenersi fallimentare o
incompiuto? La mia opinione è che in gran parte lo sia, ma non lo sia totalmente.
Penso anche che non si tratti di incompiutezza. Anche se aggiungiamo nuovi esempi
non credo affatto che migliorerà la persuasività della proposta di Margalit di pensare
il tradimento come, in generale, qualcosa di oggettivo, che si appalesa nello
scioglimento di vincoli forti, perché chi si allontana da questi vincoli mostra
semplicemente di non ritenerli tali. Questo potrebbe essere il motivo per cui, come
segnala Margalit stesso, si parla molto poco oramai di casi di ‘alto tradimento’. Vi è
però un caso paradigmatico di tradimento, ed è quello sentimentale. Molto spesso in
quel caso l’idea del tradimento è effettivamente condivisa. Chi tradisce pensa
effettivamente che lo sta facendo (e forse parte dell’eccitazione e del piacere di questo
gioco deriva proprio da questo). Sa che sta mettendo a rischio un legame forte che
�403
Margalit sul tradimento
magari non intende sciogliere. Ma condivide qualcosa, a me sembra, con gli altri
esempi della fenomenologia esibita da Margalit ed è quanto sottolineava il
personaggio, oramai anziano, interpretato da Rupert Everett: “Giusto o sbagliato: che
importa?”.
�404
�405
Etica & Politica / Ethics & Politics, XX, 2018, 1, pp. 405-414
ISSN 1825-5167
RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E
CONDIZIONI DEI LAVORATORI
NELL’INGHILTERRA DEL
DICIANNOVESIMO SECOLO:
UN’ANALISI CONTROCORRENTE
RO BE RTA A DE LA I DE MO DU GNO
Università di Roma TRE
Dipartimento di Scienze Politiche
robertaadelaide.modugno@uniroma3.it
ABSTRACT
The opinion by the historians on the Industrial revolution has been controversial. The dramatic
representation of the awful conditions of the English workers during the Nineteenth century
affected public opinion and the way capitalism has been considered by the intellectuals and the
general public as well. During the 50 of the Twentieth century a group of scholars, under the guide
of the leading Austrian economist Frederich von Hayek, challenged this representation. They
refuted the idea that Industrial revolution made the life of the workers worse. The conditions of
the workers were not better before the advent of Industrial revolution, and, in some measure, there
was an improvement of their level of life thanks to capitalism.
s
KEYWORDS
Liberalism, industrial revolution, Austrian economics, Frederich von Hayek
Un tema a lungo dibattuto e tuttora in gran parte irrisolto è quello del
giudizio da parte degli storici sulla Rivoluzione industriale in Inghilterra. Si tratta di
una questione di non scarso rilievo, tenuto conto dell’enorme influenza che ha avuto
sull’opinione pubblica la rappresentazione drammatica da parte degli studiosi delle
condizioni dei lavoratori inglesi. L’immagine è stata quella dell’immenso
sfruttamento degli operai e della irreggimentazione di uomini, donne e bambini
all’interno delle fabbriche, strappati dall’aria salubre delle campagne e ammassati
negli orrendi slums sovraffollati e antigienici delle citta industriali. Si tratta di una
rappresentazione ancora viva nella mentalità comune nel momento in cui si parla
della Rivoluzione industriale. Una tale immagine riflette quello che fu il giudizio già
di molti contemporanei osservatori inglesi. Pensatori come Robert Malthus e John
Stuart Mill ritenevano, senza ombra di dubbio, che la Rivoluzione industriale avesse
decisamente peggiorato le condizioni dei lavoratori e che avesse avuto effetti dannosi
�406
R OBE RTA A DE LA IDE M ODU GNO
per coloro che vi parteciparono. Vi furono anche pareri diversi, ad esempio da parte
di John Wesley, George Chalmers e Edwin Chadwick, che non riuscirono però a
controbilanciare uno degli argomenti che nell’immaginario comune è rimasto
fondamentale nella polemica contro il capitalismo. Nella prima metà dell’Ottocento
vi furono alcuni rapporti delle commissioni parlamentari di inchiesta sulle
condizioni dei lavoratori in Inghilterra che contribuirono alla formazione di un’
opinione negativa sull’avvento del capitalismo. Tale opinione fu poi rafforzata in
seguito all’utilizzo che di questo materiale fecero Marx ed Engels. Le descrizioni date
da Engels della classe lavoratrice inglese e da Marx nel primo libro del Capitale
rimasero alla base della riflessione anche accademica su questo tema. Questi punti di
vista furono adottati da gruppi di studiosi influenti, come quelli della scuola storica
tedesca e successivamente furono ripresi da Sidney e Beatrice Webb. Occorre
precisare che i rapporti delle commissioni di inchiesta parlamentare furono segnati
da una certa tendenziosità politica. Furono infatti soprattutto motivati dagli interessi
dei proprietari terrieri del partito tory contrapposti al nuovo ceto industriale, che si
opponeva alla protezione dell’agricoltura e che i conservatori cercarono di
danneggiare, mettendoli in cattiva luce presso l’opinione pubblica.
Negli anni Cinquanta del Novecento, un gruppo di studiosi affrontò la questione
dell’avvento del capitalismo e delle condizioni della classe lavoratrice con
spregiudicatezza e indipendenza di criteri, cercando di liberarsi dal pregiudizio. Si
tratta di Friedrich A. von Hayek, T. S. Ashton, V. H. Hutt, R. M. Hartwell e Bertrand
de Jouvenel. Scrive Hayek:
Vi è […] un mito supremo che più di ogni altro è servito a screditare il sistema
economico a cui dobbiamo la nostra attuale civiltà […]: è la leggenda che la condizione
delle classi lavoratrici sia peggiorata in conseguenza del sorgere del “capitalismo” (della
“manifattura” o del “sistema industriale”). Chi non ha sentito parlare degli “orrori del
primo capitalismo”, chi non ha avuto l’impressione che l’avvento di questo sistema
abbia arrecato nuove indicibili sofferenze a vaste classi sociali che prima erano
passabilmente soddisfatte e godevano di un discreto benessere? 1
L’economista austriaco rileva come in realtà un attento esame dei fatti ha condotto
alla confutazione di una tesi largamente diffusa. Tuttavia nota che la controversia è
ancora aperta e che l’opinione corrente non è mutata. Tra l’altro si tratta di
un’opinione diffusa non solo tra coloro che appartengono a correnti politiche avverse
al capitalismo ma anche tra coloro che si definiscono liberali. Un esempio
significativo è rappresentato da Guido De Ruggiero, il quale sostiene che “proprio
nel periodo dell’espansione industriale, la condizione dell’operaio peggiora” e che
F. A. HAYEK, Storia e politica, in Il capitalismo e gli storici, a cura di F. A. Hayek, Centro Luigi
Einaudi, Torino, 1967, pp. 23-24; ed. orig. Capitalism and Historians, edited by F. A. Hayek, Routledge
& Kegan Paul, Londra, 1954.
1
�407
Rivoluzione industriale e condizioni dei lavoratori nell’Inghilterra del diciannovesimo
secolo: un’analisi controcorrente
viene a crearsi “una specie di riserva dell’esercito della fame” 2. Sono numerosi gli
esempi di storici che contribuirono alla diffusione di tale opinione. “Come tutti i
grandi esperimenti sociali, – scrive Frederick Watkins – l’invenzione del mercato del
lavoro costò cara. Essa comportò in una prima fase un rapido e forte abbassamento
del livello materiale di vita delle classi lavoratrici” 3. Ed ancora, Bertrand Russell
asserisce:
La rivoluzione industriale causò indicibile miseria sia in Inghilterra che in America.
Penso che nessuno studioso di storia economica possa mettere in dubbio che in
Inghilterra ai primi del XIX secolo la gente sia stata in media meno felice di cent’anni
prima e che ciò sia dovuto quasi interamente alla tecnica scientifica 4.
Anche nell’ambito della narrativa, nota Hayek, è difficile trovare romanzi storici
che rinuncino al tocco drammatico di questo modo di vedere le cose. La versione di
Hayek, tuttavia, è esattamente opposta all’opinione comune. Nota, infatti, che per la
maggior parte della storia dell’umanità il fatto di possedere gli strumenti di lavoro
era imprescindibile per poter sopravvivere e mantenere una famiglia. Erano molto
pochi coloro che potevano mantenersi lavorando per altri senza possedere
l’attrezzatura necessaria. Rimanere privi di terreno e degli utensili che venivano
trasmessi da una generazione all’altra significava molto spesso morire di fame.
Solo quando i maggiori guadagni derivanti dall’impiego di macchinario procurarono
sia i mezzi sia la possibilità di investimenti, balenarono possibilità di sopravvivenza per
un numero sempre maggiore di quanti in passato rappresentavano un ricorrente eccesso
di popolazione condannata a morte prematura. La popolazione, che era rimasta
stazionaria per molti secoli cominciò ad aumentare rapidamente. Il proletariato che si
può dire sia stato una “creazione” del capitalismo non era dunque una parte di
popolazione che sarebbe esistita senza di esso e che il capitalismo aveva degradato ad un
livello inferiore; era invece una popolazione addizionale alla quale veniva data la
possibilità di crescere grazie alle nuove opportunità di impiego fornite dal capitalismo 5.
Una parte sempre più vasta della popolazione che non possedeva gli attrezzi per la
produzione fu in grado di mantenersi offrendo il proprio lavoro in cambio di un
G. DE RUGGIERO, Storia del liberalismo europeo, Laterza, Bari, 1925.
F. WATKINS, The Political Tradition of the West, Harvard University Press, Cambridge, 1948,
p.213.
4 B. RUSSELL, The Impact of Science on Society, Columbia University Press, New York, 1951, pp.
19-20.
2
3
5
F. A. HAYEK, Storia e politica, cit., p. 29.
407
�408
R OBE RTA A DE LA IDE M ODU GNO
salario. Le statistiche dell’epoca documentano un forte aumento della popolazione
proprio con il sorgere della moderna industria. Ad avviso di Hayek fu proprio il
rapido aumento del benessere a rendere più esigente il metro di giudizio e ad
aumentare le aspettative sulla condizione dei lavoratori. I casi di miseria diventarono
al tempo stesso più evidenti e meno tollerabili in un contesto in cui il benessere
aumentava. Per coloro che lasciarono la campagna per trasferirsi nei centri
industrializzati ci fu un miglioramento delle condizioni di vita. È indubbio che il
rapido diffondersi dell’industrializzazione creò problemi sanitari che fu all’inizio
difficile affrontare ma allo stesso tempo le statistiche dimostrano che ci fu un
generale miglioramento della salute pubblica 6. Mrs. Cooke Taylor, moglie del
radicale inglese William Cook Taylor, visitò nel 1843, le zone industriali del
Lancashire e la sua testimonianza è riportata in una sua lettera. La signora,
descrivendo le condizioni dei lavoratori, esprime la sua sorpresa nel trovare una
situazione soddisfacente: “ora che ho visto gli operai al loro lavoro, nelle loro casette
e nelle loro scuole, non riesco proprio a spiegarmi il clamore sulle loro condizioni.
Sono meglio vestiti, meglio nutriti e meglio trattati di molte altre classi di
lavoratori” 7. Ad avviso di Hayek molta responsabilità della diffusione di quello che
lui considera un mito errato è da ascrivere all’interpretazione materialistica della
storia di Marx ed al fatto che molti tra gli studiosi che si accostavano alla storia
economica simpatizzavano per il socialismo. Il postulato da cui partiva la maggior
parte degli studiosi, a partire dai protagonisti della scuola storica tedesca, i cosiddetti
“socialisti della cattedra”, era che il sorgere del capitalismo, con il sistema della
proprietà privata dei mezzi di produzione, doveva avere danneggiato le classi
lavoratrici. Hayek sottolinea come in modo troppo facile si attribuivano i casi di
estrema povertà che si trovavano ai primi del Diciannovesimo secolo alla Rivoluzione
industriale. Si dava per scontato che le condizioni di prima fossero migliori. In realtà,
Hayek avverte, che proprio il capitalismo fu “un sistema che per la prima volta nella
storia ha reso gli uomini consapevoli del fatto che la miseria può essere evitata. E
proprio le rivendicazioni e le aspirazioni delle classi lavoratrici furono e sono il
risultato dell’enorme miglioramento nella loro posizione” 8.
La realtà delle fabbriche e delle città industriali era indubbiamente triste e
squallida al punto che si riteneva che necessariamente dovesse esserci stato un
peggioramento di condizioni rispetto all’età precedente. Dal momento che queste
trasformazioni erano dovute all’introduzione delle macchine, proprio le macchine e i
loro proprietari furono ritenuti responsabili del peggioramento delle condizioni.
Fredrick Engels descrive la condizione della classe lavoratrice nell’Inghilterra del
1844: “la storia del proletariato in Inghilterra ha inizio con l’invenzione del motore a
M. C. BUER, Health, Wealth and Population in the Early Days of the Industrial Revolution,
Routledge & Sons, Londra, 1926.
7 Lettera di Mrs. Cook Taylor, 1834, citato in Il capitalismo e gli storici, cit., p. 33-34.
8 F. A. HAYEK, Storia e politica, cit., p. 37.
6
�409
Rivoluzione industriale e condizioni dei lavoratori nell’Inghilterra del diciannovesimo
secolo: un’analisi controcorrente
vapore e delle macchine per la lavorazione del cotone”. Prima di allora le condizioni
di vita dei lavoratori sono descritte in maniera idilliaca dando per scontata l’idea che
l’agricoltura sia l’attività più naturale e salutare per l’essere umano. Prima della
rivoluzione industriale
i lavoratori conducevano un’esistenza noiosa ma passabilmente sicura, vivendo in
maniera onesta e pacifica, in grande devozione e probità, e la loro condizione materiale
era molto migliore di quella dei loro successori. […] I loro figli crescevano all’aria fresca
della campagna e, se talvolta accadeva che aiutassero i loro genitori nel lavoro, ciò
avveniva solo di quando in quando; mentre per loro una giornata lavorativa di otto o
dodici ore era fuori discussione. […] Le conseguenze del miglioramento delle macchine
sulle nostre attuali condizioni sociali sono per il lavoratore unicamente negative e spesso
assai opprimenti. Ogni nuovo avanzamento porta con sé diminuzione di occupazione,
povertà e sofferenza 9.
Altro grande critico della rivoluzione industriale è Karl Polanyi 10, il quale viene
duramente attaccato da Murray N. Rothbard. Ad avviso di questi “qualunque mondo
prima della rivoluzione industriale, era costantemente tormentato da carestie e
pestilenze” 11. Coloro che non erano in grado di mantenersi andavano ad ingrossare le
fila dei mendicanti e dei ladri. Fu proprio la nascita del capitalismo, avverte
Rothbard, a dare loro occasioni di lavoro e furono l’avanzare del capitale e
l’espansione del mercato a produrre beni a basso prezzo per le masse, ad aumentare
il livello di vita delle masse e a creare lavoro per questo eccesso di popolazione. Ad
avviso di Polanyi la Rivoluzione industriale fu resa possibile dal fenomeno delle
recinzioni che avrebbe spostato i contadini dai campi alle città. Ma tutto ciò per
Rothbard non ha alcun senso:
Il capitalismo non distrusse tragicamente, come vorrebbe Polanyi, le calorose,
amorevoli relazioni sociali dell’era pre-capitalista. Il capitalismo prese i reietti della
società: i mendicanti, i banditi di strada, l’eccesso della popolazione rurale, gli
immigrati irlandesi e dette loro lavoro e salari che li portarono dalla miseria ad un ben
più alto livello di vita e di lavoro. È piuttosto facile torcersi le mani di fronte al lavoro
dei bambini nelle nuove officine britanniche; è facile, in apparenza anche più facile,
dimenticare che cosa faceva la popolazione infantile dell’Inghilterra rurale prima della
rivoluzione industriale e, durante la rivoluzione, in quelle numerose aree
dell’Inghilterra dove la rivoluzione industriale e il nuovo capitalismo non erano ancora
F. ENGELS, La situazione della classe operaia in Inghilterra, 1845, Editori Riuniti, Roma, 1978.
K. POLANYI, La grande trasformazione, Einaudi, Torino, 1944.
11 M. N. ROTHBARD, On Polanyi’s The Great Transformation, in Rothbard versus the
Philosophers. Unpublished Writings on Hayek, Mises, Strauss and Polanyi, edited by Roberta A.
Modugno, Ludwig von Mises Institute, Auburn, 2009, p. 125.
9
10
409
�410
R OBE RTA A DE LA IDE M ODU GNO
arrivati: questi bambini morivano come mosche e vivevano in condizioni infinitamente
più miserabili.[…] Prima che tale lavoro fosse disponibile e in quelle regioni in cui il
lavoro non era disponibile, le donne e i bambini soffrivano e vivevano in condizioni
infinitamente peggiori. Dopo tutto, donne, bambini, immigrati non furono portati nelle
fabbriche con la frusta: vi andarono liberamente e con gioia, e la ragione è quella 12.
Persino le innovazioni nei cibi e nelle bevande suscitavano indignazione. Intorno
alla metà dell’Ottocento vi fu un aumento del consumo di tè. Questo potrebbe fare
pensare ad un miglioramento del tenore di vita ed invece Northcote Parkinson
sostiene che fu l’aumento della povertà che rese il tè necessario alle classi lavoratrici,
dal momento che la birra era diventata troppo cara 13. Allo stesso modo Redcliffe
Salaman ritiene che l’introduzione delle patate nell’alimentazione dei lavoratori fosse
stata dannosa per la salute 14. Già intorno ai primi del Novecento, però, si levavano
pareri opposti all’idea di un peggioramento delle condizioni di vita dei lavoratori. Ad
esempio in Wages and Income in the United Kingdom since 1860 Arthur Lyon
Bowley mostra come i salari reali ebbero la tendenza ad aumentare 15. Certamente per
coloro che non erano forniti di alcuna specializzazione i salari rimasero bassi, ma vi
erano settori crescenti di lavoratori specializzati per i quali i redditi aumentarono e
che potevano acquistare i prodotti dell’industria il cui costo si andava
progressivamente abbassando. Per la maggioranza dei lavoratori vi fu dunque un
aumento dei salari reali. Ma questa constatazione, lamenta Thomas Ashton, non
mise fine alla polemica 16. Ciò che colpiva i contemporanei e che veniva addotto come
prova del peggioramento delle condizioni dei lavoratori, erano il degrado delle
abitazioni e le condizioni insalubri delle città. Ad avviso di Ashton, Engels
attribuendo entrambi all’era industriale ebbe non poca responsabilità nel
determinare l’atteggiamento di milioni di persone nei confronti dell’avvento del
capitalismo. Come osserva Ashton, non si mette in dubbio che la situazione sanitaria
delle zone dove viveva la classe operaia fosse deplorevole, ma al tempo stesso se ci si
documenta sulle condizioni di vita a Londra durante il Diciottesimo secolo non si
può neppure affermare che queste siano peggiorate. Ashton affronta proprio la
questione della responsabilità da parte della Rivoluzione industriale.
Ivi, pp. 127 – 128.
C. N. PARKINSON, Trade in the Eastern Seas, Cambridge University Press, Cambridge, 1937,
p. 94.
14 R. N. SALAMAN, The History and Social Influence of the Potato, 1949, Cambridge University
Press, Cambridge, 1985.
15 A. L. BOWLEY, Wages and Income in the United Kingdom since 1860, Cambridge, Cambridge
University Press, 1937.
16 T. S. ASHTON, La trattazione storiografica del capitalismo, in Il capitalismo e gli storici, cit., p.
51.
12
13
�411
Rivoluzione industriale e condizioni dei lavoratori nell’Inghilterra del diciannovesimo
secolo: un’analisi controcorrente
Nelle aree industriali, i casamenti costruiti da cooperative edilizie e da lavoratori e
piccoli impresari sono frequentemente oggetto di lamentele, in quanto si tratta delle
costruzioni meno solide e maggiormente mancanti di sistemazioni adatte. Gli unici
esempi notevoli di miglioramenti edilizi sono nelle province agricole le abitazioni
costruite da proprietari terrieri ricchi e benevoli per alloggiarvi i lavoranti delle loro
proprietà; e nelle aree industriali quelli costruiti da ricchi industriali per alloggiarvi i
loro operai 17.
Ma a chi o a cosa ascrivere la responsabilità di un tale stato di cose? All’industria?
Al capitalismo? Occorre tenere presente che il prezzo del denaro era un elemento
fondamentale nei costi di costruzione. Per i costruttori si era creato uno stato di cose
per cui era praticamente impossibile ottenere prestiti. “Lasciando aumentare il tasso
di interesse sul debito pubblico al 4,5 o al 5 per cento e non permettendo agli
industriali di offrire di più – nota Ashton - lo Stato era riuscito a scoraggiare l’attività
dei costruttori per più di vent’anni, ed aveva così fatto affluire a sé le risorse umane e
materiali necessarie per la continuazione della guerra contro Napoleone” 18. I costi dei
materiali da costruzione ebbero un enorme aumento dal 1788 al 1821, i mattoni
aumentarono del 60%, le plance di abete del 58%, il legno di quercia da costruzione
era salito del 150%, il prezzo del montaggio dei vetri del 140% 19. In generale non era
colpa dei produttori, infatti il vero problema era che durante la guerra contro
Napoleone le imposte su mattoni, tegole, pietre, ardesia e tappezzeria erano diventate
sempre più gravose. Dazi a livelli proibitivi erano stati imposti sui legnami pregiati
provenienti dal Baltico e i costruttori di case per i lavoratori dovevano così utilizzare
materiali più scadenti. Esisteva pure una tassa sulle finestre che gravava
sull’occupante di una casa. Insomma non si poteva dare la colpa di tutto questo alla
Rivoluzione industriale. Se le città erano malsane, una grossa parte di responsabilità
era dei legislatori che imponendo tasse sulle finestre facevano pagare luce ed aria e,
tassando i materiali da costruzione scoraggiavano la costruzione di scarichi e
fognature. Tra l’altro chi denunciava gli orrori della Rivoluzione industriale avrebbe
dovuto soffermarsi sul fatto che furono proprio i tubi in ferro, che erano uno dei
prodotti di quella rivoluzione a consentire alla gente di vivere in condizioni igieniche
adeguate.
Uno studioso delle condizioni dei lavoratori dell’epoca, il medico Philip Gaskell
non diede alcun sostegno alla tesi che l’avvento delle fabbriche avesse coinciso con la
degradazione economica e morale dei lavoratori. Al contrario egli affermò che questo
aveva comportato un vasto progresso materiale e che i salari degli operai
dell’industria, con la giusta economia e previdenza, consentivano loro di vivere
17
Report on the Sanitary Conditions of the Labouring Population of Great Britain, Londra, 1842, p.
233, cit. in T. S. ASHTON, Op. cit., pp. 55-56.
18 T. S. ASHTON, Op. cit., p. 57.
19 Ivi, pp. 57-58.
411
�412
R OBE RTA A DE LA IDE M ODU GNO
comodamente 20. Anche il lavoro dei bambini nelle fabbriche che oggi ci appare come
aberrante, agli occhi del contemporaneo, nel contesto popolare dell’infanzia di allora,
sembra diverso. Scrive Gaskell:
L’impiego di bambini nelle fabbriche non dovrebbe esser considerato un male, finché
gli attuali costumi morali e familiari della popolazione non saranno completamente
mutati. Finché non sarà loro possibile ricevere un’educazione in casa, e finché saranno
lasciati a condurre vita di selvaggi, essi si trovano per un certo verso in una situazione
migliore quando sono impegnati in un lavoro leggero, e il lavoro che tocca loro di
compiere è generalmente leggero 21.
Insomma ad avviso dello studioso era la vita che i fanciulli conducevano nelle loro
case prima del loro ingresso nelle fabbriche ad essere la causa principale della
degenerazione fisica di allora. E il radicale riformista William Cooke Taylor precisava
che si pensava ai bambini lavoratori come a degli schiavi senza tenere presente il
vantaggio economico che essi rappresentavano per se stessi e per le loro famiglie.
Coloro che visitavano i cotonifici e in generale le fabbriche dell’epoca vedevano i
bambini e pensavano a “quanto più piacevoli sarebbero state le libere capriole delle
piccole membra sulla collina, la vista del verde praticello con il luccichio di ranuncoli
e margherite, il canto degli uccelli e il ronzio delle api […], ma abbiamo visto fanciulli
perire di fame e null’altro che fame nei tuguri di fango o nei fossi lungo la via” 22.
Insomma, ad avviso del riformista, i lavoranti agricoli vivevano nella miseria, rispetto
agli operai delle fabbriche, e i lavori a cui i bambini erano adibiti erano molto più
faticosi del lavoro in fabbrica. Queste osservazioni avvalorano la tesi di Rothbard
secondo il quale donne e bambini andarono a lavorare nelle fabbriche per non
morire di fame.
Ronald M. Hartwell, dal canto suo, prende in esame la questione dell’aumento del
livello di vita dei lavoratori inglesi tra 1800 e 1850, anche dal punto di vista dei
cambiamenti introdotti nel regime alimentare e di accesso al cibo. In generale in
questo periodo la gente fu in grado di “nutrirsi meglio, vestirsi meglio, abitare in case
migliori, diventare una popolazione più sana, più ordinata, più risparmiatrice, più
diligente, più fiduciosa in se stessa, più educata” 23. Michael G. Mulhall, ad esempio,
ha calcolato che fra il 1811 e il 1850 aumentarono i consumi pro-capite di carne,
zucchero, tè, birra e uova 24. Le statistiche delle importazioni sono le più accurate per
P. GASKELL, The Manufacturing Population in England, Baldwin and Cradock, Londra, 1833,
p. 216.
21 Ivi, p. 209.
22 W. COOKE TAYLOR, The Factory System, Jeremiah Row, Londra, 1844, pp. 23 – 24.
23 J. M. LUDLOW, L. JONES, Progress in the Working Class 1832 – 1867, Alexander Strahan,
Londra, 1867, p. 82.
24 M. G. MULHALL, The Dictionary of Statistics, Routledge & Son, . Londra, 1892.
20
�413
Rivoluzione industriale e condizioni dei lavoratori nell’Inghilterra del diciannovesimo
secolo: un’analisi controcorrente
capire il livello dei consumi di quel tempo e mostrano importanti aumenti in una
vasta gamma di generi di consumo. Per esempio per il tè, “a partire all’incirca dal
1815 c’è un aumento secolare, notevolmente acceleratosi nell’ultimo decennio del
periodo” e per lo zucchero “la tendenza è all’aumento” 25. “Intorno al 1840 – scrive
Hartwell – le navi a vapore […] riversano in Inghilterra un flusso quasi giornaliero di
bestiame irlandese, di pollame, di carne e di uova” 26.
“Dopo l’habeas corpus e la libertà di stampa – scrisse Charles Dickens – poche
sono le cose per cui il popolo inglese ha rispetto maggiore e fede più vigorosa che la
carne di bue” 27. Nei primi cinquant’anni del Diciannovesimo secolo, la classe
lavoratrice inglese arrivò a considerare la carne come facente parte regolarmente
dell’alimentazione. Il pane di farina di grano e la carne erano per i lavoratori i segni
di un miglioramento del tenore di vita e della superiorità sugli stranieri. Altro
alimento importante il cui consumo stava aumentando in quel tempo era il pesce.
Prima del 1815 il costo del pesce era molto elevato, e questo alimento compariva solo
sulle tavole dei ricchi. Dopo il 1815 l’aumento dell’offerta e il calo dei prezzi fecero si
che i poveri divenissero dei grandi compratori di pesce. “Quando gli sgombri e le
aringhe costavano poco, i poveri ne mangiavano in grandi quantità, ed in qualunque
momento la notizia dell’arrivo di partite di pesci a buon mercato si spandeva per
Londra con meravigliosa celerità” 28. Affermare che il livello di vita della maggior
parte dei lavoratori era aumentato non equivale, ovviamente, a dire che fosse
particolarmente elevato o che stesse aumentando rapidamente, che non esistessero
sacche di povertà e disoccupazione. Ignorare i problemi di quel periodo sarebbe
altrettanto sbagliato che non riconoscere la ricchezza e le nuove possibilità create
dall’industrializzazione.
[…] molti malintesi hanno avuto origine da supposizioni – in gran parte sbagliate sulle condizioni dell’Inghilterra prima della Rivoluzione industriale; che, per esempio,
la vita dei campi fosse naturalmente migliore di quella delle città, che il lavoro in
proprio fosse migliore e più sicuro di quello alle dipendenze altrui, che il lavoro infantile
e femminile fosse una novità, che il sistema di produzione domestica fosse preferibile al
sistema della fabbrica, […] che gli slums e i cibi adulterati fossero conseguenze tipiche
dell’industrializzazione. E così di seguito. In altri termini, il mito perenne dell’età
dell’oro, la convinzione che, dal momento che le condizioni erano cattive, […] esse non
avrebbero potuto essere peggiori, e anzi dovevano un tempo essere state migliori! 29
A. D. GAYER, W. W. ROSTOW, A. J. SCHWARTZ, The Growth and Fluctuation of the British
Economy 1790-1850, Clarendon Press, Oxford, 1953, vol. II, pp. 957-965.
26 R. M. HARTWELL, L’aumento del livello di vita in Inghilterra, in Il capitalismo e gli storici, cit.,
p. 217.
27 Cit. in R. M. HARTWELL, Op. cit., p. 223.
28 R. M. HARTWELL, Op. cit., 227.
29 Ivi, pp. 233-234.
25
413
�414
R OBE RTA A DE LA IDE M ODU GNO
Come osservò Alfred Marshall, “la storia popolare sottovaluta le sofferenze del
popolo prima dell’età delle fabbriche” 30. La vita rurale era molto dura e durante
l’epoca pre-industriale le condizioni delle abitazioni nelle tenute dei nobiluomini di
campagna violavano qualsiasi norma di decenza, erano sporche e disgustose, con
dodici persone, in casi estremi, ammassate in una sola stanza, e “depravazioni che
difficilmente le città avrebbero potuto eguagliare” 31. E’, inoltre, noto che il sistema di
produzione domestico si basasse anche sul lavoro di donne e bambini. La stessa cosa
può dirsi per la condotta morale. L’immoralità negli slums non era certo peggiore
che in passato o rispetto all’alta società. Ma se la miseria, nelle sue varie forme, non
era un fatto nuovo, nuove erano le possibilità che si erano aperte per i lavoratori.
L’economia e la società si trovavano in una fase di rapidi mutamenti e le possibilità
di arricchimento e mobilità sociale erano maggiori di quanto non lo fossero mai state
in precedenza. “La classe dei lavoratori dell’industria inglese era nel complesso
meglio alloggiata, meglio nutrita, più istruita e assai meno degradata che negli anni
precedenti” 32.
A. MARSHALL, Industry and Trade, MacMillan and Co., Londra, 1920, p. 73.
R. M. HARTWELL, Op. cit., p. 234.
32 F. C. MATHER, Public Order in the Age of the Chartists, Manchester University Press,
Manchester, 1959, p. 13.
30
31
�415
Etica & Politica / Ethics & Politics, XX, 2018, 1, pp. 415-451
ISSN 1825-5167
ALTHUSSER DI FRONTE A HOBBES.
LA CRITICA DELL’UMANISMO INDIVIDUALISTA
RI CCA RDO FA NCI U LLA CCI
Dipartimento di filosofia e beni culturali
Università Ca’ Foscari di Venezia
riccardofanciullacci@libero.it
ABSTRACT
Althusser worked out two distinct and subsequent interpretation of the political philosophy
of Hobbes. In this paper I focus on the older one. According to this interpretation, the
philosophy of Hobbes is framed within individualistic humanism. Individualist humanism
is one of the conceptual frameworks Marx broke away from when he founded the science of
socio-historical reality, that is, historical materialism. This science has made possible to
recognize individualistic humanism not just as a false theory, but as a socially active
ideology. I thus offer a wide reconstruction of the place of this interpretation in Althusser’s
philosophy.
KEYWORDS
Althusser, Hobbes, humanism, individualism, social theory, marxism, human nature,
ideology.
I. INTRODUZIONE
1. Althusser non ha dedicato a Hobbes degli scritti specifici, come ad
esempio ha fatto, tra i classici della filosofia politica moderna, con
Montesquieu e Rousseau 1. Non gli ha neppure attribuito una posizione
A Montesquieu, Althusser ha dedicato, nel 1959, il suo primo libro, che è anche l’unico che
ha la forma di una vera e propria monografia: L. Althusser, Montesquieu, la politica e la storia,
introduzione e cura di A. Burgio, Manifestolibri, Roma 1995. Il più celebre scritto althusseriano
su Rousseau è il lungo articolo del 1967: Sur le “Contrat social”, che si può trovare in:
Althusser, Solitude de Machiavel et autres textes, Presses Universitaires de France, Paris 1998,
pp. 59-102. È tradotto in italiano da V. Morfino nel volume: L. Althusser, L’impensato di J.-J.
Rousseau , Mimesis, Milano 2003. A questo testo, va aggiunto perlomeno: L. Althusser, Cours
sur Rousseau , Les Temps des Cerises, Paris 2012, che raccoglie le trascrizioni di un corso
tenuto da Althusser all’École Normale Supérieure nel 1972.
1
�416
RICCARDO FANCIULLACCI
privilegiata nel suo proprio lavoro teorico, come ha invece fatto con Spinoza,
indicato fin da Pour Marx come il pensatore attraverso cui o, meglio ancora,
con cui leggere Marx per smarcare le sue formule dalle ipoteche hegeliane 2.
Infine, neanche dall’archivio Althusser sono emersi dei manoscritti capaci di
testimoniare un corpo a corpo con Hobbes paragonabile a quello realizzato
con Machiavelli 3. Per queste ragioni, non esiste una letteratura critica su tale
rapporto, né tantomeno le osservazioni di Althusser su Hobbes sono recepite e
discusse nell’ambito degli studi sul filosofo inglese. Eppure, se si raccolgono
tutti i riferimenti althusseriani all’autore del Leviatano, si può notare come si
dispongano in un modo che invita all’approfondimento.
Il fatto è che i diversi luoghi in cui Althusser si sofferma su Hobbes si
collocano nell’una o nell’altra di perlomeno due direzioni interpretative che
non sembrano affatto convergenti. La prima è quella che situa il filosofo
inglese tra i padri di quell’ideologia individualista che permea il senso comune
moderno e che, secondo Althusser, arriva a lasciare tracce di sé, dietro le
formule umanistiche, anche negli scritti giovanili di Marx e dunque nelle varie
riappropriazioni del marxismo che mettono al centro tali scritti (da R.
Garaudy, risalendo fino a G. Lukács) 4. La seconda è quella che sviluppa
l’apprezzamento, già hegeliano, del lucido realismo con cui Hobbes avrebbe
riconosciuto quanto la conflittualità sia radicata nella convivenza umana.
Questa seconda prospettiva ermeneutica si dispiega come una valorizzazione
degli elementi genuinamente materialistici del pensiero di Hobbes –
Cfr. L. Althusser, Per Marx, trad. it. di F. Madonia, Editori Riuniti, Roma 1972, p. 60; Id.,
L’oggetto del “Capitale”, in: L. Althusser, E. Balibar, R. Establet, P. Macherey, J. Rancière,
Leggere Il Capitale, trad. it. M. Turchetto et al., Mimesis, Milano 2006, pp. 189, 257; Id.,
Eléments d’autocritique, in: Id., Solitude de Machiavel et autres textes, pp. 181-189.
2
Praticamente tutti i documenti althusseriani su Machiavelli sono stati pubblicati dopo la
morte del filosofo francese o comunque negli ultimi anni della sua vita. Tuttavia, il confronto
col pensatore italiano comincia già all’inizio degli anni Sessanta. Lo scritto più importante è
naturalmente: Machiavelli e noi, trad. it. di M.T. Ricci, Manifestolibri, Roma 1999; ad esso
vanno perlomeno aggiunti gli appunti del corso dedicato all’autore de Il principe, nel 1962 e la
trascrizione della conferenza del 1977, Solitude de Machiavel, che si trovano, rispettivamente
in: Politique et Histoire, de Machiavel à Marx. Cours à l’École Normale Sepérieure 1955-1972,
(Texte établi, annoté et présenté par F. Matheron), Seuil, Paris 2006, pp. 207-254 e in : Solitude
de Machiavel et autres textes, pp. 311-324.
Cfr. R. Garaudy, Humanisme marxiste, Éditions Sociales, Paris 1957; Id., Pour un modèle
français du socialisme, Gallimard, Paris 1968; Id., Perspectives de l’homme: existentialisme,
pensée catholique, structuralisme, marxisme (1959), Presses Universitaires de France, Paris
1969; G. Lukács, Storia e coscienza di classe (1923), trad. it. di G. Piana, Mondadori, Milano
1973. Sebbene non discussa da Althusser, perché successiva, tra le letture umanistiche di Marx
va senz’altro collocata anche quella sviluppata da M. Henry, Marx (1976), Gallimard, Paris
1991.
3
4
�417
Althusser di fronte a Hobbes. La critica dell’umanismo individualista
“genuinamente materialistici” nel senso marxiano e althusseriano, non nel
senso per cui l’ontologia di Hobbes è una metafisica della materia.
Hobbes si trova così, per certi aspetti, ad essere uno dei fondatori di quella
rappresentazione umanistica del soggetto da cui Il capitale non si sarebbe
lasciato irretire, ma, per certi altri spetti, sarebbe uno dei pensatori che,
proprio come Marx, sono capaci di pensare gli effetti di un sistema di rapporti
che né è espressione fenomenica di un principio semplice più profondo, né ha
un origine che definirebbe anche il suo fine e dunque la condizione in cui
troverebbe la sua fine. Quale rapporto esiste tra questi differenti aspetti? E
Althusser si è limitato ad isolarli e a valorizzare prima gli uni e poi gli altri, o
ha reso pensabile anche la loro relazione? Per affrontare queste domande, è
necessario innanzitutto delucidare meglio le due letture appena richiamate. Il
presente scritto si dedica alla prima, ne seguirà un altro dedicato alla seconda
e al rapporto tra le due.
II. HOBBES NELL’ALVEO DELL’UMANISMO INDIVIDUALISTA
2. I due più importanti riferimenti althusseriani a Hobbes che si collocano
all’interno della prima prospettiva ermeneutica fanno parte di Pour Marx. Si
tratta davvero di due rinvii molto scarni, eppure sono collegati a una delle
problematiche centrali di quel libro.
In generale, nei saggi che compongono questo suo celebre volume,
Althusser si impegna a elaborare degli strumenti concettuali capaci di far
risaltare e rendere pienamente intellegibile la rivoluzione teorica compiuta da
Marx e che sarebbe alla base della corrente più viva del marxismo. Tale
rivoluzione consiste innanzitutto nella fondazione di una nuova scienza, la
scienza delle trasformazioni della realtà storico-sociale, a cui Althusser riserva
il nome di “materialismo storico”, ma poi anche nell’invenzione di una nuova
forma di filosofia, che in quegli anni Althusser chiama “materialismo
dialettico”. Soprattutto il chiarimento dello statuto e dei concetti fondamentali
della nuova scienza intende anche avere, per Althusser, il non secondario
effetto di delucidare il posto e la forma che tale scienza attribuisce alla lotta
politica nel processo storico.
Se questa è la posta in gioco generale di Pour Marx, più in particolare si
trattava di offrire una ricostruzione dell’assetto teorico del materialismo
storico che ne mostrasse la distanza da due influenti letture devianti: da un
lato, l’economicismo della II internazionale, per la demarcazione dal quale era
necessario secondo Althusser sviluppare (riprendendo, ma anche correggendo
il lavoro di Gramsci) una più articolata teoria della sovrastruttura e
�418
RICCARDO FANCIULLACCI
dell’ideologia 5; dall’altro lato, l’umanismo, che prendeva sempre più piede in
quegli anni (in primis, nella critica allo stalinismo) e che, agli occhi di
Althusser, illanguidiva e smorzava sia la teoria, sia la politica marxiste
introducendo concetti e problematiche a loro estranee 6.
Mentre è Pour Marx che offre i contributi althusseriani più importanti al
conflitto con l’umanismo 7, la struttura di tale conflitto e lo statuto di quei
contributi diventano pienamente intellegibili applicando i concetti che
Althusser introduce in opere successive, in particolare in Lénine et la
philosophie 8. Ebbene, quei contributi sono interventi in cui si esemplifica una
pratica materialista della filosofia. Attraverso l’introduzione di opportune
distinzioni concettuali, essi tentano di bloccare lo sfruttamento ideologico di
una scienza – dove la scienza in questione è ovviamente il materialismo
storico, mentre lo sfruttamento ideologico è quello realizzato dal discorso
umanista che, insinuando le sue rappresentazioni tra i concetti teorici del
materialismo storico, impone a quest’ultimo problematiche che non gli sono
proprie e che lo ingolfano.
Il tentativo di demarcare il confine tra umanismo e marxismo si riassume
nella celebre tesi secondo cui l’opera matura di Marx sarebbe caratterizzata da
un «antiumanismo teorico» 9. L’idea è che dopo la fase feuerbachiana, dunque a
partire dal 1845 e in maniera compiuta ne Il capitale, Marx avrebbe rigettato
le rappresentazioni e il «sistema organico di postulati» che appartengono e
definiscono l’umanismo e avrebbe fatto di tale rigetto «la condizione della
possibilità assoluta (negativa) della conoscenza (positiva) del mondo umano e
della sua trasformazione pratica» 10. Più precisamente, questo rigetto si realizza
per Althusser nel modo seguente: innanzitutto, le nozioni umanistiche non
sono ammesse tra i concetti tecnici del materialismo storico (che ragiona in
termini di modo di produzione, forze produttive, rapporti di produzione, classi
sociali, complesso strutturato a dominante, surdeterminazione tra
contraddizioni primarie e contraddizioni secondarie ecc. e non in termini di
soggetti umani, coscienze, bisogni, preferenze o interessi individuali ecc.); in
secondo luogo, quelle nozioni bandite dal luogo degli strumenti teorici della
Cfr. per esempio Althusser, Per Marx, pp. 86, 94.
Cfr. Althusser, Per Marx, p. 3-22.
Cfr. ad esempio, Althusser, Per Marx, pp. 195-222. A questo testo va aggiunto perlomeno
lo scritto postumo La querelle de l’humanisme, composto nel 1967 e pubblicato in: L.
Althusser, Écrits philosophiques et politiques, Tome II, Stok/Imec, Paris 1997, pp. 433-532.
L. Althusser, Lénine et la philosophie. Suivi de Marx et Lènine devant Hegel, F. Maspero,
Paris 1972.
Althusser, Per Marx, p 205.
Althusser, Per Marx, pp. 204 e 205.
5
6
7
8
9
10
�419
Althusser di fronte a Hobbes. La critica dell’umanismo individualista
nuova scienza sono situate dal materialismo storico nel suo proprio oggetto,
cioè nella formazione sociale e, più esattamente, nel posto specifico preparato
dal concetto tecnico di ideologia. Detto altrimenti, il materialismo storico non
si limita a disconoscere la pretesa di quelle nozioni di valere come concetti
teorico-scientifici, ma le studia come produzioni ideologiche, ricorrendo a
quella parte di sé che è la teoria materialista della realtà ideologica 11. In uno
scritto del 1975 in cui riprende i fili del suo percorso, scrive Althusser:
L’antiumanismo teorico di Marx, nel materialismo storico, è dunque il rifiuto
di fondare la spiegazione delle formazioni sociali e della loro storia su un
concetto di uomo con pretese teoriche, cioè su un concetto di uomo come
soggetto originario dei suoi bisogni (homo oeconomicus), dei suoi pensieri
(homo rationalis), dei suoi atti e delle sue lotte (homo moralis, juridicus,
politicus) .
12
Nel «rifiuto del mito dell’homo oeconomicus, ossia dell’individuo in quanto
soggetto dell’economia classica, con facoltà e bisogni ben definiti», nel «rifiuto
dell’atomismo sociale e dell’idealismo politico-etico», nonché nel «rifiuto
dell’idea morale kantiana», si realizza gran parte del rigetto marxiano della
concettualità umanistica. Questo «sistema coerente di concetti» ha per
Althusser una «struttura-tipo [nella quale] è riconoscibile» anche «il principio
fondamentale delle teorie della società» elaborate «da Hobbes a Rousseau» 13.
Chiariamo in che cosa consista questa struttura-tipo, prima di esaminare il
procedimento teorico attraverso cui Marx se ne emancipa.
III. LA STRUTTURA DELLA PROBLEMATICA UMANISTICA
3. Come è chiaro, Althusser sta qui riconducendo (non senza una certa
forzatura ermeneutica) le nozioni che autori come Roger Garaudy volevano
usare per riformulare il discorso marxista, nonché, prima ancora, le nozioni
che operano nelle analisi condotte dallo stesso Marx nei Manoscritti
economico-filosofici del 1844, all’elaborazione individualistica delle
problematiche dell’uomo, della conoscenza, del diritto, della morale, della
politica e della storia, che caratterizza gran parte della ricerca filosofica nella
prima modernità (dal XVI al XVIII secolo) 14. Da Hobbes a Ricardo, passando
Cfr. Althusser, Per Marx, pp. 202-203.
L. Althusser, È facile essere marxista in filosofia? Discussione di Amiens, in: Id., Freud e
Lacan, trad. it. di C. Mancina, Editori Riuniti, Roma 1981, p. 169.
Althusser, Per Marx, pp. 203-204.
R. Garaudy non accetta di veder ricondotto l’umanismo che egli ritrova in Marx (nelle
opere giovanili, ma anche in quelle della maturità) all’individualismo astorico moderno e
11
12
13
14
�420
RICCARDO FANCIULLACCI
per Locke, Rousseau, A. Smith e persino per Kant, con propaggini che
arrivano a Feuerbach, si sarebbe costituito un paradigma di pensiero,
evidentemente capace di ospitare differenze interne anche notevoli 15, che
costituisce l’alveo delle opere giovanili di Marx, ma anche dei vari umanismi
novecenteschi, compreso quello marxista, ma anche, per fare un secondo
esempio, quello esistenzialista 16. In generale, questo paradigma ha al suo centro
l’individualismo atomistico, mentre, in quanto applicato alla problematica
socio-politica, dà luogo alla problematica contrattualista 17.
Più precisamente, ciò che per Althusser accomuna le varie teorie del
soggetto che il materialismo storico rifiuterebbe, cioè la teoria del soggetto
giuridico, economico, morale ecc., è la messa in opera del riferimento
all’originarietà: che siano i suoi bisogni, le sue preferenze, i suoi diritti, i criteri
della sua riflessione, le sue prestazioni cognitive o la sua coscienza morale, il
punto qui è che ciascun soggetto umano è supposto possederli originariamente
(e, nel caso di prestazioni o operazioni mentali, di saperle realizzare
spontaneamente e grazie a un’abilità connaturata). Queste attribuzioni sono
qui considerate parte dell’essenza umana: sono considerate cose che
appartengono immediatamente e invariabilmente a ciascun essere umano in
quanto sono parte della sua natura, quella che condivide da sempre e per
sempre con tutti gli altri uomini.
La pretesa di definire l’essenza invariante dell’uomo si sviluppa poi nella
pretesa che la molteplicità degli individui che esemplificano tale essenza siano
gli elementi primi sulla base di cui render conto dell’ambito volta a volta in
questione, dove questo ambito può essere l’istituzione della pratica scientifica,
che si risolverà nelle prestazioni cognitive di soggetti considerabili
isolatamente, oppure la condotta morale, in rapporto alla quale la questione
decisiva riguarderà ciò che accade nel foro della coscienza, oppure ancora la
determinazione dello Stato legittimo che, in generale, sarà quello che protegge
accusa Althusser di non vedere le differenze a causa del punto di vista troppo astratto che ha
adottato: cfr. Perspectives de l’homme: existentialisme, pensée catholique, structuralisme,
marxisme, pp. 346-366. Forse la riduzione althusseriana può essere riscattata, ma di certo
occorre un giro più lungo: in effetti, come sottolinea Garaudy, un conto è dare una definizione
statica dell’essenza umana, un altro è affermare che tale essenza è data dal lavoro sociale, volta
a volta determinato dalle condizioni storiche in cui si dispiega. Seppur brevemente, tornerò tra
poco su tale questione.
Cfr. L. Althusser, Initiation à la philosophie pour les non-philosophes, Presses
Universitaires de France, Paris 2014, p. 218.
Cfr. J.-P. Sartre, L’esistenzialismo è un umanismo, trad. it. di G. Mursia Re, Mursia,
Milano 1978.
Sulla problematica contrattualista, cfr. G. Duso (a cura di), Il contratto sociale nella
filosofia politica moderna , Il Mulino, Bologna 1987.
15
16
17
�421
Althusser di fronte a Hobbes. La critica dell’umanismo individualista
la libertà che appartiene originariamente a ciascuno, facendo sì che ogni
individuo resti nel suo diritto in modo che nessuno abbia da patire soprusi
perpetrati da altri. (Dato il tema del presente scritto, conviene ricordare fin
d’ora che quanto appena detto in generale non vale sic et simpliciter per
Hobbes: lì lo Stato non si limita a proteggere l’originario diritto individuale,
ma prima di tutto lo limita. Il punto di partenza non è dunque dato
semplicemente da quel che è essenziale a tutti gli individui singolarmente
presi, è dato invece dal fatto del loro incontrarsi o potersi incontrare. È proprio
intorno alla valorizzazione di questa differenza che ruoterà la seconda
direttrice interpretativa che appartiene al rapporto di Althusser con il filosofo
inglese).
Al di qua dei dettagli su cui naturalmente le varie teorie individualiste si
differenziano, il punto su cui convergono è dato dal considerare ogni individuo
umano nelle proprietà e negli attributi che gli sarebbero originariamente
propri, cioè che gli sarebbero propri in quanto parte della sua essenza. Più
precisamente, il problema non sta nell’immaginare che un uomo possa
realmente vivere in solitudine, su un’isola ecc. Il cuore del problema si situa
più a monte, nella stessa pretesa che l’essenziale possa essere afferrato o,
comunque sia afferrato, che possa essere esemplificato da un uomo
isolatamente considerato. È già a questo livello che opera l’astrazione isolante
che si tratta di mettere in questione. Non basta criticare l’idea che l’esistenza
umana possa essere un’esistenza isolata, occorre prima ancora criticare
quell’idea di essenza che porta a guardare agli individui che la esemplificano
come a una classe logica di elementi discreti. Questa è la decisiva indicazione
teorica che Althusser ricava dalla VI delle Tesi su Feuerbach, tesi che conviene
rileggere:
Feuerbach risolve l’essenza religiosa nell’essenza umana. Ma l’essenza umana
non è qualcosa di astratto che sia immanente all’individuo singolo. Nella sua
realtà [Wirklichkeit] essa è l’insieme dei rapporti sociali [das Ensemble der
gesellschaftlichen Verhältnisse]. Feuerbach, che non penetra nella critica di
questa essenza reale [wirklichen Wesen], è perciò costretto: (1) ad astrarre dal
corso della storia, a fissare il sentimento religioso per sé e a presupporre un
individuo umano astratto – isolato. (2) L’essenza può dunque [da lui] esser
concepita soltanto come “genere” [“Gattung”], cioè come un’universalità interna,
muta, che leghi molti individui naturalmente.
18
Secondo Althusser, l’impostazione teorica fondamentale che qui Marx
ritrova nel discorso di Feuerbach caratterizza l’umanismo individualista in
K. Marx, Tesi su Feuerbach, in: F. Engels, Ludwig Feuerbach, trad. it. di P. Togliatti,
Editori Riuniti, Roma 1950, p. 84.
18
�422
RICCARDO FANCIULLACCI
generale ed è definita dalla messa in opera, in rapporto all’uomo, di una certa
idea di che cosa sia l’essenza di qualcosa e dunque anche da una certa idea del
rapporto tra l’essenza e ciò che la esemplifica. Secondo questa idea, l’essenza è
«qualcosa di astratto» e dunque è «concepita soltanto come “genere”». Se,
attraverso questa idea, si esaminano ad esempio gli uomini, ci si trova a
ragionare nel modo per cui, come esplicita Althusser sulla scorta di Marx,
l’essenza sarebbe un attributo degli individui «presi isolatamente [pris
isolément]» 19. Detto ancora altrimenti, la condizione umana è qui intesa come
una qualità che esiste realizzata in ciascun individuo a prescindere dalle
concrete relazioni che questi può avere o non avere con gli altri e con ciò che lo
circonda. È formalmente sufficiente che esista un solo individuo perché la
condizione umana sia realmente e pienamente esemplificata. All’interno di
questo modo di considerare la realtà umana, il contesto in cui un essere
umano esiste non conta perché l’essenza è appunto ciò che apparterrebbe (o
sarebbe appartenuto) a quell’essere anche se esistesse (o fosse esistito) in
tutt’altro contesto. Il quadro teorico all’interno di cui si muove questo
approccio è uno in cui, da un lato, ci sono gli individui umani come
esemplificazioni numericamente differenti di una medesima essenza
universale, e dunque come «dati assoluti» («il che implica» aggiunge Althusser,
«un empirismo del soggetto») e, dall’altro lato, c’è appunto questa essenza
universale, che si presenta in ciascuno di quelli e che si tratta di definire («il
che implica un idealismo dell’essenza») 20.
Quando Marx scrive che «nella sua realtà, essa [cioè «l’essenza umana»] è
l’insieme dei rapporti sociali» non sta semplicemente correggendo la
determinazione feuerbachiana dell’essenza umana, non sta cioè mettendo un
altro contenuto nello stesso spazio in cui altri hanno messo altre definizioni di
Althusser stesso caratterizza così il modo in cui questo approccio attribuisce a ciascun
uomo l’essenza umana: Althusser, Per Marx, p. 203 (traduzione modificata).
Althusser, Per Marx, p. 203. Le due aggiunte althusseriane citate, quella relativa
all’empirismo del soggetto e quella sull’idealismo dell’essenza non sono poi così chiare. La mia
proposta interpretativa è la seguente. L’approccio che ritiene che ogni individuo umano
esemplifichi da sé (cioè a prescindere da ciò che gli capita e dalle relazioni che attraversa)
l’essenza umana contrae anche degli impegni sul piano epistemologico: lascia infatti non
interrogate le condizioni grazie a cui è possibile riconoscere e sottoporre ad esame gli esseri
umani, pensa cioè questi ultimi come dati esperienziali immediati su cui non ha che da
esercitarsi quella sorta di processo spontaneo che sarebbe l’astrazione della loro essenza.
Questo sarebbe l’empirismo – su cui Althusser si sofferma anche nel primo dei suoi contributi a
Lire le Capital: cfr. L. Althusser, Dal Capitale alla filosofia di Marx, in Althusser, Balibar,
Establet, Macherey, Rancière, Leggere Il Capitale, pp. 34-39. Quanto poi all’idealismo
dell’essenza, credo che con questa formula Althusser intendesse riferirsi a tutte le posizioni per
cui l’essenza di qualcosa è una struttura invariante e dunque non toccata dalla vicenda storica,
ma non sono in grado di escludere che volesse suggerire anche qualche altra cosa.
19
20
�423
Althusser di fronte a Hobbes. La critica dell’umanismo individualista
che cosa sia l’essere umano, di che cosa sia il genere umano. Marx sta qui
innanzitutto smarcandosi dalla problematica che governa il conflitto tra quelle
diverse definizioni. In maniera del tutto preliminare, potremmo dire che, nella
VI tesi, si oppongono due intendimenti della categoria di essenza, cioè due
idee di che cosa sia in generale l’essenza di qualcosa: da un lato, l’idea per cui
l’essenza è il genere, qualcosa di astratto, un’universalità che lega molti
individui essendo ciò che è esemplificato in ciascuno, dall’altro lato, quella che
Marx chiama l’«essenza reale» e di cui dice che, nel caso degli uomini, è data
da «l’insieme dei rapporti sociali».
Ovviamente, è anche possibile tentare di leggere la VI tesi su Feuerbach
come se Marx volesse solo affermare che all’essenza umana appartiene la
relazione pratica tra gli uomini. In un simile caso, Marx starebbe tenendo
ferma la stessa nozione formale di essenza usata da Feuerbach (e
dall’umanismo), ma la riempirebbe con un contenuto diverso: la socialità
invece che qualche proprietà esemplificabile da parte di un individuo isolato.
Così compresa, la tesi potrebbe essere parafrasata nel modo seguente: “un
individuo esemplifica l’umanità (l’essere un uomo), non solo nella misura in
cui ha alcune proprietà intrinseche, ma anche e soprattutto in quanto è
coinvolto in rapporti di alcuni tipi con altri individui umani”. Marx starebbe
insomma dicendo che si dà soggetto umano se e solo se si dà una pluralità di
soggetti umani in interazione tra loro, cioè se e soltanto se si dà
un’intersoggettività. Secondo Althusser tale lettura è troppo superficiale: la
rivoluzione teorica riassunta nella frase “l’essenza reale dell’uomo è l’insieme
dei rapporti sociali” forse implica la tesi appena formulata, ma va certamente
molto al di là. Per Althusser, quando Marx contrappone alla nozione astratta
di uomo l’insieme dei rapporti sociali intende significare che «per incontrare e
trovare la realtà cui si allude quando si cerca non più l’uomo astratto, ma
l’uomo reale, bisogna passare alla società e mettersi ad analizzare l’insieme dei
rapporti sociali» 21.
È compiendo questo passaggio che Marx ha poi potuto operare, tra le altre
cose, anche la sua speciale critica del discorso umanistico come un’ideologia.
Ma prima di esaminare tale critica, soffermiamoci ancora un poco su quel suo
presupposto che qui Althusser evidenzia, cioè l’abbandono marxiano della
problematica umanistica relativa all’essenza.
21
Althusser, Per Marx, p. 218.
�424
RICCARDO FANCIULLACCI
IV. L’ESSENZA NON CATTURA (TUTTO) L’ESSENZIALE
4. Per Althusser, la formula marxiana secondo cui l’essenza umana reale è
data dall’insieme dei rapporti sociali ha solo la parvenza di una definizione, di
una definizione che correggerebbe le precedenti, ma accetterebbe la
problematica entro cui quelle si inscrivevano e confliggevano. In realtà,
secondo lui, tale formula va piuttosto letta come un invito ad abbandonare
quell’intera problematica e a sostituirla con un’altra. Solo all’interno di
quest’altra problematica sarebbe possibile comprendere la realtà umana, cioè,
più precisamente, sarebbe possibile «conoscere qual è la realtà […] che è
indirettamente in causa nei» concetti umanistici, sebbene non sia
adeguatamente pensata attraverso di loro 22. Quest’altro modo di impostare e
articolare la domanda di sapere relativa alla condizione umana, l’unico che
riesce davvero a dare soddisfazione a tale domanda producendo una
conoscenza effettiva di quella condizione, ecco, quest’altro modo sarebbe
quello che orienta le indagini del materialismo storico. Al posto della
problematica relativa alle caratteristiche invarianti del genere umano, Marx
avrebbe costituito una problematica grazie a cui la nuova scienza si rivolge
all’insieme (das Ensemble) o alla somma (die Summe) dei rapporti umani,
somma che costituisce una società 23, e li esamina ricostruendo il modo in cui si
ordinano, dalla configurazione della base produttiva fino all’intera
sovrastruttura che la surdetermina.
Nell’offrire tale lettura della rivoluzione teorica compiuta da Marx rispetto
alla problematica umanistica, Althusser, quantomeno in Pour Marx, non
sembra valorizzare la locuzione “essenza reale”: non si chiede se essa esprima
un nuovo concetto di essenza, né tantomeno cerca di ricostruire e delucidare
questo concetto. Non credo, tuttavia, che voglia suggerire che l’uso marxiano
della semantica dell’essenza abbia solo una valenza retorica e sia un altro
esempio di quel civettare con il lessico della tradizione filosofica, che Marx
amava praticare, ma che per Althusser rischia soprattutto di occultare ai nostri
occhi la distanza che lo stesso Marx poneva tra la sua scienza e quella
tradizione. Non è insomma per un gioco di parole o per un equivoco che la VI
Althusser, Per Marx, p. 218.
È nei Grundrisse che Marx usa la locuzione «die Summe» in una frase molto famosa che
anche Althusser cita più di una volta. Scrive Marx: « La società non consiste di individui, bensì
esprime la somma [die Summe] delle relazioni [Beziehungen], dei rapporti [Verhältnisse] in cui
questi individui stanno l’uno rispetto all’altro»; K. Marx, Lineamenti fondamentali della critica
dell’economia politica (1857-1858), vol. I, La Nuova Italia, Firenze 1968, p. 242. Althusser cita
questa frase ad esempio in: L. Althusser, Réponse à John Lewis, Maspero, Paris 1973, p. 48 e in
Althusser, È facile essere marxista in filosofia? Discussione di Amiens, p. 165.
22
23
�425
Althusser di fronte a Hobbes. La critica dell’umanismo individualista
tesi su Feuerbach riprende la parola “essenza” per giocarla contro il suo uso
tradizionale. Piuttosto, tra le due accezioni esiste un rapporto, un rapporto di
approfondimento. Lo scritto presente non è il luogo in cui delucidare il
movimento speculativo che realizza questo approfondimento, né tantomeno è
il luogo in cui ricostruire le tappe storiche che lo hanno reso possibile, anche
se, a quest’ultimo proposito, vorrei valorizzare una suggestione che Althusser
introduce a partire dagli anni Settanta. Quello che mi propongo nei seguenti
capoversi è di ottenere il seguente effetto: liberare la mente dall’impressione
che non possa che esserci un’unica accezione legittima della parola “essenza”,
cioè quella classica, e che dunque qualunque tentativo di introdurne un’altra,
che non ammetta di essere una stipulazione e dunque la produzione di una
semplice omonimia, sia solo un inganno.
Nel concetto classico-tradizionale dell’essenza, occorre innanzitutto
riconoscere due componenti: da un lato, la domanda o la questione che quel
concetto intende rendere affrontabile e, dall’altro lato, il modo in cui
effettivamente la rende trattabile. Detto altrimenti, rendere trattabile quella
questione è l’intenzione prima di quel concetto, mentre il modo in cui la rende
concretamente trattabile è il modo in cui di fatto pretende di realizzare la sua
intenzione. Che cos’è dunque che la determinazione dell’essenza di qualcosa
pretende di consentire? Ebbene, pretende di consentire che quel qualcosa sia
afferrato in ciò che ha di più significativo; più precisamente, pretende di
renderlo distinguibile da ciò da cui è più importante che sia distinto o da ciò
con cui più conta che non sia confuso. Questa è la questione: consentire di
distinguere la cosa. Ora, il concetto classico di essenza consente di distinguere
una cosa di un certo tipo (o specie) dalle cose di altri tipi (o specie). E, in molti
casi, una simile distinzione è effettivamente quella che conta. In molti casi,
afferrare quel che è più significativo di una cosa, cioè l’essenziale, ammonta a
capire che tipo o che sorta di cosa essa sia. Non è tuttavia sempre così: talvolta,
per afferrare la “specificità” di una cosa occorre spingersi a distinguerla nella
sua singolarità. Se ad esempio la domanda su che cosa sia l’essenziale di una
determinata cosa non è riferita a una mela, ma a un romanzo o a una
tradizione vivente o a una religione o al comportamento di qualcuno, appare
subito chiaro come non sia per nulla scontato che l’essenziale sia qui dato dalle
proprietà sortali di ciascuna di queste cose, quelle che ciascuna di esse ha in
comune con le altre dello stesso tipo. Qui, l’essenziale deve catturare l’identità
singolare della cosa; e nel caso in cui la cosa sia una tradizione o una religione
o simili, l’essenziale è dato anche da ciò per cui è pronto a combattere chi è in
esse coinvolto o è dato anche da ciò su cui costui non è disposto a cedere.
Considerando una di queste cose in tutta la complessità delle sue
�426
RICCARDO FANCIULLACCI
caratteristiche e determinazioni, per trascegliere quelle essenziali nel senso di
capaci di stare al centro di un resoconto che faccia afferrare questa cosa,
occorre non limitarsi alle proprietà essenziali nel senso classico, ma bisogna
anche includere alcune determinazioni che appartengono a quella cosa in
maniera contingente; sono parte della storia che l’ha resa la cosa che è, ma che
resta una storia che avrebbe potuto essere diversa.
La suggestione althusseriana prima evocata si inserisce proprio a questo
punto. Si tratta della sua valorizzazione della nozione spinoziana di essenza
singolare, nozione che lo stesso Althusser accosta a quella hegeliana di
universale concreto 24. Se la analizzassimo insieme allo speciale determinismo
di Spinoza (e poi all’idea leibniziana secondo cui tutte le proprietà di una
sostanza sono interne), questa nozione potrebbe rivelarsi l’anello di
congiunzione tra la concezione classica dell’essenza, per cui le proprietà
essenziali di una cosa sono solo (una parte di) quelle invarianti, e l’idea, cui
stiamo facendo spazio, secondo cui l’essenziale di una cosa (= ciò che è più
significativo sapere per comprenderla) può essere una sua caratteristica
contingente, ma rilevante nella storia di quella cosa. Al posto di questa
analisi 25, ci limiteremo a leggere come Althusser delucida quella nozione:
[L’] essenza singolare […] è per eccellenza la storia di un individuo o di un
popolo, come Mosé o il popolo ebraico. Che essa sia necessaria significa
solamente che si è compiuta, ma che tutto in essa poteva oscillare a seconda
dell’incontro o del non incontro di Mosè e di Dio o a seconda dell’incontro della
comprensione o della non comprensione dei profeti .
26
5. Non è per nulla scontato che per affrontare e trattare la domanda che si
interroga sulla specificità o l’essenziale della condizione umana ci si debba
rivolgere al problema che mira a stabilire che cosa, da sempre e per sempre,
distingue l’umano da ciò che umano non è. Per dissolvere l’impressione che
invece sia inevitabile e ovvio fare così, si considerino le due seguenti maniere
di lavorare la questione della specificità degli uomini rispetto agli altri animali.
Da un lato, abbiamo la ricerca delle proprietà che appartengono a tutti gli
uomini e a nessun altro animale in qualunque mondo possibile. Dall’altro lato,
abbiamo l’esplorazione dei modi attraverso cui gli uomini, nella storia, si sono
Althusser, È facile essere marxista in filosofia? Discussione di Amiens, p. 151.
Due contributi significativi a questa analisi sono offerti da V. Morfino: La scienza delle
“connexiones singulares”, in Id., Il tempo della moltitudine. Materialismo e politica prima e
dopo Spinoza , Manifestolibri, Roma 2005, pp. 15-50; L’evoluzione della categoria di causalità
in Spinoza , «Rivista di storia della filosofia» 2 (1992), pp. 239-254.
L. Althusser, Le courant souterrain du matérialisme de la rencontre, in Id., Écrits
philosophique et politiques, Tome I, Stok/Imec, Paris 1994, p. 566.
24
25
26
�427
Althusser di fronte a Hobbes. La critica dell’umanismo individualista
(o non si sono) posti a distanza dall’animale: in questi modi sono implicite idee
ben precise, seppure differenti, su che cosa sia essenziale per “noi umani”.
Queste idee non sono semplicemente concezioni alternative che competono tra
loro per definire correttamente l’essenza classificatoria, una riuscendoci e le
altre cadendo nell’insieme degli errori cognitivi; al contrario, tutte queste idee
hanno avuto effetti reali nelle società e, nei periodi in cui operavano, hanno
contribuito a determinare realmente che cosa, di volta in volta, fosse ritenuto e
dunque anche, in quel contesto, fosse tout court “vivere da uomini”. I confini
della vita propriamente umana si spostavano in corrispondenza dei confini di
queste idee. In questa seconda forma di indagine, la variazione storica e quella
sociale risultano immediatamente rilevanti, mentre nella prima erano
secondarie come qualunque altra variazione: la variazione era là proprio ciò
che non tocca l’essenziale, mentre qui l’essenziale può trasformarsi, spostarsi
altrove rispetto a dove era collocato all’inizio. (Si potrebbe credere che la
seconda forma di indagine ammonti alla tesi che la specificità dell’umano
consista nell’elaborare delle idee, storicamente mutevoli, su che cosa lo
distingua dall’animale. Se fosse davvero questo il punto, la seconda forma di
indagine sarebbe una variante interna della prima, invece non lo è. La seconda
forma di indagine ritiene che quelle idee, nella misura in cui non sono le
fantasie di questo o quel singolo, ma sono socialmente operative e implicite in
pratiche, allora contribuiscano a determinare che cosa di volta in volta è più
significativo nella realtà umana. Detto altrimenti, la specificità dell’umano non
appare qui come quella particolare caratteristica invariante che consisterebbe
nel dare risposte variabili alla domanda sulla specificità, piuttosto, qui la
specificità dell’umano appare variare e trasformarsi lungo la storia, anche se
certo non seguendo le opinioni dei singoli, bensì seguendo il processo
attraverso cui mutano quelle idee e le pratiche e le istituzioni in cui sono
implicite).
Se ora, a partire da questi due esempi, operiamo una generalizzazione,
otteniamo due approcci davvero diversi per afferrare l’essenziale della realtà
umana. Da una parte, si tratta di definire ciò che accomuna la molteplicità
degli individui in cui la realtà umana si frantuma (dove questo comune può
anche essere la proprietà per cui nessun individuo è inseparabile da una certa
qual socialità). Dall’altra parte, ci si rivolge ai modi in cui i rapporti tra gli
uomini configurano concretamente questa “realtà umana”, determinandosi
reciprocamente in una formazione sociale, surdeterminandosi tra loro e
trasformandosi nella storia.
Abbozzando questa distinzione non intendevo far altro che indebolire
l’impressione che il primo approccio sia scontatamente l’unico possibile. È
�428
RICCARDO FANCIULLACCI
chiaro però che, per oltrepassare la bozza, si dovrebbe innanzitutto definire
meglio il rapporto tra i due approcci, che per ora sembrano equipollenti e tali
che si tratti di scegliere l’uno o l’altro. In realtà, occorrerebbe, da una parte,
mostrare che ciò che è più significativo discernere per afferrare la realtà
umana include effettivamente alcune delle determinazioni di tale realtà che
mutano nel tempo (per il materialismo storico, ad esempio, tra queste
determinazioni storiche che fanno parte dell’essenziale, ci sono quelle che
definiscono il modo di produzione che è dominante nel sistema delle relazioni
tra le formazioni sociali volta a volta date). Da questa tesi consegue che il
primo approccio davvero non è sufficiente a cogliere l’essenziale della realtà
umana. Dall’altra parte, però, si tratterebbe di mostrare che il secondo
approccio non può fare totalmente a meno del primo: se, da esempio, ciò che
più conta include almeno una parte della configurazione sociale, allora
ciascun uomo deve perlomeno essere caratterizzato come capace di esser parte
di una società; se ciò che conta include le idee socialmente operanti che
riguardano i confini dell’umano, allora è necessario che gli uomini siano
perlomeno capaci di, non già produrre quelle idee, ma senz’altro di avervi a
che fare e di processarle. La concezione classica dell’essenza non è dunque
sconfessata, ma recuperata e ricollocata all’interno di un discorso che la
oltrepassa perché non considera accidentale e secondario tutto quel che non è
invariante. Questa ricollocazione, comunque, richiede che le proprietà
invarianti siano delle potenzialità generiche, attivate, modellate e
concretamente plasmate solo all’interno dei rapporti sociali. Si tratta di quel
modo di fare spazio alla trattazione della natura umana che prima Durkheim e
poi, in maniera più sfumata, anche Althusser avevano ritrovato nell’opera di
Montesquieu e avevano valorizzato come una conseguenza della presa di
distanza di quest’ultimo dalla trattazione hobbesiana e da quella degli altri
contrattualisti.
Il fatto è che sia per Durkheim, sia per Althusser la prima premessa
fondamentale che orienta tutto il successivo lavoro di Montesquieu e lo separa
dalla tradizione contrattualista è quella che realizza il rigetto dell’artificialismo
sociale: la società non è un prodotto degli individui, ma ciò in cui questi si
formano. Althusser sintetizza il punto in questo modo: «Rigetto del problema
dell’origine, assurdo. La società precede sempre se stessa» 27. (La seconda
premessa fondamentale è quella che afferma che tale realtà sociale ha una sua
propria dinamica che può essere scientificamente studiata). A questo punto,
però, c’è da rendere conto del fatto che comunque Montesquieu, nel primo
Althusser, Montesquieu, la politica e la storia (1959), p. 62. La citazione che segue nel testo
è a p. 61.
27
�429
Althusser di fronte a Hobbes. La critica dell’umanismo individualista
libro de L’esprit des lois, offre una trattazione dello stato di natura. Ebbene,
Althusser rimarca innanzitutto che si tratta di un «rapido abbozzo (rapide
aperçu)» rispetto alle ampie trattazioni offerte dai pensatori giusnaturalisti: è
una «rassegna rapida (rapid revue)» dello stato di natura in cui è innanzitutto
posto in rilievo un generico «istinct de sociabilité» 28. Durkhem, da parte sua,
era stato ancora più esplicito:
Certes, il [scil. Montesquieu] énumère des lois qui, abstraction faîte de tout état
de société, découlent de la condition humaine et qui, par suite, relèvent de la
psychologie pure, et il les appelle lois de la nature. Mais remarquons quelles elles
sont: ce sont le droit de conserver la vie ou de vivre en paix, le droit de se
nourrir, le droit pour chaque sexe de céder à son penchant pour l'autre, enfin le
droit d’avoir des relations de société avec ses voisins. […] Quoi qu'il en soit, […]
l'instinct qui nous pousse à nouer des relations avec nos semblables, s'il ouvre les
voies à la société, n'en produit cependant pas les formes, la nature, ni les lois. Il
n’y a rien dans les institutions sociales qui puisse être expliqué par ce moyen. Au
reste, tout ce problème n’est traité par notre auteur que de façon rapide et
superficielle : il n’a pas directement rapport au but qu'il se propose ; il ne
l'effleure que pour mieux définir son sujet, c’est-à-dire le distinguer des
problèmes voisins. […] Bien sûr, les sociétés n'étant constituées que d’hommes
individuels, leur nature depend pour une part de celle des hommes ; mais, dans
des sociétés différentes, l’homme lui-même est autre. Il n’a pas la même
mentalité, il n’a pas les mêmes désirs en Monarchie, en Démocratie ou sous le
Gouvernement despotique 29 .
Insomma, le determinazioni che Montesquieu attribuisce alla natura
umana, cioè alla natura esemplificata da ogni individuo umano, non sono in
generale nient’altro che (una parte de) le condizioni di possibilità della società,
Per la verità, Althusser sottolinea anche altri tratti di ciò che per Montesquieu sarebbe
naturale, in particolare alcuni nessi normativi che gli consentirebbero di compiere anche un
intervento politico-ideologico, attraverso un’opera, Lo spirito delle leggi, che in generale cerca
prima di tutto di essere un lavoro di scienza: attribuendo ad alcune norme lo statuto di leggi
naturali, Montesquieu si troverebbe con un’arma in più nel suo confronto critico con
l’artificialismo hobbesiano; cfr. Althusser, Montesquieu, la politica e la storia , pp. 75-77.
Sull’intreccio che Althusser rinviene tra la componente scientifica e quella ideologica de Lo
spirito delle leggi, mi permetto di rinviare al mio: La presa di partito in filosofia. Sulla lettura
althusseriana di Montesquieu, «Etica & Politica / Ethics & Politics», 19/3 (2017), pp. 11-31
É. Durkheim, La contribution de Montesquieu à la constitution de la science sociale, in
Id., Montesquieu et Rousseau précurseures de la sociologie, trad. fr. par A. Cuvillier, Rivière,
Paris 1953. Di quest’opera, che non è più in commercio, è possibile trovare una trascrizione
nella nota banca dati “Les classiques des sciences sociales” della Université du Québec à
Chicoutimi (http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/montesquieu_et_rousseau/
montesquieu_et_rousseau.html). Poiché però questa trascrizione non rispetta l’impaginazione
originale, oltre che le pagine di questa trascrizione (che sono pp. 17-18), riporto anche il
capitolo e il paragrafo (che sono II, 2).
28
29
�430
RICCARDO FANCIULLACCI
quelle condizioni che è necessario postulare nella misura in cui la società esiste
effettivamente. Si tratta di un movimento dall’esse al posse e nient’affatto della
scoperta di caratteristiche da cui sarebbe poi possibile dedurre le fattezze della
realtà sociale. Per questo, la loro esposizione è generica e rapida. D’altronde,
ed era questo che ora volevo evidenziare, l’esempio di Montesquieu ci offre
una prova del fatto che un discorso che ritiene che per afferrare la specificità
della realtà umana si debba “passare alla società” e alla storia non è obbligato
a negare ogni spazio alla nozione tradizionale di essenza o natura umana. C’è
anzi uno spazio per questa nozione che sembra irriducibile e che però non fa sì
che l’intero discorso si impantani nella problematica individualisticoumanistica.
V. LA NATURA UMANA SECONDO HOBBES
6. Althusser, sulla scorta di Marx, può oggettivare e, come vedremo,
criticare l’impostazione teorica individualistico-umanistica perché non si
colloca più al suo interno. La mossa di scarto fa leva sul rigetto o sulla radicale
ricollocazione della questione relativa all’essenza degli uomini: non solo non si
ritiene più che definendo tale essenza si afferri tutto l’essenziale, ma a questa
definizione non viene neppure più attribuito il posto di compito preliminare.
In effetti, non si ritiene più possibile determinare quel grappolo di condizioni
invarianti della variazione storico-sociale che sono insite nella natura umana e
nelle sue potenzialità, senza immergersi nella dimensione storica e studiarla
appropriatamente – salvo che ciò comporta che sia tale indagine a dover essere
preliminare. Inoltre, nella misura in cui si nega che dalla conoscenza di quelle
condizioni sia possibile dedurre conoscenze davvero significative su com’è o
addirittura su come dovrebbe essere la dimensione storico-sociale, allora, la
pur legittima determinazione biologica o psicologica (o, come sarebbe il caso
oggi, la determinazione propria delle scienze cognitive) della natura umana,
per non parlare di quella, epistemologicamente problematica, che sarebbe
offerta dalla fenomenologia filosofica, ecco, questa determinazione della
natura umana perde di urgenza e di decisività.
Relativamente a Hobbes, invece, sarebbe vero il contrario, secondo
Althusser. Il discorso del filosofo inglese sarebbe immerso nella problematica
umanistica e dunque, innanzitutto, nella problematica riguardante la
determinazione dell’essenza dell’uomo. Ad esser precisi, Althusser non si
sofferma mai a mostrare determinatamente come il pensiero hobbesiano sia
un’illustrazione dell’umanismo individualista: non lo fa in Pour Marx, né lo ha
fatto prima, in particolare nel libro dedicato a Montesquieu (dove pure vi sono
�431
Althusser di fronte a Hobbes. La critica dell’umanismo individualista
numerosi raffronti tra le idee e le impostazioni dei due classici), né lo farà
dopo, in particolare in quei corsi tenuti all’École Normale Supérieure su cui
torneremo per esporre l’altra direttrice attraverso cui Althusser legge Hobbes 30.
Probabilmente, riteneva fin troppo ovvio il punto fondamentale: per Hobbes la
libertà e il diritto di esercitarla sono parte della natura comune a ciascun
essere umano, appartengono cioè all’essenza dell’uomo, mentre la questione
che impegna la filosofia politica (ma, in generale, tutta la filosofia pratica)
consiste nel determinare come e in quale misura quella libertà e quel diritto
possono esistere effettivamente là dove l’individuo si trova a convivere con altri
in una certa porzione di spazio e di tempo. Le fattezze della coesistenza
dipendono innanzitutto, sebbene non solo, dalle fattezze dell’individuo, cioè
dalla natura umana; dunque è da questa natura che dipendono anche le
possibili fattezze di una coesistenza civile e pacifica. La natura umana, che è
data da ciò che appartiene essenzialmente a ciascun individuo, è insomma il
perno dell’intero discorso. Non a caso, la parte prima del Leviatano è
intitolata: Of Man / De Homine.
In una pagina del libro su Montesquieu, Althusser ricorda il celebre
passaggio del De Cive in cui Hobbes paragona la considerazione degli uomini
nello stato di natura, cioè la considerazione che non attribuisce loro altro che
ciò che hanno in virtù della loro natura o essenza (e che dunque prescinde da
quelle loro determinazioni che invece si producono attraverso gli incontri ed
eventualmente attraverso quegli incontri del tutto speciali che danno luogo a
patti o a contratti), paragona questa considerazione a una prospettiva in cui gli
uomini siano considerati «come se fossero venuti su tutti all’improvviso, a
guise di funghi (like Mushromes), dalla terra, e già adulti, senza alcun obbligo
reciproco» 31. Se teniamo presente che, per Hobbes, la coesistenza di tali uomini
è una condizione di guerra e minaccia reciproca, allora non possiamo non
Cfr. L. Althusser, Politique et Histoire, de Machiavel à Marx. Cours à l’École Normale
Sepérieure 1955-1972, (Texte établi, annoté et présenté par F. Matheron), Seuil, Paris 2006.
T. Hobbes, Elementi filosofici sul cittadino, trad. it. di N. Bobbio, UTET, Torino 1948, p.
205 (si tratta del paragrafo 1 del capitolo VIII). Althusser richiama questo paragone in
Montesquieu, la politica e la storia, p. 58. Curiosamente, Althusser evoca questa pagina di
Hobbes parlando di zucche (potirons) piuttosto che di funghi (champignons). All’origine di
questo errore c’è la prima traduzione francese del De Cive, quella realizzata da Samuel
Sorbière nel 1649 (edizione di Amsterdam; 1651 edizione parigina, poi riproposta fino ai primi
anni 2000 da Flammarion) e che era l’edizione da cui Althusser citava nei suoi corsi. Va notato
però che al tempo di Sorbière, la parola “potiron” era impiegata per indicare i funghi e non le
zucche. Non controllando il testo originale e dunque continuando a usare una traduzione che
era nel frattempo diventata scorretta per il cambio di significato della parola “potiron”,
Athusser cade nell’errore. (Il traduttore italiano del libro su Montesquieu reduplica l’errore
parlando di “zucche”).
30
31
�432
RICCARDO FANCIULLACCI
associare questo paragone a quel momento del mito di Cadmo in cui l’eroe
semina i denti di un drago e poi vede spuntare uomini adulti e armati che ben
presto si scagliano l’uno contro l’altro. Non è tuttavia la deduzione dello stato
di guerra l’aspetto che ora ci interessa, bensì il principale effetto ottenuto
dall’immaginare gli uomini come se comparissero già adulti e privi di legami:
proporre tale immagine presuppone che si consideri tutto sommato
insignificante il processo che nella realtà effettiva ha come risultato degli esseri
umani adulti e cioè il processo di cura e socializzazione. L’idea è che ciò che di
fatto accade in quel processo non produce vincoli che è importante tener
presente quando si ragiona sulle fattezze che ha la coesistenza tra individui:
quale che sia la genesi dell’individuo, quali che siano le pratiche e le istituzioni
passando per le quali si è formato, ciò che alla fine conta per capire la struttura
della coesistenza sono le caratteristiche che quell’individuo ha in comune con
qualunque altro.
Il ragionamento di Hobbes ha la sua coerenza. In effetti, se ciò che ci si
propone è, come chiarisce Althusser, definire le proprietà della «società in
generale» 32, allora è inevitabile che si voglia prescindere da ciò che differenzia
questa società da quella. D’altro canto, questa sequenza coerente si appoggia
su dei presupposti. Il primo è che la conoscenza della società in generale, cioè
delle fattezze più generali dell’umano coesistere, fornisca l’essenziale (cioè quel
che più conta) sia in vista della comprensione della realtà umana e sociale, sia
in vista della determinazione di come tale realtà dovrebbe organizzarsi. Un
secondo presupposto è che per conoscere che cosa sia la società in generale
non sia necessario passare per lo studio delle differenti società concrete e per la
dinamica storica in cui sono prese. Questo secondo presupposto dipende dalla
teoria della conoscenza e dalla teoria della scienza elaborate da Hobbes.
Per il filosofo inglese, la scienza modello è la geometria, il cui metodo è però
ridefinito all’interno di un quadro generale empiristico-nominalistico. Per
edificare la scienza di una certa porzione della realtà, occorre definire gli
elementi primi di quella porzione e poi dedurre le implicazioni delle
congiunzioni e delle disgiunzioni tra le nozioni di questi elementi 33; le
definizioni iniziali, però, sono il frutto di un lavoro sulle esperienze percettive,
che sembra risolversi in un complesso di movimenti associativi più o meno
governati dalla memoria. Grosso modo: a forza di vedere mele, si resta colpiti
dalla loro somiglianza e a tale somiglianza viene attribuito un nome comune,
“mela”, poi, alla somiglianza tra questa somiglianza e altre somiglianze, viene
Althusser, Montesquieu, la politica e la storia, p. 52.
T. Hobbes, Leviatano, trad. it. di R. Santi, Bompiani, Milano 2001, pp. 69-73 (parte I, cap.
V, §§ 2-6).
32
33
�433
Althusser di fronte a Hobbes. La critica dell’umanismo individualista
dato un altro nome comune, “frutto”, e così via 34; anche le connessioni causali
sono elaborate in maniera simile, riflettendo sui nessi tra i fenomeni registrati
dalla sagacia e dalla prudenza 35. Applicato allo studio dell’uomo, questo
complesso gnoseologico-epistemologico porta Hobbes ad affermare che per
sviluppare un sapere de homine non occorre altro che leggere con attenzione
se stessi (e poi dedurre le conseguenze di quanto si sarà così accertato):
Data la somiglianza dei pensieri e delle passioni di un uomo con le passioni e i
pensieri di un altro, chiunque guardi dentro se stesso e consideri ciò che fa
quando pensa, opina, ragiona, spera, teme ecc. e su che cosa si basa, con ciò
leggerà e conoscerà quali sono i pensieri e le passioni di ogni altro uomo in
condizioni simili a queste. […] quando avrò messo per iscritto in modo
sistematico e chiaro la lettura di me stesso, l’unica pena che lascerò agli altri sarà
di riscontrare la stessa cosa anche in se stessi. Questo genere di dottrina, infatti,
non ammette altra dimostrazione .
36
Siamo davvero all’opposto di Montesquieu, secondo cui per comprendere la
realtà umana bisogna immergersi ad esaminare (certo ordinatamente e
organicamente e non al modo della raccolta di curiosità o della cronaca) la
varietà delle leggi e dei costumi che appartengono alle diverse società lungo la
storia.
7. Sebbene sia ovviamente il metodo di Montesquieu, piuttosto che quello di
Hobbes, il metodo che Althusser ritiene più vicino al materialismo storico, c’è
un tratto del secondo che egli non può non valorizzare. Non si tratta
genericamente del materialismo hobbesiano, ossia, non si tratta tanto delle tesi
ontologiche di Hobbes secondo cui essere significa essere un corpo (o
un’affezione di un corpo riducibile a un movimento di quello). Si tratta
piuttosto dell’effetto epistemologico e metodologico che ha questa
impostazione materialistica. Il fatto è insomma che per sviluppare quelle sue
tesi di ontologia generale, Hobbes è costretto ad operare una radicale epoché
delle rappresentazioni attraverso cui il senso comune pensa e che provengono
da tradizioni autorevoli. Per Althusser, si esprime qui quell’esigenza di rottura
epistemologica che è una condizione necessaria della fondazione di una nuova
scienza 37. Le presunte evidenze del senso comune vanno messe da parte,
affinché lo sguardo sulla realtà possa essere governato dai concetti e dagli
assunti della scienza che si sta fondando.
34
35
36
37
Hobbes, Leviatano, pp. 53-57 (parte I, cap. IV, §§ 6-12).
Hobbes, Leviatano, pp. 41-45 (parte I, cap. III, §§ 4-10).
Hobbes, Leviatano, pp. 17-18 (parte I, Introd. §§ 3-4).
Cfr. Althusser, Politique et Histoire, de Machiavel à Marx, p. 369.
�434
RICCARDO FANCIULLACCI
Ma non è solo la sospensione delle rappresentazioni e delle nozioni ricevute
che Althusser ritrova nel lavoro di Hobbes, ma anche un altro elemento per lui
fondamentale: la fondazione di una nuova scienza ha sempre la forma
dell’estensione a una nuova porzione della realtà di quel tipo di razionalità
che ha già dato prova di sé in altre scienze. Naturalmente, tale estensione
richiede l’introduzione di nuovi concetti, ma non è pensabile se non si
considerano gli esempi di scienza già in campo. Ad esempio, per Althusser,
Montesquieu riprende da Newton il concetto di legge scientifica e, attraverso
l’introduzione di nuovi concetti (in particolare quelli atti a designare le
«diverses choses» con cui le leggi positive sono in rapporto, cioè il clima, i
costumi, le maniere, la religione, la grandezza di una società ecc.) 38, tenta di
fondare una nuova scienza, una sorta di fisica delle leggi positive e della
giurisprudenza. Ebbene, un tentativo simile, seppur diverso, lo avrebbe
compiuto Hobbes: trattare scientificamente, cioè nei modi esemplificati da
Euclide in rapporto allo spazio e da Galilei in rapporto alla realtà fisica, la
natura e la convivenza umane 39.
Certamente, lo abbiamo già accennato, Hobbes non tenta come
Montesquieu di individuare le covarianze tra alcuni fenomeni indagando i
rapporti reali in cui questi fenomeni si presentano (ad esempio: scoprire i
principi di covarianza tra il clima che caratterizza il luogo in cui sorge una
società e il tipo di ordinamento governativo secondo cui essa si organizza),
piuttosto, una volta definiti due fenomeni, tenta di dedurre quali sono i loro
possibili o non possibili rapporti (ad esempio, se l’uomo è un essere così e così,
allora quando due o più uomini si incontrano, è escluso che accada questa tal
cosa ed è inevitabile che accada quest’altra o probabile che accada quest’altra
ancora) 40. Si tratta dunque solo in parte (quella parte che presiede alla
costruzione delle definizioni) di una scienza empirico-sperimentale: qui infatti
gli esperimenti sono esperimenti mentali o ragionamenti controfattuali.
Tuttavia gli assunti materialistici di Hobbes, lo portano a tentare delle
riduzioni che, per quanto in se stesse problematiche, rivelano quell’esigenza
scientifica che Althusser era molto attento a valorizzare. In questo senso è
Cfr. Montesquieu, Lo spirito delle leggi, trad. it. di B. Boffito Serra, Rizzoli, Milano 1989,
p. 152 (lib. I, cap. III).
Cfr. Althusser, Montesquieu, la politica e la storia , pp. 49-53; Id., Politique et Histoire, de
Machiavel à Marx, p. 369. Questo aspetto dell’impresa hobbesiana era stato valorizzato anche
da Durkheim in un corso tenuto a Bordeaux nel 1895, ma pubblicato (parzialmente) solo di
recente e dunque certamente non noto ad Althusser: cfr. É. Durkheim, Hobbes à l’agrégation,
Éditions EHESS, Paris 2011, pp. 27-29.
Per un confronto tra l’idea hobbesiana di scienza e quella di Montesquieu, cfr. Althusser,
Montesquieu, la politica e la storia, pp. 52-53, 60-61.
38
39
40
�435
Althusser di fronte a Hobbes. La critica dell’umanismo individualista
paradigmatica l’operazione hobbesiana sull’immagine ricevuta del soggetto
pratico e delle sue possibili motivazioni.
La negazione del dualismo tra realtà spirituale e realtà corporea legittima
l’estensione del metodo scientifico ai cosiddetti moti dell’animo, ma, nel
concreto, tale estensione è ancor più dissacrante di quanto questa premessa
generale non faccia immaginare. Per Hobbes, l’individuo umano, come ogni
altra presunta sostanza irriducibile, è in realtà semplicemente un corpo
coinvolto in movimenti locali di vario genere. Ne consegue che, anche in
rapporto all’uomo, tutto ciò che non può essere ridotto a una caratteristica
fisica o all’effetto di un moto locale non esiste davvero: la scienza lo rivela
un’illusione – dove l’illusione, in quanto “stato mentale”, è ovviamente
riducibile all’effetto di moti locali e di urti tra corpi. I corpi complessi come
quello umano sembrano capaci di quelle prestazioni speciali, quali giudicare,
ragionare, desiderare, sperare, temere, aver fede ecc., che il senso comune (cioè
il sapere non scientifico) registra, ma in realtà, tali prestazioni sono effetti di
moti fisici e potrebbero essere ridescritte in questo modo.
Anche sul piano di questa variegata molteplicità di prestazioni, comunque,
è possibile rinvenirne alcune che, rispetto alle altre, stanno nella posizione di
elemento fondamentale. Ad esempio, al di sotto dell’apparente ricchezza della
vita morale umana, ci sono soltanto due impulsi (o conati) causalmente
associati a due rappresentazioni mentali: da un lato il desiderio, che è
correlato alla rappresentazione di qualcosa di piacevole (oppure di utile al
godimento di un piacere), dall’altro l’avversione, che è correlata alla
rappresentazione di qualcosa che, immediatamente o mediatamente, è
spiacevole o molesto. E ancora, non vi sono cose intrinsecamente buone e cose
intrinsecamente cattive: i beni sono le cose desiderate, i mali le cose avversate.
Sia i beni che i mali variano dunque da uomo a uomo, sebbene vi siano cose
che ogni uomo desidera e altre che ogni uomo avversa: la conservazione della
vita, la salute e la sicurezza, da un parte, e la morte (in particolare la morte
violenta e dolorosa) e il suo pericolo, dall’altra.
Gli assunti materialistici di Hobbes, lo conducono insomma ad operare una
rottura radicale con l’immagine ricevuta e diffusa della vita pratica: gli
atteggiamenti e le passioni umane comunemente tenuti distinti vengono
ricondotti alla semplice combinazione dei pochi elementi citati, mentre, dietro
l’apparente ricerca del Bene o di ciò che vale per se stesso, viene ritrovato
l’interesse dell’agente verso il proprio vantaggio, cioè verso il piacere o l’utilità.
Qui, però, va notata una differenza importante tra Hobbes e Althusser. Per
quest’ultimo, nella misura in cui la rottura epistemologica che fonda una
nuova scienza produce una trasformazione dello sguardo gettato su quella
�436
RICCARDO FANCIULLACCI
porzione di realtà di cui tale scienza consentirà di “appropriarsi
conoscitivamente” (in effetti, ora quello sguardo non è mediato dalle
rappresentazioni comuni e ideologiche, ma dai concetti tecnici e dalla teoria
della nuova scienza), allora poi, la verifica di che cosa effettivamente c’è e
accade in quella porzione di realtà non può che prodursi dall’interno della
pratica scientifica fondata grazie a quella rottura 41. Detto altrimenti: nella
misura in cui lo spettacolo che la nuova scienza presenta a chi rivolge lo
sguardo verso quella porzione di realtà risulta visibile solo lasciando cadere le
evidenze del senso comune (per il quale, ad esempio, il moto uniforme è
tutt’altro che uno stato; quando una cosa piccola come un gatto corre per una
stanza, le pareti di questa non vibrano affatto; i comportamenti e le scelte degli
uomini in società sono determinati da loro stessi e non dalla loro posizione nel
complesso sociale ecc.), allora non è qualcosa che si possa immediatamente
riconoscere come vero in virtù del suo essere noto o familiare 42. Per Hobbes, al
Ho qui riassunto alcuni dei capisaldi della teoria althusseriana della scienza, avendo cura
di suggerire come il costruzionismo concettuale (cioè la nota tesi che Althusser riprende da
Bachelard e Ganguilhem secondo cui la scienza introduce concetti nuovi che, perlomeno in
generale, non si pongono come riscatti dei concetti e delle rappresentazioni ordinarie: il
concetto fisico di moto non esprime la verità del concetto comune, ma è un altro concetto,
quello che, operando insieme agli altri che fanno parte della teoria meccanica della fisica
classica, consente di produrre l’effetto di conoscenza del mondo fisico) non implichi affatto
l’abbandono del realismo. La conoscenza scientifica, dice Althusser, non è conoscenza
dell’oggetto reale, ma dell’oggetto di conoscenza (o oggetto scientifico): si tratta di una formula
fuorviante per comprendere la quale occorre innanzitutto ricordare che lo studio dell’oggetto
scientifico consente un’appropriazione (Aneignung) speciale (quella conoscitiva) dell’oggetto
reale. Che cosa dice dunque quella formula? Innanzitutto che le indagini di una scienza sono
governate dai concetti fondamentali di quella scienza e non dalle rappresentazioni ricevute, per
cui la scienza, quando guarda dove guarda il senso comune, non vede lo stesso spettacolo (ad
esempio, la scienza storico sociale, se guada al mondo umano, non vede uomini che
interagiscono sulla base delle loro preferenze e bisogni naturali, ma vede un complesso sistema
di rapporti); in secondo luogo, che il processo che ha prodotto quei concetti fondamentali non è
il processo storico in generale (per cui la scienza sarebbe il luogo in cui la storia arriva a pensare
se stessa, a prendere coscienza di sé), ma è il processo speciale della pratica scientifica. I testi
fondamentali in cui Althusser elabora la sua teoria della scienza sono innanzitutto il sesto
capitolo di Pour Marx, cioè quello Sulla dialettica materialista (in particolare il terzo
paragrafo), quindi i suoi due contributi, già citati, all’opera collettiva Lire le Capital: Dal
“Capitale” alla filosofia di Marx e L’oggetto del “Capitale”.
Qui si colloca la distinzione radicale che Althusser pone tra conoscere e riconoscere: grazie
alla scienza si conoscono alcune verità, mentre le presunte verità evidenti in cui ci si riconosce e
che si riconoscono immediatamente perché sono note e familiari non sono in realtà contenuti
di conoscenza, ma contenuti ideologici; cfr. ad esempio, Althusser, Per Marx, pp. 123 e 159.
L’ideologia funziona proprio in questo modo: rendendo alcuni contenuti delle evidenze ben
riconoscibili e che dunque non è necessario difendere o discutere; cfr. Althusser, Initiation à la
philosophie pour les non-philosophe, pp. 225-228. (Tra queste evidenze c’è anche il fatto che la
neve è bianca? In realtà, esempi come questo possono svolgere una funzione ideologica non per
41
42
�437
Althusser di fronte a Hobbes. La critica dell’umanismo individualista
contrario, quello spettacolo è qualcosa che ciascuno può verificare da sé
esercitando con onestà l’introspezione 43. Da ciò consegue che quella che per
Althusser è la realtà sociale dell’ideologia (qualcosa che ha effetti storici e che
solo la pratica scientifica può mettere a distanza), per Hobbes è solo una sorta
di favola in cui ciascuno si trattiene per semplice mancanza di coraggio
intellettuale.
Quest’ultima differenza osservata non ha peso solo sul piano
epistemologico, ma anche in riferimento a una teoria della morale. Quando
Hobbes fa della morale il contenuto di un discorso diffuso il cui incanto può
però essere spezzato da chiunque abbia l’onestà e il coraggio di guardare in se
stesso e vedere che nient’altro che il suo vantaggio o piacere o utilità lo motiva
a fare e perseguire quel che fa e persegue, non sta facendo altro che articolare
il suo scetticismo morale. E nel farlo, offre un resoconto delle pretese morali
molto problematico: sono davvero costruzioni che si potrebbero per principio
lasciar cadere, che ciascuno potrebbe per principio lasciar cadere e che, là dove
non sono lasciate cadere, ciò accade solo per qualche ragione di convenienza o,
appunto, di debolezza e malafede? Quando Althusser afferma che «la morale
[…] è nella sua essenza ideologia» 44, non dà voce ad alcuno scetticismo, ma
pretende di situare la morale in una certa regione della realtà sociale: sta
rispondendo alla domanda che chiede che tipo di realtà sociale sia la morale.
Dire che è ideologia non significa dire che è falsa, né che l’individuo possa
deporla grazie a qualche rischiaramento della sua coscienza. Quella tesi
comporta che i contenuti concreti della morale volta a volta vigente in una
formazione sociale si articolano storicamente e che tale articolazione o
sviluppo non è un processo autonomo, ma dipende in ultima istanza da altri
processi, processi che però quello sviluppo surdetermina e da cui non dipende
in maniera meccanica.
Va certamente ammesso che nella tradizione marxista ci si compiace
facilmente nel dar mostra di un atteggiamento demistificatorio nei confronti
della morale: sarebbe solo la falsa coscienza a poter credere che le istanze
morali contino qualcosa nella reale dinamica storica! Questa demistificazione,
la banalità che dicono, in questo caso che la neve è di colore bianco, ma per ciò che
suggeriscono, ad esempio, che vi sono concetti che sarebbero imposti dalle cose stesse, grazie a
somiglianze o differenze che spiccano da sé. Insomma, l’evidenza ideologica nascosta in quegli
esempi è quella relativa alla supposta ovvia validità dell’epistemologia empirista, oppure di una
metodologia di indagine che parte da ciò che sarebbe semplice e concreto per arrivare a ciò che
è più complesso).
Oltre alla pagina del Leviatano già citata nel § 6, si veda anche: Hobbes, Elementi filosofici
sul cittadino, pp. 61-62 (sono pagine che appartengono alla Prefazione ai lettori).
Althusser, Per Marx, p. 207.
43
44
�438
RICCARDO FANCIULLACCI
però, può appoggiarsi a teorie di fondo molto diverse: un conto è dare per
scontato che ciò che davvero conta sono gli interessi particolari di classe, un
altro è interrogare la nozione stessa di interesse particolare e scoprire che essa
può essere riscattata da una cornice che di fatto resta individualista, solo se si
riconosce una qualche realtà storico-sociale a quegli ideali e a quelle idee
attraverso cui un interesse interpreta se stesso. È questa seconda via quella in
cui si è incamminato Althusser. Si potrebbe dire che la sua critica
dell’empirismo del dato colpisce anche quel dato che sarebbero gli interessi
particolari (che siano attribuiti a un gruppo o a un individuo): questi, ben lungi
dall’essere all’origine del campo ideologico, si definiscono determinatamente,
si interpretano e si articolano al suo interno; non si costituiscono interamente
in quel campo e tuttavia, nella loro concretezza, dipendono da esso. Per questo,
mentre il riferimento agli ideali è per Hobbes solo una maschera di un
desiderio o interesse perfettamente afferrabile come attrazione verso un certo
piacere o vantaggio, per Althusser, non esiste una prospettiva che può lasciar
cadere quella maschera, esiste solo una prospettiva, quella scientifica, che la
situa in un complesso più ampio (la formazione sociale). Sennonché, una
“maschera” che non si può lasciar cadere non è una maschera: è una realtà che
aspetta categorie migliori per esser resa intellegibile.
8. C’è un ultimo aspetto dell’antropologia hobbesiana che merita di essere
citato perché Althusser ne offre una valorizzazione che, in una certa misura,
complica una troppo rapida classificazione del pensiero di Hobbes tra i
rappresentanti dell’individualismo umanistico. Si tratta del modo in cui nel
Leviatano viene spiegata la presenza del linguaggio tra gli uomini. Per
concepire lo stato di natura, aveva detto il De Cive nella celebre pagina già
evocata, possiamo immaginare gli uomini come se fossero spuntati dalla terra
all’improvviso, già dotati di tutte le loro abilità cognitive e comunicative. Il
Leviatano, però, non procede così e tenta di spiegare come tali abilità possano
appartenere a ciascun individuo, sapendo che questo è fondamentalmente un
corpo dotato di una certa complessità interna. Ebbene, osserva Althusser,
Hobbes, portando a fondo questa impostazione, si troverebbe a complicare la
possibilità stessa di un’antropologia umanistico-individualista.
Senza il linguaggio, per Hobbes, non solo non vi sarebbe una
comunicazione articolata, ma non vi sarebbe neppure il pensiero 45 e dunque,
tra le altre cose, la possibilità di accordarsi in un contratto 46. Il linguaggio,
tuttavia, non è una dotazione naturale di quei corpi che sono i corpi umani
45
46
Hobbes, Leviatano, p. 65 (parte I, cap. IV, § 22).
Hobbes, Leviatano, p. 49 (parte I, cap. IV, § 1).
�439
Althusser di fronte a Hobbes. La critica dell’umanismo individualista
(che di per sé sono solo capaci di percezioni e di associazioni tra percezioni,
realizzate dall’immaginazione), ma è un artificio 47. Come va intesa, tuttavia, la
produzione di tale artificio? Ovviamente, non può essere il prodotto di una
convenzione, che è una forma di patto e che dunque presuppone il pensiero e
il linguaggio. Nella misura, però, in cui il linguaggio ha una realtà non
puramente individuale, allora non può neppure essere l’esito di un qualche
processo associativo realizzato da un singolo. Non resta che pensare che quella
produzione artificiale sia una sorta di effetto emergente di un’interazione tra
degli individui che non esemplificano ancora tutte le prestazioni propriamente
umane (appunto perché queste presuppongono il linguaggio). Ne vengono due
conseguenze: (1) vi sono abilità, tra cui il pensiero, che appartengono
all’individuo solo in quanto abita già uno spazio di interazioni e dunque di
linguaggio (scrive Althusser: «il campo dell’artificio e del linguaggio pone la
ragione. Questa non è dunque né lume trascendentale, né lume naturale») 48; (2)
non c’è qualcosa che sia l’origine o la causa del campo linguistico, ci sono
piuttosto delle condizioni in cui esso emerge 49. Questa seconda conseguenza
porta Althusser a parlare di «rifiuto di ogni interrogazione sull’origine
dell’insieme che costituisce questo campo» e di «affermazione dell’autonomia»
di tale campo, quindi a concludere che si profila qui un «rifiuto di ogni
rinascita della [problematica della] naturalità a partire dalla genesi degli
elementi, il che torna a mettere in questione la possibilità stessa di qualunque
antropologia» 50.
Questo tipo di complicazione della lettura secondo cui la pietra angolare del
discorso hobbesiano è un’analisi delle caratteristiche del mondo umano intese
come caratteristiche di ogni individuo è il tipo di complicazione che guida la
seconda linea interpretativa seguita da Althusser nel suo confronto con il
filosofo inglese: in attesa di approfondirla nello scritto che completerà il testo
presente, dobbiamo ora considerare la critica dell’umanismo hobbesiano che
Althusser riprende da Marx.
Cfr. Althusser, Politique et Histoire, de Machiavel à Marx, p. 370-371.
Althusser, Politique et Histoire, de Machiavel à Marx, p. 371.
Sia osservato en passant che in realtà Hobbes scrive: «Il primo autore del linguaggio fu Dio
stesso, che istruì Adamo su come dare i nomi alle creature che presentava al suo cospetto»
(Leviatano, p. 49). In questo come in altri casi, Althusser non dà alcuna importanza ai momenti
in cui Hobbes sembra introdurre Dio come causa: li considera probabilmente pegni pagati
all’ideologia allora dominante.
Althusser, Politique et Histoire, de Machiavel à Marx, p. 372.
47
48
49
50
�440
RICCARDO FANCIULLACCI
VI. LA CRITICA MATERIALISTA
INDIVIDUALISTICA
DELLA
ROBINSONATA
9. Trattando dei «dei presupposti dell'ideologia borghese classica e
dell’economia politica borghese», Althusser scrive in Pour Marx:
Da che cosa parte questa ideologia classica (sia che si tratti di Hobbes nella
composizione dei conatus, sia di Locke e di Rousseau nella generazione della
volontà generale; sia di Helvétius o d’Holbach nella produzione dell’interesse
generale, sia di Smith e Ricardo — i testi abbondano — nei comportamenti
dell’atomismo), da che cosa parte, se non appunto dal mettere fronte a fronte
queste famose volontà single [volontés individuelles], che non sono affatto il
punto di partenza della realtà, ma il punto di partenza per una rappresentazione
della realtà, per un mito destinato a dare (in eterno) un fondamento naturale (il
che vuol dire appunto per l’eternità) agli obiettivi della borghesia? […] Marx
criticò così bene in questo esplicito presupposto il mito dell’homo oeconomicus.
51
In questo passo, Althusser compie una sequenza di operazioni.
Innanzitutto, considera un gruppo di discorsi, tra cui quello di Hobbes, che
pretendono di definire il «punto di partenza della realtà», cioè gli elementi
fondamentali della realtà sociale – tali discorsi identificano questi elementi
nelle volontà individuali. In secondo luogo, sconfessa o falsifica quella pretesa
affermando che le volontà individuali non sono affatto il punto di partenza
della realtà. Queste due prime operazioni sono classiche: un certo discorso
viene considerato e valutato nella sua pretesa di dire il vero. La terza
operazione presuppone un cambio di prospettiva: il discorso in oggetto, infatti,
non è più considerato epistemicamente (cioè nel suo contenuto e nella sua
pretesa di verità o validità), bensì è considerato come una enunciazione e,
come tale, viene posto in connessione con la realtà sociale in cui è enunciato e
radicato, ovviamente sulla base di una teoria di sfondo riguardante il tipo di
elementi che appartengono a una formazione sociale (qui, ad esempio, si fa
riferimento a classi, a obiettivi di classe e a rappresentazioni o miti). Più
precisamente, quel discorso è posto in relazione a una rappresentazione o mito
che svolge una certa funzione, cioè la funzione di dare un fondamento
naturale agli obiettivi storici di una classe sociale. Quel discorso serve a tale
mito perché gli offre il giusto punto di partenza da cui quello potrà derivare
quanto gli serve (cioè una naturalizzazione degli obiettivi della borghesia).
Detto altrimenti, i discorsi come quelli di Hobbes sono identificati come
contributi all’ideologia borghese e al suo lavoro di legittimazione (e di
articolazione) degli obiettivi della classe borghese. Il loro contributo consiste
51
Althusser, Pour Marx, p. 104.
�441
Althusser di fronte a Hobbes. La critica dell’umanismo individualista
innanzitutto nell’elaborazione di quel presupposto individualistico che Marx
ha criticato sotto il nome di “mito dell’homo oeconomicus”.
Si tratta di una discussione del tutto peculiare di discorsi come quello di
Hobbes, una discussione che non si limita a esaminare la loro coerenza o
consistenza interna, né a confrontarli con la realtà che essi pretendono di
rivelare, ma che li prende alle spalle inscrivendoli nella dinamica sociale in cui
sono formulati o in cui comunque si diffondono e prendono piede. Per
Althusser, è Marx ad aver reso possibile la mossa fondamentale che fa
accedere a quest’altro modo di considerazione e di discussione. L’ha resa
possibile elaborando quella teoria della realtà storico sociale grazie a cui, di
fronte a un discorso, è possibile vedere qualcosa di più che l’elaborazione di un
intelletto individuale, da valutare mettendola in un rapporto epistemico con la
realtà di cui tratta. Tra le pagine a cui Althusser poteva alludere rinviando alla
critica marxiana dell’homo oeconomicus, la più celebre è senz’altro quella che
sta all’inizio della Introduzione del 1857 a Per la critica dell’economia politica
(dove tra l’altro si parla di “punto di partenza”):
L’oggetto in questione è anzitutto la produzione materiale. Il punto di partenza
[Ausgangspunkt] è costituito naturalmente dagli individui che producono in
società – e perciò dalla produzione socialmente determinate degli individui. Il
singolo ed isolato cacciatore e pescatore con cui cominciano Smith e Ricardo,
rientrano tra le fantasie prive di immaginazione delle robinsonate del XVIII
secolo le quali, a differenza di quanto pensano gli storici della cultura, non
esprimono affatto solo una reazione all’eccessiva raffinatezza e un ritorno a una,
per altro fraintesa, vita naturale. Come del resto il contrat social di Rousseau, il
quale mediante il contratto crea un rapporto e una connessione tra i soggetti
indipendenti per natura, non si fonda su tale naturalismo. Questa è l’apparenza,
e soltanto l’apparenza estetica delle grandi e piccole robinsonate. Si tratta
piuttosto dell’anticipazione della «società civile» che si stava preparando dal XVI
secolo e che nel XVIII ha compiuto passi da gigante in direzione della sua
maturità. In questa società della libera concorrenza, l’individuo si svincola dai
legami naturali, ecc., che facevano di lui, nelle precedenti epoche storiche, un
accessorio di un determinato e circoscritto conglomerato umano. Ai profeti del
XVIII secolo, sulle cui spalle poggiano ancora completamente Smith e Ricardo,
questo individuo del XVIII secolo – che, da un lato, è il prodotto della
dissoluzione delle forme sociali feudali e, dall’altro, è il risultato delle nuove
forze produttive sviluppatesi a partire dal XVI secolo – sta dinanzi agli occhi
come un ideale che sarebbe esistito già in passato. Non come un risultato della
storia, bensì come il suo punto di partenza. Poiché per individuo naturale, in
conformità con la loro rappresentazione della natura umana, essi non intendono
un individuo che sorge storicamente, ma che invece è posto dalla natura stessa .
52
K. Marx, Introduzione alla critica dell’economia politica , trad. it. di G. Backhaus,
Quodlibet, Macerata 2010, pp. 11-12.
52
�442
RICCARDO FANCIULLACCI
Teorie come quella di Rousseau, ma anche di Hobbes, sarebbero dunque
un’«anticipazione» della conformazione concorrenziale della società civile del
XVIII secolo. Ma che tipo di relazione viene designata dall’espressione
“anticipazione” (Vorwegnahme)? L’opera di Althusser offre una risposta
articolata a questa domanda che Marx ha innanzitutto reso possibile, e persino
doveroso, formulare.
10. Innanzitutto, ad Althusser interessa rimarcare la peculiarità del cambio
di problematica operato da Marx e a cui abbiamo fatto riferimento poc’anzi.
Non si tratta semplicemente di discutere una teoria come quella hobbesiana
nella sua interna pretesa di validità. A questo proposito, Marx la liquida con la
seguente annotazione: «la produzione dell’individuo isolato all’esterno della
società […] è un’assurdità pari al formarsi di una lingua senza che esistano
individui che vivano e parlino assieme. Non è il caso di soffermarsi oltre su
questo tema» 53. Le prestazioni che Hobbes considera connaturare all’individuo
umano in quanto tale, ad esempio parlare, ma anche ipotizzare il possibile
decorso di azioni o avvenimenti, o ancora, valutare e porre in scala le proprie
preferenze e avversioni, sono prestazioni che hanno condizioni di emergenza
che oltrepassano l’esistenza di un singolo uomo. Il punto non è dato solo dal
fatto che un individuo deve apprenderle o riceverle da altri: prima ancora, si
tratta del fatto che non si possono per nulla costituire, né dunque possono
essere concepite, al di fuori di una condizione di socialità. Ora, questo tipo di
rilievo confuta la pretesa di validità dell’antropologia individualista
hobbesiana, ma non realizza ancora il cambio di problematica compiuto da
Marx. Quel tipo di rilievo, potremmo dire, consente di passare da
un’antropologia individualista a un’antropologia sociale: consente di porre la
categoria di socialità come indispensabile per pensare le prestazioni proprie di
un soggetto, ma non fuoriesce ancora dalla problematica filosoficoantropologica. Come già sappiamo, tale uscita richiede di passare ad
esaminare concretamente le società storiche e il loro sviluppo.
Solo quando si verifica questo passaggio, la filosofia è davvero presa alle
spalle: la sua problematica è spostata, dal sovratemporale “spazio delle
ragioni”, dove i pensieri si scontrano in una discussione argomentativa, alla
formazione sociale in cui quella discussione concretamente si svolge e da cui è
sovradeterminata. Nella fattispecie, non basta evidenziare il fondamento
sociale delle prestazioni che Hobbes attribuiva all’individuo come tale e
dunque agli individui nello stato di natura (cioè nello stato caratterizzato dal
grado zero di socialità), qui si tratta di mostrare il fondamento e l’origine
53
Marx, Introduzione alla critica dell’economia politica, pp. 12-13.
�443
Althusser di fronte a Hobbes. La critica dell’umanismo individualista
sociale della rappresentazione che pensa quelle prestazioni come connaturali
all’individuo. Grosso modo: solo in società l’uomo può elaborare
rappresentazioni, ma solo una certa società lo induce ad elaborare (o a
riconoscersi nell’elaborazione di) una rappresentazione in cui egli appare
naturalmente e spontaneamente capace, nella sua individualità, di elaborare
rappresentazioni. (Detto altrimenti: non si tratta solo di svelare il fondamento
sociale della capacità di produrre rappresentazioni, ma anche di svelare qual è
la società che tende a produrre quella specifica rappresentazione che è la
rappresentazione individualistica del produrre rappresentazioni, la
rappresentazione per cui il rappresentare e il pensare sarebbero prestazioni
individuali, cioè che non richiedono altro che un individuo) 54. Quale sia questa
specifica società non è qualcosa che la filosofia possa scoprire da sé operando
una critica interna di quella rappresentazione individualistica: lo si può
scoprire solo studiando sul campo i rapporti tra quella rappresentazione e la
società in cui è sorta o in cui ha preso piede – e tale studio richiede di avere a
disposizione una teoria riguardante che cosa sia una società e come si
coordinino i suoi elementi (tale teoria è, per Althusser, quella fondata da Marx
sotto il nome di materialismo storico).
La mossa appena chiarita non fa accedere genericamente alla socialità, ma a
una certa società ben determinata. A questo punto, però, resta da capire quali
fattezze rivela il discorso filosofico, ad esempio quello hobbesiano, una volta
che sia stato posto in relazione alla società in cui è stato elaborato e ha preso
piede. Né per Marx, né per Althusser si tratta semplicemente di esporre la
genesi storica di un errore: non si tratta di spiegare come abbia potuto essere
elaborato o prender piede un discorso che è falso perché considera connaturali
all’individuo delle prestazioni che invece presuppongono una socialità.
Nel compiere questa mossa che non consiste solo nel rilevare le condizioni sociali di una
certa prestazione mentale di cui l’umanismo individualista ritiene che il singolo uomo abbia
connaturata in sé la capacità di realizzarla, bensì nel rilevare le condizioni sociali che
presiedono alla produzione di questa rappresentazione umanistico-individualista, Marx ha dei
predecessori e non si tratta solo, né prima degli altri di Hegel. Specificatamente in rapporto a
Hobbes, ad esempio, già Montesquieu aveva rilevato le due seguenti cose: (a) Hobbes
«attribuisce agli uomini, prima dell’istituzione della società, ciò che accade soltanto dopo detta
istituzione, la quale può offrire i motivi per attaccare e difendersi»; Montesquieu, Lo spirito
delle leggi, p. 150 (Lib. I, cap 2). (Come già abbiamo chiarito, questa affermazione non va intesa
come se Montesquieu concepisse la società istituita da uomini che allo stato di natura sono da
intendere in modo diverso da come li ha intesi Hobbes, bensì nel modo seguente: ciò che
Hobbes ritiene possibile attribuire all’uomo al di fuori della società, presuppone invece la
società). (2) la paura che Hobbes ritiene sia il sentimento che sorge spontaneamente in
qualunque coesistenza, è in realtà il sentimento fondamentale di quella specifica forma di
coesistenza che è data dalle società dispotiche (cioè il cui regime è quello dispotico); cfr.
Althusser, Montesquieu, la politica e la storia, pp. 120-121.
54
�444
RICCARDO FANCIULLACCI
Innanzitutto, potremmo dire che in quel discorso sono isolate due componenti:
(a) quel che esso rappresenta, cioè quel che offre come contenuto della
rappresentazione in cui consiste, e (b) come rappresenta ciò che rappresenta.
Così, esso (a) rappresenta la coesistenza di una pluralità di individui liberi e
individualmente capaci di una serie di prestazioni e (b) tale coesistenza, la
rappresenta come la condizione naturale, cioè come la struttura di ogni
socialità. Ora, il secondo elemento è esaminato attraverso la teoria secondo cui
i discorsi filosofici sul contrattualismo servono la causa della borghesia: sono
contributi all’ideologia attraverso cui la borghesia si relaziona a sé e ai suoi
obiettivi (ad esempio presentandoli come conseguenze della natura umana). (E
se tale relazione della borghesia ai suoi obiettivi e, in generale, di una classe
sociale ai suoi obiettivi, sia da intendere come una relazione di
mascheramento di obiettivi particolari sotto la “forma illusoria dell’universale”
o se invece sia da intendere come una relazione più complessa, in cui è messo
in questione l’assunto per cui una classe avrebbe un accesso diretto ai suoi
obiettivi e interessi, ecco, questo problema lo lasceremo ora da parte, Osservo
solo che, se, ne L’ideologia tedesca, Marx ed Engels sembrano optare per la
prima scelta, il lavoro di Althusser può essere letto come una decostruzione
degli assunti di tale scelta). Quanto poi al primo elemento (a), la sua analisi
storico-materialista è più complicata.
Marx sembra suggerire che la rappresentazione della socialità come un
libero connettersi di individui dapprima isolati riflette una certa condizione
storia. Ma che cosa si nasconde e che cosa è presupposto in questa teoria del
riflesso? Per abbozzare una risposta, consideriamo dapprima quella
condizione in cui un individuo può ricontrattare i rapporti in cui è preso e
dunque non ne dipende interamente, cioè non ne dipende fino al punto di
essere solo un momento o un accessorio di tali rapporti. Tale condizione è
reale e, aggiunge Marx, si realizza nella società moderna. Si tratta della
condizione in cui la società si configura in maniera tale da lasciare ai suoi
membri margini più o meno ampi per ricontrattare la loro posizione in essa.
Quando la società si configura così, non è che diventi «praticamente vero» 55
che l’individuo non dipende dalla società, ma diventa «praticamente vero» che
non ne dipende come ne dipendeva prima, quando i rapporti di cui era parte
non erano da lui modificabili. Ora, questa condizione reale viene catturata in
qualche modo, più precisamente in modo astratto, da quella rappresentazione
che pone l’individuo come per sé indipendente dalla società. Abbiamo
dunque:
55
L’espressione è, come noto, di Marx e sta al centro del celebre terzo paragrafo di Marx,
Introduzione alla critica dell’economia politica, p. 40.
�445
Althusser di fronte a Hobbes. La critica dell’umanismo individualista
(i) una condizione storica reale caratterizzata da un accentuato grado di
isolamento degli individui: un certo grado di astrazione (cioè di
isolamento) qui è reale.
(ii) Una rappresentazione astratta (cioè inadeguata) di quella condizione
reale: è la rappresentazione individualistico-atomistica.
(iii) La teoria scientifica che descrive in maniera non astratta la condizione
reale di isolamento e che descrive poi il rapporto tra quella
condizione e la rappresentazione astratta che si diffonde là dove
quella condizione è realizzata. Questo rapporto è quello evocato, ma
nient’affatto pensato adeguatamente attraverso la parola “riflesso”:
l’astrazione reale (o praticamente vera) si rifletterebbe nella
rappresentazione filosofica astratta.
Althusser non ha mai veramente accettato questa metafora del riflesso, ma
non ha elaborato una chiara teoria con cui sostituirla 56. Ha però introdotto
Dello scetticismo althusseriano è prova anche l’ironia con cui commenta una delle più
note formule marxiane in cui si ritrovano gli effetti della metafora del riflesso, la formula
secondo cui: «l’umanità non si propone se non quei problemi che può risolvere» (K. Marx, Per
la critica dell’economia politica, trad. it. di E. Cantimori Mazzemonti, Editori Riuniti, Roma
1957, p. 5), formula che implica che quel che, in ogni data epoca l’umanità rende pensabile
attraverso le rappresentazioni diffuse, è anche tutto ciò che in ciascuna di quelle epoche ha da
pensare (per cui, ciò che un’epoca ha da pensare si rifletterebbe nell’ideologia che caratterizza
quell’epoca); cfr. ad esempio, L. Althusser, Marx dans ses limites, in Id., Écrits philosophique et
politiques, Tome I, Stock/Imec, Paris 1994, pp. 403 e 425. Quel che Althusser non accetta della
metafora del riflesso e del suo uso consueto, anche all’interno del marxismo, è innanzitutto
l’idea della relazione meccanica tra l’oggetto e il suo riflesso, il quale è effettivamente
calcolabile conoscendo l’oggetto, le leggi della rifrazione e le proprietà della superficie
riflettente: questa idea si traduce nella concezione della sovrastruttura e in particolare delle
forme dell’ideologica come determinate in maniera lineare da una base strutturale la cui
dinamica sarebbe del tutto autonoma e indipendente. Questa concezione, comunque, si
appoggia a una seconda idea veicolata dalla metafora del riflesso che, se possibile, è ancora più
fuorviante della prima: se l’ideologia o la rappresentazione è intesa come un riflesso della
realtà, allora è con ciò espulsa dalla realtà! Questo significa non affrontare il problema della
realtà (sociale) dell’ideologia e della relazione tra questa realtà e la realtà che vi si dovrebbe
riflettere (che è il problema della determinazione/surdeterminazione tra la dinamica produttiva
e le altre componenti della formazione sociale). Chiarito tutto questo, è giusto riconoscere che
talvolta Althusser usa la parola reflet per indicare (ma non per definire) la relazione tra
l’ideologia e la realtà di cui quella parla; cfr. ad esempio Per Marx, p. 46; ma anche, proprio in
riferimento a Hobbes, Politique et Histoire, de Machiavel à Marx, p. 379. Grosso modo, questa
relazione va parafrasata così: la “realtà” “riflessa” “nell’ideologia” è una configurazione in cui
sono presi dei gruppi i quali rappresentano, elaborano e riflettono la loro poszone in tale
configurazione e dunque la configurazione stessa in quella ideologia (e, in vero, in una pluralità
di ideologie, ciascuna delle quali è tale che un gruppo vi si riflette e riconosce più che nelle altre
56
�446
RICCARDO FANCIULLACCI
alcuni vincoli che tale teoria dovrebbe rispettare. Il primo è dato dal fatto che
tale teoria, piuttosto che farsi irretire dall’opposizione idealistica tra astratto e
concreto, tenga fermo lo sguardo sul nesso reale che deve cercare di rendere
pensabile: il nesso per cui, nella condizione storica indicata nel punto “i”,
viene elaborata e prende piede (cioè diventa socialmente significativa e non è
solo l’elucubrazione di un qualche pensatore isolato) una rappresentazione
(quella indicata nel punto “ii”) in cui coloro che si trovano in quella condizione
tendono a riconoscersi e a trovarvi espresse le loro questioni e i loro interessi (o
meglio, vi trovano risorse che tendono a sembrar loro adeguate ad articolare le
loro questioni e i loro obiettivi). (Se il riconoscersi in un discorso è per
Althusser la forma del rapporto con l’ideologia, tale riconoscimento è
tendenziale perché si realizza a gradi diversi a seconda della classe sociale
interessata 57: la borghesia, ad esempio, si riconosce negli assunti del
contrattualismo individualista ben di più di quanto non faccia la nobiltà, ad
esempio la nobiltà di toga cui era vicino Montesquieu 58).
Il secondo vincolo è dato dal fatto che la scoperta del nesso tra la
rappresentazione “ii” e la condizione “i” non si costituisca come una
legittimazione dialettica di quella rappresentazione. Quella rappresentazione,
presa per sé, è un’astrazione, ma riconoscervi il “riflesso” della condizione
storica “i”, non equivale a toglierle il carattere di astrazione per conservarla a
un livello più elevato. Quella rappresentazione non viene conservata come
verità dell’Idea assoluta a un dato momento del suo sviluppo storico. Non è
falsa in quanto isolata dalla storia e vera in quanto configurazione dello spirito
di una data epoca. Questo tipo di lettura sa certamente connettere la
rappresentazione che si presentava come sovrastorica alla storia, ma la
connette alla storia in quanto pensata attraverso categorie che non sono quelle
del materialismo storico. La reinscrizione della rappresentazione nella storia
compiuta da quest’ultimo non è l’Aufhebung di quella rappresentazione.
Il terzo vincolo è dato dal fatto che la reinscrizione della rappresentazione
filosofico-individualista nella storia non vale neppure come una sua immediata
sconfessione. Questo terzo vincolo è l’istanza anti-storicista che Althusser
difende. Se un discorso è invalidato dalla sua inscrizione storica, come può
pretendere di valere il discorso che opera tale iscrizione, cioè il discorso della
– sebbene tutti si riflettano e riconoscano almeno in parte nell’ideologia dominante, quella in
cui si riflette nel modo migliore il gruppo dominante).
Cfr. Althusser, Initiation à la philosophie pour les non-philosophe, pp. 257-258 ; cfr. anche,
per il rapporto in generale tra ideologia e riconoscimento, Per Marx, pp. 127-129.
Sul modo in cui Althusser elabora questo aspetto del pensiero di Montesquieu, mi sono
soffermato nel già citato: La presa di partito in filosofia. Sulla lettura althusseriana di
Montesquieu , in particolare alle pagine 21-24.
57
58
�447
Althusser di fronte a Hobbes. La critica dell’umanismo individualista
scienza, visto che anch’esso è elaborato nella storia? Se ogni categoria è solo un
riflesso di un’epoca, allora anche le categorie del materialismo storico sono
solo il riflesso dell’epoca presente. E se per difendere la loro validità, ci si
spinge ad affermare che l’epoca presente è quella che realizza la critica di sé,
per cui la sua coscienza è un’autocoscienza, ecco che ci si ritrova nuovamente
nelle secche dell’idealismo e dell’idea di sapere assoluto 59. A questo esito,
Althusser contrappone la teoria della pratica scientifica che egli ha elaborato
sulla scorta di Bachelard e Canguilhem: una pratica sociale caratterizzata da
una certa autonomia, che cerca di produrre conoscenze del suo oggetto (in
questo caso, dell’epoca storica) e che controlla e convalida le sue affermazioni
sottoponendole alla prova sperimentale sulla base di criteri distillati all’interno
della pratica scientifica stessa 60.
In questo senso, rilevare la connessione tra un discorso come quello di
Hobbes e la configurazione sociale del suo tempo non ha né l’effetto di
legittimare tale discorso in quell’epoca, né di sconfessarlo in quanto mero
riflesso di quell’epoca, ma ha l’effetto di gettare luce sugli ulteriori fattori che
surdeterminano il suo sviluppo, oltre alla sua logica interna, e che
surdeterminano l’elaborazione delle definizioni che vi fungono da premesse,
oltre all’introspezione e all’induzione realizzate, certamente con le più oneste
intenzioni, da Thomas Hobbes.
11. Sulla base dell’impianto analitico appena descritto, Althusser tematizza
concretamente le preoccupazioni pratico-politiche che gravano sulla libera
speculazione hobbesiana e rispetto alle quali il filosofo inglese prende partito
in un modo che non lascia immune il suo discorso – pur senza fare di questo
discorso una sorta di maschera retorico-ideologica (o, ancora, una
razionalizzazione) di quel partito. In particolare, Althusser arriva a complicare
la lettura marxista standard di Hobbes, cioè quella per cui nella sua
concezione del mondo umano come una coesistenza di libertà individuali
ciascuna preoccupata di estendere i propri godimenti e perciò in competizione
con le altre (che possono sottrargli ciò che vuole o ostacolarla e minacciare
altrimenti i suoi piani) si rifletterebbe la società di mercato e la competizione
che la caratterizza 61. La prima urgenza, per Hobbes, sarebbe invece stata quella
di rendere intellegibile quella condizione di guerra civile che anch’egli stava
concretamente vivendo in Inghilterra: si trattava di definirne la struttura logica
Cfr. Althusser, L’oggetto del “Capitale”, pp. 202-222.
Cfr. Althusser, Dal Capitale alla filosofia di Marx, pp. 39-63; Id., Pour Marx, pp. 161-170.
Rievoca questa lettura marxista, aggiungendo che però non è mai stata formulata
esplicitamente da Marx, anche L. Jaume, Hobbes et l’État représentatif moderne, Presses
Universitaires de France, Paris 1986, p. 27.
59
60
61
�448
RICCARDO FANCIULLACCI
di una tale condizione e dunque poi il profilo logico di una condizione
alternativa. Come Althusser scriverà in un celebre testo del 1982:
So bene che Hobbes ha in mente tutt’altra cosa che, come si è creduto, la
concorrenza economica, e cioè le grandi sedizioni di cui fu testimone (non si è
impunemente i contemporanei di Cromwell e dell’esecuzione di Carlo I) .
62
La questione di rendere pensabile la concorrenza economica e, preso partito
per essa, anche di giustificarla facendola apparire naturale, comunque, non è
assente, secondo Althusser, dalle preoccupazioni che surdeterminano la
ricerca hobbesiana sulla natura umana e sulle possibili configurazioni della
convivenza (dalla configurazione denominata stato di natura a quella
denominata stato civile, passando per quelle intermedie). L’idea di Althusser è
che Hobbes tenti di identificare (rendendole così concepibili o rappresentabili)
e di distinguere, da un alto, le condizioni delle concorrenza economica, che si
tratta di salvaguardare, e dall’altro lato, le condizioni della guerra civile, che si
tratta di debellare.
La nozione che Hobbes avrebbe offerto alla classe in ascesa perché questa
potesse rappresentarsi (e dunque anche pensare) il fondamento del suo potere,
cioè la nozione che Hobbes avrebbe distillato per la borghesia affinché questa
potesse rappresentare il libero mercato e la concorrenza economica 63, consiste
nell’idea di libertà come «libero sviluppo», ossia come individuale «potenza
utilitarista di espansione»: «è la tesi del liberalismo individualista» 64. Per
Hobbes, tuttavia, lo spazio in cui le libertà possano competere deve essere
strutturato in maniera tale da impedire che questa competizione diventi
contesa. La «morte metaforica» che si produce nella concorrenza mercantile va
separata dalla morte in senso stretto che accade nella guerra 65.
Hobbes ha per obiettivo di conservare e sviluppare il principio del liberalismo
individualista, ma sormontando lo stato di guerra .
66
All’interno di un’interpretazione come questa del pensiero di Hobbes,
un’interpretazione in cui, lo ripeto, la logica del discorso non è negata, ma è
considerata insieme alla presa di partito che la surdetermina, all’interno di una
simile interpretazione, tutti i concetti centrali del discorso hobbesiano vanno
considerati da due prospettive, anzi, da tre. La prima è quella, classicamente
filosofica, che li esamina in relazione al ruolo che occupano nello sviluppo
62
63
64
65
66
Althusser, Le courant souterrain du matérialisme de la rencontre, p. 567.
Cfr. Althusser, Politique et Histoire, de Machiavel à Marx, pp. 280 e 393.
Althusser, Politique et Histoire, de Machiavel à Marx, p. 269.
Althusser, Politique et Histoire, de Machiavel à Marx, p. 270.
Althusser, Politique et Histoire, de Machiavel à Marx, p. 270.
�449
Althusser di fronte a Hobbes. La critica dell’umanismo individualista
dell’argomentazione: ad esempio, la nozione di libertà è introdotta da Hobbes
fra i tratti essenziali di quel corpo che è l’uomo. La seconda prospettiva è
quella in cui le nozioni hobbesiane sono poste in connessione con le
rappresentazioni ideologiche (=socialmente operative) che quelle nozioni
contribuiscono ad articolare e definire: così, nella nozione hobbesiana di
libertà è qui riconosciuta una messa in forma della rappresentazione liberalista
ante litteram della libertà; quella nozione, articolando questa
rappresentazione, offre alla società di mercato uno degli strumenti attraverso
cui rappresentarsi e articolare le sue esigenze e i suoi interessi. La terza
prospettiva, infine, è quella in cui le nozioni hobbesiane sono poste in
connessione con la realtà sociale vera e propria, ossia, sono poste in
connessione con la realtà quale appare all’interno dello sguardo della scienza
storica. Qui si può vedere che la nozione hobbesiana di libertà e la
rappresentazione ideologica che mette in forma indicano un fenomeno, la
concorrenza, che non è affatto adeguatamente conoscibile per mezzo loro
(infatti, la scienza della storia, per Althusser, ha dimostrato che il mercato non
è lo spazio originario in cui concorrono libertà naturalmente intraprendenti).
Quanto illustrato in rapporto alla nozione di libertà va ora ripetuto in
rapporto alla nozione di stato di guerra, visto che la tesi althusseriana è che
l’obiettivo di Hobbes sarebbe separare la nozione liberale di libertà e di
concorrenza da quella di guerra. Ebbene, dall’interno della prima prospettiva,
quella che guarda al ruolo della nozione nella logica del discorso, bisogna
sottolineare questo: lo stato di guerra è introdotto da Hobbes come l’effetto
della struttura di un certo tipo di convivenza, quella denominata stato di
natura. Alla luce della seconda prospettiva, la nozione dello stato di guerra è
l’articolazione della rappresentazione drammatica della guerra civile inglese
elaborata da coloro che in quella guerra e nella rivoluzione avevano visto messi
a repentaglio le loro certezze, i loro interessi e le loro intraprese. Prima di
considerare la terza prospettiva, soffermiamoci ancora sul nesso tra quanto
emerge dalla prima e quanto emerge dalla seconda.
Nel Leviatano si mira a individuare qual è il tratto che è peculiare allo stato
di natura e che, se si presenta in una convivenza che sembrava ed era civile, la
corrompe e la porta verso quello stato, cioè, più precisamente, la fa degenerare
in una condizione di guerra civile 67. Questo tratto è dato dalla pretesa di ogni
La nozione hobbesiana di guerra civile dunque non designa ciò che designa la nozione di
stato di natura, bensì quella degenerazione di una convivenza civile che rende la configurazione
di quest’ultima il più vicino possibile alla configurazione dello stato di natura; cfr. Hobbes,
Leviatano, p. 209 (parte I, cap. XIII, § 11). Fatta salva questa distinzione tra due nozioni
hobbesiane che occupano posizioni diverse nella logica del discorso, è poi ben possibile
osservare che in entrambe le nozioni e soprattutto in quella che nel discorso riceve più spazio,
67
�450
RICCARDO FANCIULLACCI
libertà di poter disporre di tutta la sua potenza, cioè dal suo rifiuto di
qualunque limitazione che possa venire dalla potenza di un’altra: se ogni
libertà pretende di avere il potere, allora non ci può essere un potere che
ordina, ma solo l’anarchia della guerra 68. Per disattivare questa sequenza,
occorre istituire la figura del sovrano dotato di potere assoluto sui suoi sudditi.
In un corso tenuto all’École Normale Supérieure nel 1971-72 e interamente
dedicato a Hobbes, Althusser ricorda che «le funzioni dell’assolutismo sono di
“impedire la guerra civile” (le fazioni) […] di assicurare la libertà individuale
sul piano economico» 69. (D’altronde, come anche Althusser ricorda, lo stesso
Hobbes, nel De Cive, aveva scritto: «I governanti non possono contribuire
meglio alla felicità [felicitas] dei loro sudditi che dando loro la possibilità di
fruire dei prodotti del loro lavoro, sicuri dalla guerra e dalle lotte civili») 70. In
un altro corso, di sei anni prima, da cui ho già tratto alcune delle ultime
citazioni, il filosofo francese era stato ancora più esplicito nel formulare il
«paradosso generale» di Hobbes: «far coabitare l’assolutismo del potere
sovrano [col fatto che questo] deve intervenire il meno possibile. Assolutismo
liberale. […] L’assolutismo ha per fine il liberalismo, cioè il godimento dei
risultati dell’industria» 71. In effetti, Hobbes, nell’illustrare il contenuto della sua
nozione di stato di natura (nozione in cui, come ci insegna la seconda
prospettiva, si rifletteva e si definiva una rappresentazione socialmente diffusa
della guerra civile inglese) offre un ritratto drammatico di come in tale stato
ogni attività, economica, ma non solo, sia paralizzata:
In tale condizione non c’è spazio per l’operosità, perché il suo frutto è incerto e,
di conseguenza, non c’è coltivazione della terra, né navigazione, né uso delle
merci che si possono importare per mare, né edifici comodi, né strumentí per
muovere e rimuovere cose che richiedono molta forza, né conoscenza della
cioè nella nozione di stato di natura, Hobbes offre un’articolazione di una delle
rappresentazioni socialmente operative della guerra civile inglese e della rivoluzione che ha
portato alla morte di Carlo I. (Nel già annunciato scritto che completerà quello presente, mi
soffermerò in maniera più analitica sulla distinzione e la relazione tra le due nozioni
hobbesiane di stato di natura e di guerra civile e, nel farlo, discuterò anche la diversa
interpretazione che di questa snodo del pensiero hobbesiano ha offerto Giorgio Agamben nel
suo: Stasis. La guerra civile come paradigma politico. (Homo sacer, II 2), Bollati Boringhieri,
Torino 2015).
Per l’associazione tra lo stato di natura (e il bellum omnium contra omnes) e l’anarchia,
cfr. Hobbes, Elementi filosofici sul cittadino, p. 191 (cap. VII, § 5).
Althusser, Politique et Histoire, de Machiavel à Marx, p. 392. Il corso del 1971-72 occupa
le pagine 367-393.
Hobbes, Elementi filosofici sul cittadino, p. 273 (parte II, cap. XIII, § 6).
Althusser, Politique et Histoire, de Machiavel à Marx, p. 280. Nel corso del 1965-66,
dedicato a Rousseau et ses prédècesseurs, la parte dedicata a Hobbes (e in particolare al De
Cive) occupa le pagine 264-280.
68
69
70
71
�451
Althusser di fronte a Hobbes. La critica dell’umanismo individualista
superficie terrestre, né calcolo del tempo, né arti, né lettere, né società e, cosa
che è la peggiore, ci sono la continua paura e il continuo pericolo di morte
violenta e la vita di un uomo è solitaria, povera, sofferta, brutale e breve .
72
Qual è però la vera realtà che emerge nella guerra civile? Si tratta forse
dell’irrazionale riaffiorare in alcune libertà individuali di quella pretesa
illimitata e di quella sete di potere che nello stato di natura sono senza
controllo? Questa è l’idea di Hobbes che in effetti contribuisce a rappresentare
la guerra civile come una condizione simile a quella dello stato di natura. Le
domande appena formulate, in realtà, possono essere trattate solo accedendo
all’ultima delle tre prospettive evocate in precedenza: solo la scienza sociale,
che per Althusser coincide con il materialismo storico, può rispondere perché
solo questa scienza dispone dei concetti che rivelano la vera struttura e la vera
dinamica sociali. Ebbene, pur non sviluppando la risposta, Althusser offre in
proposito un’indicazione importante: al di sotto delle fazioni che si scontrano
nella guerra civile occorre saper vedere una certa fase della lotta di classe.
Ecco dunque come Althusser riformula l’obiettivo ultimo cui obbedisce la
costruzione teorica (e non meramente retorico-strumentale) di Hobbes e
dunque anche l’individualismo umanistico che ne costituisce uno dei pilastri
centrali:
Hobbes non intende forse conservare il capitalismo individuale [cioè
concorrenziale] sul piano economico, insieme trovando una soluzione alla lotta
violenta delle classi? Come risolvere il problema della lotta di classe?
73
E ancora:
Hobbes assicura il trionfo del liberalismo con le armi dell’assolutismo. Lo Stato
ha una doppia funzione: potere assoluto per sopprimere la lotta delle classi e
intervenire il meno possibile sul piano economico.[… Hobbes] assicura le
condizioni della sicurezza della classe borghese.
74
72
73
74
Hobbes, Leviatano, p. 207 (parte I, cap. XIII, § 9).
Althusser, Politique et Histoire, de Machiavel à Marx, p. 379.
Althusser, Politique et Histoire, de Machiavel à Marx, pp. 392-393.
�452
�453
INFORMATION ON THE JOURNAL
Etica & Politica/Ethics & Politics is an open access philosophical journal,
being published only in an electronic format.
The journal aims at promoting research and reflection, both historically and
theoretically, in the field of moral and political philosophy, with no cultural
preclusion or adhesion to any cultural current.
Contributions should be submitted in one of these languages: Italian,
English, French, German, Portuguese, Spanish.
All essays should include an English abstract of max. 200 words.
The editorial staff especially welcomes interdisciplinary contributions with
special attention to the main trends of the world of practice.
The journal has an anonymous double peer review referee system.
Three issues per year are expected.
The copyright of the published articles remain to the authors. We ask that in
any future use of them Etica & Politica/Ethics & Politics be quoted as a source.
All products on this site are released with a Creative Commons license (CC
BY-NC-SA 2.5 IT) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/
ETICA & POLITICA/ETHICS & POLITICS POSITION ON PUBLISHING
ETHICS.
The Editors of Etica & Politica/Ethics & Politics have taken every possible
measure to ensure the quality of the material here published and, in particular,
they guarantee that peer review at their journal is fair, unbiased and timely, and
that all papers have been reviewed by unprejudiced and qualified reviewers.
The publication of an article through a peer-review process is intended as an
essential feature of any serious scientific community. The decision to accept or
reject a paper for publication is based on the paper’s relevance, originality and
clarity, the study’s validity and its relevance to the mission of the journal. In
order to guarantee the quality of the published papers, the Editors encourage
reviewers to provide detailed comments to motivate their decisions. The
comments will help the Editorial Board to decide the outcome of the paper, and
will help to justify this decision to the author. If the paper is accepted with the
request of revision, the comments should guide the author in making the
�454
revisions for the final manuscript. All material submitted to the journal remains
confidential while under review.
Once the author receives a positive answer, he/she should send the final
version of the article since proofs will not be sent to him/her. E&P will publish
the paper within twelve months from the moment of the acceptance, and the
author will be informed of the publication.
The journal is committed to such standards as originality in research papers,
precise references in discussing other scholars’ positions, avoiding plagiarism.
E&P takes these standards extremely seriously, because we think that they
embody scientific method and are the mark of real scholarly communication.
Since Etica & Politica/Ethics & Politics is devoted solely to scientific and
academic quality, the journal neither has any submission charges nor any
article processing charges.
The following guidelines are based on existing Elsevier policies and COPE’s
Best Practice Guidelines for Journal Editors
1. PUBLICATION AND AUTHORSHIP
EUT (Edizioni Università di Trieste), is the publisher of the peer reviewed
international journal Etica & Politica/Ethics & Politics .
The publication of an article in a peer-reviewed journal is an essential step of
a coherent and respected network of knowledge. It is a direct reflection of the
quality of the work of the authors and the institutions that support them. Peerreviewed articles support and embody the scientific method. It is therefore
important to agree upon standards of expected ethical behaviour for all parties
involved in the act of publishing: the author, the journal editor, the peer
reviewer, the publisher.
Authors need to ensure that the submitted article is the work of the
submitting author(s) and is not plagiarized, wholly or in part. They must also
make sure that the submitted article is original, is not wholly or in part a republication of the author’s earlier work, and contains no fraudulent data.
It is also their responsibility to check that all copyrighted material within the
article has permission for publication and that material for which the author
does not personally hold copyright is not reproduced without permission.
Finally, authors should ensure that the manuscript submitted is not currently
being considered for publication elsewhere.
�455
2. AUTHOR’S RESPONSIBILITIES
Etica & Politica/Ethics & Politics is a peer-reviewed journal, and Authors are
obliged to participate in our double blind peer review process.
Authors must make sure that all and only the contributors to the article are
listed as authors. Authors should also ensure that all authors provide retractions
or corrections of mistakes.
3. PEER REVIEW AND REVIEWERS’ RESPONSIBILITIES
Both the Referee and the Author remain anonymous throughout the “double
blind” review process. Referees are selected according to their expertise in their
particular fields.
Referees have a responsibility to be objective in their judgments; to have no
conflict of interest with respect to the research, with respect to the authors
and/or with respect to the research funders; to point out relevant published
work which is not yet cited by the author(s); and to treat the reviewed articles
confidentially.
4. EDITORIAL RESPONSIBILITIES
Editors hold full authority to reject/accept an article; to accept a paper only
when reasonably certain; to promote publication of corrections or retractions
when errors are found; to preserve anonymity of reviewers; and to have no
conflict of interest with respect to articles they reject/accept. If an Editor feels
that there is likely to be a perception of a conflict of interest in relation to their
handling of a submission, they will declare it to the other Editors. The other
Editors will select referees and make all decisions on the paper.
5. PUBLISHING ETHICS ISSUES
Members of the Editorial Board ensure the monitoring and safeguarding of
the publishing ethics. This comprises the strict policy on plagiarism and
fraudulent data, the strong commitment to publish corrections, clarifications,
retractions and apologies when needed, and the strict preclusion of business
needs from compromising intellectual and ethical standards.
Whenever it is recognized that a published paper contains a significant
inaccuracy, misleading statement or distorted report, it will be corrected
promptly. If, after an appropriate investigation, an item proves to be fraudulent,
�456
it will be retracted. The retraction will be clearly identifiable to readers and
indexing systems.
PAST ISSUES AND STATISTICS
Past issues with download and visitors statistics for each article are provided
here: http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/4673
EDITOR:
RICCARDO FANCIULLACCI (Venezia) riccardofanciullacci@libero.it
PIERPAOLO MARRONE (Trieste) marrone@units.it
EDITORIAL BOARD:
ELVIO BACCARINI (Rijeka) ebaccarini@ffri.hr
ROBERTO FESTA (Trieste) festa@units.it
GIOVANNI GIORGINI (Bologna) giovanni.giorgini@unibo.it
EDOARDO GREBLO (Trieste) edgreblo@tin.it
FABIO POLIDORI (Trieste) polidori@units.it
WEBMASTER:
ENRICO MARCHETTO (Trieste) enrico.marchetto@gmail.com
ITALIAN ADVISORY AND SCIENTIFIC BOARD:
B. ACCARINO (Firenze), A. ALLEGRA (Perugia), G. ALLINEY (Macerata), S.
AMATO (Catania), M. ANZALONE (Napoli), D. ARDILLI (Modena), F.
ARONADIO (Roma), G. AZZONI (Pavia), F. BACCHINI (Sassari), E. BERTI
(Padova), M. BETTETINI (Milano), P. BETTINESCHI (Venezia), P. BIASETTI
(Padova), G. BISTAGNINO (Milano) R. CAPORALI (Bologna), A.A. CASSI
(Bergamo), G. CATAPANO (Padova), M. COSSUTTA (Trieste), L. COVA (Trieste),
S. CREMASCHI (Vercelli), G. CEVOLANI (Modena), R. CRISTIN (Trieste), U.
CURI (Padova), A. DA RE (Padova), G. DE ANNA (Udine), P. DONATELLI
(Roma), P. DONINI (Milano), M. FARAGUNA (Milano), M. FERRARIS (Torino), L.
FLORIDI (Oxford), R. FREGA (Bologna), S. FUSELLI (Verona), A. FUSSI (Pisa), C.
GALLI (Bologna), R. GIOVAGNOLI (Roma), P. KOBAU (Torino), E. IRRERA
�457
(Bologna), E. LECALDANO (Roma), L.A. MACOR (Oxford), E. MANGANARO
(Trieste), G. MANIACI (Palermo), R. MARTINELLI (Trieste), F.G. MENGA
(Tübingen), R. MORDACCI (Milano), V. MORFINO (Milano), B. DE MORI
(Padova), M. PAGANO (Vercelli), G. PELLEGRINO (Roma), V. RASINI (ModenaReggio Emilia), M. REICHLIN (Milano), M. RENZO (Stirling), A. RIGOBELLO
(Roma), P.A. ROVATTI (Trieste), S. SEMPLICI (Roma), A. SCHIAVELLO
(Palermo), A. SCIUMÈ (Bergamo), M. SGARBI (Venezia), F. TOTO (Roma), F.
TRABATTONI (Milano), F. TRIFIRÒ (London), M.S. VACCAREZZA (Genova), C.
VIGNA (Venezia), P. VIGNOLA (Guayaquil)
INTERNATIONAL ADVISORY AND SCIENTIFIC BOARD:
J. ALLAN (New Zealand), K. BALLESTREM (Germany), T. Bedorf (Germany),
G. BETZ (Germany), W. BLOCK (USA), M. BYRON (USA), S. CHAMBERS
(Canada), J. COLEMAN (UK), C. COWLEY (Ireland), W. EDELGLASS (USA), C.L.
GESHEKTER (USA), A. KALYVAS (USA), J. KELEMEN (Hungary), F. KLAMPFER
(Slovenia), M. KNOLL (Turkey), C. ILLIES (Germany), D. INNERARITY (Spain),
A. LEVER (Switzerland), H. LINDAHL (Netherlands), J. M ARTI (Spain), M.
MATULOVIC (Croatia), J. M CCORMICK (USA), N. MISCEVIC (Croatia), A.
MOLES (Hungary), L. PAULSON (France), A. PRZYLESBSKI (Poland), J. QUONG
(USA) V. RAKIC (Serbia), A. SCHAAP (UK), B. SCHULTZ (USA), N. TARCOV
(USA), D. WEBB (UK), J.P. ZAMORA BONILLA (Spain)
REFEREES LIST FOR 2017:
B. ACCARINO (Università di Firenze), L. ALICI (Università di Macerata), A.
ALTOBRANDO (China University of Politics and Law, Pechino) A. ALLEGRA
(Università per Stranieri, Perugia), S. AMATO (Università di Catania), P.
BETTINESCHI (Università di Padova), S. BIANCU (LUMSA, Roma), M.
BALLISTRERI (Università di Torino), M. BETTETINI (IULM, Milano), C.
CANULLO (Università di Macerata), R. CAPORALI (Università di Bologna), G.
CEVOLANI (IMT, Lucca), F. CIARAMELLI (Università di Napoli, Federico II), A.
CISLAGHI (Università di Trieste), R, CRISTIN (Università di Trieste), G. DE
ANNA (Università di Udine), P. DONATELLI (Università di Roma, La Sapienza),
A. FABRIS (Università di Pisa), S. FERRANDO (Université de Strasbourg), A.
FUSSI (Università di Pisa), C. GERBAZ (Università di Rijeka), B. GIOVANOLA
(Università di Macerata), G. GRANDI (Università di Padova), L. GRECO
(Università di Oxford), M.L. LANZILLO (Università di Bologna), G. MANIACI
(Università di Palermo), R. MARTINELLI (Università di Trieste), F. MENGA
(Università di Tubinga), F. MIANO (Università di Roma, Tor Vergata), M.
�458
MONALDI (Università di Trieste), R. MORDACCI (Università San Raffaele,
Milano), B. DE MORI (Università di Padova), G. PELLEGRRINO (LUISS, Roma),
U. POMARICI (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”), V. RASINI
(Università di Modena e Reggio Emilia), C. ROFENA (Università Ca’ Foscari,
Venezia), A. SCHIAVELLO (Università di Palermo), P. ŠUSTAR (Università di
Rijeka), M. TROBOK (Università di Rijeka), F, TUROLDO (Università Ca’ Foscari,
Venezia), M. VACCAREZZA (Università di Genova), S. ZANARDO (Università
Europea di Roma)
�
 Vittorio Morfino
Vittorio Morfino Tommaso Gazzolo
Tommaso Gazzolo Agostino Cera
Agostino Cera Etica & Politica / Ethics & Politics
Etica & Politica / Ethics & Politics Ferdinando Menga
Ferdinando Menga F. Manti
F. Manti