Vendetta e multiculturalismo
in G. Lorini. M. Masia (a cura di) Antropologia della Vendetta, Edizioni scientifiche
itaiane-ESI, 2015, pp. 271-290
Ilenia Ruggiu
Università di Cagliari
1. Il “ritorno” della vendetta come istituto giuridico attraverso i conflitti
multiculturali.
La vendetta intesa come istituto giuridico è progressivamente scomparsa con l’affermarsi
dello Stato, nel cui ambito è stata sostituita dal processo: il diritto/dovere di vendetta della
cosiddetta folk law diviene diritto di difesa delle proprie ragioni e interessi in qualunque grado di
giudizio nell’art. 24 Costituzione italiana. Anche quelle che potevano considerarsi forme di
vendetta incorporate dall’ordinamento statuale come il duello o il delitto d’onore, sanzionati con
minori pene edittali, sono state via via espunte1. Resta, ancora oggi in molti ordinamenti, la pena di
morte, che appare una forma di vendetta legalizzata, ma anch’essa è in qualche modo disciplinata,
presa sotto custodia dallo Stato. Con l’affermarsi della statualità ogni forma di vendetta è stata
sottratta al singolo2 e gli atti di vendetta, che pure continuano ad accadere nell’effettività, sono
repressi e considerati devianze, che suscitano una aspra reazione dell’apparato sanzionatorio
statuale.
A fronte di questo quadro che tratta la vendetta come devianza, allontanando l’istituto dalla
dimensione giuridica che già Antonio Pigliaru3 vi scorgeva, nelle ultime decadi, si registra un
ritorno della vendetta all’attenzione dei giuristi come “norma”, in quella dimensione che la vede
come parte di un ordinamento giuridico. La vendetta ritorna in tale dimensione sotto forma di
considerazione, da parte dei giudici, del fattore culturale e dei reati culturalmente motivati4 a
seguito dell’apertura degli ordinamenti alle istanze del multiculturalismo. Come presto vedremo, i
1
In Italia fu con la legge n. 442 del 5 agosto 1981 che venne abrogato il delitto d’onore previsto dall’art. 587 c.p.:
“Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione
carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre
a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima
relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella”.
2
Non ho, in questa sede, il tempo di esaminare le implicazioni positive e negative di tale trasformazione per le quali
rinvio a Remo Bodei, Geometria delle passioni. Paura, speranza, felicità: filosofia e uso politico, Feltrinelli, Milano,
1991, 10: “Almeno dai tempi di Stendhal e di Tocqueville, viene sistematicamente denunciata l’eclissi delle grandi e
nobili passioni a causa del prevalere del calcolo egoistico, della vanità individuale e, soprattutto, dell’accresciuta
sicurezza della vita. Assumendosi progressivamente il compito di tutelare l’individuo nei momenti critici dell’esistenza
(nascita, infanzia, vecchiaia, malattia) e facendosi carico di risarcirlo, secondo giustizia, di fronte alle offese subìte –
ossia vietandogli ogni coinvolgimento in spirali di vendetta privata -, lo Stato, in un certo modo, si arrogherebbe il
monopolio legittimo di alcune delle passioni più forti ed esclusive. L’assenza di passioni, e non la passione stessa,
diventa ora il vero peccato”.
3
Antonio Pigliaru, La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico, Giuffrè, Milano, 1959.
4
La formula “reati culturalmente motivati” è stata teorizzata da J. Van Broeck, Cultural defence and culturally
motivated crimes (cultural offences), in European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, vol. 9/1, 2001,
1–32, che li definisce come “il comportamento realizzato da un membro appartenente ad una cultura di minoranza, che
è considerato reato nell’ordinamento giuridico della cultura dominante. Questo stesso comportamento, tuttavia,
all’interno del gruppo culturale dell’agente è condonato o accettato come comportamento normale o, addirittura, è
sostenuto e incoraggiato in determinate situazioni”. Per un’analisi dei reati culturalmente motivati da parte della dottrina
penalistica Cristina De Maglie, I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali, Edizioni ETS, Pisa, 2010;
Fabio Basile, Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali, Cedam, Padova,
2010.
�giudici quasi mai sono adesivi o giustificano forme di vendetta, tuttavia, in certi casi danno loro
rilevanza e, comunque, in qualche modo la vendetta rileva nell’argomentazione – e questo mi
sembra l’aspetto più rilevante – non più come una devianza individuale, bensì come una norma che
appartiene ad un altro ordinamento giuridico, quello culturale. Mi pare cioè possa dirsi, con le
precisazioni che vedremo, che l’idea della vendetta come istituto giuridico di un diritto popolare
(folk law) sia ricomparsa, non solo nel mondo accademico (dove, in effetti, non è mai tramontata),
ma anche a livello giurisprudenziale che, con atteggiamento post-positivistico, si rivela sempre più
attento alla teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici come inverata nel multiculturalismo.
Per cercare di dimostrare quanto affermato, inizierò la mia riflessione ricostruendo le due
principali teorizzazioni che attualmente ricevono i comportamenti culturalmente motivati – tra cui
quelli qualificabili come forme di vendette – nell’ambito degli studi sul multiculturalismo (par. 2).
Quindi, illustrerò alcuni casi giurisprudenziali di vendetta per verificare se e quando i
giudici le hanno riconosciuto una qualche rilevanza. I casi che coinvolgono latu sensu forme di
vendetta si collocano tra l’ampia messe di hard cases del multiculturalismo: essi vengono in genere
utilizzati per testare i limiti di quest’ultimo; in questo contributo li analizzerò per capire in che
modo i giudici chiamati a risolvere conflitti multiculturali si pongano rispetto a diverse forme di
vendetta e diano soluzioni più o meno diversificate ai casi (par. 3).
Nell’ultimo paragrafo, infine, vorrei sviluppare criticamente un dato che emerge dall’analisi
compiuta: l’approccio alla vendetta come “norma” di folk law riguarda sempre culture altre, le
culture degli immigrati e non spiega mai comportamenti che hanno luogo nella nostra cultura (es. i
femminicidi) a cui invece di culturalmente normativo non viene riconosciuto alcunchè,
considerandoli pure devianze individuali. Cercherò di interrogarmi sul perché di questa discrasia
nella classificazione della vendetta e sugli effetti che essa produce, chiedendomi se per caso essa
non perpetui, foucaultianamente, un discorso di potere e di allontanamento dell’altro e non
impedisca un ragionamento d’insieme su alcuni fenomeni comuni (par. 4).
2. L’inquadramento della vendetta nelle teorie del multiculturalismo.
Nelle ultime decadi gli ordinamenti occidentali hanno dovuto affrontare una profonda
trasformazione in senso multiculturale delle società. Ciò ha determinato una serie di conflitti dati
dal fatto che il comportamento di soggetti appartenenti a culture altre, pienamente legittimo se non
doveroso nel gruppo di appartenenza, confliggeva con le norme dell’ordinamento giuridico statuale:
dal Sikh che vuole indossare il suo coltello rituale (kirpan) e incorre nel reato di porto abusivo
d’arma, al genitore ebreo che vuole circoncidere il figlio rischiando di integrare il reato di lesioni,
alla donna islamica che indossa il burqa violando legge che vieta la presenza in spazi pubblici
mascherati, i conflitti multiculturali hanno, negli ultimi decenni, messo a prova soprattutto i giudici.
Ciò è avvenuto principalmente per la mancanza di chiari riferimenti normativi, a loro volta
conseguenza del fatto che il dibattito è ancora in corso e che manca una compiuta teoria
costituzionale intorno alla cultura.
La concettualizzazione dei conflitti multiculturali ha visto l’elaborazione, da parte della
dottrina giuridica, di almeno due orientamenti. Di seguito li descriverò riflettendo sulle
conseguenze che la loro applicazione può avere nell’analisi dei comportamenti culturalmente
motivati che implicano forme di vendetta.
Un primo orientamento tende a ricostruire il comportamento culturale nell’ambito della
teoria dei diritti fondamentali, che andrebbe arricchita dalla previsione di una nuova categoria di
diritti: i diritti culturali, necessari al singolo o al gruppo (essendo ancora discusso se si tratti di
diritti individuali o collettivi) per tutelare la propria identità. Il dibattito sui diritti culturali può
riassumersi in alcune date simboliche. Il 1966, con l’approvazione dell’art. 27 del Patto
internazionale sui diritti civili, economici e sociali, segna la loro data di nascita a livello
�internazionale5. Il 1982 segna l’ingresso del principio multiculturalista nel diritto costituzionale, con
l’approvazione dell’art. 27 della Costituzione canadese che si impegna a proteggere il patrimonio
multiculturale di tutti i canadesi e la codificazione, all’art. 35, dei diritti aborigeni per una
minoranza specifica, quella dei popoli nativi. Da allora circa 50 costituzioni al mondo, delle oltre
190 esistenti, hanno dato riconoscimento o a diritti culturali rivolti a specifiche minoranze (popoli
indigeni o altre minoranze nazionali) o a diritti culturali riconosciuti all’individuo in quanto tale,
aperti quindi ad incorporare qualsiasi tipo di gruppo e di pratica. Il fenomeno riguarda
prevalentemente il Sudamerica e l’Africa e coinvolge meno il continente europeo.
Chi aderisce a tale posizione tende a sostenere che il comportamento quando è riconducibile
alla cultura del soggetto ha luogo nell’esercizio di un diritto culturale e può incontrare, pertanto, la
scriminante dell’esercizio del diritto, in certi casi anche a livello penale, sempre che non intacchi
beni giuridici essenziali quali la vita o l’integrità fisica. Ciò avviene, in particolare, se si tratta di
una pratica che ha un fondamento religioso come accaduto in Italia nei riguardi dei Sikh cui è stato
riconosciuto di indossare il kirpan, nonostante questo comportamento nella nostra cultura integri il
reato di porto abusivo d’arma, perché ritenuto nell’esercizio della libertà religiosa6. In generale,
essendo la libertà religiosa riconosciuta in tutti i testi costituzionali esistenti, quando viene in rilievo
una pratica che ha un fondamento religioso il giudice si muove all’interno della teoria dei diritti
fondamentali usando le ben note tecniche di bilanciamento tra diritti. Vi sono poi alcuni
ordinamenti, come detto, che hanno dato autonomo riconoscimento anche a diritti culturali privi di
una connessione con la religione, ma non sono certo la maggioranza per cui è possibile affermare
che la persistente distinzione che il diritto costituzionale effettua tra cultura e religione ha delle
conseguenze importanti nell’impostazione e soluzione di un conflitto a seconda che la pratica
controversa sia inquadrata sub specie cultura o sub specie religione.
L’applicazione di questa costruzione teorica, che legge la cultura come un diritto, alla
vendetta presupporrebbe che esista un diritto culturale alla vendetta, connesso all’identità di un
gruppo. In termini pratici, invero, la risoluzione del conflitto multiculturale non cambia perché
probabilmente in questo caso i giudici ricorrerebbero alle tecniche del bilanciamento, per cui il
diritto culturale cederebbe di fronte al superiore diritto alla vita e all’integrità fisica. Ad ogni modo,
nella consapevolezza che molte regole culturali risultano antitetiche all’ordinamento giuridico
statuale, è interessante osservare come diverse Costituzioni di Stati africani abbiano voluto inserire
nelle costituzioni formule che subordinano il riconoscimento di diritti culturali al limite dei diritti
umani ammettendone l’implicita potenziale conflittualità.
Un secondo orientamento nega alla cultura la natura di diritto, tanto meno costituzionale,
costruendola piuttosto come fonte, precisamente come consuetudine. E’ stata la Corte di Cassazione
italiana, nel panorama comparato, ad elaborare in modo più compiuto tale ricostruzione: da un lato
riconoscendo alla cultura la dignità di un sistema normativo, nel contempo inserendola all’interno
del più complesso sistema delle fonti italiano e offrendo dei meccanismi di risoluzione
dell’antinomia tra le fonti. Il giudice – dice la Corte di Cassazione italiana – deve operare come
“mediatore culturale”, tendenzialmente riconoscendo rilevanza alla cultura che è costruita come
consuetudine, appunto come una regola, che può trovare riconoscimento nel nostro ordinamento,
ma soltanto alla condizione7 che non contrasti con i principi costituzionali e con le norme del diritto
penale poste a presidio di tali principi.
Il riferimento alla pratica culturale come consuetudine, prassi, costume appare, a mio avviso,
pienamente plausibile. Se nelle più attuali definizioni antropologiche la cultura è un sistema
5
L’art. 27, sancisce la nuova categoria del “diritto ad una vita culturale propria” riconosciuto a tutte le minoranze,
nazionali, ma anche immigrate, come avrà modo di chiarire il General Comment n. 23, The rights of minorities, dell’8
aprile 1994.
6
Trib. Cremona, 19 febbraio 2009, n. 15.
7
Ho più diffusamente analizzato la costruzione che fa propria la giurisprudenza italiana del concetto di cultura,
comparandola con le opzioni di altri ordinamenti in Ilenia Ruggiu, Il giudice antropologo. Costituzione e tecniche di
composizione dei conflitti multiculturali, Franco Angeli, Milano, 2012.
�interconnesso di segni, uno spazio semiotico coerente in cui avviene una comunicazione, da una
prospettiva giuridica la cultura può essere definita come un insieme di norme non scritte che dà vita
ad un ordinamento. Non ho, nell’economia del presente lavoro, occasione di affrontare il tema dei
“confini” di tale ordinamento: se in esso, ad esempio, rientri anche ciò che è mera regolarità, ogni
comportamento che accade o, viceversa, soltanto ciò che riceve una consapevole adesione e viene
riconosciuto come dotato di valore dai componenti il gruppo, tuttavia, fatta salva la problematica
della delimitazione dei confini, la lettura della cultura come un ordinamento normativo appare
convincente.
Dal punto di vista pratico, la concettualizzazione della vendetta nell’uno o nell’altro
orientamento non produce conseguenze significative: in entrambi i casi, infatti, appare difficile che
la vendetta trovi riconoscimento dall’ordinamento statuale, nel primo caso in quanto soccombente
nel bilanciamento con altri diritti, nel secondo caso in quanto fonte subordinata.
Tuttavia, a fronte di tali due orientamenti teorici che usano o la teoria dei diritti
fondamentali o quella delle fonti per inquadrare i comportamenti culturali, il panorama
giurisprudenziale offre un quadro più frammentato e diversificato. Si passa dall’estremo di giudici
che ignorano totalmente le componenti culturali di un comportamento, ad altri in cui, pur venendo
compromessi beni essenziali dell’ordinamento come la vita o l’integrità fisica, si è sensibili alle
motivazioni culturali. In alcune sentenze, infatti, è dato cogliere una totale adesione da parte del
giudice ad un ragionamento relativistico, more anthropologico basato sulla interiorizzazione della
quintessenza di tale pensiero ossia che tutti gli esseri umani vedono il mondo in modo diverso e che
c’è una sorta di determinismo comportamentale che può derivare dall’appartenere ad un certo
gruppo culturale. Il giudice si immerge talmente tanto nella altrui visione del mondo e la fa propria,
arrivando ad un’assoluzione o un’attenuazione notevole della pena. Nel tema che ci riguarda, è
come se il giudice prenda atto che il soggetto non poteva sottrarsi all’imperativo della vendetta e,
spesso utilizzando strumenti dello stesso ordinamento statuale (temporanea infermità di mente,
attenuante della provocazione), tenga conto di questa ineluttabilità.
L’analisi di alcuni casi giurisprudenziali dimostra come la vendetta ha avuto diverse
configurazioni nell’argomentazione giudiziale: talvolta è stata trattata come norma culturale, talaltra
come infermità di mente, talaltra come devianza personale. Nell’economia del presente lavoro mi
limiterò ad alcuni casi esemplari occorsi negli Stati Uniti e in Italia, ma preciso che i fenomeni
descritti sono comuni e ricorrenti in molte società multiculturali.
3. La vendetta nell’argomentazione giudiziale: tra devianza individuale e norma
culturale.
I primi casi di conflitti multiculturali coinvolgenti forme di vendetta riguardano immigrati
italiani negli Stati Uniti. E’ il 1930 e nel New Jersey un siciliano immigrato negli Stati Uniti,
all’atto di venire arrestato per aver ucciso il seduttore sedicenne della figlia, mostra tutta la sua
sorpresa “dal momento che aveva semplicemente difeso l’onore della sua famiglia secondo la
tradizione” e che in Sicilia tale comportamento era non soltanto ammesso, ma addirittura doveroso.
L’uomo viene condannato, ma il caso, insieme ad altri, stimolò un dibattito nella dottrina americana
che portò Thorsten Sellin a uno studio considerato tra i lavori ante litteram sul multiculturalismo8 .
Probabilmente influenzato dalle teorie di Santi Romano, Sellin fu uno dei primi studiosi che
teorizzò i conflitti multiculturali come conflitti normativi. Nel suo lavoro egli sostiene che nelle
persone immigrate scatta un “conflitto normativo”, che le porta a scegliere le norme del proprio
ordinamento culturale in quanto più vincolanti o, in certi casi, le sole conosciute. Tale costruzione
teorica è tutt’oggi presente, sia nei tentativi di costruzione dogmatica, sia nella topica dei conflitti
multiculturali. Senza trascurare gli studi volti a ricercare tracce di pluralismo normativo interno
8
Thorsten Sellin, Culture and conflict in crime, Social Science Research Council, New York, 1938, 68 ss.
�nelle varie formazioni sociali9, è, a ben vedere, il multiculturalismo a meglio incarnare, attualmente,
la teoria del pluralismo degli ordinamenti giuridici.
Se gli anni ’30 iniziano a porre la questione, le istanze del multiculturalismo – che, vale la
pena ricordarlo, esiste come termine soltanto dal 197010. – e l’attenzione al dato culturale si
intensificano sia negli Stati Uniti che in altri ordinamenti a partire dal 1970. In questo periodo la
vendetta si ripropone all’attenzione da parte dell’ordinamento attraverso omicidi d’onore o
passionali realizzati da immigrati negli Stati Uniti provenienti da culture altre11. La categoria dei
delitti d’onore è tendenzialmente associata con casi di donne uccise per tradimento o perché si
sottraggono alle regole del clan familiare, ma in realtà essa si rivela molto più ampia includendo
tutte le ipotesi di reazioni a violazioni del proprio onore dovute anche ad affronti compiuti su
persone della propria famiglia, ad insulti o minacce percepiti in modo più grave a causa del proprio
contesto culturale.
Nel caso The People v. Metallides (1974) il signor Kostas Metallides, immigrato greco in
Florida, uccise un suo amico dopo aver scoperto che questi aveva violentato la figlia. L’avvocato lo
difese sostenendo che “the law of the old country is that you do not wait for the police if your
daughter has been raped”. L’uomo venne assolto per temporanea infermità mentale che, in qualche
modo, il giudice aveva ricavato dallo stato di shock culturalmente determinato. La soluzione
adottata dal giudice è tipica dei primi passi che muovono i giudici che tentano di farsi antropologi
prendendo atto dell’altrui visione del mondo: usare un istituto del proprio ordinamento, come
l’infermità mentale, per offrire spazio al riconoscimento dell’altrui cultura. Ma con il passare del
tempo, il giudice antropologo diviene più ardito nel diretto riferimento alla cultura come elemento
di deroga all’applicazione della norma penale.
Nel caso The People v. Chen, 1988 un uomo cinese, avuta notizia che la moglie lo tradiva, la
uccise a colpi di martello. Al processo venne sentito un antropologo, il dottor Pasternak, esperto di
cultura cinese, che spiegò come la percezione di lesione al proprio onore che aveva subito l’uomo
era tale da rendere culturalmente necessitato il suo comportamento. Il giudice mostrando deferenza
verso la perizia antropologica che aveva spiegato le diverse concezioni dell’onore in Cina, osserva:
“se questo reato fosse stato commesso da un soggetto nato e cresciuto in America o anche nato
altrove, ma cresciuto principalmente in America, anche nella comunità cinese, la Corte non
avrebbe avuto difficoltà a riconoscere l’imputato colpevole di omicidio doloso. Ma questa Corte
non può ignorare… la grande influenza e la forte pressione della testimonianza del dott. Pasternak,
che è forse il maggior esperto in America di relazioni interfamiliari nella cultura cinese”. Sulla
base dell’argomento culturale il giudice assolse l’imputato disponendo soltanto alcuni anni di una
misura alternativa al carcere. La sentenza fu molto criticata e ancor oggi, negli Stati Uniti, continua
ad essere citata ad emblema dei rischi di aperture eccessive al multiculturalismo.
L’argomento culturale fu, invece, respinto, per inconsistenza, nel caso Nguyen v. State
(1998) riguardante una donna vietnamita che, dopo essere stata verbalmente insultata dal marito e
dalla figliastra e dopo essere stata minacciata dal marito di divorzio, sparò entrambi uccidendoli.
L’avvocato la difese sostenendo che la sua reazione così (apparentemente) sproporzionata fosse
dovuta ad un tipo di emozione culturalmente determinata, che un americano non poteva
comprendere: l’ira per gli insulti ricevuti, paragonabili nella cultura occidentale a delle percosse, e
9
Esempi riportati in Augusto Cerri, Istituzioni di diritto pubblico. Casi e materiali, Giuffrè, Milano, 2002, cap. I.
Il fatto storico-politico che portò alla sua genesi fu il tentativo di risolvere le tensioni tra il Canada anglofono e il
Quebec. Nel 1963 il governo istituì la Royal commission on bilingualism and biculturalism per cercare di ricomporre i
conflitti che allora ruotavano intorno al cosiddetto “biculturalismo” del Canada. Tuttavia, sia gli immigrati canadesi, in
particolare quelli che avevano partecipato alla II guerra mondiale, sia i popoli indigeni rivendicarono la più ampia
diversità culturale del Canada denunciando che le cosiddette “due solitudini” (Canada anglofono e Quebec) non
rappresentavano tutta la società. A seguito di tali rivendicazioni, l’allora premier canadese Pierre Elliot Trudeau
propose di abbandonare il termine “biculturalismo” e di introdurre il più onnicomprensivo “multiculturalismo”, che poi
conobbe una fortuna indiscussa tanto da entrare nel 1982 nel nuovo testo della Costituzione canadese.
11
Tutti i casi che cito possono essere approfonditi in Alison Dundes Renteln, The cultural defense, Oxford University
Press, Oxford, 2004, 23-47.
10
�la paura di essere sottoposta all’umiliazione del divorzio, fatto traumatico nella cultura vietnamita.
In questo caso la donna fu condannata perché il giudice, pur affermando che ci sono dei casi in cui
la cultura rileva, ritenne che in questo caso il comportamento della donna non fosse stato
culturalmente determinato.
In modo simile fu risolto il caso Trujillo Garcia v. Rowland (1992-1994), che aveva visto un
immigrato originario del Messico sparare ad un suo amico dopo che questi gli aveva rivolto
l’espressione “chinga tu madre”. All’avvocato che chiedeva le attenuanti motivate dalla
provocazione, si contrapponeva il pubblico ministero che insisteva sul fatto che la provocazione
non può valere, nel diritto americano, se è soltanto verbale. In questo caso il giudice rifiutò
l’argomento culturale sostenendo che una persona ragionevole messicana (reasonable Mexican
man) non avrebbe mai ucciso per questo insulto e attribuendo la reazione alla personalità
particolarmente irruenta dell’imputato leggendola, dunque, come devianza personale priva del
supporto normativo del gruppo culturale.
I casi riportati rivelano un atteggiamento opposto da parte del giudice: da un lato una sorta
di deferenza verso il determinismo comportamentale che deriverebbe dall’appartenere ad una
determinata cultura, che porta all’assoluzione anche in casi che coinvolgono il bene vita, dall’altra
una negazione della componente culturale di un comportamento che, da un lato, potrebbe essere
strumentale ad evitare le conseguenze dell’accoglimento dell’argomento culturale, dall’altro
potrebbe essere il frutto di una effettiva conoscenza della cultura altra e dell’effettivo accertamento
che l’argomento culturale fosse usato come una mera strategia processuale della difesa.
Spostandoci dagli Stati Uniti all’Italia lo scenario cambia notevolmente. In Italia la Corte di
Cassazione, che ha iniziato a risolvere casi quando già era nata una cospicua dottrina critica sui
rischi del multiculturalismo12, ha preso una chiara posizione contro i reati culturalmente motivati
che intaccano beni essenziali quali la vita o l’integrità fisica. La posizione italiana riporta alla luce
la teoria del pluralismo degli ordinamenti giuridici, sia pure “addomesticata” al primato del diritto
statuale e dei valori costituzionali. La Corte di Cassazione, infatti, costruisce la norma culturale
come una consuetudine, degna di rilievo, che impone al giudice un ruolo di “mediatore culturale”,
purchè non contrasti i principi costituzionali e la norma penale, nel qual caso non potrà mai rilevare.
Come exemplum di questa giurisprudenza, si consideri la sent. 1520/2008 in cui la Corte
affronta la richiesta di un marito marocchino che picchiava la moglie e chiedeva l’annullamento
della condanna emessa in appello motivando che lo stesso difendeva il proprio onore secondo la
propria cultura visto che la moglie rifiutava di assolvere il debito coniugale. La Corte di Cassazione
osserva: “la situazione evoca il ben noto fenomeno dei ‘reati culturali’ che la dottrina ha definito
come il frutto di un conflitto normativo, suggestivamente espresso con il termine ‘interlegalità’
intesa come condizione di chi, dovendo operare una scelta, è costretto a fare riferimento ad un
quadro articolato di norme, contemporaneamente vigenti ed interagenti tra sistemi giuridici
diversi” e si sofferma diffusamente sulle influenze del multiculturalismo sulle categorie del diritto.
La sua risposta a questo conflitto normativo è che un’apertura alle norme culturali può avvenire:
“nella misura in cui non contrastino con i principi cardine del nostro ordinamento, anche di rango
costituzionale, in tema di famiglia, rapporti personali e di coppia ivi compresa l’interazione
sessuale che nel nostro sistema è stata rigidamente ed innovativamente regolata dalla legge n. 66
del 1996”. La Corte richiama gli art. 2 e 3 della Costituzione e osserva che essi “costituiscono uno
sbarramento invalicabile contro l’introduzione, di diritto e di fatto, nella società civile di
consuetudini, prassi, costumi, che si propongono come ‘antistorici’ a fronte dei risultati ottenuti nel
corso dei secoli, per affermare i diritti della persona, cittadino o straniero”.
La posizione della Corte di Cassazione italiana consente di individuare alcuni punti fermi,
ma pone anche diverse questioni. Mi pare indubbio che la posizione della Corte sia volta a dare
riconoscimento alla teoria del pluralismo degli ordinamenti giuridici. Quando si parla di
12
L’articolo che segnò la prima critica al multiculturalismo, viceversa letto dalle teorie del riconoscimento come un
movimento progressista e liberatorio, promanò dal femminismo e simbolicamente può essere identificato nel lavoro di
Susan Moller Okin, Is multiculturalism bad for women?, in Boston Law Review, oct./nov. 1997.
�“interlegalità” o di “conflitti normativi” è evidente che la Corte dia dignità normativa alle norme di
condotta altrui che affondano nel proprio contesto culturale. Lo status di queste vere e proprie
norme di comportamento è – ci dice la Corte – quello di una consuetudine, una prassi, un costume.
E sul punto si aprono numerose questioni che la Corte non risolve. Si tratta di consuetudini
“esterne” che si formano fuori dal territorio statuale e da parte di consociati che non sono cittadini:
questo dato impedisce loro una piena collocazione tra le consuetudini dell’ordinamento italiano?
Che posizione esattamente hanno nel nostro sistema delle fonti? A mio avviso, la territorialità della
consuetudine, ossia il fatto che la stessa sia sorta fuori dal territorio italiano, non dovrebbe
impedirne la valutazione: la consuetudine è un fatto che sorge tra i consociati e nulla dicono le
preleggi tra quali consociati. Tuttavia, proprio il riferimento che la Cassazione fa ad una
interlegalità presuppone che la consuetudine culturale resti, comunque, una fonte esterna
incorporata nel nostro ordinamento di volta in volta.
Problematica è anche la collocazione di queste consuetudini, posto che sono di natura
“esterna” esse assumono, nella ricostruzione della Corte, una posizione diversa rispetto a quella
delle normali consuetudini del nostro ordinamento. Mi pare si possa dire che quelle culturali sono
consuetudini “rinforzate” cioè superiori nella scala delle fonti alle normali consuetudini, nel senso
che il loro limite è rappresentato dalla norma penale che protegge beni costituzionali, mentre in tutti
gli altri casi sembrerebbe che la consuetudine possa anche operare in deroga ad altre fonti di diritto
scritto: sicuramente le fonti secondarie e forse anche le fonti primarie che non proteggano beni
costituzionali. La giurisprudenza di merito, ma anche di legittimità, che hanno dato rilevanza
all’argomento culturale in numerosi casi sembrano provare questo assunto.
Viene, qui in rilievo il terzo problema che questo tipo di ricostruzione pone: se siamo di
fronte ad una norma non scritta esterna come il giudice può ricostruirne l’esatto contenuto? Il
giudice spesso è totalmente sprovvisto di conoscenza dell’altrui cultura per cui come fa a
distinguere se, ad esempio, la pratica culturale è evocata strumentalmente dalla difesa, se sia
davvero una pratica tutt’oggi esistente o se invece lo stesso gruppo di appartenenza la sta
abbandonando? E ancora: come fa a stabilirne il livello di obbligatorietà, l’effettiva ineluttabilità di
quel comportamento e via enumerando? L’accertamento preciso e puntuale della pratica culturale
pone un problema di valutazione tecnica, che negli Stati Uniti è risolto consultando l’antropologo,
ossia un esperto culturale che istruisce il giudice sui contenuti di quella pratica, mentre in Italia è
quasi sempre svolto dal giudici in solitudine. Secondo la dottrina penalistica, infatti, vi sarebbe un
divieto di perizia antropologica, basato sull’art. 220 del c.p.p. dedotto dal divieto di perizia
criminologica.
Per completezza espositiva, sia pure sempre circoscritta all’economia del presente lavoro,
vorrei infine osservare che, analogamente a quanto accade negli Stati Uniti, anche i giudici italiani
non sempre accolgono passivamente l’argomento culturale sollevato dalla difesa e in certi casi
hanno negato la qualifica di norma culturale a quelle che sembravano forme di vendetta codificate
dal gruppo. E’ quanto accaduto nel noto caso Hina Saleem, la ventenne pakistana che nel 2006 fu
uccisa a Salezzo, vicino Brescia, dal padre per aver infangato l’onore familiare andando a convivere
con un italiano e scegliendo di adottare uno stile di vita occidentale. L’opinione pubblica lesse il
caso come un omicidio d’onore, una vendetta le cui motivazioni affondavano nella cultura/religione
islamica. Tuttavia, in questo caso, il giudice (in tutti e tre i gradi di giudizio) respinse l’argomento
culturale e non attribuì il comportamento ad un sentimento di vendetta culturalmente accettato ma
al personale e “distorto rapporto di possesso parentale” 13. Secondo il giudice era stata la psiche di
quel particolare individuo e non pratiche di vendetta pakistane a giustificare il comportamento, con
la conseguenza che la condanna a 30 anni di reclusione è stata confermata. La Corte di Cassazione,
dunque, ha de-culturalizzato il comportamento riportandolo nell’alveo della devianza individuale.
Ciò è stato possibile anche perché la comunità pakistana in Italia ha immediatamente preso
13
Cass. sez. I penale, sent. 6587/2010.
�posizione di forte critica verso l’omicidio negando che un qualsiasi padre pakistano si sarebbe
comportato così.
4. Vendetta come cultura degli immigrati versus vendetta come devianza delle società
occidentali.
Ricapitolando, mi pare che siano due le osservazioni estraibili dal complesso ed eterogeneo
quadro sopra illustrato.
La prima è che la vendetta continua a porsi all’attenzione del diritto come norma giuridica
tramite i conflitti multiculturali. Ciò mostra come la teoria del pluralismo degli ordinamenti
giuridici sia viva più che mai e che riceva oggi il suo forse maggiore inveramento proprio nel
multiculturalismo. La teoria del pluralismo normativo, peraltro, non serve soltanto a
concettualizzare la vendetta come regola che proviene da un altro assetto normativo, ma sia pure
raramente porta i singoli giudici a riconoscere alcune delle “ragioni” della vendetta, prescindendo
dal bene giuridico compromesso.
La seconda osservazione attiene alla diversa classificazione dei comportamenti latu sensu
riconducibili al fenomeno della vendetta a seconda che questi siano posti in essere da immigrati o
altre minoranze culturali o, viceversa, da cittadini o membri della maggioranza. Può, infatti, notarsi
che se nel primo caso la vendetta viene spesso concettualizzata come norma culturale, ciò quasi mai
avviene nel secondo caso, dove la vendetta appare sempre una forma di devianza riconducibile al
singolo. Si potrebbe obiettare che questa distinzione è pienamente plausibile visto che il nostro
ordinamento, come si diceva al principio, ha espunto questo tipo di folk-law e anche a livello
sociale essa non riceva più il supporto, il sigillo normativo della maggioranza. Tuttavia, a mio
avviso, questa distinzione è, talvolta, la conseguenza di un discorso volto a distinguere un “voi”
arretrato e antistorico rispetto ad un “noi” più moderno ed evoluto, impedendoci di prendere atto
che vi sono comportamenti di vendetta comuni ai due sistemi culturali. Ad esempio, spesso i giudici
attribuiscono l’etichetta di culturale in modo piuttosto superficiale, per il solo fatto che un
comportamento abbia luogo, senza imporsi un accertamento più rigoroso di ciò che è o non è
accettato come culturale dal gruppo. Per esempio, nel caso citato del marocchino che picchia la
moglie che non assolveva il debito coniugale, la Corte di Cassazione ha dato per presupposto che
l’inquadramento sub specie cultura che proponeva la difesa fosse corretto, senza chiedersi: è vero
che tutti in Marocco tengono questa condotta se la moglie rifiuta rapporti sessuali? Senza
considerare che il Marocco ha visto nel 2000 una profonda riforma del suo diritto di famiglia e
senza considerare che anche l’Europa conosce moltissimi casi, con statistiche paragonabili al
Marocco, di maltrattamenti di donne da parte del marito. La Corte attribuisce alla pratica,
presuntamente marocchina, la qualifica di costume “anti-storico”, senza riflettere che, nel presente
italiano, si tratta di una pratica fortemente presente. Che l’approccio sia discutibile ben si può
apprezzare quando l’argomento culturale è applicato all’estero, a noi, come dimostrano le reazioni
italiane al noto caso di Maurizio Pusceddu, un sardo emigrato in Germania che aveva picchiato la
compagna lituana e che aveva subito le attenuanti culturali, con uno sconto di ben due anni di pena,
per le sue “particolari impronte culturali ed etniche”; Pusceddu, infatti, scriveva il giudice tedesco:
“è un sardo. Il quadro del ruolo dell’uomo e della donna esistente nella sua patria non può certo
valere come scusante, ma deve essere tenuto in considerazione come attenuante”14.
Simili errori sono compiuti molto spesso dai giudici italiani nei riguardi di minoranze
culturali. Ex plurimis, si pensi alla sent. 45516/2008, in cui la Corte di Cassazione ha attribuito alla
cultura del popolo Rom la pratica del mendicare15, mentre questo gruppo ne negava tale natura
14
Tribunale di Bückeburg, sent. 25 gennaio 2006 La decisione sarà successivamente annullata dal giudice di appello,
probabilmente anche a seguito delle proteste dell’Italia, dove il caso divenne un incidente diplomatico.
15
La Corte nell’annullare la sentenza d’appello che aveva individuato il reato di riduzione in servitù da parte della
madre che faceva mendicare il figlio di 4 anni osserva che nel valutare l’abuso di autorità bisogna prestare attenzione a
�spiegando che si trattava di una mera pratica connessa al disagio economico visto anche che in
passato i Rom lavoravano in svariate attività che poi hanno subito un tracollo durante
l’industrializzazione e l’urbanizzazione.
Tornando ai casi riguardanti forme di vendetta, viene in rilievo la diversa configurazione che
subiscono gli omicidi di donne per ragioni passionali, che rivelano una crescente ascesa anche nelle
società occidentali tanto da aver portato al conio di un nuovo termine: i femminicidi. Questo tipo di
omicidi, infatti, possono essere ben letti come esempi di vendetta sia nell’ambito di singole unità
culturali, quella pakistana, afgana, ma nessuno ha mai parlato di un mutamento della cultura italiana
anche se le statistiche di una donna morta ogni due giorni per mano del compagno sono molto
vicine a quelle del Pakistan. Si potrebbe ribattere che in Italia ci troviamo di fronte ad una mera
regolarità non accompagnata da alcuna condivisione da parte del gruppo che possa dare ai
femminicidi il sigillo normativo che li renda idonei ad entrare nel nostro contesto culturale. Tuttavia
è evidente che già lo stesso linguaggio che distingue i due fenomeni (omicidi d’onore in Pakistan,
femminicidi in Italia) tiene ben distinti i due fenomeni.
Per superare questa classificazione, che opera foucaultianamente per perpetuare un discorso
di potere in cui l’occidente è meno barbaro e antistorico dell’oriente, sono interessanti i tentativi
della critica femminista di classificare tutti gli omicidi di donne nell’ambito del patriarcato,
ravvisando in esso comportamenti trasversali a molteplici unità culturali. Ovviamente il
concettualizzare gli omicidi d’onore come istituti della vendetta pakistana o istituti della vendetta
patriarcale cambia molto le cose. Nel primo caso si crea un ben netta e chiara distinzione tra un noi
e un altro, l’uccisione di una donna diviene omicidio d’onore se compiuta da un immigrato, e mera
devianza personale, gesto quasi incomprensibile, se compiuto da un italiano; nel secondo caso
anche i femminicidi che avvengono in Italia altro non appaiono che espressioni di un fenomeno
comune, da combattere insieme.
diversi fattori, tra cui quello culturale: “ciò è particolarmente vero per alcune comunità etniche ove, ad esempio, la
richiesta di elemosina costituisce una condizione di vita tradizionale molto radicata nella cultura e nella mentalità di
tali popolazioni... È necessario prestare attenzione alle situazioni reali al fine di non criminalizzare condotte che
rientrino nella tradizione culturale di un popolo”. Dopo aver affermato che, trattandosi di un elemento culturale, non è
possibile criminalizzare, la Corte di Cassazione, tuttavia, precisa: fermo restando, però, che se determinate pratiche,
magari anche consuetudinarie e tradizionali, mettano a rischio diritti fondamentali dell’individuo garantiti dalla nostra
Costituzione o confliggano con norme penali che proprio tali diritti cercano di tutelare, la repressione penale è
inevitabile. È fin troppo evidente, infatti che consuetudini contrarie all’ordinamento penale non possano essere
consentite”. Nel ribadire la sua costruzione, tuttavia, la Cassazione non considera che i Rom hanno all’unanimità negato
che si trattasse di una loro pratica culturale associando il manghel più ad una conseguenza del loro disagio economico.
�
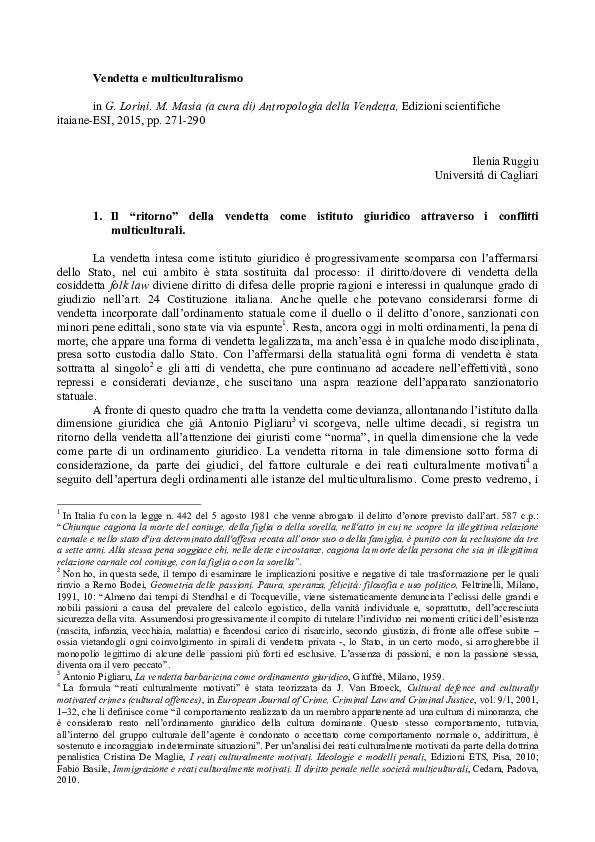
 Ilenia Ruggiu
Ilenia Ruggiu